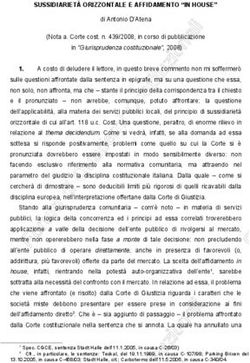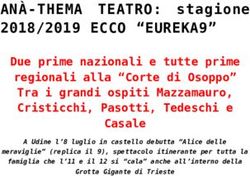I marchi illeciti e l'evoluzione del costume sociale - MARIO LIBERTINI UIBM - 16 NOVEMBRE 2017 - Ufficio ...
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
I marchi illeciti e l’evoluzione
del costume sociale
UIBM – 16 NOVEMBRE 2017
MARIO LIBERTINIIl principio di liceità del marchio - I ▪ Due profili: divieto dei marchi ingannevoli e divieto dei marchi illegali o immorali. Qui ci occuperemo solo del secondo profilo DATI NORMATIVI ▪ Art. 14.1 c.p.i.: «Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume» ▪ Art. 7 Reg. 2017/1001/UE: «Sono esclusi dalla registrazione i marchi contrari all’ordine pubblico o al buon costume» ▪ Art. 4 Dir. 2015/2436/UE: «Sono esclusi dalla registrazione o, se registrati, possono essere dichiarati nulli i marchi contrari all’ordine pubblico o al buon costume»
Il principio di liceità del marchio - II ▪ Per confronto: § 2 (15 U.S.C. § 1052). Trademarks registrable on the principal register; concurrent registration “No trademark by which the goods of the applicant may be distinguished from the goods of others shall be refused registration on the principal register on account of its nature unless it— (a) Consists of or comprises immoral, deceptive, or scandalous matter; or matter which may disparage or falsely suggest a connection with persons, living or dead, institutions, beliefs, or national symbols, or bring them into contempt, or disrepute” U.S. Supreme Court 19.06.2017: “the Lanham Act disparagement clause violates the First Amendment’s Free Speech clause”
Il principio di liceità del marchio - III Art. 3 (3) Trade Marks Law 1994 UK “A trade mark shall not be registered if it is—(a) contrary to public policy or to accepted principles of morality” ▪ § 8 (2) Markengesetz (1994) «Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken die gegen die öffentliche Ordnung oder die gegen die guten Sitten verstoßen» ▪ Art. L711-3 Code de la propriété intellectuelle « Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, ou dont l'utilisation est légalement interdite » Conclusione: sostanziale uniformità dei testi normativi, ma incertezza sul peso sistematico da attribuire alla libertà di espressione
Il principio di liceità del marchio - IV
▪ Il principio ha una doppia giustificazione:
I) Prevenire modi e contenuti comunicativi comunque ritenuti meritevoli di
riprovazione > estensione al marchio di norme di condotta generali presenti
nell’ordinamento (p.e. delitti contro il sentimento religioso, contro la moralità
pubblica e il buon costume ecc.)
II) Garantire la parità concorrenziale, evitando che un’impresa possa acquisire
vantaggi competitivi mediante acquisizione di un surplus di attenzione del
consumatore, derivante dall’impiego di messaggi «scioccanti»
→ La prima giustificazione tende oggi a restringere il campo di applicazione del
divieto (evoluzione del costume e libertà di espressione)
→ La seconda giustificazione porta invece ad allargare l’ambito di applicazione
del divietoLa nozione di ordine pubblico - I ▪ E’ tradizionalmente intesa come insieme dei principi fondamentali dell’ordinamento. Esempi di definizione: - «complesso dei principi fondamentali caratterizzanti l'ordinamento interno in un determinato periodo storico, ma ispirati ad esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo comuni ai diversi ordinamenti e collocati a un livello sovraordinato rispetto alla legislazione ordinaria» (Cass.civ. sez. I 30.09.2016 n. 19599) - «i principi fondamentali della Costituzione ovvero quegli altri principi che rispondono all'esigenza universale di tutelare i diritti fondamentali dell'uomo, la cui lesione determina uno stravolgimento dei valori fondanti dell'ordinamento» (Cass.civ. sez. III 22.08.2013 n. 14905) - «un sistema assiologico posto in primo luogo dalla Costituzione e, più in generale, dalle fonti di diritto internazionale, con riferimento particolare ai principi consolidatisi nell'ambito dell'Unione Europea» (Cass.civ. sez. I 27.09.2012 n. 16511)
La nozione di ordine pubblico - II ▪ Collocazione sistematica: - «l'ordine pubblico da strumento di tutela dei valori nazionali, da opporre alla circolazione della giurisprudenza, diviene progressivamente "veicolo di promozione" della ricerca di principi comuni agli Stati membri, in relazione ai diritti fondamentali» (Cass.civ. ss.uu. 05.07.2017 n. 16601) Conclusione La nozione continua ad avere contorni vaghi e tende a coincidere con l’insieme dei principi e diritti fondamentali riconosciuti a livello costituzionale, europeo e internazionale. Il contenuto della nozione tende a dilatarsi.
La nozione di buon costume - I ▪ E’ tradizionalmente intesa come insieme di principi e regole che sono radicate nel costume sociale, sì da creare profonda riprovazione sociale in capo a chi violi tali regole (la nozione è tradizionalmente distinta dalla «buona educazione»). Ciò a prescindere da un riconoscimento di tali regole in fonti giuridiche formali. ▪ Una integrazione di tale nozione è legata al concetto di «pudore», come sentimento primordiale che impone di limitare alcune informazioni ed esperienze nella sfera dell’intimità personale (nozione non necessariamente limitata alla sfera della vita sessuale)
La nozione di buon costume - II ▪ Definizioni giurisprudenziali: - «La nozione di buon costume non si identifica soltanto con le prestazioni contrarie alle regole della morale sessuale o della decenza ma comprende anche quelle contrastanti con i principi e le esigenze etiche costituenti la morale sociale in un determinato ambiente e in un certo momento storico» (Cass.civ. sez. III 21.04.2010 n. 9941) - «La nozione di buon costume comprende in via generale tutti quei principi e tutte quelle esigenze etiche che costituiscono la morale sociale, a cui i consociati, complessivamente, uniformano i propri comportamenti, in un determinato contesto storico» (Cass.pen., sez. II 05.04.2007 n. 14440) Conclusioni: la nozione è non solo vaga, ma anche difficilmente concretizzabile di fronte alla fluidità della morale sociale odierna ►La riforma francese della disciplina generale del contratto (2016) ha eliminato il buon costume come limite all’autonomia privata, accanto all’ordine pubblico e alle norme imperative
L’oggetto del divieto ▪ E’ stato precisato che il divieto ha ad oggetto il segno in sé considerato e non l’eventuale uso illecito che del segno possa essere fatto, nell’ambito di un’attività vietata: Trib. I Gr. CE sez. II, 13.09.2005, T-140/03, Sportwetten (caso «Intertops») ▪ Il rifiuto della registrazione come marchio non comporta divieto assoluto di usare il segno nella comunicazione commerciale (Trib. I Gr. UE 09.03.2012 T- 417/10, «¡Que buenu ye! HIJOPUTA») ▪ Introduzione alla casistica: - o.p. e b.c. continuano ad essere criteri di valutazione dei marchi largamente usati - la casistica può classificarsi intorno a tre filoni: (i) suggestioni favorevoli ad attività illegali; (ii) espressioni volgari o indecenti; (iii) appropriazione privata di espressioni simboliche di uso comune (interferenza con l’art. 10.2 c.p.i.)
Richiamo ad attività illegali - I E’ stato applicato soprattutto per segni che utilizzano simboli politici incompatibili con i principi costituzionali ▪ Simboli nazifascisti (vietati da Trib. Torino 06.12.2012, GI 2013 2061, nt. adesiva Lerro) ▪ Simbolo dell’Unione Sovietica (vietato da Trib. I Gr. UE 20.09.2011 T-232/10 perché contrastante con l’ordine pubblico di alcuni stati membri) ▪ «Mechanical Apartheid» (R 2804-2014-5) ▪ Simboli richiamanti movimenti terroristici (caso «Bin Ladin», Comm. Ric. UAMI, 29.09.2004
Richiamo ad attività illegali - II ▪ Segni richiamanti la criminalità organizzata - caso «Il clan dei camorristi»: Comm.Ric. UIBM 06.10.2014 - Caso «La Mafia se sienta a la mesa» (R 803/2016-1: l’apparente stemperamento del richiamo alla criminalità organizzata rende particolarmente offensivo il segno) ▪ Segni costituenti incitamento a condotte illegali - caso «Io mi difendo», relativo a un cartello da affiggere su cancelli di ingresso a spazi privati, contenente allusione ad una probabile reazione armata: illecito per Comm.Ric. UIBM 11.11.2013 n. 14 - «Contrabando» per liquore rum: lecito perché chiara espressione di fantasia (R2822/2014-5) - «Illicit» per profumi: lecito perché chiaramente di fantasia (MUE 13 469 523)
Vilipendio delle istituzioni o dei valori
socialmente accettati
▪ Segni denigratori verso le istituzioni
(«La police coupable» per un gioco da tavolo: INPI 2015 – marchio raffigurante un
poliziotto a cavallo che alza il manganello contro un giovane: Italia 2017)
▪ Segni denigratori verso la famiglia
(«Puta Madre»: nullo per contrarietà ai buoni costumi per Cass. Fr. 29.03.2011)Richiamo all’uso di droghe ▪ Incertezze applicative - Marchi «Hashish» (vietato) e «Oppio» (ammesso) - «Cannabis Trade Marks»: giurisprudenza alterna negli U.S.A. - «Cannabia» vietato in Francia (App. Paris 18.10.2000) - «Opium» ammesso in Francia per profumi (App. Paris 17.05.1979) - «Cocaine Soft Drinks»: vietato negli U.S.A. Sembra eccessivo vietare qualsiasi richiamo di fantasia
I marchi «politicamente scorretti» ▪ Allusioni razziali - Caso Washington Redskins (squadra di football americano), giudicato “disparaging of Native Americans” (USA 2014). “This is a perfect example of a phrase that may have been acceptable by the majority 20 or 30 years ago, has become a racist or disparaging racial slur in modern times” (J.Pryor, 2014) - Caso Pommiebasher (Australia 2016): espressione ingiuriosa contro gli inglesi, vietata la registrazione come marchio di un club sportive [“Pommies” ammesso però in Europa] - Caso Paki (illecito per Trib. I Gr. UE 05.10.2011 T-526/09) - Caso The Slants (= occhi a mandorla, aspetto mongoloide), come marchio per una banda rock composta da musicisti asiatici: USPTO nega la registrazione, ma la Corte Suprema (giugno 2017) ritiene l’uso consentito dalla libertà di espressione
Appropriazione di simboli appartenenti alla
collettività
▪ «Je suis Paris» e «Pray for Paris» (non registrabili: INPI 2015)
▪ «Ataturk» (UAMI R 2613/2011-2): offensivo per la sensibilità dei cittadini turchi
> Interferenza con l’art. 10.2 c.p.i. (segni con significazione politica o di alto valore
simbolico)Richiami religiosi ▪ Caso «Jesus Jeans», ammesso in Italia e vietato in UK (Ricolfi 361) ▪ Caso «Buddha Bar»: Cass.civ. sez. I 25.01.2016 n. 1277 ha risolto il caso dichiarando la nullità del marchio per difetto di capacità distintiva, ma Trib. Milano 04.11.2008, darts-ip.com, ha ritenuto tale marchio contrario all’ordine pubblico ▪ BPatG 50/10: contrarietà ai buoni costumi del marchio «Dakini» (divinità femminili della religione hindu) per servizi di massaggi
Le espressioni volgari o impudiche ▪ Il cattivo gusto non è ostativo alla registrazione del marchio (Direttive di esame UAMI § 8.7; caso «Dick & Fanny», Comm.Ric. UAMI 25.03.2003) ▪ C’è un confine tra il cattivo gusto e la violazione del buon costume? ▪ Caso recente: immagine di un uomo che vomita (con il vomito stilizzato in colori arcobaleno) ▪ Altro caso recente italiano: immagine del dito medio alzato (casi simili in molte parti del mondo) ▪ Casi EUIPO: «fucking freezing!» (R 0168/2011-1) / «Hijoputa» figurativo (T- 417/10) / «Ficken» (T-52/13) / «Fuck Cancer» (R 0703/2014-2) /
I richiami sessuali ▪ Orientamenti generalmente restrittivi ▪ Un caso italiano recente: marchio «Sex Drugs and Bunga Bunga» ▪ All’estero frequenti sono i casi di condanne di segni che utilizzano espressioni pesantemente volgari (p.e. BPatG 09.02.2011, Arschlecken24 – BPatG 03.12.2015, Headfuck Statement Fashion) ▪ Casi europei: marchio «Screw You» (vietato da Comm. CE Dec. 06.07.2006) ▪ Casi americani («Asshole Repellent», USPTO 2014): la dottrina americana tende a criticare questi divieti in nome della libertà di espressione e dell’evoluzione del costume (che avrebbe fatto venir meno il concetto di «scandalous») ▪ Caso «Nutsack» (significa «scroto»; marchio per birre): giudicato registrabile perché le abitudini linguistiche si sono evolute e sopportano, più che in passato, espressioni «forti» (USPTO, 2015)
Richiami erotici non volgari ▪ Non c’è un divieto di principio all’inserimento di richiami di carattere erotico - caso «Erotik Lounge», Comm.Ric. UAMI 12.05.2006 - caso «Desir Sexe» (ammesso da App. Paris 2005)
Espressioni o immagini tendenziose ▪ Simboli sessuali stilizzati - decisioni contrastanti: Trib. Milano 17.12.2005 GADI 4990 / Trib. Bari 12.07.2007, FI 2007 I 3628 nt. Casaburi è un caso in cui il divieto si giustifica, prima che per ragioni morali, per prevenire vantaggi competitivi non fondati sul merito ▪ Varianti - «Fack Ju Göthe» (R 2205/2015-5) ▪ Anagrammi - «“Absofcukinglutely» (Australia, 2010) ▪ Doppi sensi - «Kunt» (foneticamente uguale a «cunt» (organo sessuale femminile) [Australia, 2007]
Espressioni in lingua straniera ▪ E’ frequente che un’espressione abbia significato osceno o volgare in una certa lingua, ma sia priva di significato per il consumatore medio ▪ Questa situazione è stata ritenuta non ostativa alla registrazione di un marchio europeo (caso «Reva» [organo genitale femminile in finlandese]: Comm.Ric. UAMI 18.07.2006) ▪ Ma una soluzione opposta si è avuta nel caso «Curve» (prostituta in romeno) per servizi informatici: Trib. I Gr. UE 26.09.2014 T-266/13, Brainlab AG
Illiceità relativa limitata ad alcune categorie
merceologiche
▪ Comm.Ric. UIBM 06.10.2014 n. 37: marchio «Il clan dei camorristi», lecito per serie
di fiction televisive e prodotti connessi, ma non per categorie merceologiche
lontane dal prodotto-baseLa rilevabilità d’ufficio ▪ Ammessa da Trib. Torino 06.12.2012, in applicazione diretta (sembra) dell’art. 1421 c.c. ▪ L’applicazione analogica dell’art. 1421 non può estendersi a tutti i casi di nullità, ma sembra plausibile nei casi di contrarietà all’ordine pubblico o al buon costume
Puoi anche leggere