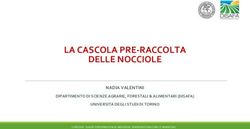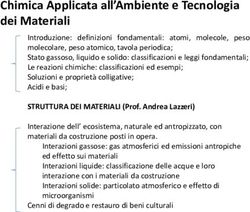Definire la strategia a breve per pensare a lungo termine: l'EU ETS e la politica climatica al 2030 - Giuseppe Astarita Federchimica
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Definire la strategia a breve per
pensare a lungo termine: l'EU ETS e
la politica climatica al 2030.
Giuseppe Astarita
Federchimica
Milano, 13 Marzo 2014L'Europa e la politica Energia-Clima.
Osservazioni/1.
• La UE è l'unica regione con obiettivi vincolanti
(al 2020)
• L'effetto di traino per altri Paesi non si è
verificato. Nessun accordo globale è atteso
prima della COP 21 (Dicembre 2015, Parigi).
• Il contributo delle emissioni GHG UE alle
emissioni globali, ora al 10-11%, è previsto al
4-5% al 2050.
• E' utile assumere ulteriori impegni unilaterali?L'Europa e la politica Energia-Clima.
Osservazioni/2.
• Politica UE basata su aumento dei costi
dell'energia per ricavare risorse per ridurre le
emissioni di gas serra (GHG)
• Altre aree sono state "attente" ad evitare
politiche climatiche con impatti significativi sui
costi.
• Circostanze indipendenti hanno ulteriormente
favorito tali aree, che hanno poi ottenuto
importanti risultati (shale gas in USA).L'Europa e la politica Energia-Clima.
Problematiche non risolte.
• Obiettivi separati su Rinnovabili e le conseguenti politiche di
incentivazione (soprattutto per EE) hanno ostacolato la transizione
verso il completamento del mercato dell'energia, creando in
qualche caso altissimi costi per i consumatori (per giunta non
uniformi in UE) e sottraendo al mercato la corrispondente energia
(regolata). Conseguenze (negative):
- sulla competitività dell'UE (vs altre regioni)
- sulla competitività intra UE (per la diversa incidenza dei costi di
incentivazione, e la diversa ripartizione tra settori economici, e
all'interno della stessa industria)
- sul funzionamento operativo del mercato elettrico, con
spiazzamento della produzione "baseload" e insufficienza delle
regole per governare la stessa situazione
- su proposte per rimediare allo "spiazzamento economico" delle
centrali tradizionali, che produrrebbero ulteriori costi (es. capacity
payment)Altre conseguenze negative.
• Il fortissimo sviluppo delle rinnovabili ha contribuito (assieme alla
crisi economica) a generare la sovrabbondanza di quote (EUA)
sul mercato ETS
• Con lo sviluppo dei costi rimasto "fuori" dall'ETS, la riduzione del
prezzo di mercato delle quote (pur non compromettendo l'obiettivo
fissato di riduzione delle emissioni) ha tolto la capacità di
"responsabilizzare" le fonti più intensive:
- ad es. la produzione di EE da carbone, anche in centrali poco
efficienti, risulta più conveniente di quella da centrali efficienti a
gas, in tal modo sprecando occasioni di contenimento delle
emissioni, senza che i costi (per gli incentivi alle rinnovabili)
siano risparmiati ai consumatoriLe proposte della Commissione per il 2030. • GHG: riduzione delle emissioni del 40% (2030 vs 1990) • Energia da Fonti Rinnovabili: incidenza sui consumi finali del 27% (ma obiettivo non ripartito in obiettivi nazionali • Efficienza Energetica: nessun obiettivo esplicito • Contributo al PIL della UE da industria manifatturiera al 2020: 20% (dall'attuale 15-16%) • Introduzione di una riserva strategica per le quote ETS dopo il 2020 • Comunicazione sullo sviluppo dello shale gas • Conservazione lista settori industriali esposti al rischio di Carbon Leakage (CL)
I valori delle emissioni GHG
(al lordo LULUCF).
(Mt CO2eq./a) EU 15 EU 27
1990 4.254,5 5.574,4
2005 4.173 5.129
2011 3.530,7 4.550,2Emissioni GHG (valori in %). Mt CO2eq./a EU 15 EU 15 EU 27 1990 100 76,32 100 2005 98,08 74,86 92,01 2011 82,99 63,34 81,63
Riduzione 40% emissioni GHG al 2030. • Obiettivo molto ambizioso (e unilaterale) • Differenziato tra ETS (-43% vs 2005) e non-ETS (-30% vs 2005) • Rispetto al 1990 importanti differenze tra settori (confrontando gli obiettivi impliciti al 2030) : - Industria energia -41 % - I. Manifatturiera (MIC+Proc. Ind.) - 50 % - Ind. Chimica (MIC+Proc. Ind.) -60 % - Agricoltura -38 % - Trasporto -14 %
Altre osservazioni. • Obiettivo aumento contributo al PIL da parte di industria manifatturiera: molto positivo, ma non accompagnato da misure specifiche (le altre indicate non sembrano di aiuto) • EU ETS: le misure proposte sembrano preoccuparsi esclusivamente di produrre un recupero del prezzo delle quote, non affrontando I significativi problemi strutturali
LO SCHEMA EUROPEO DI EMISSIONS TRADING (EU ETS) Le proposte di modifica di Federchimica
Le emissioni in EU ETS
EU ETS. Criticità per insufficiente protezione della competitività nel periodo di politica isolata della UE. • Assegnazione ex-ante e fissa (per il singolo operatore): troppe quote in fase di crisi, barriere alla crescita nelle fasi di espansione • Compensazione incerta e parziale per le emissioni indirette • Livello dei benchmark (top 10%) troppo ambizioso (accoppiato a CSCF e LRF) • Regole incomplete: ad es. no RNE dopo il 2020 • Velocità di riduzione del cap incompatibile con I miglioramenti attesi dello sviluppo tecnologico
EU ETS. Misure di protezione della
competitività/1.
• La III fase dello schema (2013 – 2020) realizza una
transizione verso un completo acquisto delle quote
(full auctioning).
• Per i settori industriali sono previste quote gratuite
decrescenti.
• Per i settori riconosciuti esposti al rischio di CL le
quote gratuite sono costanti al 100% del livello del
benchmark (di prodotto), invece di decrescere da 80%
a 30% al 2020.
• Il livello di benchmark è basato sulla prestazione del
10% dei migliori (top 10%, con copertura ulteriormente
ridotta dai fattori correttivi (LRF, CSCF).
• Ne risulta una copertura parziale per la maggioranza
dei soggetti.EU ETS. Misure di protezione della
competitività/2.
• L'EU ETS induce dei costi sulle emissioni "indirette",
come quelle relative ai consumi di elettricità.
• Le compensazioni previste per I costi indiretti sono:
- a discrezione degli Stati Membri
- parziali a causa dei meccanismi di copertura:
intensità di aiuto da 85% (2013-2015) a 75% (2019-2020);
fattore di riduzione 80% per i prodotti senza benchmark
• Ne deriva un altro motivo di copertura solo parziale
dei costi.Il criterio ex-ante per le assegnazioni
gratuite.
• Le quote gratuite dipendono, oltre che dal benchmark,
dal livello di produzione in un periodo storico di
riferimento, e da altre regole con le seguenti
implicazioni:
- sovra-assegnazione in periodi di crisi economica
- sotto-assegnazione e penalizzazione della
crescita in fase di espansione del ciclo economico
- barriere e rischi per ottenimento quote gratuite
da sostituzioni di impianti e potenziamenti
- incentivo implicito alla riduzione di produzione
(la produzione è alternativa alla vendita di quote).I motivi a favore del criterio ex-ante. • Il criterio ex-ante determina costi associati alla produzione (opportunity costs, per la mancata vendita delle quote). • Tali costi determinano il cosiddetto "segnale di prezzo", molto importante per gli economisti "verdi" fautori del "permit trading". • Inoltre, per molto tempo, ed erroneamente, il criterio ex-ante è stato ritenuto compatibile con l'obiettivo, dichiarato come prioritario, della protezione dal rischio di Carbon Leakage.
Assegnazione gratuita con criterio ex-
ante.
• L'assegnazione di quote gratuite con il criterio ex-ante
è indipendente dal livello di produzione effettiva (a
meno di non scendere sotto alcuni livelli, il che
determina perdita di quote).
Livello di produzione % Riduzione di quote gratuite
> 50 % 0%
25 – 50 % -50 %
10 – 25 % -75%
< 10 % -100 %Assegnazione gratuita con criterio ex-
ante. Incentivo perverso.
• La riduzione di quote in corrispondenza a certe soglie
(che è in effetti, e curiosamente, un'applicazione del
criterio ex-post, sia pure "a gradini") genera un
incentivo alla riduzione della produzione fino al
minimo livello per conservare le quote assegnate
(51%).
• La possibilità di vendita delle quote corrispondenti
alla diminuzione della produzione costituisce un
incentivo perverso.La soluzione ex-post e il suo rifiuto in
passato.
• L'assegnazione ex-post (in base alla produzione
effettiva) elimina i problemi di sotto e sovra-
assegnazione, e l'incentivo implicito alla riduzione di
attività.
CONTRO: l'ex-post implica una forte attenuazione del
"segnale di prezzo" (non ci sono quote gratuite
alternative alla produzione) che si riduce alla differenza
rispetto al benchmark.
Ciò fu causa del rifiuto del criterio ex-post a favore
dell'ex-ante, ritenuto (erroneamente) compatibile con
l'obiettivo dichiarato e prevalente di protezione dal
Carbon Leakage.Fattori che influenzano
il Carbon Leakage.
• Metodo di assegnazione delle quote gratuite
(ex-ante o ex-post).
• Livello del Benchmark (valore nullo del
benchmark = Auctioning)
• Prezzo del Carbonio (soprattutto rilevante per
le decisioni di investimento, per le quali
contano le previsioni a lungo termine)Le varie forme di Carbon Leakage.
Il CL strutturale di produzione (hard cash cost).
Condizione:
Il ricavo dalla vendita di quote (corrispondenti
alla riduzione di produzione) è maggiore del VA
lordo. Quindi:
• La produzione genera meno valore aggiunto
della vendita di quote.
E' la forma più estrema di CL.Le varie forme di Carbon Leakage. Il CL da produzione. Opzione disponibile per chi può scegliere di produrre in UE o fuori UE. Condizione: I costi di trasporto in UE (da fuori UE) sono inferiori ai ricavi dalla vendita di quote. In tal caso: • Conviene spostare la produzione fuori UE (fino al 51% della produzione UE di riferimento).
Le varie forme di Carbon Leakage. Il CL da investimento. Nelle valutazioni per la decisione di un investimento conta un orizzonte temporale adeguato (> 20 anni). Sono rilevanti le incertezze e le barriere su: - (potenziamenti): franchigia 10%, dimostrazione nuovo livello di potenzialità in un periodo breve (90 gg.), RNE dopo 2020…. - Incertezze sui futuri prezzi del carbonio, che porta ad ipotizzare valori conservativi (elevati), e quindi penalizzanti per il CL. Risultato: gli investimenti per la sostituzione degli impianti meno efficienti sono "spinti" fuori UE.
I prezzi di break-even del carbonio per
l'arbitraggio CL.
(prodotti petrolchimici e ammoniaca).
€/t CO2
CL strutturale (hard 40 - 80
cash cost)
CL da produzione 15 - 35
CL da investimento 20 - 35Riforma EU ETS: i punti interessati. • Criterio di assegnazione (da ex-ante a ex- post). • Trattamento delle emissioni indirette (con assegnazioni gratuite). • Livelli di benchmark e fattori di correzione/riduzione. • RNE dopo il 2020. • Stabilità dello status di esposizione al CL.
L'assegnazione di quote gratuite. • Criterio: da ex-ante ad ex-post. • Riferimento: da Top 10% a WAE (Weighted Average Efficiency). • Fattore di riduzione: da LRF (1,74%/anno) a ILRF (0,80%/anno).
Il fattore di riduzione LRF (1,74%/annno). Non in linea con il miglioramento atteso al 2050 (CEFIC Roadmap), di ca il 30% al 2050.
Un fattore di riduzione LRF "realistico"
(0,80%/annno).
Notare che la proposta della Commissione
prevede dopo il 2020 il LRF a 2,2%/anno!Il trattamento delle emissioni indirette. • Proposta di assegnazione gratuita per le emissioni indirette (con diminuzione delle quote in asta). • I produttori di EE sono danneggiati? NO, perchè si riduce la quantità di quote all'asta, ma aumenta quella sul mercato secondario. • L'implicazione è la riduzione dei ricavi dalle aste.
Evitare prezzi eccessivi di CO2.
La valvola di sicurezza.
• Riserva Strategica. Può avere un ruolo di
moderazione per evitare i picchi di mercato.
• In alternativa si può eliminare l'obbligo di
riacquisto quote non restituite. Il valore della
penale in tal caso (es. 100 €/t CO2) può
costituire la garanzia di limite di prezzo.Le assegnazioni gratuite aggiuntive.
• Maggiori assegnazioni gratuite di quote (con
corrispondente diminuzione di quelle all'asta):
- dirette: + 200 Mt CO2/a (benchmark WAE
invece di Top 10%)
- indirette: +175 Mt CO2/a (aggiuntive)
Totale 375 Mt CO2/a pari, a 30 €/t CO2, a 11 G€/a.Puoi anche leggere