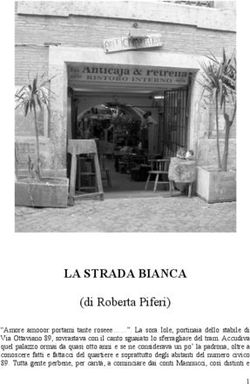Da lontano 2020 Arianna BABBI - Sfogliami.it
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Da lontano
Arianna BABBI
2020Premio Campiello Giovani 2020 Selezione della cinquina finalista Da lontano di Arianna Babbi, Classe (RA)
Da lontano
La donna grattava col cucchiaio sul fondo di una confezione di cibo ci- 3
nese: la fame le raschiava ancora in fondo alla pancia, non lasciava indietro
neanche un chicco bianco. L’ultimo l’aveva tenuto un attimo in più sotto la
lingua, prima di mandarlo giù.
La porta di casa aveva mandato un cigolio, un gemito. Ascoltava i passi
del ragazzo nell’ingresso: erano pesanti, sotto le gambe magre. Si era af-
facciato alla porta della cucina per salutarla con un cenno, gli occhi neri
di trucco. Lei gli aveva risposto con un gesto del cucchiaio di metallo, poi
si era allontanato e si era richiuso dietro la porta del bagno. Dopo qual-
che secondo arrivavano, attutiti, i riverberi di qualche canzone vecchia,
poi il getto della doccia. Lei succhiava il cucchiaio, i resti di sugo che le si
scioglievano contro il palato, finché non era rimasto solo il metallo secco,
asciutto.
Ma lo stomaco le si contorceva ancora, dava urli sommessi. Lei conti-
nuava a succhiare il cucchiaio, volgeva gli occhi agli angoli bianco sporco
del soffitto, alla macchia di umidità vicino alla finestra, con la vernice che si
staccava come da un taglio nuovo. Li rivolgeva alle sue mani: erano piene
di solchi, scavate da fiumi asciutti tra le vene e i tendini. Il cerchio profondo
intorno all’anulare. Il cambiamento era stato così garbato, così muto, che
non se n’era accorta. Un’iniezione. Si era alzata in fretta, gettando il cartone
rosso del take away nel cestino della carta, il cucchiaio nel lavandino, con
un tintinnare bagnato. Nell’altra stanza lo sentiva cantare a mezza voce.
Aveva preso una confezione di biscotti secchi dalla credenza, strappan-
dola aperta. Si pensava nuda davanti allo specchio, la pelle che prendeva
morbidezze diverse, si scavava e si spezzava con una geologia che le eranuova. Se la studiava con una consapevolezza vagamente colpevole: il ven-
tre era più gonfio. Ecco era gonfia, più che altro. Gonfia di “schiscette” di
riso gommoso riscaldato nel microonde dell’ufficio, dell’acqua che prende-
4 va il sapore metallico del thermos. Aveva affondato i denti su un biscotto, la
testa intontita. Li mangiava uno dopo l’altro, a morsi piccoli, affondandoci
i pensieri come in un’anestesia. Di là il getto della doccia si era zittito. Lei
li mangiava piano, mentre apriva il sito di qualche compagnia di volo low
cost sullo schermo lucido del cellulare.
Dopo qualche minuto era entrato in cucina anche lui, i capelli corti
ancora umidi sulla tuta scura. Aveva aperto il frigorifero, tirandone fuori
un barattolo di yoghurt bianco di quelli grandi, già aperto. Aveva preso
un cucchiaino di metallo dal cassetto delle posate e ve lo aveva affondato
dentro, la schiena contro il freddo di una credenza di legno, vecchia, piena
di buchi. Le aveva chiesto com’era andata la giornata. Lei gli rispondeva
distratta. Lo guardava, gli occhi macchiati dal trucco che si era sciolto nella
doccia, due fondi di bicchiere, fino ai piedi scalzi. Non riusciva a perdere
quell’abitudine inquieta di fare da mamma a qualcuno, la cosa la colpiva
quando non se lo aspettava come un pungiglione, un senso di colpa.
Erano arrivati in Inghilterra negli stessi giorni, sotto la stessa pioggia
fitta. Entrambi cercavano un coinquilino su quei gruppi di Facebook, per
quel bisogno smanioso di costruirsi a una famiglia nuova che parlasse una
lingua vecchia, di aggrapparsi a un letto tra quelle strade che si smangia-
vano a vicenda, le auto veloci. Aveva risposto al suo annuncio per strada,
pigiando sul telefonino di fretta, l’ombrello che le scivolava tra le dita. Le
sembrava un ragazzo a modo, li definiva così, giovani a modo. Nell’imma-
gine del profilo rideva, con la pelle olivastra, una mano sottile a coprirsi i
denti. Non aveva trent’anni, aveva una laurea, un tirocinio in un’azienda
con un nome importante, grosso, in inglese. Un po’ come lei. Solo che leiaveva anni diversi.
Da quando avevano iniziato a convivere certe volte cenavano insieme,
guardavano la tv italiana nello schermo rigato del tablet di lui. Nessuno dei
due la guardava mai a casa, a casa, ma lì era una tentazione costante. Erano 5
diventati grandi in un posto, ora dovevano reimparare da capo, ricostruirsi
il mondo attorno, un pezzo alla volta: quali erano le marche buone dei
biscotti, il bar per la colazione, il peso da dare a ogni sillaba per non farsi
guardare fisso dalle commesse nei negozi. La sera si riconoscevano nelle
scenografie di un programma che facevano finta di trovare divertente, ci si
rifugiavano con la coda tra gambe, il figliol prodigo. Più i giorni andavano
e più avevano voglia di disseppellire quegli ossi spaccati, lei gli raccontava
della figlia, lui del padre che aveva smesso di parlargli, quando aveva inizia-
to a uscire la sera con la matita nera negli occhi.
«Pensava che fossi gay, io non lo ero, non lo sono neanche adesso.»
Si era indicato la faccia con un sorriso, un dolore: «Lo trovavo diverten-
te, quando andavo a suonare, mi piaceva. Mi piaceva e basta. Però mi ha
guardato con un odio… ho pensato che certe volte non ha senso nemmeno
combattere.»
Gli aveva voluto bene per la prima volta, quel giorno. Più spesso si par-
lavano del lavoro, dei contratti difficili, degli uffici con le vetrate enormi,
contro i palazzi alti e un cielo sempre fitto di nuvole.
Quella sera lei si sentiva addosso una faccia diversa, uno sguardo fisso.
Anche lui doveva essersene accorto perché le faceva più domande del soli-
to, ma non toccava mai il punto. Lei continuava a rigirararsi i biscotti tra le
dita, pensava che erano anni che non li mangiava così. Capiva i suoi sottin-
tesi, quelle sopracciglia che si stringevano, nel dubbio che qualche mese di
convivenza non fosse abbastanza per farsi largo nel suo silenzio. Alla fine
aveva raddrizzato la schiena contro la sedia, le premeva contro la chiusuradel reggiseno.
«Devo tornare a casa per qualche giorno, la prossima settimana.»
«Sì? Come mai?»
6 Lei aveva stretto i denti su un biscotto.
«Così. un giretto. Faccio una sorpresa a mia figlia.»
«Fai bene.»
Aveva disteso il viso. Lei aveva la bocca piena di biscotto.
«Quand’è che vai?»
«Dopodomani, uscirò di casa presto. Starò via quattro, cinque giorni.»
Era il volo che aveva intenzione di prenotare, ma non l’aveva ancora fat-
to. Guardava le icone nere nel cellulare, fisso, finché non le si confondeva-
no gli occhi. Gli aveva chiesto cosa avrebbe fatto lui quella sera, contenta,
perché lui aveva iniziato a raccontare di un bar di un quartiere famoso dove
poteva suonare con alcuni amici. Lui suonava il basso, ogni tanto trovavano
i plettri sul fondo bagnato della lavatrice. La prima volta lei li aveva scam-
biati per gusci neri di insetti. Quando nella confezione erano rimasti solo
un paio di biscotti aveva arrotolato il bordo e l’aveva riposto sullo scaffale.
L’aveva salutato con una voce alta, acuta, e si era chiusa dietro la porta della
camera da letto, piano.
La stanza era ancora chiara, il buio non scendeva. Il cielo fuori dalla
finestra era di un blu ancora tiepido di luce, anche se erano già passate le
nove. Erano a nord, il sole faceva fatica a scendere del tutto, gli ci voleva di
più. La luce continuava a stendersi sui palazzi, a specchiarsi sui vetri, con-
tro i nembi. Era un sole che non conosceva: lei pensava alle notti d’estate, le
prime volte che sua figlia usciva alle feste in spiaggia e lei andava prenderla
in macchina, sotto un cielo nero viscoso, acceso solo di lampioni, di locali. I
tappetini della macchina che sbatteva dalla sabbia, sua figlia che ogni tanto
rideva, ogni tanto se ne stava seria e si slacciava i sandali, le righe rosse chele lasciavano sulle caviglie.
Quella luce la innervosiva, alla fine aveva tirato le tende pesanti, si era
coricata sopra le coperte ancora fredde. Aveva il cellulare acceso su quel
volo, guardava la data con un’asfissia stretta al collo. Non tornava da mesi, 7
dopo quel primo biglietto di sola andata. Prima di partire aveva promesso
alla figlia che sarebbe tornata per il suo compleanno, che a giugno avrebbe
avuto un po’ di ferie. Quanti anni avrebbe compiuto? Cinque, trenta? Era
piena di diacronie che nella sua testa si confondevano, una bambina, un
embrione, e certe volte la guardava e aveva questi occhi da donna, con una
sofferenza che le faceva venire voglia di gridare, di piangere. Sedici anni,
erano sedici anni. Glielo ricordava sempre il biglietto di auguri che le aveva
comprato, stava appoggiato sul pacchetto regalo lucido sopra la sua scriva-
nia. Se ci passava una mano sopra, le dita le impazzivano un po’. Alla fine
si era decisa a chiamarla, lo faceva tutte le sere, era ora.
La figlia era stretta in una coperta, sul divano ruvido. Guardava la re-
plica di un vecchio quiz sullo schermo piccolo della tv della nonna, i con-
correnti avevano facce sgranate, intente. Le piaceva indovinare le risposte.
Scambiava qualche parola con la nonna, poi l’aveva sentita russare, la testa
nascosta dentro il palmo di una mano, allora aveva sorriso, si era stretta le
labbra. Intanto le si era annunciato un fastidio in fondo alla pancia, come
tutte le sere: non l’aveva ancora chiamata. Era tornata a concentrarsi sulle
domande, gli occhi dentro quelli chiari del presentatore, sui suoi modi ve-
loci, i giri di parole che conosceva a memoria. Il telefono aveva iniziato a
vibrarle contro una coscia mentre pensava a dei fatti della seconda guerra
mondiale, ma aveva sbagliato, aveva detto bene il concorrente. Aveva ri-
sposto con un’inclinazione di fastidio, mentre abbassava il volume, con un
pugno in pancia.
«Nanà, come stai?»Aveva preso a mordicchiarsi intorno a un’unghia, le aveva raccontato
qualcosa della scuola mentre teneva gli occhi sul programma, muto, sul
sorriso imbarazzato e pieno di denti della concorrente che era appena stata
8 eliminata, vedeva come le si piegavano i capelli intorno alla testa. Non le
chiedeva mai niente di rimando, ma lei le raccontava lo stesso, quello che
faceva, quello che non faceva. Un lavello che continuava a perdere acqua.
Alla fine si era svegliata anche la nonna, aveva battuto un po’ le palpebre
sugli occhi macchiati. L’aveva ascoltata in silenzio per un po’, alla fine le
aveva chiesto di passargliela.
«Chiara? Ciao. Ascolta, allora quando arrivi?»
Aveva annuito appena, i lobi appesantiti da cerchi dorati che le tremava-
no intorno alla faccia.
«No, ma che hotel, stai qui da me. Sì… tranquilla. Ciao, ciao.»
Aveva restituito il cellulare alla nipote, la bocca sigillata. Forse non se
ne rendeva conto ma continuava a scuotere un filo la testa, anche mentre si
aggiustava la coperta sulle ginocchia, mentre la ragazza rialzava il volume
del televisore, mentre i concorrenti ricominciavano a parlare. Scuoteva la
testa. E a un certo punto la ragazza era certa di averle sentito uscire dalla
bocca una parola, “strega”: le aveva provocato come una risata, un riflesso
involontario, aggressivo. Si era chiesta per un attimo se fosse possibile per
una madre odiare la propria figlia, se era questo che aveva sentito in quel
sussurro incattivito.
La nonna non si era più riaddormentata dopo. La ragazza l’aveva sa-
lutata con un bacio contro la guancia piena di fili, piena di increspature.
Era uscita nel cortile stretto, l’aria satura dell’odore bagnato della terra, gli
insetti aggrappati alla lampadina che illuminava il vialetto. Le mettevano
addosso un fastidio strano, aveva fatto i gradini della scala esterna due a
due. Cercando le chiavi si sentiva formicolare i capelli, si era richiusa laporta dietro con frenesia. Papà bofonchiava qualcosa, la telecronaca di una
partita a volume troppo alto. Aveva cominciato a dirglielo lei, di abbassarlo,
prima lo faceva la mamma. L’aveva salutato di fretta, nella casa buia, era en-
trata nel bagno tastando con le mani contro i muri ruvidi, le intercapedini 9
di legno, la maniglia fredda metallica della porta. Una tensione le iniziava a
salire dalle piante dei piedi, le si arrampicava sulle gambe mentre si lavava
i denti allo specchio, mentre cambiava l’assorbente tra le ginocchia aperte.
Dopo si era passata un’altra volta il mascara, si era anche riempita la bocca
di un rossetto scuro, uno di quelli che aveva lasciato sua madre, ma se l’era
strofinato via dalla faccia con vergogna, lasciandosi le labbra arrossate.
Si aggrovigliava nel letto macchiando il cuscino di trucco, nella luce cal-
da della lampada che teneva sul comodino. Teneva il cellulare tra le dita,
cercando di far entrare nello schermo il nero dei ricci sul collo, sul petto. Si
riempiva la faccia di fotografie, lasciava che la corrodessero. Ogni prospet-
tiva era quella sbagliata, la carne le cadeva male sulle guance, riempiva gli
spazi dell’immagine con geometrie tutte diverse e tutte sbagliate. Alla fine
scorreva la galleria, un nugolo di seni, di luce aranciata, i suoi stessi occhi
che la riguardavano decine di volte. Lui le aveva mandato un messaggio, le
chiedeva dove fosse finita. Alla fine gli aveva inviato una delle immagini, di
fretta, una di quelle sfocate, con un sorriso che le moriva in bocca, un’ansia
elettrica nelle dita. Ma poi lui le aveva mandato un altro messaggio e le
diceva che era bella e le diceva che la amava, l’ansia le si scioglieva dentro,
come sale nell’acqua. Anche oggi la amava.
Era un’abitudine, una messa. Lui era un amico di amici, coi denti lucidi,
alto. Era più grande di lei, di qualche anno. L’aveva guardata qualche volta
nel buio sfocato di un locale, le aveva offerto da bere. Lei aveva detto di
no, grazie, che era con le sue amiche. Lui aveva alzato le spalle, un sorriso
candido, un morso nelle labbra. Poi un venerdì ci aveva litigato, con le sueamiche, aveva lo stomaco gonfio di nervosismo, smangiava la cannuccia di
una coca-cola. Lui le aveva fatto un altro sorriso bianco, e alla fine avevano
condiviso un Long Island, qualche parola. Lei aveva insistito per restituirgli
10 i soldi del drink, lui aveva riso e lei aveva fatto finta di non vergognarsi. Le
aveva raccontato dell’università, di come si viveva in una città grande. Lei
qui a volte si sentiva morire. Gliel’aveva detto così, con l’alcool che le si
scioglieva nelle braccia, e lui e aveva dato un bacio in fronte, un battesimo.
Non si erano mai toccati più di così. Lui le mandava messaggi pieni
di impegni, le raccontava che non sarebbe tornato a casa per un po’, per
gli esami. Lei tornava nel locale con le sue amiche, e lui non c’era. Erano
rimaste solo quelle conversazioni, quelle notti accese, si erano fissate tra le
sue necessità come una colla, una dose. Aveva toccato zone buie di lei che
le avevano sempre insegnato a tenere spente, la rabbia enorme che aveva
addosso, una voglia sconosciuta di sentirlo vicino, quando lui le parlava.
Gli aveva raccontato di sua madre, ne aveva parlato solo con lui. Non lo
sapeva nessun altro, sapevano solo che i suoi genitori avevano divorziato.
E se lo aspettavano, sua madre era sempre incazzata. Invece a lui aveva
spiegato che se n’era andata per lavorare. Che aveva preso una laurea a
quarant’anni, con una premeditazione meschina, che aveva trovato un la-
voro in Inghilterra. Lui aveva detto che doveva essere molto brava, e lei
l’aveva odiato, per l’unica volta. In un attimo le si era sedimentata dentro la
certezza oscura che lui non era la cura di nulla, ma aveva imparato a fingere
di non vederla. Dopo lui le aveva chiesto se poteva vederle il seno. Non si
era mai sentita così spoglia, come mentre si sfilava la maglietta di cotone del
pigiama tra le lenzuola sfatte, ma l’adrenalina le uccideva la rabbia, attutiva
il vuoto.
Quella sera le aveva chiesto un’altra foto, davanti allo specchio. Si era
alzata dal letto senza nemmeno pensare, stringendosi una mano addossodavanti alla specchiera alta, nell’angolo della stanza.
Suo padre guardava la replica di una partita vecchia, le mani strette die-
tro la nuca, tra i capelli che iniziavano a farsi radi, leggeri. Guardava fisso
lo schermo al punto che i giocatori sembravano macchie bianche, che si 11
avvicinavano e si allontanavano in preda ad attrazioni, a repulsioni recipro-
che. Atomi nell’aria, ai fini della partita c’erano movimenti più sensati, ma
era tutto talmente soggettivo da risultare quasi casuale. Chiara le tornava
in mente con un bruciore alla bocca dello stomaco, un vuoto in mezzo alla
gola. Lei era stata l’atomo più imprevisto, non il più imprevedibile. Ogni
notte le galleggiavano in testa segnali che non aveva considerato, sintomi a
cui non aveva dato peso, costruiva le geometrie di un presente che poteva
essere diverso, una malattia che si poteva prendere per tempo. Se avesse
ascoltato quando lei si arrabbiava, se avesse guardato come le si piegava la
bocca quando ammetteva di lavorare nel negozio dei genitori, nell’odore
fitto delle scatole di scarpe. E certe volte non riusciva a trattenere quella
smania di raccontare che aveva dovuto lasciare l’università a pochi esami,
che era brava, solo che era incinta. E ci aveva provato, i primi mesi vomita-
va con la testa appoggiata contro le mattonelle bianche dei bagni dell’uni-
versità, fredde contro la fronte. Ma poi aveva perso contro gli affitti, contro
i genitori, contro le debolezze del suo corpo. E quando era nata, aveva
amato sua figlia, davvero, un dito sotto il suo naso ogni notte, nella culla,
per l’ansia di sentirla respirare.
Lui però la vedeva disfarsi sempre di più con la testa sulla spesa, sui con-
ti delle bollette, vedeva con che insofferenza guardava il pollo bruciare nel
forno, quando se l’era dimenticato, riempiendo la cucina di un odore acre.
Che voglia di urlare le veniva quando la madre le chiedeva della bambina,
le faceva notare che dal piano di sotto la sentiva tossire, una notte che aveva
la febbre. Alla fine l’aveva guardata con la testa piena di contrasti mentreapriva il pacco di Amazon con i libri dell’università, mentre se li mangiava
una notte dopo l’altra, nel letto. Lui le stringeva una coscia nel palmo e si
abituava a dormire con la luce ancora accesa, a chiudere a chiave la porta
12 del bagno.
Quando lui aveva trovato le mail che si era scambiata con un’azienda in-
glese avevano deciso pacati, freddi, che era finita lì, e lei era partita, lascian-
dosi dietro scatoloni di cartone chiusi in un ripostiglio che tutti evitavano
di guardare. Il pensiero di rivederla gli metteva una strana elettricità sotto
pelle, un nervosismo doloroso, pieno di rancore. I puntini bianchi sullo
schermo continuavano a inseguirsi in traiettorie disfatte. Per la figlia, ovvio.
Era arrabbiato per la figlia. Parlava poco, aveva fatto due occhi piccoli di
rabbia. Pensandoci si era alzato dal divano, con un fastidio che gli si ripie-
gava dietro la schiena, giù fino alla gamba. Buttava avanti un passo lento
dopo l’altro verso la camera della ragazza, una luce tenue che riverberava
sotto la porta. L’aveva aperta con un peso dentro le mani, forse consapevo-
le. Poi aveva visto la ragazza davanti alla specchiera, il cellulare, i vestiti che
non aveva, e aveva sbattuto la porta di nuovo, veloce.
Le era caduto un peso dentro, un tuono addosso, mentre suo padre spa-
riva in uno schianto dietro la porta chiusa, era rimasta a guardare il legno
pieno di righe, una paralisi che le soffocava le braccia. Alla fine si era richiu-
sa sotto le coperte, in una felpa grande. Non aveva più osato rispondere al
cellulare, lo schermo si affollava di messaggi, di lettere senza un senso. L’a-
veva lasciato sotto il letto, uno scorpione, per le sue dita morbide. Sentiva
i passi di suo padre fuori dalla porta, li seguiva con le orecchie affilate, lui
che camminava nel corridoio, nel bagno, i cigolii delle porte e il risucchio
dello sciacquone. Al chiudersi della sua camera da letto era riuscita a strin-
gere gli occhi.
Si era invischiata nelle reti di un sonno agitato. Era dentro uno dei suoiprimi ricordi da bambina, al mare. Sentiva i rimbalzi della risacca oltre le
file aranciate degli ombrelloni, i discorsi della gente dietro agli occhiali da
sole. Passava un dito sopra la tovaglia azzurra e ruvida del bar, i piedi scalzi,
il sedere rigato dalla sedia di plastica. Sua madre parlava alle signore ame- 13
ricane con dei vagiti in una lingua sconosciuta. La facevano ridere, anche
loro ridevano, ma con una risata troppo grassa, la pelle scottata. Una aveva
i denti storti. E sua madre continuava a farle ridere, tre come cerbero, con
quei germi di parole, finché non le piantava gli occhi nella fronte, e aveva
sempre la bocca impastata di quella lingua oscena. E lei parlava e parlava,
finché alla figlia non bruciavano le guance nello sforzo di continuare a sor-
ridere, come le americane. Si era svegliata con gli occhi fissi, le bruciavano.
Le era passato per la mente di allungare una mano sotto il letto per prende-
re il cellulare, per vedere l’ora, ma le era mancato il coraggio. Lo schermo
si accendeva se le arrivava una notifica, illuminava il pavimento, la polvere,
il mostro sotto il letto. Lei restava con gli occhi attaccati al soffitto nero, le
mani strette sui nodi che si sentiva in fondo alla pancia.
Le mattine d’estate suo padre usciva presto, lei si era abituata ai risvegli
lenti, ad aprire le finestre sul mattino già tiepido, ad ascoltare i propri passi
sul pavimento. Quella mattina aveva aperto gli occhi con una strettoia nel
petto, che per qualche minuto non aveva saputo riconoscere, poi le era pre-
cipitata di nuovo addosso la consapevolezza piena di vergogna. Si stringeva
nelle lenzuola, nel buio soffocante, tra le persiane si indovinava la luce della
mattina, ci mescolava insieme i pensieri nel dormiveglia. La delusione dei
genitori, la rabbia, tutte quelle rabbie che si incollavano l’una sull’altra.
Quella volta in cui aveva rotto il televisore grande, da bambina, con
una palla. Lo schermo aveva ondeggiato un momento prima di ribaltarsi
in avanti, uno schianto sul pavimento pieno di briciole di vetro. Quando
sua madre l’aveva sollevato, il davanti era un intrecciarsi di cavi, di schedeluccicanti. Sua madre le urlava sulla testa, lei guardava i pezzi di vetro sul
parquet, la palla che era rotolata distante. Aveva urlato anche la sera a cena,
mentre lei fissava la purea di patate gialla che poi non aveva toccato, poi in
14 macchina il giorno dopo, ancora, aveva urlato, e i suoi occhi erano rimasti
attaccati all’oscillare tenue di un Arbre Magique. Aveva quegli urli addosso
come un vestito, come una condanna.
Il telefono aveva iniziato a vibrare sotto il letto, l’aveva raccolto con un
dolore tra le coste, le dita rigide di sonno. Era sua madre. Da qualche parte
nella sua testa, in fondo, si diceva di meritarselo, mentre rispondeva veloce,
le orecchie già cariche di quegli urli, di quella rabbia che le cadeva in testa,
un diluvio.
«Nanà? Ho parlato con papà… Come stai?»
Invece era piena di incertezza, di riserbo. Aveva una leggerezza che non
aveva mai conosciuto, la appoggiava in ogni parola come una carezza, un
regalo. Aveva ripreso a respirare, respirava e basta.
«Non lo so.»
«Ne vuoi parlare?»
I pensieri le andavano alla deriva contro il palato, contro le labbra chiuse.
«Ascolta, stai tranquilla. Si risolve tutto, okay? Qualsiasi cosa sia, io tra
poco torno e risolviamo tutto insieme va bene?»
La madre le aveva ascoltato tutti i singhiozzi, tutte le giustificazioni, per-
ché non aveva voglia di parlarne ancora, che l’avrebbe fatto poi. Riusciva
ad ascoltarla da lì, da così lontano, riusciva a vederla. Lo stesso pensiero le
attraversò entrambe come un lampo, che forse da lì la vedeva anche più ni-
tida, con una lucidità diversa. Riattaccare le aveva lasciato un sapore strano
in gola, una smania addosso di prenotare quel volo in fretta, con la certezza
piccola, definitiva, che sua figlia sarebbe stata felice di vederla per qualche
giorno.E mentre piegava delle magliette sottili dentro il trolley si arrendeva alla consapevolezza atroce che ogni persona è un pianeta altro, per quanto forte ti stringa, e si muove con un’ellissi che non sempre è possibile calcolare, prevedere. Aveva imparato con una fitta tremenda che la vicinanza non era 15 sempre la soluzione più gentile, che non tutto l’amore si sapeva esprimere negli stessi gesti, e che certe volte i legami di sangue non erano i legami più sinceri. E forse era razionale ipotizzare di poterle voler bene così, da lontano, lontano abbastanza per non farsi male, per non accavallarsi, per lasciarsi respirare. In un intrico di logiche soggettive, potevano costruirsi un equilibrio che tenesse, certe che a volte anche sugli abissi più profondi, si potevano costruire delle pause, dei ponti. Certe che a volte, anche quegli abissi potevano non contare niente.
Puoi anche leggere