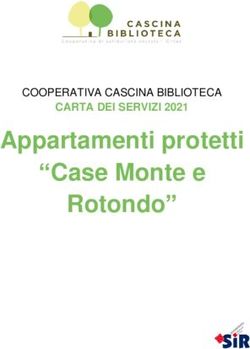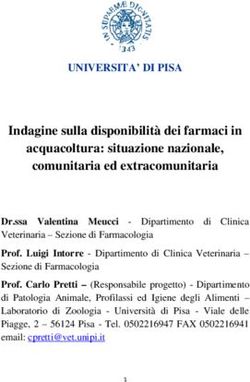CONTENUTI GENERALI Workshop Piombino 4 marzo 2017 - Associazione Piscicoltori Italiani
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Workshop Piombino 4 marzo 2017
CONTENUTI GENERALI
PREMESSA
L’acquacoltura toscana è stata il polo produttivo italiano più importante tra gli anni ottanta e novanta e
riveste ancora oggi un posto di primo piano nella produzione di specie pregiate marine per qualità e
quantità (oltre il 20% della produzione nazionale). Da segnalare che sono nati negli ultimi anni impianti
di lavorazione e trasformazione del prodotto ittico, anche consortili, che conferiscono valore aggiunto e
diversificano il prodotto.
Le aziende toscane stanno sviluppando al loro interno settori volti alla trasformazione e
commercializzazione del prodotto ed entrano sul mercato anche con prodotti lavorati di pregio. La
Regione sostiene questi interventi sia con risorse comunitarie che regionali, e ha inoltre sviluppato una
normativa specifica rivolta allo sviluppo di azioni di ricerca ed innovazione nel settore.
Nell'ambito della valorizzazione dei prodotti agroalimentari, in Toscana sono stati riconosciuti numerosi
prodotti tradizionali ittici, che interessano in prevalenza le produzioni e le particolari lavorazioni delle
zone di Orbetello e della Garfagnana. Inoltre, sono annoverati tra i presidi Slow Food la Palamita di mare
di Toscana e la Bottarga di Orbetello.
Di pari passo con gli alti valori di produzione, l’acquacoltura toscana si è da sempre indirizzata verso una
strategia basata sulla qualità e sulla sostenibilità ambientale, come sostegno in un contesto difficile del
mercato nazionale e internazionale, che ha visto, a partire dagli anni novanta, la crescente concorrenza
da parte dei prodotti esteri. L’utilizzo delle migliori materie prime nel rispetto della sostenibilità
ambientale e i disciplinari interni volontari che molte aziende toscane del settore adottano
rappresentano alcuni aspetti a garanzia di un prodotto di qualità apprezzato e stimato non solo in Italia,
come da tradizione per il “Made in Tuscany”. La scelta volontaria di analisi periodiche dei parametri
chimico-fisici delle acque, analisi nutrizionali, chimiche e microbiologiche sul prodotto finito prima della
sua commercializzazione assicura il consumatore sugli aspetti qualitativi, organolettici e di sicurezza
alimentare del prodotto acquistato.
Codice CUP J82F16000360007 Progetto finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
1CONTESTO DI RIFERIMENTO
Profilo costiero della Regione Toscana
II litorale della Toscana si estende per 578 km, suddivisi in 329 km di coste continentali e 249 km di coste
insulari. Da un punto di vista geologico la costa toscana è caratterizzata dalla presenza di cordoni dunali,
anche se in gran parte alterati, da vaste pinete litoranee, da lagune, zone umide e laghi costieri, da
falesie e da basse spiagge erose e
modellate in prossimità della foce
dei fiumi.
Nell'ottocento, lungo le coste della
Toscana, fino alla foce dell'Arno,
erano ancora presenti aree
acquitrinose, mentre a sud di
Livorno, in particolar modo nelle
valli del Cecina e del Cornia e nella
Maremma grossetana, erano già
iniziate le opere di bonifica che
sono proseguite fino al XX secolo.Il
litorale toscano è diviso in quattro
compartimenti marittimi: Marina
di Carrara, Livorno, Viareggio e
Portoferraio.
I sistemi di pesca impiegati sulla
costa toscana sono principalmente:
lo strascico, la circuizione, la
piccola pesca e l’utilizzo di
polivalenti passivi. Non ci si avvale
di altri metodi adottati in altre
zone del litorale italiano, come: il
volante, la draga idraulica, il
palangaro.
La flotta toscana ha una capacità media superiore al livello italiano nei metodi della circuizione, in
termini medi di stazza lorda (GT) dei battelli e equipaggio, e della piccola pesca, per valori medi di stazza
lorda e potenza dei motori.
La flotta toscana, inoltre, è impegnata principalmente nella piccola pesca con il 75% dei battelli e il 55%
dei marittimi sul totale; si tratta tuttavia di imbarcazioni caratterizzate da piccola capacità in termini di
stazza e potenza del motore. Nella pesca per strascico è impegnato solo il 20% della flotta, ma i battelli
ad essa dedicati costituiscono il 61% del volume totale e il 47% della potenza del motore. (Mipaaf-Irepa)
Codice CUP J82F16000360007 Progetto finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
2VALORIZZAZIONE DELLE TRADIZIONI ALIMENTARI LOCALI E DEI PRODOTTI TIPICI
La nostra attività progettuale prevede di attuare una politica educativo-informativa-alimentare
finalizzata a sensibilizzare un target mirato allo scopo di:
• Informare gli operatori del settore della pesca e dell’acquacoltura circa le misure atte a garantire le
migliori condizioni di gestione delle attività di produzione e di commercializzazione per i loro prodotti,
valorizzandone le tradizioni e promuovendone la tipicità attraverso la creazione di Organizzazione di
Produttori o altre forme di associazionismo e opportunità commerciali;
• Informare i pescatori ed acquacoltori sulle moderne esigenze del settore ittico al fine di aumentarne la
competenza, la competitività nel rispetto dell’ambiente, del benessere del pesce e della sicurezza
alimentare;
• Promuovere il settore ed i suoi prodotti attraverso azioni di comunicazione mirate a rafforzare una
visione positiva nel ruolo dei produttori nella gestione, responsabile delle risorse e sui mercati,
promuovendo le tradizioni alimentari locali come punto di forza nella commercializzazione ed
immissione sul mercato di prodotti ad alto valore aggiunto (qualità e tipicità).
In tal modo non solo si promuove il settore ittico e i suoi prodotti ma si valorizzano le tradizioni
alimentari locali e di conseguenza i prodotti tipici del territorio. Questa idea progettuale mira ad attuare
una campagna informativa e di valorizzazione dei prodotti di pesca, sottolineando i valori culturali, la
tutela dell’origine e della salvaguardia del prodotto proposto. I temi affrontanti nella presente proposta
e gli obiettivi che si vogliono raggiungere hanno l’intento di promuovere il settore ittico nell’area di
riferimento, attraverso misure che conducano gli operatori di settore e in particolare la possibilità di
creare nuove OP e la creazione di possibili marchi collettivi.
Un’azione volta a tutelare e valorizzare le tradizioni locali, unitamente a interventi strutturali sulla flotta
da pesca e sull’organizzazione del ciclo produttivo-commerciale, può costituire un aiuto fondamentale
per difendere l'occupazione e il reddito dei pescatori ed evitare così lo spopolamento dei borghi
marinari.
Codice CUP J82F16000360007 Progetto finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
3LE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI DELLA PESCA E DELL’ACQUACOLTURA:
COSA SONO E LORO EVOLUZIONE (A PARTIRE DAI RELATIVI REGOLAMENTI COMUNITARI)
Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999 relativo all'organizzazione comune
dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura
L'organizzazione comune dei mercati (OCM) dei prodotti della pesca è stata creata nel 1970. Essa ha
rappresentato il primo capitolo della politica comune della pesca (PCP).
NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE
I prodotti della pesca possono essere messi in vendita o commercializzati soltanto se conformi alle
norme di commercializzazione, che si riferiscono alla classificazione in categorie di qualità, di dimensioni
o di peso, nonché all'imballaggio, alla presentazione e all'etichettatura. Gli Stati membri controllano la
conformità dei prodotti alle norme di commercializzazione.
INFORMAZIONE DI CONSUMATORI
I prodotti vivi, freschi o refrigerati possono essere proposti per la vendita al consumatore finale soltanto
se recano un'indicazione o un'etichetta adeguata che precisi:
• La denominazione commerciale della specie;
• IL metodo di produzione (cattura in acqua dolce, in mare o allevamento);
• La zona di cattura.
CREAZIONE E RICONOSCIMENTO DELLE OP
Le organizzazioni di produttori (OP) sono costituite per iniziativa di un gruppo di pescatori o acquacoltori
che si associano liberamente per attuare misure in grado di assicurare migliori condizioni di vendita dei
propri prodotti e volte a:
• Incoraggiare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, in
particolare attuando piani di cattura;
• Promuovere la concentrazione dell'offerta;
• Stabilizzare i prezzi;
• Promuovere i metodi di pesca che favoriscono lo sfruttamento sostenibile.
Gli Stati membri riconoscono quali OP le associazioni di produttori che ne facciano domanda, a
condizione che soddisfino determinati requisiti.
Le organizzazioni di produttori (OP) sono costituite da pescatori o acquacoltori che si associano
liberamente per adottare misure atte a garantire le migliori condizioni di commercializzazione per i loro
prodotti. Le OP costituiscono un elemento fondamentale dell'organizzazione del mercato dei prodotti
ittici perché è proprio attraverso le OP che l'industria cerca di organizzare e di stabilizzare il mercato.
Codice CUP J82F16000360007 Progetto finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
4COME LE OP CONTRIBUISCONO AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELL’OCM
Il vantaggio principale di queste organizzazioni è di consentire agli stessi produttori di adeguare la
produzione alla domanda del mercato. La Comunità ha incoraggiato la loro creazione sin dagli esordi
della politica comune della pesca nel 1970. Le OP devono soddisfare una serie di requisiti per essere
riconosciute dai rispettivi Stati membri, segnatamente:
• Devono rappresentare una proporzione minima dell'attività economica nella zona che intendono
coprire;
• Non devono operare alcuna discriminazione sulla base della nazionalità o dell'ubicazione geografica
dei potenziali aderenti;
• Devono soddisfare le condizioni legali richieste dallo Stato membro interessato.
Per essere rappresentativa, l'organizzazione deve contare tra i propri affiliati una percentuale minima
dei pescherecci che operano nella zona o garantire che una quantità minima della produzione dei propri
aderenti venga venduta nella medesima zona
A causa del carattere imprevedibile della pesca, è inevitabile che vi sia un certo squilibrio tra l'offerta e
la domanda. La Comunità ha messo a punto dei meccanismi per ridurre gli effetti più deleteri di tali
fluttuazioni. Per alcune delle specie che rivestono importanza per l'industria comunitaria della pesca, il
Consiglio dei ministri ha stabilito prezzi di orientamento, che possono essere presi come riferimento
dalla Commissione per la fissazione dei prezzi di ritiro. Le OP possono applicare questi prezzi ritirando
dal mercato i prodotti ittici per assicurare un reddito minimo ai pescatori quando i prezzi di mercato
calano. A seconda del tipo di prodotto, i membri ricevono un'indennità dalle rispettive OP, che a loro
volta si rivalgono sulla Comunità.
Per poter beneficiare della compensazione finanziaria, i prodotti ritirati devono essere conformi ai criteri
qualitativi legali. I ritiri devono inoltre essere limitati ad eccedenze di produzione occasionali. Il livello
della compensazione è inversamente proporzionale ai quantitativi di pesce ritirato: quanto maggiore è il
volume ritirato dal mercato, tanto più basso è il compenso erogato.
I prodotti ritirati dal mercato non sono automaticamente distrutti. Le OP possono prendere misure
diverse per evitare che il pesce venga sprecato: possono ad esempio venderlo per produrre mangimi o
immagazzinarlo per reimmetterlo sul mercato non appena si verificherà una ripresa della domanda.
Tra queste misure rientrano le operazioni di riporto, che prevedono la trasformazione e
l'immagazzinamento di alcune specie a determinate condizioni. È stato istituito anche un regime di aiuto
per compensare i pescatori di tonno in caso di crollo del mercato; in virtù di tale regime, i pescatori non
beneficiano dell'acquisto all'intervento, ma sono compensati per la perdita di reddito qualora i prezzi di
mercato scendano al di sotto di un certo livello.
Come già osservato, i membri delle OP devono rispettare una serie di norme. I membri devono vendere i
loro prodotti esclusivamente tramite l'organizzazione, concentrando così l'offerta.
Poiché gli operatori non aderenti potrebbero danneggiare il mercato astenendosi dall'adeguare gli
sbarchi alla domanda, le OP possono chiedere che l'applicazione del loro regime venga estesa a tutti i
pescatori. Anche i non affiliati possono pertanto essere tenuti a rispettare, in una zona e in un periodo
determinati, le medesime restrizioni cui sono soggetti i membri delle OP.
Codice CUP J82F16000360007 Progetto finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
5I PIANI DI PRODUZIONE
La riforma dell'OCM adottata nel 1999 (Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre
1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e
dell'acquacoltura) ha rafforzato il ruolo delle organizzazioni di produttori. Dal momento che le OP si
trovano in una posizione strategica fra la produzione e il mercato, esse possono attuare misure per una
gestione razionale delle risorse, aggiungere valore ai prodotti ittici e contribuire alla stabilità del
mercato. Conferire maggiore responsabilità alle OP ai fini dell'autoregolamentazione nella gestione delle
risorse disponibili contribuisce a garantire un migliore soddisfacimento dei requisiti del mercato e una
minore pressione sugli stock.
L'obiettivo è evitare la cattura di pesci per i quali la domanda sia scarsa o addirittura inesistente,
incoraggiando la pianificazione delle attività di pesca.
Per conservare gli stock ittici e rimanere competitivi, i produttori devono anticipare le esigenze del
mercato in termini non solo di quantità, ma anche di regolarità dell'offerta. In base al regolamento, le
OP devono elaborare e attuare ogni anno programmi operativi che indichino le misure per adeguare le
catture alle esigenze del mercato. Ciò riguarda non solo il pesce catturato in mare, ma anche i prodotti
dell'acquacoltura.
In accordo con i propri membri, le OP possono distribuire le attività di pesca dei loro pescherecci nel
tempo. Ciò evita la corsa ai contingenti e consente ai produttori di distribuire gli sbarchi nel corso
dell'anno, evitando drastiche riduzioni dei prezzi e garantendo al mercato un'offerta più stabile. Un
maggior numero di sbarchi regolari di qualità andrà a beneficio dei produttori in termini di prezzi, dei
commercianti in termini di offerta e dei consumatori in termini di valore monetario.
Una maggiore adesione dei pescatori nelle organizzazioni di produttori e una più stretta cooperazione
fra queste e altri operatori presenti sul mercato dovrebbero rendere più efficace la gestione del mercato
dei prodotti della pesca a vantaggio di tutti gli interessati.
PIANI DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’
Questo meccanismo è finalizzato ad incoraggiare le organizzazioni di produttori a migliorare la qualità
dei loro prodotti. Gli Stati membri possono accordare un riconoscimento specifico a quelle
organizzazioni che presentano un piano in questo senso. Le organizzazioni di produttori che
intraprendono iniziative per migliorare la qualità dei loro prodotti possono chiedere alle rispettive
autorità nazionali il riconoscimento specifico trasmettendo le informazioni seguenti:
• Elenco dei prodotti oggetto del piano per il miglioramento della qualità;
• Sintesi degli studi preliminari realizzati per valutare le carenze del sistema esistente insieme ai
miglioramenti proposti;
• Spiegazione del modo in cui il piano favorirebbe un sostanziale miglioramento della qualità dei
prodotti della pesca e dell'acquacoltura nella catena di produzione;
• Descrizione delle misure da applicare in ciascuna fase;
• Sistema permanente di valutazione e controllo;
• Previsioni di bilancio.
Codice CUP J82F16000360007 Progetto finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
6Esempi di metodi utilizzati per migliorare la qualità nell'Unione comprendono periodi più brevi in mare,
minori quantità di casse per pesci, miglior uso di imballaggi con ghiaccio e minore movimentazione nella
catena di produzione.
ORGANIZZAZIONI INTERPROFESSIONALI
Tradizionalmente, le divisioni fra le diverse attività del settore della pesca hanno indebolito il comparto.
Ma gli atteggiamenti iniziano a cambiare. Come per altre aree, l'industria dovrebbe essere in grado di
creare organizzazioni interprofessionali al fine di promuovere progetti di partenariato di reciproco
interesse. A tal fine, è prevista una deroga alle regole comunitarie in materia di concorrenza. Pertanto,
nel rispetto di talune condizioni, sono consentiti gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate di
organizzazioni interprofessionali riconosciute nel settore della pesca.
Ad esempio, i rappresentanti delle attività di cattura, commercio e trasformazione di regioni diverse
possono cooperare ai fini dell'attuazione di misure che vadano a vantaggio dell'intero comparto. Tali
misure potrebbero essere finalizzate a:
• Migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato;
• Contribuire ad un più adeguato coordinamento dell'immissione sul mercato dei prodotti della pesca, in
particolare attraverso ricerche o studi di mercato;
• Elaborare contratti tipo compatibili con la normativa comunitaria;
• Promuovere la valorizzazione dei prodotti della pesca;
• Diffondere le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per adeguare la produzione, in particolare
in termini di qualità e sostenibilità ambientale, con più attenzione alle esigenze del mercato e ai gusti e
alle aspirazioni dei consumatori;
• Introdurre metodi e strumenti allo scopo di migliorare la qualità dei prodotti;
• Valorizzare e tutelare le etichette di qualità e le indicazioni geografiche;
• Promuovere metodi di produzione più rispettosi dell'ambiente;
• Definire, per quanto riguarda la cattura e la commercializzazione dei prodotti della pesca, regole più
restrittive delle normative comunitarie o nazionali.
Il Reg. (UE) n. 1379/2013 – Organizzazione comune dei mercati (OCM) comprende:
a) Le organizzazioni professionali;
b) Le norme di commercializzazione;
c) Le informazioni del consumatore;
d) Le norme di concorrenza;
e) Le informazioni sul mercato.
Codice CUP J82F16000360007 Progetto finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
7PIANI DI PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE
Nello specifico dell’articolato previsto dalla nuova disciplina comunitaria, occorre soffermarsi sull’art. 7,
relativo agli obiettivi che le OP devono perseguire:
f) Promuovere l'esercizio di attività di pesca redditizie e sostenibili da parte dei propri aderenti in
piena conformità della politica di conservazione prevista, in particolare, dal regolamento (UE) n.
1380/2013 e del diritto ambientale, rispettando nel contempo la politica sociale e, ove lo Stato
membro interessato lo preveda, la partecipazione alla gestione delle risorse biologiche marine;
g) Evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture indesiderate di stock commerciali e, ove
necessario, farne il miglior uso possibile senza creare un mercato per tali catture che sono al di
sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione, in conformità dell'articolo 15 del
regolamento (UE) n. 1380/2013;
h) Contribuire alla tracciabilità dei prodotti della pesca e all'accesso dei consumatori ad
un'informazione chiara e completa;
i) Contribuire all'eliminazione della pratica di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.
j) Migliorare le condizioni di immissione sul mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dei
propri aderenti;
k) Migliorare il rendimento economico;
l) Stabilizzare i mercati;
m) Contribuire all'approvvigionamento alimentare e promuovere elevati parametri di qualità e
sicurezza alimentare, favorendo nel contempo l'occupazione nelle zone costiere e rurali;
n) Ridurre l'impatto ambientale della pesca, anche mediante misure volte a migliorare la selettività
degli attrezzi da pesca.
Le OP per perseguire gli obiettivi indicati, si avvalgono di “misure”, peraltro indicate nell’art. 8 dello
stesso Regolamento, quali:
• Adeguare la produzione alle esigenze di mercato;
• Canalizzare l'offerta e la commercializzazione dei prodotti dei loro aderenti;
• Promuovere i prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione dei loro aderenti in modo non
discriminatorio servendosi, ad esempio, della certificazione dei prodotti, e, in particolare, di
denominazioni di origine, marchi di qualità, denominazioni geografiche, specialità tradizionali
garantite e meriti dei prodotti in termini di sostenibilità;
• Verificare che le attività dei loro aderenti siano conformi alle norme stabilite dall'OP interessata
e adottare misure per garantire tale conformità;
• Promuovere programmi di formazione professionale e di cooperazione al fine di incoraggiare i
giovani ad entrare nel settore;
• Ridurre l'impatto ambientale della pesca, anche mediante misure volte a migliorare la selettività
degli attrezzi da pesca;
• Promuovere l'uso della tecnologia dell'informazione e della comunicazione per migliorare la
commercializzazione ed i prezzi;
• Agevolare l'accesso dei consumatori all'informazione sui prodotti della pesca e
dell'acquacoltura.
Il calendario orientativo dell’offerta dei prodotti e l’analisi di mercato, affrontata sistematicamente dal
Consiglio di amministrazione e dai responsabili di marketing delle OP consentono – con un certo
Codice CUP J82F16000360007 Progetto finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
8margine di approssimazione – di adeguare le quantità complessivamente pescate dai soci
dell’Organizzazione a quelle che sono le esigenze del mercato di riferimento (mercato ittico alla
produzione e altri soggetti acquirenti esterni al mercato medesimo).
L’obbligo di conferimento del prodotto pescato/allevato da parte dei soci consente di canalizzare
l’offerta verso acquirenti certi della filiera. Non sono ammesse eccezioni all’obbligo previsto, e – nei casi
ammessi – la vendita del prodotto deve essere preventivamente approvata dal C.d.A., e comunque nel
rispetto delle norme comuni di produzione e commercializzazione, adottate dalle OP e previste nei
diversi Regolamenti interni.
Rimanendo un obiettivo di fondamentale importanza la promozione del prodotto con la certificazione di
origine e/o qualità, le OP possono avvalersi degli strumenti messi a disposizione dalla stessa Unione
Europea e dello Stato nazionale, per prevedere iniziative volte a qualificare la produzione
dell’Organizzazione.
Tali requisiti rendono inoltre sistematico il controllo da parte delle OP sull’attività svolta dai soci, in
relazione ai sistemi di pesca utilizzati, ai programmi di cattura e/o di prelievo delle specie, alla qualità dei
prodotti sbarcati, e più in generale al rispetto delle norme comuni adottate dall’Organizzazione.
FONTI:
• Ministero Politche Agricole e Forestali (Organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca e
dell’acquacoltura) - (c) Lionel Flageul
• FederOp e ITALIANA PRODUTTORI ITTICI Associazione Nazionale di Organizzazioni di Produttori del
Settore Ittico (PROGRAMMA NAZIONALE TRIENNALE DELLA PESCA E DELL’ACQUACOLTURA 2013 -
2015 IL RICONOSCIMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI)
• FederOp (Statuto Dell’ Organizzazione di Produttori in base alla nuova PCP e OCM)
PER MAGGIORI INFORMAZIONI: http://www.federop.it/
Codice CUP J82F16000360007 Progetto finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
9ALCUNI ESEMPI DI MARCHI COLLETTIVI RIFERITI AI PRODOTTI ITTICI
Il marchio collettivo "Agricoltura Ambiente Qualità (A.Qu.A.) - Marchio di qualità concesso dalla Regione
Friuli Venezia Giulia".
Il marchio A.Qu.A. è stato istituito dalla Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia con la Legge Regionale n.
21/2002. Si tratta di un marchio di certificazione
volontaria, che rappresenta per le aziende un importante
strumento di comunicazione e di promozione dei propri
prodotti, garantendone la qualità e assicurandone la
visibilità nei confronti dei consumatori.
La Legge regionale n. 21/2002 ha indicato, quale ente
gestore del marchio, l’Agenzia regionale per lo sviluppo
rurale (ERSA) che è quindi competente ad individuare i tipi
di prodotto da ammettere al marchio e ad approvare i relativi disciplinari di produzione, nei quali sono
previsti i metodi di ottenimento del prodotto.
Perché un prodotto possa ottenere il marchio AQUA, infatti, è necessario che ci sia un disciplinare,
approvato, che normi i requisiti del prodotto finale, stabilisca le tecniche da utilizzare nelle diverse fasi
di produzione, e descriva i criteri di identificazione e tracciabilità del prodotto. Il soggetto economico
interessato ad utilizzare il marchio sui propri prodotti dovrà, quindi, rispettare, nel processo di
produzione, le indicazioni descritte nel relativo disciplinare, rivolgersi poi ad un organismo di
certificazione indipendente, a cui richiederà una certificazione che attesti la conformità del suo prodotto
alle norme descritte nel
relativo disciplinare tecnico. Una volta ottenuto il certificato di conformità, il produttore presenterà
domanda di concessione d’uso direttamente all’Ersa che, verificati i requisiti, concederà l’uso del
marchio.
Inoltre, l’ERSA ha adottato il Regolamento d’uso del marchio collettivo, che dispone – ai sensi delle
norme sui marchi collettivi – le norme generali sulla concessione e l’uso del marchio.
Tra i prodotti ittici che rientrano nel marchio AQUA troviamo Cozze, Vongole Veraci, Trota iridea e
Salmerino.
Codice CUP J82F16000360007 Progetto finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
10“Cozza di Scardovari”
Il marchio “Cozza di Scardovari” e “Denominazione
d’origine protetta” o “DOP” è stato riconosciuto dal
MIPAAF nel 2013 e il detentore del marchio è Il
Consorzio Cooperative Pescatori del Polesine nonché
l'Organizzazione di Produttori Soc. Coop. A.r.l..
La Cozza di Scardovari DOP è commercializzata viva o
trasformata (surgelata con o senza guscio).
I contenitori, sacchetti chiusi a rete o confezioni di
plastica o altro materiale idoneo, vengono sigillati in
maniera tale che l’apertura della confezione comporti la
rottura del sigillo o della confezione stessa. In etichetta sono indicate le diciture “Cozza di Scardovari” e
“Denominazione d’origine protetta” o “DOP”. Deve inoltre essere riprodotto il simbolo grafico
comunitario della DOP e il logo della DOP “Cozza di Scardovari”.
La “Cozza di Scardovari”, appartenente alla specie Mytilus galloprovincialis, allevata nella zona di
produzione della Sacca di Scardovari nei territori delle frazioni di Scardovari, Ca’ Mello e Santa Giulia nel
comune di Porto Tolle, in provincia di Rovigo. Il termine “sacca” individua l’insenatura marina formatasi
per naturale sbarramento parziale di un braccio di mare, che rimane in comunicazione con il mare
aperto attraverso due “bocche lagunari”. La Sacca di Scardovari è situata fra i rami del Po di Tolle a nord-
est e del Po di Gnocca a sud-ovest, nell’area meridionale del Delta del Po, la zona umida più vasta d’Italia
la cui peculiarità e valore ambientale sono stati riconosciuti a livello internazionale (convenzione di
Ramsar, Iran, 1971). Occupa una superficie di circa 3.000 ha con una profondità massima di 3 m.
La prima Cooperativa di pescatori locali della Sacca di Scardovari è del 1936. La trasformazione del
territorio nel secolo scorso è stata molto rapida, sia grazie alla mano dell’uomo, sia per effetto di fattori
naturali tanto che la configurazione attuale della Sacca di Scardovari si raggiunge dopo l’alluvione del
1966. È a partire da questo momento, che venne iniziata la sperimentazione dell’allevamento di mitili in
piccoli vivai all’interno della Sacca, come alternativa alla pesca in mare.
Le caratteristiche qualitative, fisiche e organolettiche della Cozza di Scardovari sono il risultato delle
peculiarità ambientali della Sacca da cui prendono il nome. Si caratterizza per un basso tenore di sodio
nelle carni, inferiore a quello presente nei bivalvi allevati in mare aperto, che determina la dolcezza delle
carni e la particolare gradevolezza e delicatezza del prodotto al palato.
Codice CUP J82F16000360007 Progetto finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 11Acciughe sotto sale del Mar Ligure
Le Camere di Commercio Liguri, coordinate da Unioncamere Liguria, sono state designate (D.M.
Politiche agricole alimentari e forestali dell'11 maggio 2010) quali autorità pubbliche a
effettuare le funzioni di controllo sulla Indicazione Geografica Protetta (IGP) Acciughe sotto sale
del Mar Ligure, registrata in ambito Unione Europea con Regolamento CE n. 776 del 4 agosto
2008.
Con medesimo decreto è stato approvato il Piano di controllo Acciughe sotto sale del Mar
Ligure IGP, appositamente predisposto dal sistema camerale ligure secondo il disciplinare di
produzione approvato, per avviare e svolgere le attività di controllo per la certificazione del
prodotto.
I soggetti coinvolti nella filiera Acciughe sotto sale del Mar Ligure IGP sono:
• Pescatori;
• Commercianti all'ingrosso;
• Trasformatori;
• Confezionatori.
Ciascuno di questi operatori, può aderire al sistema di certificazione presentando alla Camera di
Commercio di competenza la richiesta di adesione, a regime entro il 1° marzo dell'anno a
decorrere del quale intende commercializzare il prodotto.
La tracciabilità delle Acciughe sotto sale del Mar Ligure, definita dal piano di controllo
approvato in funzione della certificazione IGP, è garantita attraverso un costante monitoraggio
del prodotto a partire dal pescato, grazie a documenti di accompagnamento prodotto in cui è
specificata dal pescatore la zona di pesca del Mar Ligure, controllo che si protrae nella fase di
trasformazione e sino alla fase di confezionamento per la commercializzazione.
Il Piano di controllo ideato dal sistema camerale ligure, assicura il limite imposto dal disciplinare
di produzione, che richiede l'avvio della fase di lavorazione entro le 12 ore dalla pesca, inoltre le
fasi di trasformazione e salagione sono registrate in un documento in cui il trasformatore
riporta i dati riguardanti la trasformazione delle acciughe, specificando i riferimenti della
cattura e della fase di avvio della trasformazione, i quantitativi di acciughe atte all'IGP avviate
alla lavorazione e la loro modalità di stoccaggio nei barili atti alla maturazione. Tale registro
deve essere trasmesso entro le 24 ore dall'avvio di ogni operazione di trasformazione alla
Camera di Commercio di competenza.
Il costante controllo della filiera segue quindi il prodotto atto al confezionamento. Avviata la
fase di salagione, le acciughe salate definite "mature" - dopo un periodo minimo di stagionatura
pari ad almeno 40 giorni - per essere certificate IGP su richiesta del Confezionatore, sono
sottoposte a un campionamento da parte di un tecnico specializzato inviato dalla Camera di
Commercio che attua una verifica sul prodotto in conformità alle caratteristiche organolettiche
e chimico-fisiche previste dal disciplinare. Dopodiché, la Camera di Commercio, valutata la
conformità del lotto richiesto dall'operatore, rilascia l'autorizzazione al confezionamento.
Le Acciughe sotto sale del Mar Ligure ritenute conformi ai parametri IGP sono avviate al
confezionamento in funzione della commercializzazione, nei tipici contenitori detti arbanelle,
con una specifica etichetta, garanzia del prodotto IGP, autorizzata dalla Camera di Commercio
secondo le indicazioni previste dal disciplinare di produzione.
Codice CUP J82F16000360007 Progetto finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 12Trote del Trentino IGP
Riconoscimento del MIPAAF avvenuto nel 2012 per la Zona di
produzione riguardante l'intero territorio della Provincia di
Trento e nel comune di Bagolino in Provincia di Brescia.
L’IGP “Trote del Trentino” è attribuita ai pesci salmonidi
appartenenti alla specie trota iridea — Oncorhynchus mykiss
(Walb.), allevati nell’intero territorio della Provincia Autonoma
di Trento e nel comune di Bagolino in Provincia di Brescia. In
questa zona la pratica dell’allevamento in vasca delle trote è
molto antica e risale al XIX secolo.
All’atto dell’immissione al consumo, le trote devono presentare
un dorso verdastro con una fascia rosea su entrambi i fianchi;
ventre biancastro; macchiette scure sparse sul corpo e sulla
pinna dorsale e caudale. La IGP “Trote del Trentino” si distingue
dai prodotti appartenenti alla stessa categoria merceologica per
l’indice di corposità e il contenuto di grassi molto ridotti.
Le fasi di allevamento che comprendono gli stadi di avannotto, novellame, trota adulta e le operazioni di
macellazione devono avvenire all’interno della zona delimitata.
Le vasche di allevamento del novellame e del materiale adulto devono essere costruite completamente
in cemento, o terra e cemento, o con argini in cemento e fondo in terra, o in vetroresina, o acciaio, e
devono essere disposte in serie o in successione in modo da favorire al massimo la riossigenazione.
L’acqua utilizzata nell'allevamento deve provenire da acque sorgive, e/o pozzi e/o fiumi e torrenti
compresi nella zona di produzione delimitata.
In particolare, l'acqua in entrata nelle vasche esterne deve presentare le seguenti caratteristiche:
• La temperatura media nei mesi da novembre a marzo non deve superare i 10°C;
• L’ossigeno disciolto non deve essere inferiore a 7 mg/l.
• La densità di allevamento in vasca, in relazione al numero di ricambi giornalieri dell'acqua.
La razione alimentare deve seguire i requisiti consolidati dalla tradizione nel rispetto degli usi leali e
costanti. Proprio per questo i mangimi utilizzati devono essere privi di OGM e opportunamente
certificati secondo la normativa vigente.
Il prodotto è posto in vendita confezionato. L’identificazione del prodotto IGP dovrà essere possibile per
ogni singola/o confezione/imballo sulla quale dovrà comparire in caratteri chiari, indelebili nettamente
distinguibili da ogni altra scritta la dizione "Indicazione Geografica Protetta" o la sigla “I.G.P”.
Codice CUP J82F16000360007 Progetto finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 13La Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino (DOP)
Il marchio si riferisce al pesce allo stato fresco della specie Tinca
tinca nato, allevato e cresciuto negli stagni dell'Altopiano di Poirino
che era ed è ancora contraddistinto da un gran numero di piccole e
grandi peschiere ricavate spesso nelle vicinanze di abitazioni e
borgate.
Il prodotto si caratterizza rispetto alle altre tipologie di Tinca poiché non denota al gusto e
all'olfatto il sapore di «fango» o «erba» e le carni sono tenere. Questa peculiarità è
direttamente determinata dal tipo di gestione delle peschiere che si distinguono rispetto alle
altre perché in esse il fondo melmoso non riesce a formarsi con continuità e la massa d'acqua
presenta condizioni estremamente variabili per gran parte della stagione produttiva,
impedendo l'instaurarsi delle condizioni favorevoli alla proliferazione delle alghe.
Il collegamento tra i fenomeni geologici, che hanno contraddistinto la formazione dell'Altopiano
di Poirino, e la comparsa di specie ittiche permettono di considerare la Tinca tinca una specie
autoctona già diffusa o in via di diffusione a partire dal periodo Pleistocene medio- inferiore
appartenente all'era Neozoica. La presenza della Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino
conosciuta ed apprezzata per il suo valore alimentare ed economico è inoltre comprovata da
documenti risalenti al XIII secolo che attestano come tra le tante tasse che affliggevano la
popolazione rurale di Ceresole d'Alba una imponesse la consegna di quantitativi variabili di
tinche.
Anche in periodi relativamente recenti si hanno notizie molto precise sull'allevamento della
Tinca e sulla presenza di peschiere e di pescatori professionisti che ottenevano le loro entrate
dall'allevamento e dalla vendita delle tinche, attività che si è protratta nei secoli. La zona di
produzione comprende i comuni di Poirino, Isolabella e Pralormo (Torino), Cellarengo (Asti), e
Ceresole d'Alba (Cuneo). Sono compresi parzialmente anche altri comuni delle province di
Torino, Cuneo e Asti.
Codice CUP J82F16000360007 Progetto finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 14PROGETTI IN ATTO:
Unioncamere-Mipaaf, programma per qualità e consumo responsabile
filiera ittica MADE-IN-ITALY
Pescare, allevare rispettare. Questi i punti cardine del programma per
promuovere la qualità e il consumo responsabile di prodotti della filiera
ittica. Per gli italiani il pesce è un alimento cardine della dieta
mediterranea: 8 su 10 vogliono essere informati e garantiti della sua
qualità e sono disposti a pagare anche qualcosa in più per essere certi che
il prodotto è stato pescato o allevato nel rispetto dell’ambiente. E’
quanto svela un sondaggio promosso da Unioncamere ad ottobre scorso
su un campione di consumatori rappresentativo della popolazione totale.
E proprio per rispondere a questa domanda di qualità e di tutela
dell’ambiente, la Direzione generale pesca marittima e dell’acquacoltura del Ministero delle politiche
agricole e Unioncamere hanno promosso la realizzazione di un programma che coinvolgerà le grandi
categorie di soggetti della filiera ittica, dalla produzione al consumo.
Il programma si articolerà su tutto il territorio nazionale. Tre i filoni di questa iniziativa: la qualificazione
delle imprese e dei prodotti dell’acquacoltura con un Sistema di qualità nazionale per l’acquacoltura e
l’adozione di un codice etico focalizzato sulla sostenibilità ambientale e sociale per la piccola pesca
artigianale costiera. Questi strumenti saranno diffusi e messi a disposizione di tutte le imprese italiane
del settore. A seguire, la commercializzazione dei prodotti, per innestare il tema della qualità nei
rapporti presso i mercati all’ingrosso e la vendita al dettaglio, nonché nella ristorazione, alla quale verrà
proposto di adottare un decalogo che aumenta la trasparenza verso i clienti; l’informazione e la
sensibilizzazione ai consumatori attraverso campagne sui media e alle giovani generazioni (i cosiddetti
'piccoli consumatori') con iniziative di educazione alimentare attraverso le scuole primarie e secondarie
di I grado, per richiamare ad un consumo responsabile delle risorse ittiche oltre che per favorire
l’acquisto dei prodotti di qualità.
“Per il sistema economico è fondamentale un clima di fiducia tra chi produce e chi consuma. La
competitività delle imprese si gioca anche sui fattori di distinzione, cioè quegli aspetti che fanno capire
al mercato quanto una impresa e i suoi prodotti corrispondano alla qualità attesa dal mercato stesso.
Questo programma in collaborazione con la Direzione della pesca marittima e dell’acquacoltura vuole
proprio mettere insieme questi due aspetti, da un lato la qualificazione delle imprese della filiera,
dall’altro lo stimolo alla domanda di prodotti di qualità”.
I temi di grande rilevanza del progetto si intrecciano con i principi della dieta mediterranea che dà
grande rilievo al consumo di pesce, olio, verdure e cereali. La filiera ittica diventa però prioritaria se si
considera che le risorse disponibili nei mari e nelle acque interne non sono infinite ed anzi alcune specie
sono a rischio estinzione: occorre trovare un equilibrato rapporto e sinergia tra pesca e acquacoltura per
rispondere alla domanda alimentare. L’allevamento di pesci, molluschi e crostacei a fini alimentari ha
superato, a livello mondiale, la pesca tradizionale. Entro il 2030 (dati Fao) l’acquacoltura raggiungerà i
due terzi della produzione complessiva. Nell’ultimo Rapporto Biennale su Pesca e Acquacoltura
pubblicato lo scorso 7 luglio, la Fao afferma pure che il consumo procapite di pesce ha superato per la
prima volta i 20kg l’anno. E sempre per la prima volta la quantità di pesce prelevato in natura è stata
inferiore a quello allevato.
Il sondaggio realizzato da Unioncamere fotografa la situazione di partenza confermando la necessità di
queste azioni di qualificazione e informazione. L’82% degli italiani ritiene molto importante che i
prodotti ittici freschi, molluschi, crostacei e pesci di acqua salata e dolce, siano certificati nella qualità
dal Mipaaf. Il 30% non comprende le informazioni dell’etichetta sui prodotti e a volte non la trova. Il
60% ritiene molto importante che nei menù dei ristoranti sia specificato se i prodotti ittici utilizzati
Codice CUP J82F16000360007 Progetto finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 15provengono da allevamenti o da catture. Il 76% sarebbe disponibile a pagare in più per l'acquisto di
pesci pescati o allevati nel rispetto dell'ambiente. Nella dieta degli italiani il pesce è presente almeno
una volta a settimana (36% degli intervistati) e per il 12% anche due volte a settimana. Sono solo il 26%
a consumarlo solo ogni due settimane e il restante 26% una volta al mese o meno. Il 67% degli italiani
preferisce acquistare pesce fresco. Il 42% in pescheria, il 36% al supermercato, il 18% al mercato rionale
e solo il 4% direttamente dal pescatore.
"COSTA TOSCANA" il marchio doc del pescato regionale
Per affiancare il consumatore in una scelta consapevole e guidarlo tra le varie offerte e al fine di
valorizzare il pescato di qualità, promuovere specie ittiche locali favorendo la diversificazione e la
stagionalità dell'offerta; sostenere l'economia della filiera locale; fornire maggiori e più precise
informazioni al consumatore finale, il sistema delle camere di commercio della costa toscana ha
proposto un sistema di tracciabilità e garanzia qualitativa del pescato della costa toscana attraverso un
vero e proprio marchio collettivo: il Marchio Costa Toscana.
È merito della Maremma se la Toscana dal 2016 chiama il pesce “doc” della sua costa: da Marina di
Carrara a Capalbio. Possono aderire al sistema di riconoscimento “Costa Toscana” gli operatori ittici che
svolgono una delle fasi della pesca: dall’uscita in mare alla conservazione al trasporto di prodotti ittici,
rispettando, però, i requisiti fissati dal Disciplinare di produzione.
Codice CUP J82F16000360007 Progetto finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 16Nuovo Consiglio consultivo per l'acquacoltura (Aquaculture Advisory Council
- AAC) per garantire lo sviluppo dell'acquacoltura europea.
Nell'ambito della politica comune della pesca, è stato istituito un Consiglio Consultivo per
l'Acquacoltura (AAC). Tale organizzazione è la principale interfaccia tra il mondo produttivo
dell'acquacoltura le Istituzioni Europee e gli Stati Membri ed ha come scopo primario quello di fornire
segnalazioni, raccomandazioni e suggerimenti sulle problematiche relative allo sviluppo del
settore.
L'AAC è composta da rappresentanti del comparto (allevatori, trasformatori, mangimisti,...) ed altre
parti interessate (prevalentemente ONG), con una ripartizione del 60% e 40% rispettivamente dei
seggi assegnati nell'Assemblea Generale (GA) e nel Comitato Esecutivo (ExCom). L'AAC è
supportato finanziariamente dall'UE in quanto è un organismo che persegue un obiettivo di interesse
generale europeo ed ha sede a Bruxelles.
L’AAC ufficialmente operativo da pochi mesi è composto oltre che dall'Assemblea Generale e
dal Comitato esecutivo da tre gruppi di lavoro (WG): WG Fish per la piscicoltura, WG Shellfish per
la molluschicoltura e WG General Affairs per le questioni generali.
Piattaforma Acquacoltura Nazionale – ITAQUA
E’ stata presentata nella prima edizione di AquaFarm 2017 la Piattaforma Acquacoltura
Nazionale – ITAQUA, il primo Forum di lavoro, interazione e scambio per i diversi operatori
dell’acquacoltura italiana. La piattaforma è stata istituita dalla Direzione Generale della Pesca
e dell’Acquacoltura del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per
condividere e attuare le azioni strategiche da mettere in campo per sostenere la crescita e la
competitività dell’acquacoltura nazionale e perseguire gli obiettivi europei di Crescita Blu.
La Piattaforma ITAQUA è tra le azioni prioritarie programmate nel Piano Strategico per
l’Acquacoltura in Italia (PSA) 2014-2020 per facilitare l’attuazione del Programma Operativo
FEAMP 2014-2020 attraverso un approccio trasparente e inclusivo che tiene conto dei
fabbisogni dei diversi settori produttivi e delle specificità territoriali.
La struttura, le funzioni e l’organizzazione della Piattaforma ITAQUA sono state definite sulla
base dei risultati della prima consultazione on-line promossa dalla DG PEMAC e nell’incontro
tenutosi a Roma il 20 Dicembre 2016, alla quale hanno partecipato esperti da Amministrazioni
centrali e regionali, associazioni di imprese e organizzazioni di produttori, industria, sindacati di
categoria, cooperative e consorzi nazionali di settore Enti di ricerca pubblici e privati
societàscientifiche e ONG.
Codice CUP J82F16000360007 Progetto finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 17La Piattaforma ITAQUA è stata organizzata in tavoli di lavoro che affrontano i temi
strategici della semplificazione amministrativa, della pianificazione spaziale, della valutazione
d’impatto ambientale, della salute e benessere animale, del mercato, della ricerca e della
comunicazione. Assicurerà un supporto tecnico, informativo e consultivo alla DG PEMAC del
MiPAAF per individuare le criticità e le priorità per i comparti produttivi, rimuovere gli
ostacoli alla crescita, tutelare gli interessi delle imprese che operano responsabilmente e
favorire lo sviluppo e l’innovazione.
Codice CUP J82F16000360007 Progetto finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 18PRODUZIONE DELL'ACQUACOLTURA ITALIANA IN TONNELLATE
E CORRISPETTIVO VALORE IN MIGLIAIA DI EURO PER IL 2015
Impianti vallivi e
Impianti a terra e a mare TOTALE VALORE -PLV
SPECIE salmastri
(tonnellate) (tonnellate) (migliaia di euro)
(tonnellate)
SPIGOLA 6.450 500 6.950 55.400
ORATA 7.360 500 7.860 59.000
OMBRINA 250 250 1.900
ANGUILLA 1.000 250 1.250 14.000
CEFALI 3.000 3.000 9.750
TROTA 38.000 38.000 (*) 152.000
SALMERINO DI FONTE 700 700 3.150
PESCE GATTO 600 600 3.300
CARPE 700 700 2.500
STORIONE (**) 1.480 1.480 13.500
ALTRI PESCI (***) 2.000 2.000 14.500
TOTALE PISCICOLTURA 58.540 4.250 62.790 329.000
MOLLUSCHI DA ACQUACOLTURA
MITILI 80.000 64.000
VONGOLE 34.000 136.000
TOTALE MOLLUSCHI 114.000 200.000
TOTALE ACQUACOLTURA 176.790 529.000
(*) viene considerato anche il valore aggiunto per il prodotto trasformato fresco in azienda.
(**) escluso il valore prodotto dal caviale
(***) dentice, sarago, persico spigola, salmerino alpino, tinca, temolo, luccio, etc.
Codice CUP J82F16000360007 Progetto finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
elaborazioni dati API 2016
19SWOT ACQUACOLTURA ITALIANA – visione API
Punti di forza Punti di debolezza Minacce Opportunità
Elevato grado di conoscenze Scarsa disponibilità di Forte importazione Diversificazione di
e specializzazione Novellame per alcune specie
dai europei UE - prodotto, prodotto
tecnologica, sicurezza e Norvegia e paesi trasformato e di
Scarsa innovazione del
qualità della filiera prodotto trasformato Terzi (Turchia, Sud specie
Potenziale tecnologico per la Est Asiatico)
Elevati oneri per le Crescita del
trasformazione e concessioni demaniali
Impossibilità di mercato europeo
diversificazione dei prodotti
e di specie Elevati oneri nell’attività di competere (costo e per i prodotti
gestione dell’acquacoltura. prezzo vendita) con trasformati
Sostenuta domanda interna i prodotti
Scarsa immagine dei
per i prodotti ittici (locali) Integrazione
prodotti (comunicazione, provenienti da paesi
verticale e
Esistenza di canali di
promozione ed educazione Terzi
consumatore) trasformazione
distribuzione che
Riduzione dei delle produzioni e
garantiscono l’assorbimento Non chiara etichettatura sulla
profitti e prodotti
delle produzioni nazionali di provenienza dei prodotti
qualità ittici conseguenti rischi
Implementazione
per le imprese
Capacità di offrire sul Pressione delle importazioni in materia di
mercato prodotti di qualità (volume e prezzo, Level Concentrazione certificazione e
Playing Field) della domanda marchi di qualità
costante e sicuri durante
tutto l'anno Dimensioni aziendali Elevata
Difficoltà delle Potenzialità di
liquidità immobilizzata nelle
Leader a livello europeo / imprese di fare crescita per
imprese (ciclo produttivo)
internazionale nella investimenti produzioni oggi
produzione in alcune specie Mancanza di credito di
marginali
(molluschi, trote, caviale) esercizio, difficoltà all’acceso Tendenza della GDO
per nuovi investimenti
a imporre proprie Ottimizzazione dei
Prossimità ai mercati
Elevati costi dei mangimi e politiche di sistemi di
nazionali che domandano
prodotti di eccezionale
energia certificazione rintracciabilità del
freschezza prodotto
Mancanza di programmi di Ridotto margine di
riproduzione/ricerca genetica
Disponibilità di tecnologie manovra dei Miglioramento
per le specie maggiormente
consolidate ed innovative allevate produttori nella della catena
lungo tutta la filiera gestione della produttiva e
(allevamento, Scarsa disponibilità di vaccini
dinamica dei prezzi distributiva
e scarsa disponibilità
trasformazione /packaging)
all’acceso di farmaci specifici
per l’acquacoltura (level
playing field)
Codice CUP J82F16000360007 Progetto finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 20APPUNTI: Codice CUP J82F16000360007 Progetto finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 21
Puoi anche leggere