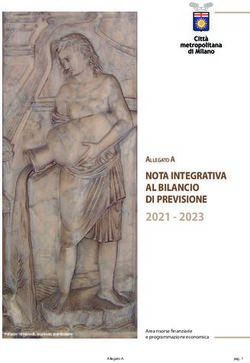Che fine hanno fatto le smart city? - cheFare
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Che fine hanno fatto le smart city? Una domanda piuttosto importante, dato che qualche anno fa non si parlava d’altro. La smart city doveva essere il paradigma che avrebbe condotto la vita nelle città (che rappresentano la principale forma aggregativa per l’umanità) verso condizioni migliori: minori sprechi energetici, maggiore attenzione all’ambiente, migliori condizioni culturali, maggiore welfare e più engagement della cittadinanza. Nel 2017, il rapporto Cities in Motion ha stilato una classifica delle città più interessanti secondo il fenomeno della smart city, che tiene in considerazione 10 indicatori principali. Come si sono posizionate le città italiane? La risposta, probabilmente, è scontata: non molto bene. Ovviamente, nessuna delle nostre città è rientrata nella top-ten, che elenca, in ordine, New York, Londra, Parigi, Boston, San Francisco, Washington, Seul, Tokio, Berlino ed Amsterdam. Per trovare la prima italiana, bisogna scendere di qualche posizione, e con maggior precisione la 38° (Milano), seguita da Roma (43°), Firenze (49°), Torino (61°), con Napoli (93°) che chiude la presenza dello stivale. Oltre ad essere utile per ricordare a molti italiani che il Bel Paese non è così centrale negli equilibri mondiali, questa classifica può essere utilizzata anche per approfondire un po’ le differenze domestiche. In primo luogo, è da notare quante città siano assenti dal radar. In secondo luogo, è interessante valutare quali siano come e quali le differenze possano essere più importanti tra le nostre città. Più nel dettaglio, le dimensioni analizzate dal rapporto sono Economia, Capitale Umano, Coesione Sociale, Ambiente, Management Pubblico, Governance, Pianificazione Urbana (Urban Planning), Connessione Internazionale, Tecnologia, Mobilità e Trasporti. La lettura della tabella permette di individuare quali siano le dimensioni in cui meglio “performano” e in quali le nostre città potrebbero notevolmente migliorare. Se Milano spicca per le dimensioni economiche, il capitale umano e la mobilità, Firenze ha invece il primato nostrano per Coesione Sociale e Governance, mentre a Torino spetta il podio per l’Ambiente e la Pianificazione Urbana. Peggio di tutte Napoli, che segue le altre in ogni dimensione venga esaminata, soprattutto per quanto riguarda il capitale umano, il management pubblico e le connessioni internazionali. In generale, la dimensione in cui le nostre città sono meno attrattive è quella definita come “management pubblico”, formata 6 indicatori che misurano nello specifico: la pressione fiscale sulle imprese, Riserve (?) e Riserve (Per capita), numero di ambasciate presenti nel territorio urbano, gli utenti di Twitter in posizioni prominenti e imposte sulla vendita. Per questa dimensione, il primato va a Ginevra – Svizzera, seguita da Washington D.C. e Baltimora.
Ci sono altre valutazioni che sicuramente colpiscono: la Coesione Sociale di Roma, ad esempio, la più bassa tra quelle italiane, e la valutazione in merito al Management Pubblico di Torino, surclassata dai risultati attribuiti alla città di Napoli. Certo, questo report avrà sicuramente dei margini di discrezionalità, e gli indicatori (si rimanda alla metodologia dello stesso report per approfondire la questione) possono essere giudicati più o meno indicativi, ma senza ombra di dubbio, i risultati di questo report forniscono una visione chiara del grande percorso che ancora c’è da fare per l’affermazione delle città italiane a livello globale. Un’ultima riflessione riguarda il Capitale Umano: a comporre la dimensione sono indicatori inerenti il livello di studi (Proporzione della Popolazione con almeno il diploma), il numero di Business Schools, Il numero di università, quello dei musei e delle gallerie d’arte e infine la spesa per attività di leisure e di entertainment. Quella del Capitale Umano è tra tutte le dimensioni esaminate, quella che presenta maggiori difficoltà strutturali per le nostre città di “scalare” la classifica. Un miglioramento del nostro asset culturale, così come attività volte a stimolare la domanda (a pagamento, e non gratuita) sono sicuramente obiettivi più raggiungibili della riduzione del coefficiente di Gini. Essere smart, in fondo, non vuol dire anche questo? L’ex Dogana San Lorenzo a Roma diventa smart city culturale Al momento è uno spazio senza un’identità precisa, prevalentemente utilizzato per dj set, live di musica elettronica, dance floor, ma che ha anche ospitato un’edizione di Altaroma, l’evento capitolino dedicato al fashion, e una di Outdoor, contenitore internazionale di Street Art curato da nufactory, che un po’ lanciò la location. Ma sul futuro dell’ex Dogana del quartiere San Lorenzo – uno scalo merci ferroviario in disuso, per un totale di 23.000 mq di storia e stratificazioni – si discute da anni. Lo spazio, inizialmente di proprietà demaniale, viene ceduto nel 2004 a Cassa Depositi e Prestiti. Nel 2007 Fingen, Pirelli Re e Gruppo Maire si aggiudicano 4 immobili della Capitale – tra cui l’ex Dogana – con l’obiettivo di attuare un programma di recupero e valorizzazione. La formula è quella della società mista pubblico-privata: il destino del luogo è oggi nelle mani di Residenziale Immobiliare 2004 Spa, società per il 75% di proprietà della Cassa Depositi e Prestiti e per il restante 25 di Finprema, gruppo Fingen. Cosa ne faranno? In teoria, nel 2019, dovrebbe inaugurare qui The Student Hotel, dell’omonimo
gruppo alberghiero olandese. Hotellerie, co-living, co-working, con stanze per studenti, camere d’albergo, aree studio e start up, ristorante, bar, palestra, piscina all’aperto, sala giochi. Questo il futuro, che tra giunte che si susseguono, burocrazie che ingolfano, opposizioni che frenano ed economie che si complicano, ha sempre un po’ il sapore dell’incertezza e del miraggio. In una città che vive la nuova architettura e lo sviluppo urbanistico di qualità come una minaccia (e che invece accetta di buon grado episodi di speculazione ed evidenti scempi). E poi c’è un presente tutto nuovo. Una parentesi che durerà fino a dicembre 2018. Diciannove mesi di tempo e di lavoro, per trasformare questo spazio straordinario nell’Ex Dogana Smart City Culturale. La gestione temporanea va a MondoMostre Skira, società che vede al fianco l’editore e produttore di mostre Skira e i partner romani del gruppo MondoMostre. L’area viene ripensata, a livello di struttura, funzione e programmazione: un headquarter polivalente da riattivare, facendone un reale riferimento per il quartiere e la città. Ci sarà un’area Uffici, cuore pulsante e materia grigia dell’imponente corpo architettonico, là dove si disegneranno e coordineranno i progetti, come in una vera factory della cultura. Anche il pubblico potrà accedervi, grazie all’area Coworking. Lo Scalo Ovest sarà usato come area musicale e per l’apertura estiva, con la prima tranche di eventi attesa dal 21 giugno al 15 luglio: grandi concerti open air di musica classica, elettronica e pop, con star internazionali. Amsterdam: il futuro per nulla radioso delle smart city Il Randstad, la megalopoli formata da Amsterdam, L’Aia e Rotterdam, è una delle zone a più alta densità di popolazione al mondo: una “città anello” – questo il suo significato letterale – policentrica e decentralizzata, che connette le principali città olandesi ad altre più piccole (Utrecht, Haarlem, Delft…) formando una delle regioni metropolitane più grandi d’Europa. Se non consideriamo le aree urbane, nessuna città olandese arriva al milione di abitanti. Tuttavia, il Randstad conta più di sette milioni di persone, e questo nonostante l’anello racchiuda al suo interno anche un’ampia area rurale dove i tulipani si alternano a serre, mulini e vacche al pascolo. Se lo si guarda dall’alto, più che un anello il Randstad dà l’idea di un network, i cui nodi principali sono il polo amministrativo della nazione (L’Aia), quello industriale (Rotterdam) e quello creativo (Amsterdam). Dei tre nodi, Amsterdam è di sicuro quello più grande. Curiosamente, anche la città replica al suo interno una struttura ad anello: il Ring – la tangenziale che ne delimita l’area urbana – racchiude il
centro storico, a sua volta formato da canali concentrici. La capitale insomma non solo è figlia del sistema in cui è inserita, ma contribuisce alla sua definizione. Considerare l’Olanda e Amsterdam come un network, aiuta a capirne l’essenza: è come se ogni parte del tutto, scomposto in cellule, presenti la stessa struttura. In un momento storico in cui sempre più oggetti e persone sono digitalmente connessi tra loro, il progetto Amsterdam Smart City non può quindi che ripartire proprio dal concetto di network, i cui nodi sono stavolta rappresentati da istituzioni locali, università, imprese e piccole comunità di cittadini, a loro volta scomponibili in network più piccoli al loro interno. Tutto è connesso, e lo è già ora, nel 2016. Tra dieci anni, possiamo solo immaginare quello che diventerà: caricatori di auto elettriche che parlano con i passanti, intelligenze artificiali che elaborano risposte in lingue diverse per ogni tipo di domanda, alberi che si connettono ai goggle dei turisti mostrando la città in epoche diverse grazie alla mixed reality, gente che cammina sola parlando nei microfoni degli auricolari mentre altri, seduti al bar, sono altrove, nella realtà virtuale. Smart City, quanto conta la tecnologia? Se avete sempre provato curiosità per capire a fondo cosa vuol dire “smart city”, neoanglicismo normalmente usato (e anche un po’ abusato) per indicare la trasformazione tecnologica a cui sono soggette le grandi città mondiali, dagli Usa piomba la notizia che Columbus, capitale dello Stato dell’Ohio, è la vincitrice del primo “Smart City Challenge”, grande concorso con in palio 40 milioni di dollari indetto dal Dipartimento dei trasporti americano per creare la prima vera città totalmente 3.0 del Paese. Ma attenzione, la tecnologia c’entra, naturalmente, ma quello che ha fatto preferire il progetto della capitale del Mid-West americano è la sua visione “olistica” e la sua capacità di unire in un modello di sostenibilità e cooperazione fondi pubblici e privati. Basta guardare il seducente video realizzato dal team di Columbus per pitchare al concorso per capire che il loro modo di intendere una Smart City verte su un pilastro fondamentale: «La cultura della collaborazione tra pubblico e privato. E non sono solo parole visto che secondo statistiche recenti, la città ha il più alto tasso di crescita dell’occupazione e anche del numero di abitanti. Ecco perché quella dello Smart City Challenge era un’opportunità troppo allettante per lasciarsela sfuggire: la dimostrazione di questa cultura della collaborazione di cui sopra, sta anche nelle cifre, visto che accanto ai 40 milioni pubblici, ne sono già stati raccolti altri cento da aziende e sponsor privati, per realizzare il sistema di trasporti connesso e integrato più all’avanguardia degli States. Il bando del concorso prevedeva infatti la costruzione di un network innovativo di mobilità pubblica “integrato”, connesso e sostenibile, ovvero un ecosistema in cui ogni singola unità in movimento sia
linkata alle altre e in grado così di far risparmiare tempo ed energia al sistema dei trasporti locale: questo grazie a un IDE data system che consentirà lo scambio di info in tempo reale tra tutti i mezzi circalanti grazie a sofisticati software di analisi dei Big Data realtivi al trasporto cittadino. Smart City all’italiana La prima difficoltà in cui ci si imbatte nella comprensione delle smart city è capire cosa siano. La città intelligente in fondo non presenta complicazioni diverse da quelle che si incontrano con le persone brillanti: se le conosci non puoi farne a meno, ma occorre un manuale di istruzioni per avvicinarle. Da oltre un anno la Direzione generale per le politiche interne Parlamento Europeo ha compilato uno studio che fornisce informazioni e disposizioni sulle smart city del continente. Il report si propone di mappare e di sondare le dichiarazioni più autorevoli sul fenomeno, prima di passare al versante prescrittivo del documento. Non sarà un manuale di istruzioni, ma poco ci manca. Anche il comitato scientifico europeo comincia da una richiesta di definizione, e si scontra con la varietà delle opinioni sul tema. I punti fermi però non mancano, e insistono in particolare sulla progettualità urbanistica, sulla raccolta e l’elaborazione di informazioni collegate ai piani in sviluppo, sull’infrastruttura tecnologica che permette di collegare conoscenze ad attività di realizzazione. La sintesi raggiunta in sede comunitaria si incardina su tre principi: il ricorso a piattaforme digitali, la formazione di partnership che coinvolgano diversi soggetti dell’economia e della società civile, lo sviluppo di servizi utili alla comunità. L’ordine previsto è rovesciato rispetto a quello della mia esposizione: correttamente, vengono elencati prima i requisiti di benessere pubblico, poi le infrastrutture tecnologiche, infine il contesto delle relazioni istituzionali. Come esige la razionalità, prima ci si interroga sugli obiettivi, poi si scelgono i mezzi. Secondo il documento UE, l’Italia rappresenta un campione ideale per svelare i misteri della nozione di Smart City: se arrivate a pagina 40, potrete strofinarvi gli occhi a piacimento, ma il monitor continuerà a riproporvi il dato che oltre il 70% delle nostre città sopra i centomila abitanti è smart. Siamo leader dell’innovazione in Europa, insieme ai paesi scandinavi, all’Austria, alla Slovenia e all’Estonia. Siamo più brillanti degli inglesi, e terribilmente più inventivi dei tedeschi e dei francesi: i primi della classe non riescono a rimanere nella scia di quello che si fa a Milano, Bari e Torino. Sbalorditivo. Vale la pena allora dedicare un po’ di tempo alla ricognizione di un portale tematico dell’Anci sui progetti smart city attivi nel nostro Paese. Le iniziative sono 1309, coinvolgono 158 comuni, impegnati in otto macro-gruppi tematici: amministrazione, mobilità, economia, energia, ambiente, persone, stile di vita, pianificazione. La prima curiosità che andrebbe soddisfatta è la ragione per cui l’organismo di coordinamento dei comuni italiani abbia dovuto snocciolare la tassonomia dei lavori in corso in inglese. Un suggerimento potrebbe arrivare dal fatto che le etichette si sovrappongono
quasi alla perfezione a quelle indicate dalla direttiva europea; rimane l’enigma della trasformazione della governance comunitaria in government (un retaggio del vecchio mito dell’e-government che piaceva tanto a Ross Perot?), e l’introduzione di altre due classi, energy e planning. Ma, per una volta che siamo più avanti delle richieste europee, perché farsi tutte queste domande? Un secondo interrogativo, più serio, riguarda la nozione di open data che ispira la pubblicazione dei dati. L’unica forma di accesso ai contenuti è la visualizzazione dei box in html, che si caricano otto per volta sulle pagine del sito. Senza alcuna pretesa di web semantico, basterebbe poter scaricare i dati dei progetti almeno in un banale formato Excel o csv. Invece nulla: l’esplorazione è possibile solo per operatori umani, anche pazienti e ben motivati, che guardino le pagine del portale e le scorrano un pezzo per volta, iterando la richiesta di altri contenuti ogni otto box controllati. Una macchinosità davvero poco smart per chi è tanto progredito nella pianificazione di intere città intelligenti. Forse sarà per questo che, sebbene i progetti coinvolgano una popolazione complessiva di oltre 15 milioni di italiani, per un investimento complessivo di quasi 4 miliardi di euro – gli utenti del sito a gennaio 2016 siano stati solo mille, almeno secondo le stime di un popolare strumento di monitoraggio come Similarweb. Ma ancora più curiosa è la situazione per cui oltre un quarto delle risorse finanziarie complessive finiscono per essere assorbite da una categoria di investimento che nel report europeo non compare nemmeno, l’arcano planning, popolato solo da 103 progetti, il 7,9% del totale. Di che tipo sono questi progetti al quadrato, questi piani di pianificazione? Smart city e il controllo dell’intelligenza Qualche mese fa ho comprato una Playstation 4 e nella confezione era incluso un videogame dal titolo Watch Dogs. Il gioco è ambientato in una versione alternativa di Chicago in cui infrastrutture e servizi sono gestiti da un sistema operativo centrale. Il protagonista può usare il suo smartphone per penetrare i dispositivi elettronici e controllarli a proprio piacimento, per esempio cambiando i colori dei semafori o spegnendo l’illuminazione stradale. Inoltre può spiare le persone, i loro conti in banca e le parole cercate più sovente su Google. Watch Dogs rende l’idea dell’immaginario urbano che circonda le smart city. Ovviamente si tratta di un prodotto di finzione, ma alcune idee – l’interconnessione delle infrastrutture, i big data e la possibilità di accedere a informazioni personali – sono ben radicate in idee collettive sulla città del futuro. Inoltre, secondo l’azienda che ha prodotto il videogioco, tutte le tecnologie hacker presentate sono potenzialmente ‘reali’. L’idea di smart city non è di facile definizione. Si tratta di un concetto sviluppato nell’ultimo decennio da giganti dell’industria informatica come IBM, Cisco, Siemens, Hitachi e Toshiba. La città
smart è sostanzialmente efficiente e pulita grazie a sistemi di gestione informatizzati, ed esistono già numerosi esempi di città che hanno affidato la gestione di servizi sanitari, di sicurezza o energetici a tecnologie sviluppate da queste imprese multinazionali. L’idea probabilmente più popolare è che la città smart riceva costantemente feedback dai cellulari dei cittadini e da sensori sparsi nello spazio urbano; quindi, attraverso l’analisi dei big-data, la città può adeguare la fornitura di servizi, per esempio mutando il comportamento dei semafori al variare del traffico o attivando l’illuminazione pubblica solamente in presenza di passanti. Si tratta di idee che risuonano con la speranza che le innovazioni tecnologiche possano risolvere i nostri problemi – per esempio quelli collegati alla questione ambientale, alla sicurezza urbana, alla crescita economica – senza mettere in discussione i nostri insostenibili stili di vita. Non è quindi un caso che la smart city sia entrata nel novero delle parole-chiave dei documenti europei e che i progetti in quest’ambito siano supportati da sostanziosi finanziamenti. Watch Dogs Nonostante gli evidenti effetti positivi dell’innovazione tecnologica sulle città e sulla vita quotidiana, è però importante sottolineare alcuni elementi critici. La città è un luogo di elevata complessità: l’idea di poterla assimilare, controllare e governare con dispositivi tecnologici è per molti versi presuntuosa e riconducibile alle vecchie filosofie moderniste, come quando si costruivano dighe e si modificava il tragitto dei fiumi per aumentare l’efficienza dei sistemi idrici senza rendersi conto dei disastri ambientali prodotti in molti casi. La filosofia della smart city tende infatti a ridurre complessi problemi sociali e ambientali a semplici questioni tecniche risolvibili con una app. La maggior parte di noi, inoltre, non è in grado di comprendere appieno le logiche di queste tecnologie; si finisce così col fidarsi degli algoritmi della IBM sperando che in futuro si potrà continuare a mantenere la temperatura di casa stabile a 23 gradi in tutte le stagioni senza sentirsi in colpa per i danni ambientali. E ancora, la maggior parte di queste tecnologie sono sviluppate e vendute da imprese private, ed è possibile che logiche di profitto possano insediarsi nella fornitura di servizi pubblici, accelerando la spinta al neoliberismo. Fra i vari pericoli, uno dei più sentiti riguarda il rapporto fra smart city e sorveglianza. Occorre premettere che vi è una lunga storia di politiche urbane che, in nome della sicurezza, hanno assunto posizioni violente nei confronti di soggetti deboli. Si pensi alla tolleranza zero della New York di Giuliani: in nome della sicurezza sono stati rimossi senzatetto e prostitute, soggetti senza dubbio poco ‘pericolosi’ in senso stretto. Una norma che criminalizza il dormire in pubblico non è una politica di sicurezza, ma un modo per rimuovere dal paesaggio urbano gli homeless. E ancora, le note gated communities che proliferano in tutto il mondo (un po’ meno in Europa) separano una minoranza privilegiata dall’incontro con esperienze urbane di povertà e/o di insicurezza, ma
difficilmente possono essere immaginate come strumenti per aumentare la sicurezza urbana. È quindi necessario domandarsi sicurezza di chi? e da chi?. Una tesi plausibile è che le tecnologie smart non faranno che accelerare alcune tendenze già in atto. Si provi a osservare l’immagine qui sotto, estratta da un sito della polizia inglese. Invita a riportare comportamenti strani e accenna all’utilità delle telecamere, strumento cruciale delle smart city. Ma cosa significa strano? Eccentrico? Fuori luogo? Arabo? Devo controllare i miei vicini? Questo tipo di approccio è socialmente pericoloso, perché implicitamente si sovrappone a un’idea di profiling etnico che degenera facilmente in marginalizzazione, stigmatizzazione e disintegrazione sociale. Le nuove ‘telecamere intelligenti’, però, operano proprio in questa logica: attraverso sistemi di riconoscimento facciale e complessi algoritmi, seguono i soggetti che si comportano in modo strano. Ma ci sono molti modi in cui possiamo essere strani, e cercando sul web si possono trovare innumerevoli esempi di persone che sono state individuate e spiate in seguito a segnalazioni generate da telecamere intelligenti o da sistemi di controllo delle parole chiave contenute nelle email. Se siete interessati al tema, suggerisco il documentario della BBC Naked citizen. https://www.youtube.com/watch?v=VZxd8w11YSA Ma vi è altro. Proprio come in Watch Dogs, l’analisi dei big data ha originato tecniche di polizia predittiva, ossia modelli statistici che permettono di individuare il profilo dei soggetti e dei luoghi in cui è più probabile che prendano forma crimini, in modo da poter concentrare le forze di polizia in specifici luoghi e momenti della giornata. Tutto questo può sembrare efficiente a un manager urbano, ma è pauroso per chi lavora nelle scienze sociali. Significa stigmatizzare e militarizzare sempre più i luoghi pericolosi. Si consideri l’esempio delle favelas brasiliane, sempre meno percepite come spazi di povertà e marginalità, quanto piuttosto come aree pericolose da sorvegliare e pulire con forze, tecnologie, armi e linguaggi tipici degli scenari di guerra (blitz, raid, ecc.). Ma siamo sicuri che gli abitanti li considerino una soluzione, e non invece una parte dei problemi del luogo? Tutti questi problemi sono ovviamente soltanto potenziali. Ci possono essere tecnologie smart buone e cattive, e certamente la tecnologia – vecchia e nuova – può migliorare le nostre vite. Ma l’idea che le tecnologie saranno la nostra salvezza le protegge da sguardi critici. Non è così semplice: siamo sicuri che sia sostenibile gettare via la mia vecchia lavatrice per comprarne una nuova eco-efficiente e smart?
Forse è meglio continuare a usare quella vecchia il più a lungo possibile; probabilmente non vi è una singola risposta e dipenderà dalle circostanze. Siamo sicuri che le auto elettriche risolveranno la crisi energetica e ri problemi della mobilità urbana, e che non occorrano invece altri strumenti di pianificazione? Watch Dogs L’ipercelebrazione delle tecnologie promuove l’idea che esse generino automaticamente città migliori, come se si trattasse solamente di affrontare problemi tecnici, da risolvere con il giusto software, a prescindere dalla varietà dei percorsi di sviluppo delle società locali, dalla difficoltà di ridurre il caos e la complessità delle città a una manciata di indicatori statistici da monitorare e controllare, dalla necessità di dibattiti, regole e forme di controllo per plasmare l’innovazione tecnologica, e dall’opportunità di controllare il comportamento dei soggetti privati che gestiscono servizi pubblici. Occorrono dibattiti sulle possibili alternative tecnologiche da scegliere, tenendo a mente che ogni città è unica. In definitiva, non credo esista una singola possibile città intelligente. L’espressione smart city sembra autogiustificarsi, in quanto una città non-smart è necessariamente stupida. Vi sono però un gran numero di modi di essere intelligenti e avanzati. Possiamo avere piccoli eco-villaggi (anche se difficilmente immaginabili per 7 miliardi di persone), oppure grattacieli in grado di ospitare migliaia di persone. Possiamo avere tecnologie che espandono la nostra libertà e altre che aumentano sorveglianza e controllo. Davvero vogliamo essere costantemente monitorati per la nostra sicurezza? Forse cominceremmo a comportarci in maniera differente sapendo che qualcuno ci sta controllando. Forse sarà meglio evitare parole come bomba, e magari anche protesta e dissidente. Watch Dogs
Possiamo anche avere una grande varietà di città, tecnologie e problemi urbani. Certamente, le imprese che forniscono soluzioni tecnologiche e smart app massimizzano il profitto vendendo lo stesso prodotto a un più città: in economia si chiamano economie di scala. Inoltre, con la crisi economica, molti governi sono felici di aprire le porte a investimenti pubblici e privati in progetti di città smart. Le imprese stanno quindi diventando attori chiave nella produzione di spazi urbani. Ma non è forse pericoloso indirizzare percorsi e strategie delle città in un’unica direzione, in tutte le parti del pianeta, attraverso un modello universale? La standardizzazione dei percorsi di sviluppo e degli stili di vita limita fortemente la possibilità di immaginare e sviluppare alternative, suggerendo tra l’altro in modo implicito che le soluzioni da cercare siano strettamente tecniche, e non sociali e politiche. È per questa ragione che occorre mantenere alto il profilo del dibattito critico sulle smart city e interrogarsi sul tipo di città del futuro in cui si intende vivere. Questo intervento di Alberto Vanolo è il primo di un serie (qui la presentazione) a cura di Roberta Marzorati e Marianna D’Ovidio sui temi urbani. Uno spazio sviluppato da cheFare in collaborazione con il dottorato UrbEur di Milano. Città digitale e smart city La terminologia di città digitale viene spesso usata erroneamente come sinonimo di smart city. In realtà queste diciture fanno riferimento a due concetti distinti. Per quanto riguarda la smart city, in letteratura non esiste ancora una definizione olistica accettata dal mondo accademico, politico e industriale, ma si tratta ancora di un concetto confuso e non ben delineato. Infatti, l’aggettivo smart si traduce letteralmente in “intelligente” e a seconda del significato che si attribuisce a questa parola, discende una definizione diversa di smart city. Hollands ne propone alcune, che discendono da termini usati più frequentemente in letteratura o in casi empirici di smart city. • Città intelligente (intelligent city); una città dotata di competenze professionali e di ICT che è in grado di produrre conoscenza e di trarre da essa il massimo rendimento. Tale conoscenza si traduce in abilità uniche e distintive di difficile imitazione, diventando così l’elemento caratterizzante della città. Pertanto, il capitale intellettuale rappresenta la componente fondamentale di questo tipo di città, grazie al quale è possibile supportare l’apprendimento, lo sviluppo tecnologico e i processi innovativi. • Città della conoscenza (knowledge city): la città che è stata creata esclusivamente per favorire la promozione della conoscenza. Il suo scopo è quello di utilizzare la conoscenza per migliorare la competitività del contesto urbano nell’ambito dell’economia globale.
• Città ubiqua (ubiquitous city); una città in cui lo spazio fisico e lo spazio virtuale convergono creando una nuova generazione di spazio urbano. Lo scopo della città ubiquitous (detta anche u-city) è quello di promuovere l’innovazione urbana, migliorare la qualità della vita e lo sviluppo industriale. Il fattore critico di successo è la corrispondenza tra le esigenze dei diversi stakeholder e gli u-service messi a loro disposizione. Tuttavia, la u-city sembra rivolgersi quasi esclusivamente ai fruitori giovani escludendo così gran parte dei cittadini. • Città digitale (digital city); la città connessa in rete sia con sistemi wired che wireless, digitalizzata, che è dotata di piattaforme tecnologiche basate sull’ICT e su Internet, grazie alle quali è possibile elaborare enormi quantità di dati ed informazioni collegando così la dimensione urbana (tangibile) con la dimensione virtuale (intangibile) e i diversi attori coinvolti (Hollands, 2008; Ishida, 2000). In questo modo si promuove la condivisione dei dati (open data) e contemporaneamente lo sviluppo di strumenti di e-democracy che favoriscano la comunicazione e il coinvolgimento attivo dei cittadini. Le componenti su cui si basa la città digitale sono pertanto l’hardware, il software, le TLC, le attività ed i servizi informatici e il wetware. • Città eco-sostenibile (sustainable city): la città che mira a essere “green” incentivando l’utilizzo dell’ICT per avviare processi di efficientamento energetico e per ridurre le emissioni di anidride carbonica (Bagatan, 2011). Le istituzioni europee, in materia di smart city, puntano proprio all’eco- sostenibilità per ovviare alle numerose problematiche che è chiamata a rispondere la città moderna. Per questo motivo la Strategic Energy Technology Information System europea (Eu-SETIS) ha elaborato una road map fino al 2020 che prevede obiettivi smart in termini di: – building, investendo nella costruzione di edifici a impatto energetico zero; – energy, diffondendo l’utilizzo di impianti elettrici con tecnologia smart grid e impianti di riscaldamento e raffreddamento a bassissimo consumo energetico e impatto ambientale; – trasporti, investendo nel miglioramento dei trasporti pubblici urbani attraverso tecnologie smart in grado di ridurre il traffico, l’inquinamento e migliorare la viabilità. Questa smart city, quindi, sarà caratterizzata dall’essere dotata di smart building con tecnologia smart grid e impianti per l’utilizzo di energie rinnovabili, smart device per monitorare il traffico urbano, la viabilità, la disponibilità dei parcheggi, ecc. • Città del benessere (well-being city); la città che si pone l’obiettivo di creare le condizioni per garantire ai propri cittadini il miglioramento della qualità della vita. Inoltre, la città del Benessere si occupa anche di promuovere il proprio territorio per renderlo maggiormente attrattivo per le imprese e per i turisti, sfruttando le sue potenzialità e le sue caratteristiche.
Playable City. La città si mette in gioco In un’epoca di profondi cambiamenti sociali, economici e tecnologici anche lo spazio urbano nel quale viviamo, la città, è destinato a mutare per rispondere a nuove e crescenti sfide legate al sovraccarico delle reti viarie, all’approvvigionamento idrico ed energetico ed alla co-esistenza in spazi sempre più ristretti di un numero crescente di individui. Stime Fao ci dicono che entro il 2050, l’80% della popolazione mondiale vivrà all’interno di spazi urbani, rendendo inderogabile un ripensamento delle relazioni tra infrastrutture materiali delle città ed il capitale umano, culturale, intellettuale e sociale di chi le abita. Nell’ultima decade urbanisti, amministratori urbani ed aziende ICT (Information and Communication Technology) in primis hanno intrapreso un fervente dibattito sull’immaginare e progettare le città del futuro. Una Smart City, città intelligente, in cui tecnologia, innovazione, ottimizzazione ed efficienza sembrano essere i capisaldi di un nuovo modo di sviluppare le politiche di pianificazione urbana. Una idea ben presto divenuta di moda, Google Trends mostra l’accelerazione di interesse che il tema ha conosciuto dagli inizi del 2015 confermata dai quasi 4 miliardi di investimento dei comuni italiani per dotarsi di una qualche progettualità smart: cassonetti e lampioni dotati di sensori, bike e car sharing, sistemi di video-sorveglianza integrata, arredo urbano dotato di chip. Personalmente intravedo un rischio nel percorso verso questa idea di città del futuro. La tecnologia ed in generale un approccio tecno-centrico, rischia di aggiungere complessità, freddezza e asocialità se non accompagnata da partecipazione attiva della cittadinanza. Nessun software o hardware apporta miglioramenti senza un adeguato tessuto umano in grado di gestire, pianificare ed utilizzare i nuovi strumenti. È per questo che preferisco di gran lunga l’idea di una Playable City, un luogo in cui i cittadini siano il fattore abilitante della rivoluzione. L’amministrazione si apre ai residenti e visitatori per riconfigurare e riscrivere servizi, posti e il racconto collettivo. Cittadini motivati e tenuti insieme dall’idea che la tecnologia possa essere umana, portatrice di benefici concreti, gioiosa e accompagnata da una sana componente di divertimento. Il gioco come momento di riflessione sul nostro essere umani quasi ad interrompere quel flusso di efficienza utilitaristica che permea molto del nostro essere cittadini. Proprio il gioco, quando ben calato nel design delle infrastrutture ed esperienze quotidiane, supera il tradizionale stereotipo di frivolezza e passatempo divenendo strumento per favorire cambi comportamentali positivi nell’individuo e nelle relazioni che esso intrattiene con persone ed ambienti prossimi. E’ sicuramente la lezione più importante che ho appreso lavorando negli ultimi 15 anni nell’industria dei video-giochi, un medium creativo e culturale che ad oggi coinvolge circa 30 milioni di persone in Italia e muove un fatturato vicino ai 100 miliardi di dollari nel mondo. Ma ancor prima che una industria, i video-giochi sono strumenti pensati per generare coinvolgimento, stati d’animo e favorire l’apprendimento. Soffermiamoci a guardare le espressioni facciali di chi gioca, basterà poco per rendersi conto di quante emozioni provino durante l’esperienza: rabbia, felicità, passione, sorpresa, altruismo, auto-espressione, senso epico. E perché non provare a migliorare molte delle nostre esperienze quotidiane anche attingendo all’immenso set di pratiche e teorie che i game designer hanno sperimentato con successo nelle ultime decadi? Molti dei temi oggi caldi nel dibattito urbano, dalla progettazione dal basso alla partecipazione attiva
passando per l’audience engagement e utilizzo delle nuove tecnologie sono rintracciabili sin dal 1989 in produzioni “ludiche” come SimCity. Il gioco manageriale e gestionale di città, ideato da Will Wright e pubblicato da Electronic Arts, ha portato milioni di persone nel mondo a contribuire volontariamente, e a proprie spese, alla risoluzione di problemi complessi di pianificazione urbana. Miliardi di decisioni prese da persone “comuni” che han avuto come scopo realizzare una città ideale e del futuro il cui obiettivo primario fosse la felicità dei Sim-cittadini. Molte delle soluzioni proposte sono state realmente utilizzate da urbanisti che continuano ad utilizzare SimCity come software lavorativo. Nel XXI secolo aziende come Wolkswagen hanno contribuito a innovare il paradigma di progettazione con iniziative pioneristiche come The Fun Theory. Una contest in cui si invitavano persone da tutto il mondo a realizzazione idee in cui la componente “fun” fosse propulsore di cambiamento. Tra i progetti piu famosi ricordiamo il vincitore Speed camera lottery (un autovelox che premia gli automobilisti che viaggiano entro i limiti con un biglietto della lotteria invertendo il paradigma motivazionale dalla punizione al premio) e Bottle Bank Arcade Machine (un bidone che stimola la raccolta differenziata del vetro attraverso l’utilizzo di punti, feedback luminosi e un meccanismo stile gioco della talpa). Entrambi i progetti, sono a costo economico sostanzialmente zero, e fanno leva su un modello di gioco che permette di rafforzare la propria conoscenza della città, mettendo in rilievo quelli che generalmente sono considerati semplici elementi di sfondo (oggetti d’arredo, viabilità, edifici, ecc.) attraverso nuovi paradigmi di interazione. A Bristol, Inghilterra, da ormai quattro anni viene assegnato il Playable City award volto a premiare i migliori progetti internazionali di innovazione attraverso la componente di gioco. HelloLamp, vincitore dell’edizione 2013 permette l’interazione tra cittadini ed arredo urbano; dai semafori ai cassonetti dell’immondizia passando per le panchine, il codice univoco assegnato dall’amministrazione diventa lo strumento per dialogare via sms. Inviando il testo ≪Hello + il nome dell’oggetto + il suo codice identificativo>>, l’oggetto risponde salutando e ponendo domande o richieste attraverso un algoritmo che auto apprende nel tempo. Oggetti, apparentemente inanimati, iniziano a vivere divenendo custodi di storie, racconti ed emozioni degli individui coi quali si sviluppa una naturale empatia che sta portando, nelle città mondiali in cui il progetto è stato lanciato, ad una diminuzione del tasso di vandalismo verso oggetti che, ora, hanno un nome ed un anima. Sogno una città in cui il sorriso e il divertimento diventino connettori sociali. Una città in cui giocare significhi esplorare, imparare e sviluppare senso civico. Una città che susciti costantemente azioni e reazioni. Voglio ascoltare i miei nipoti raccontare le loro gesta urbane con gli stessi pronomi utilizzati dai video-giocatori: “io ho esplorato”, “io ho preso parte ad una missione”, “ho collaborato per superare un ostacolo “. Quando le storie passeranno dalla terza alla prima persona, la sfida potremo considerarla vinta! In copertina: ph. Scott Webb da Unsplash
Due startup italiane selezionate da Cognicity Con la fine di Gennaio non sono finite le buone notizie per l’ecosistema imprenditoriale italiano. Proprio con la fine del mese che ha segnato una serie di vittorie impreviste per il nostro paese, è arrivata anche la notizia dell’inclusione di due startup italiane, Qurami e di Snapback nel più recente cohort di Congicity, il più famoso programma verticale sulle SmartCity d’Europa. COS’E’ COGNICITY Cognicity è il punto di riferimento per chi fa innovazione nel settore Smart City in Europa. Finanziato dal consorzio “Canary Wharf” costruttore dell’omonima la penisola di Londra centro finanziario della city, Cognicity ha preso diverse forme nel corso degli anni. Mentre lo scorso anno si presentava sotto forma di “challenge” con un premio finale di £50k messo a disposizione da Intel e la possibilità di testare i propri servizi all’interno del network di Canary Wharf, quest’anno si presenta come un hub che metterà sotto lo stesso tetto alcuni dei miglior esperti nel settore insieme alle startup selezionate. La prima volta che incontro Ester Vigilante, COO di Snapback è stato qualche mese negli uffici di un acceleratore qui a Londra. Mi avevano detto che Ester stava lavorando a qualcosa di sensazionale, qualcosa che serviva per comandare le macchine senza toccarle. “Si chiamano interfacce” mi corregge prontamente Ester “la nostra vision è quella di progettare interfacce trasparenti, che permettano una rivoluzione copernicana così da invertire il rapporto tra l’uomo e le macchine a vantaggio dell’essere umano. Vogliamo cioè mettere la tecnologia al servizio dell’essere umano e non l’essere umano al servizio della tecnologia”. Sul subito non riuscì ad avere una reazione migliore di un sano stupore, anche perché detto cosi mi sembrava un altro dei mille progetti irrealizzabili dei quali sento spesso parlare. Ma quando rivedo Ester passare per il Google Campus, capisco che le cose stanno prendendo una piega diversa e mi annuncia “Siamo stati selezionati da Cognicity!”. Snapback nasce da 3 co-founder, Giuseppe Morlino CEO, Claudio Capobianco ed Ester Vigilante. Ester ha un background come una linguista con una passione per le interfacce e per la sicurezza. “Le interfacce sono dei linguaggi e come linguista io mi occupavo di linguaggi, poi la sicurezza, personale e pubblica, è sempre stata una mia grande passione!” E per quanto possa sembrare incredibile che una ragazza arrivi dalla linguistica alla programmazione e che poi si interessi di sicurezza, parlando con Ester tutto questo sembra piuttosto normale. Ma che c’entra la sicurezza con la creazione di interfacce mi chiedo io. E lei mi risponde “immaginati uno smartwatch che abbia un’interfaccia intelligente in grado di capire quando cadi e non riesci più a rialzarti. Lo smartwatch può chiamare direttamente i soccorsi o i tuoi cari. Ecco questo tipo di interfaccia si chiama fall detection” Interfacce per sistemi wearables ma non solo. Snapback sta anche lavorando a un software in grado di riconoscere e reagire al soffio delle persone. Soffiando verso il nostro smartphone il sistema capirà che stiamo cercando di trasmettergli un messaggio e reagirà di conseguenza. “Per ora questo è un giochino con poche applicazioni pratiche, ma rende l’idea di come la nostra tecnologia possa interpretare e reagire ad ogni rumore, il che è molto più difficile che farla reagire alla voce e al dialogo.”
Per Richard Sennett, dobbiamo immaginare
strutture flessibili per un urbanesimo aperto
Partecipa a laGuida, il Festival Itinerante dei nuovi centri
culturali di cheFare. Scopri il programma.
Questo articolo fa parte dei contenuti de laGuida, il festival itinerante dei nuovi centri culturali.
Ogni tappa de laGuida riunisce i nuovi centri culturali di una determinata zona d’Italia in rassegne
online e dal vivo di conferenze, seminari e laboratori per sviluppare nuove competenze, costruire
assieme un orizzonte di senso comune e costruire un dialogo con chi costruisce l politiche culturali e
sociali. Il tema della prima tappa de laGuida – dedicata ai nuovi centri culturali di Liguria, Piemonte
e Valle D’Aosta – è Partecipazione. E lo indaghiamo anche con le righe che seguono.
Un “urbanismo aperto” per costruire un ambiente flessibile, non sovradeterminato o del tutto
definito a priori, così da conservare i benefici del vivere insieme nelle città ma scongiurarne leminacce più pericolose. Quelle derivanti da virus e malattie, ma anche quelle legate agli effetti dei cambiamenti climatici. Per Richard Sennett, tra i più autorevoli intellettuali del nostro tempo, visiting professor di Urban Studies al Massachusetts Institute of Technology e senior advisor per il programma dell’Onu su cambiamento climatico e città, solo un urbanismo aperto o tattico è all’altezza della grande sfida che abbiamo di fronte. Evitare il sovraffollamento, mantenendo la densità sociale che rende ogni città veramente tale. Ne abbiamo discusso in quest’intervista per che Fare, in occasione dell’inizio de laGuida, il Festival itinerante dei nuovi centri culturali. La portata globale della pandemia, e la sua diffusione nei contesti urbani, ha ridato nuova linfa agli studi sulle città e agli interrogativi sui modi in cui le costruiamo e le abitiamo, questioni di cui lei si occupa da molti anni, con ricerche e libri centrali nella discussione accademica e non solo. Ritiene che da questa pandemia si possano già trarre delle lezioni, anche politiche, o è ancora troppo presto per farlo? Parto da una premessa: da 35 anni circa, da quando ho abbandonato l’insegnamento alla London School of Economics, sono consulente delle Nazioni Unite sulle questioni urbane. Una delle questioni
più importanti su cui stiamo lavorando ora riguarda proprio le trasformazioni che la pandemia produrrà nelle città del Nord globale e del Sud globale. Il nodo complicato è in che modo legare la necessità di rendere le città più salubri da un lato e quella di renderle più verdi dall’altro. Non è facile tenere insieme contrasto alla “malattia” e contrasto e adattamenti ai cambiamenti climatici: molte delle ricette per affrontare il cambiamento climatico tendono a rendere le città più compatte, più affollate, più efficienti dal punto di vista energetico ma meno salubri, mentre le ricette per renderle più salutari spesso disperdono energia e tendono in un’altra direzione. La pandemia ci invita a pensare ancora di più con lo sguardo rivolto in avanti, puntando a quello che qualcuno definisce urbanismo tattico e io chiamo open urbanism. La pandemia ci invita a pensare ancora di più con lo sguardo rivolto in avanti, puntando a quello che io chiamo open urbanism L’urbanismo aperto non definisce e determina la città, come vorrebbe fare chi vede nella pandemia una spinta a isolare le persone, a suburbanizzare nuovamente la città, secondo il principio che quanto più la gente è distante, meglio sta. L’isolamento non è una cura. É una pessima soluzione, anche per la salute. Dobbiamo cercare modi e strumenti per un urbanismo più flessibile, non più rigido. Pensiamo al virus, un bersaglio in movimento che ha costantemente cambiato la propria configurazione, e alle risposte elaborate. C’è stato il momento in cui il virus è arrivato, che si trattasse dell’Italia o della Gran Bretagna, quando il lockdown era una necessità per rallentarne la diffusione, ma ora che il tasso di contagiosità è sceso abbiamo bisogno di tutta un’altra serie di strategie. La pandemia non sarà l’ultima, anche se trovassimo un vaccino. Con il mio gruppo di lavoro stiamo cercando di capire come creare città che siano più flessibili, che non debbano necessariamente chiudere, e chiudere tutto, per rispondere a un evento simile a quello affrontato. Che sappiano meglio modulare le strategie di risposta. Prima di ragionare sulle lezioni “politiche” della pandemia, ci racconta qualcuna delle ricerche condotte con il suo gruppo? Uno dei risultati delle nostre ricerche ci dice che la produttività del lavoro da casa è più bassa di quella del lavoro faccia a faccia. Non dovrebbe sorprenderci: lavorare online è un processo lineare, anche avere una discussione via Zoom lo è, perché non c’è vera interazione e comunicazione di gruppo quando ognuno è concentrato sullo schermo. La produttività deriva da complessi processi di interazione continua. Chi sostiene che non ci sia più bisogno di andare in ufficio o nell’azienda “perché tutto più essere fatto online” sostiene un’idea economicamente nociva e che aumenta le disuguaglianze sociali. Molti dei lavori della classe media possono essere trasferiti su uno schermo, ma l’immondizia non si raccoglie on- line, le case non si puliscono on-line. Chi è socialmente più in basso risulta più esposto al rischio. Una risposta che produce danni sociali non è una vera risposta.
Il pericolo più grande della pandemia è quello identificato da Giorgio Agamben: la naturalizzazione dello stato d’eccezione Dobbiamo minimizzare i rischi che a volte sono legati alla vicinanza fisica, ma conservare i benefici che derivano dallo stare insieme. Ci sono molti modi pratici per farlo. Contano gli orari di lavoro, per esempio. Se tutti vanno a lavoro e rientrano a casa nello stesso orario, ciò inevitabilmente produce affollamento, ma se cominciamo a diversificare e ridistribuire gli orari di lavoro possiamo diminuirlo. Per ora, quello rimane un “altro” modo di vivere, familiare alla classe operaia – gente che lavora di notte e che riesce comunque a mandare avanti una famiglia -, non alla classe media. Quel che chiamo open urbanism, urbanismo aperto è proprio questo: la sperimentazione delle diverse possibilità che abbiamo per costruire il nostro rapporto con la città. Un’alternativa alle risposte rigide, che spesso diventano permanenti. Anche sul piano politico, il pericolo più grande della pandemia è quello identificato da Giorgio Agamben: la naturalizzazione dello stato d’eccezione, il farsi permanente delle leggi e del controllo. Negli Stati Uniti, come reazione al terrorismo e agli attentati dell’11 settembre sono state introdotte leggi molto severe, ancora in vigore. Il pericolo oggi è reale e va scongiurato. In una società aperta l’emergenza non dovrebbe essere normalizzata, diventare permanente. Pare di capire che la pandemia abbia rafforzato ancora di più la sua convinzione – al centro di Costruire ed abitare. Etica per la città – che occorra costruire città più incomplete, con spazi non sovradeterminati nelle loro funzioni ma “ambigui”, flessibili, porosi. Eppure c’è chi oggi sostiene che la smart city – in cui forme e funzioni sono sovradeterminate a priori – sia anche più salutare, più resistente alle malattie. Come replica? Il problema non è la smart city di per sé, ma che tipo di smart city abbiamo in mente. E quale uso del potere della tecnologia. Anche qui conta molto il contrasto tra le città del Nord globale e quelle del Sud globale. In alcune città “povere” del Sud globale come Delhi o Lagos le reti di risorse e sostegno istituzionale sono piuttosto deboli nello spazio pubblico, e spesso chi ne ha bisogno riesce a ricevere assistenza solo usando il telefono, attraverso un buon uso della tecnologia, modellato sul contesto locale. Senza un telefono cellulare alcune comunità non avrebbero affatto informazioni fondamentali. Nelle cosiddette smart cities del Nord globale le tecnologie sono usate invece per il controllo e per l’isolamento, ecco perché in questo caso l’idea che le smart cities siano più salutari è un non-senso. In questo caso quel che puoi fare usando l’app giusta è non entrare mai in contatto con chi è potenzialmente esposto al Covid, in genere gente della working class, che si tratti di chi fa le pulizie in casa, di chi guida il bus, di chi raccoglie l’immondizia o di chi si prende cura dei nostri bambini. Con una app puoi evitare di entrarci in contatto. È forse smart? Non lo è, è un isolamento che diventa privilegio.
Richard Sennett, Umberto Eco, Susan Sontag La contrapposizione netta tra smart cities e città aperte dunque non mi convince, perché sembra presupporre un solo, unico uso della tecnologia. Un telefono cellulare è un pezzo di tecnologia molto diverso da una camera di sorveglianza, usata come avviene per esempio a San Paolo per evitare l’ingresso di un estraneo, uno della classe operaia in un posto che si ritiene non gli appartenga, in una “gated community”. Ma con un telefono possiamo interagire, creare, comunicare, creare una piccola rete informale online come pratica democratica. Sono entrambi strumenti tecnologici. Il problema non è la tecnologia, ma l’uso della tecnologia e il potere che deriva. Poco fa ha fatto riferimento alle tesi di Agamben sui pericoli dello stato d’eccezione. Tra gli strumenti per istituire, monitorare e far applicare lo stato d’eccezione ci sono, sempre di più, quelli tecnologici. La stessa idea di smart city è intimamente legata a un certo uso della tecnologia, tanto che in Costruire e abitare lei invita a diffidare di quella che definisce come “fantasia tecnologica”. Ritiene che nei Paesi a capitalismo neoliberale sia prioritario affrontare il “pericolo tecnologico”? Oggi il problema del capitalismo neoliberale non è la tecnologia, ma il fatto che in Paesi come gli Stati Uniti o l’Inghilterra questo capitalismo produce un welfare state così debole. Negli Usa devi essere molto ricco, e spesso bianco, per essere curato in un ospedale. Per la gente oggi è più importante questo che non lo stato della tecnologia. Il neoliberalismo ha creato società molto deboli nell’affrontare sfide ampie, complesse e difficili come quella attuale. L’Inghilterra è l’essenza del neoliberalismo in Europa ed è molto meno capace di contenere la diffusione del contagio rispetto a Paesi anche più poveri come la Grecia proprio perché ha un sistema sanitario così debole. Perché la Grecia e l’Italia, più poveri di noi, hanno svolto un lavoro migliore? Perché abbiamo disinvestito più di loro nella sfera pubblica. Quel che del neoliberalismo conta davvero sono questi
effetti. Si prenda l’esempio della Germania, più simile per benessere e per grandezza all’Inghilterra: ha fatto molto meglio perché lo Stato è più forte e più efficace in ambiti fondamentali della vita comune. Per restare ancora sul neoliberalismo: in alcuni dei suoi libri precedenti – penso per esempio ad Autorità o a La cultura del nuovo capitalismo – lei ha sostenuto che il capitalismo finanziario consente al potere di sganciarsi dall’autorità, di abdicare all’autorità e all’accountability, con una sorta di divorzio. Ora, durante la pandemia molti governi hanno guadagnato ulteriore potere, gli esecutivi sono diventati più forti e meno vincolati. Anche in questo caso all’aumento del potere corrisponderà un’abdicazione o il contesto è così particolare che i governi dovranno rispondere delle loro azioni? Un esempio paradigmatico di questo distacco e scollamento è, sfortunatamente, quello degli Stati Uniti, che non hanno dispiegato una vera e propria politica nazionale contro la pandemia e che vantano un presidente che sostiene che il virus tutto sommato non sia un suo problema, suggerendo ai cittadini di iniettarsi sostanze nelle vene. Faccio notare che i Paesi che più si contraddistinguono per una maldestra e colpevole risposta al Covid – il Brasile, gli Stati Uniti e l’Inghilterra – sono quelli in cui il potere da tempo e con più evidenza ha divorziato dall’accountability. La contrapposizione tra smart cities e città aperte non mi convince So che a molti italiani la gestione della pandemia in Italia appare pessima, ma anche il presidente del Consiglio Conte può diventare un modello di accountability se lo si compara a Boris Johnson, che andrebbe paragonato semmai a Salvini, che non ha mai reso conto delle sue scelte. Ritiene che con la pandemia i cittadini – per esempio negli Stati Uniti o in Inghilterra – siano più inclini a rivendicare la trasparenza e la coerenza dei politici, che siano più portati a chiedere conto delle scelte da loro compiute, o che tendano a delegare di più alle autorità? Sia in Brasile che negli Stati Uniti, e direi in parte anche in Inghilterra, c’è un’enorme volontà popolare mossa da uno scontento profondo e che rivendica proprio questo: trasparenza nelle decisioni dei governi, conoscere i criteri e le scelte compiute. Il problema però è come rendere trasparenti e rispondenti anche quei regimi il cui potere è sì concentrato, ma che dispongono di meno risorse. Per il gruppo delle Nazioni Unite a cui ho fatto riferimento è una questione urgente e reale, che riguarda alcuni governi africani o dell’Asia meridionale, Paesi con poche risorse e scarsa trasparenza verso i cittadini. Vista da lì è come se la sua domanda diventasse meno cruciale, o addirittura un lusso. In Thailandia, un Paese molto popoloso ma con poche risorse – ci sono pochissimi ventilatori sul territorio nazionale – come affrontiamo la questione? Più povero sei e più complicata diventa la questione, più diventa un lusso. Collaboro da molti anni con l’Onu, ma negli ultimi 4 anni il mio coinvolgimento è cresciuto e ho compreso meglio la differenza tra Nord globale e Sud globale. Ci sono alcune questioni che ci paiono urgenti in un luogo e che non lo sono in un altro. Spesso si tratta di una questione di risorse. La sfida per me è verificare come mettere in pratica le proposte avanzate nel mio libro Costruire e abitare in posti che dispongono di poche risorse materiali e in cui ci si affida di più al potere dell’immaginazione per affrontare i grandi problemi, incluso quello del sovraffollamento.
Puoi anche leggere