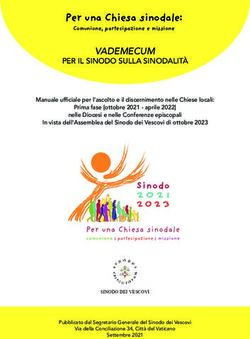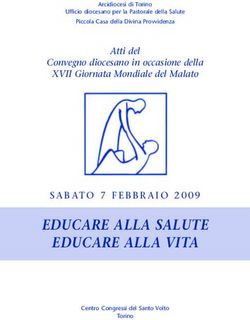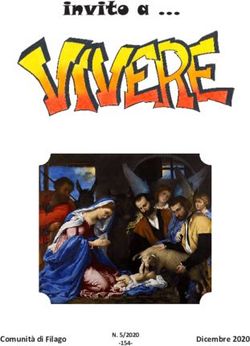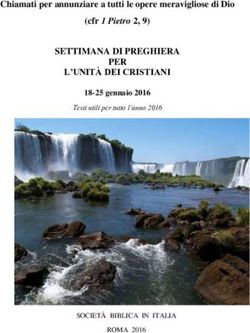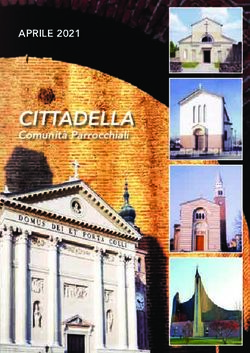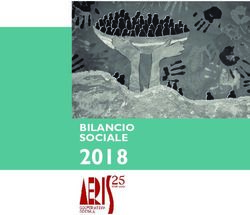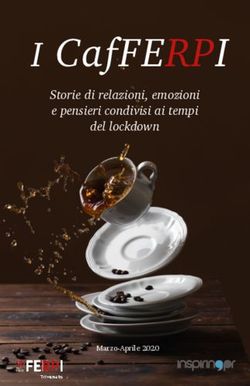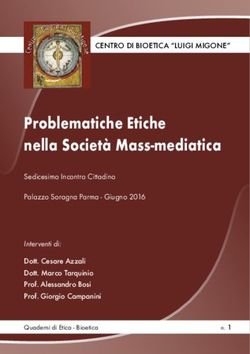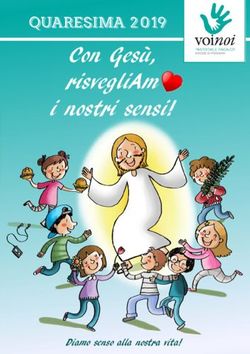Caritas diocesana pensieri, riflessioni, idee e prospettive per una accoglienza - pastorale - Caritas Reggiana
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
se mi
accogli... pensieri,
riflessioni, idee
e prospettive per
una accoglienza
pastorale
Caritas diocesana
Reggio Emilia-Guastalla
Isacco Rinaldi 1se mi accogli...
Indice 5 Introduzione Isacco Rinaldi 9 Aspetti teologico pastorali dell’accoglienza Vescovo Luciano Monari 15 Accogliere nei processi relazionali: lavorando in rete nella parzialità coinvolgendo e costruendo legami nella lettura di territori che parlano di situazioni sempre più complesse Antonella Morlini 29 Animare e formare le comunità parrocchiali all’accoglienza: dall’emergenza alla quotidianità ascoltando e accompagnando nella prevalente funzione pedagogica Valerio Corghi
Introduzione
Isacco Rinaldi
Ricorre quest’anno il 20esimo anniver- Per tutti questi motivi abbiamo pensa-
sario della morte di don Luigi Gugliel- to di dedicare a don Luigi questa pub-
mi, direttore della Caritas diocesana blicazione e per rimanere fedeli al suo
dal 1992 al 1996, che amo ricordare stile vogliamo sia sobria, essenziale,
come persona ricca di umanità e aper- ma anche vera e provocatoria.
to all’accoglienza dell’Altro. È stato per
me e per tanti altri un “maestro” di vita. Accoglienza, proprio di questo voglia-
Maestro perché ci ha testimoniato nel- mo parlare anche se oggi non è facile
la quotidianità il senso vero dell’acco- farlo. Da una parte vediamo migliaia di
glienza. persone che scappano dalla guerra e
Un uomo che si è sentito accolto dalla dalla fame in cerca di un futuro miglio-
sua famiglia e dalle tante persone che re, tante famiglie che a causa della crisi
gli hanno voluto bene, un prete che si economica perdono la casa; dall’altra i
è sentito accolto dalla Chiesa dioce- recenti fatti di Parigi e Bruxelles porta-
sana che tanto ha amato e che ha cer- no molti a chiudersi e a vedere l’altro
cato di servire fino in fondo con i suoi come un nemico, qualcuno da cui di-
doni e con i suoi limiti. Sorretto da una fendersi.
profonda spiritualità e dalla preghiera Vogliamo, quindi, fornire uno strumen-
quotidiana, ha saputo esprimere una to di approfondimento per aiutare la
vera accoglienza nei confronti delle nostra Chiesa e la nostra comunità a
persone che incontrava. Ha saputo ac- riflettere. Per farlo proponiamo una pri-
cogliere molti di noi che iniziavamo a ma riflessione teologico pastorale che
conoscere la Caritas, molti giovani che ci aiuta a guardare l’altro cercando in
attraverso l’obiezione di coscienza e il lui il volto di Dio. Una seconda riflessio-
conseguente servizio civile si lascia- ne ha maggiormente un taglio sociolo-
vano coinvolgere da proposte “alte” e gico e una terza esperienziale.
tanti “poveri” che bussavano alla porta Nella prima abbiamo chiesto al Vesco-
della Caritas o a quella della canonica vo di Brescia, Mons. Luciano Monari,
di Castellazzo. amico, confratello e compagno di don
Isacco Rinaldi 5Luigi ai tempi del seminario diocesano, ribadircelo invitandoci ad abitare le pe-
un contributo sulla relazione con l’Altro, riferie esistenziali. L’indizione del Giubi-
che ci aiuti a riscoprire quanto sia im- leo della Misericordia è una straordina-
portante essere prossimi a chi si trova ria occasione e un tempo di grazia e di
nella difficoltà. L’altro di cui vogliamo conversione personale e comunitaria
parlare è un altro molto concreto, è che ci è stata offerta per rivedere i no-
Colui che si incarna nelle persone che stri stili di vita.
incontriamo sulla nostra strada, che il A tal proposito il progetto di accoglien-
Padre ci pone sul nostro cammino. za invernale vuole aiutare le nostre co-
Spesso siamo alla ricerca di giustifica- munità parrocchiali e la cittadinanza
zioni o ci riempiamo la vita e il tempo tutta a riscoprirsi prossimo dei tanti
di cose e di impegni che non ci per- che ancora oggi non sanno dove dor-
mettono di considerare gli altri come mire o che sono vittime dei moderni
“un nostro problema”. Deve occuparse- “briganti”.
ne il Comune, il Servizio Sociale, chi è Non vogliamo solo trovare posti letto.
preposto a questo o a quel bisogno… Se questo fosse stato l’obiettivo sareb-
e così via. Queste sono le principali be stato più semplice allestire un gran-
scuse che troviamo per non accettare de dormitorio; vogliamo soprattutto
di metterci in relazione. Sicuramente offrire spazi di relazione dove ciascuno
siamo tenuti anche a richiamare chi ha, possa sentirsi accolto da qualcun altro
per responsabilità istituzionali, il dove- ed essere riconosciuto nella sua digni-
re di difendere i più poveri e bisogno- tà di persona.
si, e lo faremo con forza, ma abbiamo Gli ospiti potranno sentirsi accolti dalle
anche il dovere di interpellare le nostre parrocchie e dai volontari, ma anche
coscienze su quanto possiamo e dob- i volontari potranno vivere la stessa
biamo fare in prima persona. esperienza nei confronti di chi li ac-
Il Vangelo di Matteo (Mt 25, 31-46) ci compagna nel percorso di accoglienza
ricorda il metro con il quale saremo e anche da chi viene accolto. Ho sem-
giudicati e Papa Francesco continua a pre cara nella memoria la vicenda di
6 Isacco Rinaldiquel volontario che confrontandosi con tro”, “i problemi diventano risorsa”, ci
una delle persone ospitate gli parlava ricordano che siamo tutti in cammino e
della difficoltà nell’accudire i bambini che il percorso possiamo e dobbiamo
durante il pomeriggio finita la scuola e farlo insieme facendoci carico gli uni
di come, attraverso questa relazione, degli altri perché siamo tutti figli dello
fu proprio l’ospite ad offrirsi per tener- stesso Padre.
glieli. E da questo nacque una bella re- Infine, ma non per ultimo, abbiamo in-
lazione che persiste tuttora. serito una testimonianza in merito a
Se abbiamo il coraggio di aprirci agli questi anni di accoglienza invernale, te-
altri il Signore ci concede grandi doni stimonianza di chi, insieme a tanti altri,
e ci fa scoprire tutti bisognosi gli uni si è messo in gioco dedicando cuore
degli altri. e tempo alle parrocchie e ai volontari,
cercando con assiduità e coerenza la
In questi anni ci siamo resi conto che collaborazione con tutti: servizi sociali,
le situazioni che incontriamo sono terzo settore, associazioni di volonta-
sempre più complesse e le risorse non riato e semplici cittadini.
sono infinite. Questo ci chiede di ripen-
sare alle nostre modalità di sostegno e Nel riflettere su questa tematica mi
aiuto alle persone cui vogliamo dare un pongo, però, anche interrogativi che
aiuto. La dottoressa Morlini, che in que- vorrei condividere con chi ha respon-
sti anni ci ha accompagnato in diversi sabilità ecclesiali e di governo della
cammini formativi, ci aiuta in modo nostra città.
laico, ma profondamente cristiano, ad Vediamo tante persone che transitano
approfondire alcuni aspetti dell’acco- per l’accoglienza invernale da diversi
glienza, fornendoci spunti di riflessio- anni… Possiamo e dobbiamo consi-
ne e piste di lavoro molto affascinanti derarli “cronici” e ci rassegniamo a ri-
e altrettanto praticabili. Alcuni termini trovarceli tutti gli anni il 1° dicembre
come “limiti”, “tempo”, “saper aspetta- all’apertura del nuovo progetto di ac-
re”, “aprirsi alle reali possibilità dell’al- coglienza invernale o abbiamo il corag-
Isacco Rinaldi 7gio di intraprendere nuovi percorsi per
far loro recuperare la dignità dei figli di
Dio?
Molte delle persone che vivono ai mar-
gini ormai non riescono più a trovare, o
forse neanche a cercarselo, un lavoro.
Ci rassegniamo di fronte ai fallimenti
o li rimettiamo al centro della politica
e della pastorale del nostro territorio e
con loro ripartiamo?
Potranno sembrare utopie, ma io vo-
glio continuare a sognare e a lavorare
per far sì che nessuno possa essere
considerato “cronico” o “senza spe-
ranza” e che le nostre comunità civili
ed ecclesiali non si chiudano all’acco-
glienza dell’Altro.
Penso che questa sia l’eredità che don
Luigi ci ha lasciato e auspico ci sia an-
cora chi ha il coraggio di lanciarsi in
questa affascinante avventura.
Isacco Rinaldi
8 Isacco RinaldiAspetti teologico pastorali dell’accoglienza
Vescovo Luciano Monari
VA’ E ANCHE TU FA’ LO STESSO stesso. Avesse rifiutato ogni attenzio-
ne ai suoi stessi bisogni, avesse odiato
Il messaggio della parabola del buon la sua vita così tanto da non fare nulla
Samaritano (Lc 10,29-37) sta essen- per mantenerla, avrebbe già cessato di
zialmente nel mutamento del concet- vivere. Ciascuno di noi, dunque, deve ri-
to di prossimo che essa promuove. Si conoscere di avere ‘amato’, almeno ini-
legge nel libro del Levitico il comanda- zialmente, la sua vita, di averla nutrita,
mento: “ama il prossimo tuo come te protetta e difesa.
stesso” (Lv 19,18) e ci si chiede che Il comandamento chiede di allargare
cosa significhi un tale comando. Si questa attenzione e cura anche ad al-
suppone, evidentemente, l’amore per tre persone. Ci si può chiedere il perché
se stesso; si riconosce questo ‘amore di un tale precetto. Gli altri non sono
di sé’ come cosa buona e si chiede di me stesso; amare me stesso non s’i-
allargare la cerchia dell’amore inclu- dentifica con l’amare gli altri. Perché se
dendo in essa anche altre persone, ap- io amo me stesso dovrei amare anche
punto ‘il prossimo’. degli altri? Se mi fermo al fatto di ‘ave-
Che l’uomo ami se stesso, come di- re’ la vita, l’allargamento dell’amore non
cevamo, è dato per scontato come segue necessariamente; se invece fer-
fosse una verità evidente per se stes- mo l’attenzione sul fatto che ho ricevu-
sa. Forse qualche psicologo avrebbe to la vita come ‘dono’, cioè come un pa-
qualcosa da precisare, ma il testo è trimonio non meritato, anzi nemmeno
sufficientemente chiaro: ogni essere meritabile, allora la riflessione si apre.
vivente tende a difendere e prolungare Ho ricevuto la vita dai miei genitori (è il
la sua vita; è un impulso naturale che fatto evidente) e la vita che ho ricevuto
spinge a soddisfare i bisogni essenzia- è un patrimonio che valuto positivo (al-
li, a opporsi alle minacce, a desiderare trimenti l’avrei rifiutata); questi due fatti
il meglio per se stessi. Fino che una insieme fondano un dovere di ricono-
persona umana vive, ciò significa im- scenza verso coloro che mi hanno dato
plicitamente che si è preso cura di se la vita, verso i genitori. Solo verso i miei
Vescovo Luciano Monari 9genitori? No; anche i miei genitori han- rispondere subito: tutti gli uomini. Ma no ricevuto la vita nello stesso modo e questa sarebbe una risposta astratta quindi debbono essere a loro volta rico- perché la mia vita non è immediata- noscenti: è il complesso della società a mente in contatto con tutti gli uomini diventare il riferimento necessario del- e quindi l’amore per l’umanità intera la riconoscenza perché la vita dei sin- è più una benevolenza di sentimento goli può sorgere e mantenersi solo nel che una responsabilità concreta. Se complesso della società. A sua volta la voglio dare un contenuto effettivo al società può esistere e svilupparsi solo termine ‘prossimo’ devo staccare all’in- nel contesto del cosmo intero con le terno dell’insieme di tutti gli uomini un sue leggi, possibilità e limiti. Insomma, sottoinsieme che contenga solo alcu- per il fatto che vivo e amo la mia vita ho ni soggetti e che possa essere inteso un debito di riconoscenza nei confron- come appello pressante al mio impe- ti della mia famiglia, della società, del gno, alla mia azione. mondo, di tutto ciò che esiste. Il modo in cui lo scriba pone la doman- Da qui il debito nel confronti di un pros- da è già indicativo: “Chi è il mio pros- simo: nei confronti dei miei genitori, simo?” S’intende: io sono il centro del evidentemente, perché la vita ha per mio mondo – il mondo dei miei pen- me anzitutto i lineamenti del loro vol- sieri, dei miei desideri, delle mie azioni. to, del loro amore; ma inevitabilmente Attorno a me si stende il territorio am- anche nei confronti di coloro che sono plissimo dove gli uomini vivono, alcuni strettamente uniti ai miei genitori. Non vicino a me, altri lontani da me; alcuni potrei evidentemente amare i miei ge- parlano la mia lingua, altri parlano lin- nitori se non amassi anche coloro che gue più o meno incomprensibili; alcuni ai miei genitori sono legati. La chiama- condividono interessi con me, altri mi ta all’amore comincia così ad allargar- sono estranei o addirittura concorren- si. Fin dove? Questa è la domanda che ti; riesco a comprendere abbastanza lo scriba pone a Gesù quando chiede: bene gli ideali che muovono alcuni, ma “Chi è il mio prossimo?” Potrei anche faccio fatica a entrare nelle mentalità 10 Vescovo Luciano Monari
di altre persone. All’interno di questo lo scopo della definizione è assumere
territorio complesso, dove si colloca la una di queste possibilità ed escludere
linea, che sarà anche sottile ma deve tutte le altre in modo che il concetto di
essere chiara, che distingue il prossi- prossimo rimanga ben definito e che
mo dal remoto? che quindi fissa il mio quindi l’estensione del mio obbligo di
dovere di amare in modo concreto ed amare abbia un contenuto concreto
effettivo? Certo, posso amare tutti ma e preciso – che non si allarghi troppo
solo in modo verbale o sentimenta- (perché allora diventerebbe un obbligo
le; voglio sapere chi debbo amare in solo mentale) e non si restringa troppo
modo effettivo, in modo da coinvolgere (perché allora rischierebbe di indentifi-
le mie azioni, i miei programmi di vita. carsi con l’impulso naturale ad amare
A questa domanda Gesù non rispon- se stesso e diventerebbe inutile per la
de con una ‘definizione’ del prossimo. formazione della società).
Una definizione è una delimitazione Il pasticcio nasce quando ascoltiamo la
di confine; serve a distinguere chi è risposta di Gesù. Gesù non dà una defi-
dentro da chi è fuori; una buona defi- nizione tecnica del prossimo; risponde
nizione del ‘prossimo’ deve compren- invece narrando una parabola. Ora, se
dere tutti quelli che sono prossimi e c’è qualcosa di difficile da afferrare è
deve escludere tutti quelli che non lo una definizione di mezzo a un raccon-
sono. Possiamo ipotizzare: sono pros- to. La definizione è fissa, stabile, vale
simi tutti i miei parenti e affini fino al sempre e dovunque; il racconto è mo-
grado ‘x’ di parentela o affinità; oppu- bile, dinamico; anche quando è pignolo
re: sono prossimi tutti i cittadini della nella descrizione dei particolari lascia
mia città, o della mia provincia, o della sempre dei buchi che debbono essere
mia regione, o del mio stato…; oppure: riempiti dall’immaginazione dell’ascol-
sono prossimi tutti coloro che parlano tatore. Sembra che il racconto sia il ge-
o comprendono la mia lingua, tutti co- nere letterario meno adatto per definire
loro che condividono la mia religione, la un concetto; eppure Gesù qui, come in
mia etnia… Le possibilità sono infinite e altri casi, usa la parabola. Un passante
Vescovo Luciano Monari 11assalito dai briganti, spogliato dei suoi sul perché il sacerdote e il levita non si averi, colpito a sangue, abbandonato siano fermati a curare il ferito sono sta- lungo la strada… un sacerdote e un le- te immaginate delle risposte: se il ferito vita che passano, vedono e continuano fosse morto, sacerdote o levita avreb- il cammino… un Samaritano che vede, bero contratto un’impurità rituale e non prova compassione, si avvicina, cura, avrebbero potuto fare il loro servizio porta all’osteria… Non c’è dubbio che la nel Tempio; oppure: avevano urgenza narrazione vuole contrapporre il com- proprio perché dovevano svolgere un portamento del Samaritano a quello servizio liturgico…; tutte risposte possi- del sacerdote e del levita; e vuole, la pa- bili, ma evidentemente ipotetiche, che rabola, che gli ascoltatori diano ragione stanno fuori del racconto. Il racconto al Samaritano e diano torto ai due reli- suppone invece che queste due per- giosi. E così di fatto avviene. Quando sone abbiano valutato il ferito come Gesù chiede allo scriba: “Chi di questi non-prossimo e abbiano pensato che tre ti sembra sia stato il prossimo di un loro intervento non fosse richiesto colui che è incappato nei briganti?” la dal comandamento. Non si può pensa- risposta dello scriba riassume la rispo- re, infatti, che un sacerdote non ricor- sta di ogni ascoltatore attento: “Chi ha dasse il comandamento del Levitico o avuto compassione di lui.” che volontariamente lo volesse violare. Abbiamo allora la risposta al nostro Dunque tre persone passano accan- quesito? Sappiamo ora chi è il nostro to a un ferito; due non lo considerano prossimo? Sì e no. Sì, perché abbiamo prossimo e non se ne prendono cura, davanti ai nostri occhi l’esempio di uno uno invece prova compassione e ‘si fa (il Samaritano) che ha usato compas- vicino’ (il racconto usa proprio questa sione nei confronti di un ferito, che espressione!) e con il suo comporta- quindi lo ha amato come suo prossi- mento lo fa vivere. mo. No, perché non ci sono elencati (o A questo punto non so definire con definiti) i casi in cui questo comporta- precisione chi sia prossimo o remoto; mento diventa doveroso. Alla domanda so però come si diventa prossimi di chi 12 Vescovo Luciano Monari
è ferito: anzitutto con la compassione, so che in un modo o nell’altro si trova
poi un comportamento efficace che sul nostro cammino. Le altre qualifiche
cura. Il ferito era stato lasciato dai bri- non contano: l’età, la razza, la religione,
ganti ‘mezzo morto’ e cioè sul crinale l’appartenenza politica… tutte queste
sottile che separa la vita dalla morte. cose, che sono così importanti nella
Con il suo comportamento il Samari- vita sociale, sono irrilevanti quando
tano ha detto a quel ferito: “Io voglio si tratta dell’amore del prossimo. Qui
che tu viva”; in questo modo lui, che quello che conta è solo il bisogno re-
all’inizio era un lontano (i Samaritani ale di qualcuno e la volontà di aiuto di
appaiono tali agli occhi dei Giudei), si qualcun altro.
è fatto prossimo, ha superato la barrie- Non c’è bisogno di spiegare che un
ra che separa prossimo e remoto e ha racconto di questo genere è fecondo
compiuto l’opera efficace dell’amore. sempre, ma in modo particolare quan-
Un racconto di questo genere è nar- do si incrociano etnie diverse, religioni
rato non per rispondere esattamente diverse, culture diverse. Chi è il mio
alla domanda etica su chi sia il pros- prossimo? Dove posso fermare il mio
simo di qualcuno, ma per provocare interesse e la mia preoccupazione? La
un atteggiamento di compassione che parabola dice: abbi compassione e di-
superi tutti i confini e giunga a costrui- venta prossimo. Nessuno di noi riuscirà
re legami di prossimità, quei legami di a farsi prossimo di tutti i bisognosi che
cui c’è bisogno perché l’uomo possa incontra sulla sua strada; ma ciascuno
vivere. Ci sono nel mondo situazioni di noi crescerà in umanità nella misura
di debolezza, di bisogno, di malattia, di in cui dilaterà la sua attenzione e la sua
pericolo; queste situazioni incrociano azione efficace. Se provi compassione,
l’esperienza quotidiana di molti. Eb- ti fai vicino; se ti fai vicino, impari a pro-
bene, il comandamento di Dio è invito vare compassione; se provi un po’ più
pressante a farsi vicino all’uomo e ad di compassione, ti farai un po’ più vici-
usare la propria forza per fare vivere. no… Il processo di civilizzazione va in
A quale uomo? Al debole, al bisogno- questa direzione. Il processo opposto,
Vescovo Luciano Monari 13quello che ritira la compassione e quin- struire umilmente giorno per giorno un di il gesto di vicinanza va invece nella futuro che possa essere ancora umano direzione di una minore umanità – e e che non potrà essere umano senza quindi anche di una minore gioia. compassione. È comprensibile che rimaniamo sor- Questo mi è venuto da pensare quando presi dai cambiamenti che avvengo- mi è stata chiesta una riflessione che no oggi negli insediamenti umani; è richiamasse don Gigi Guglielmi. Io lo comprensibile anche che salgano dal ricordo così: un prete capace di aprire cuore sentimenti ambigui, risentimenti il cuore a tutte le situazioni di bisogno aggressivi. Ma non è degno dell’uomo umano, capace di perdonare e aiutare. lasciarsi dominare da questi sentimen- Credo si debba dire anche: un prete per ti; degno dell’uomo è imparare a prova- il futuro che abbiamo davanti; impara- re compassione; degno della società re da lui significa essere un poco più degli uomini è diventare gli uni per gli attrezzati per quanto dovremo vivere. altri sostegno e difesa. Il futuro sarà profondamente diverso dal presen- te. Quasi tutti gli indici di incremento Vescovo Luciano Monari demografico riferiti all’Europa sono negativi; e tutti gli indici negativi sono riferiti all’Europa (con l’eccezione del Giappone). È pura illusione pensare che questa situazione non si tradurrà in una trasformazione demografica epocale, una vera e propria rivoluzione. Si possono deplorare i fatti, accusare i colpevoli, ma sono tutti atteggiamenti sterili. Vale la pena, invece, immagina- re le risposte migliori a questa sfida, portare il peso che essa comporta, co- 14 Vescovo Luciano Monari
Accogliere le persone nei differenti
percorsi: lavorando in rete, nella parzialitá,
coinvolgendo e costruendo legami,
nella lettura di territori che parlano
di situazioni sempre più complesse
Antonella Morlini
1. CHE COSA SIGNIFICA
ACCOGLIERE?
Mi è cara l’accoglienza perché solle- di freddezza. Nei processi di accoglien-
cita la riflessione e l’azione aprendo za i tratti emotivi, personali prendono
all’incontro con differenti persone, tempo, energie e rischiano di avere
situazioni, esperienze. Il movimento il sopravvento rispetto alla ricerca di
dell’accoglienza impegna i pensieri, le comprensioni articolate riguardo alle
scelte, interpella le paure più profonde, situazioni di realtà. Accogliere significa
può incoraggiare slanci e collaborazio- anche accettare, approvare una pro-
ni inattese. Il significato riconduce a posta, un orientamento: ricomprende
sguardi molteplici: riceviamo qualcuno la scelta, il criterio, le ipotesi che ci ac-
“con varia disposizione d’animo”, emo- compagnano, evidenzia il contatto con
tivamente possiamo sentirci propensi la responsabilità personale, di gruppo
e vicini alle persone che incontreremo, e sociale. Nell’accoglienza c’è il signi-
con le quali cercheremo di sviluppare ficato ulteriore di contenere: un teatro,
un tratto di percorso, oppure percepia- ad esempio, può accogliere 200 perso-
mo distanza, spaesamento, difficoltà. ne, non di più, oppure un’aula scolasti-
L’impatto emotivo è in primo piano, ca contiene fino ad un massimo di 30
può aprire a relazioni di immediata alunni. Il senso del contenere restitui-
empatia, può acuire il senso di paura,15 sce all’accoglienza il suo limite: di spa-
Antonella Morlini 15zio, di tempo, forse anche di energie responsabili di enti, aziende, organizza-
emotive, di risorse economiche, socia- zioni: il valore e il riconoscimento che
li. Il significato riflessivo “accogliersi” riusciamo a offrirci, la collaborazione
apre all’idea di radunarsi, riunirsi, quin- che apprendiamo a costruire possono
di riconoscersi gli uni con gli altri, in un diventare approdi strategici e significa-
senso sociale, comunitario. C’è anche tivi. Che cosa implica il contatto, l’in-
il valore di “accogliere sé”, nel senso terazione con persone di culture diffe-
di raccogliersi in preghiera, in medi- renti, in situazione di difficoltà, disagio
tazione, alla ricerca di un contatto più psicofisico e/o sociale? Quali attenzio-
approfondito con noi stessi, con quel- ni, orientamenti possono sostenerci
lo che sentiamo, pensiamo, cogliamo. nella comprensione delle complesse
L’accogliersi tiene insieme tratti perso- realtà di vita che incontriamo? Il primo
nali e sociali, il riconoscimento di sé fatto impegnativo e forse anche inten-
e degli altri interlocutori, la riflessività so, curioso è proprio questo: le persone
soggettiva e di gruppo. possiamo vederle, cercare di interagire
I significati dell’accogliere e dell’ac- con loro per come sono, per come rie-
cogliersi ci restituiscono tratti di lavoro scono a parlare, a urlare, a ripiegarsi
impegnativi e differenziati: la relazione su loro stesse senza apparenti energie
con le persone che accogliamo e con per esprimersi. Le donne e gli uomini
gli altri soggetti, gruppi, istituzioni, or- che incontriamo nei percorsi di acco-
ganizzazioni che insieme a noi accol- glienza sollecitano interventi rapidi,
gono; il contatto con percezioni, vissuti ampi, risolutivi perché le problematiche
molteplici, unitamente a percorsi deli- sembrano evidenti: difficoltà economi-
mitati da progettare, accompagnare e che, familiari, relazionali, fisiche e/o
sostenere nei contesti sociali territoria- psicosociali. I bisogni ci paiono chiari e
li. L’esperienza dell’accoglienza ci impe- servono tante risorse per riuscire a so-
gna personalmente, eppure si realizza stenere le persone, le famiglie. Rischia-
sempre in relazione con altre persone, mo di muoverci in modo decisamente
volontari/e, professionisti/e dei servizi, lineare, meccanicistico, problema –
16 Antonella Morlinisoluzione, trascurando la complessità compagnare le persone che chiedono
della situazione, dei contenuti e le reali ascolto, accoglienza.
possibilità dei servizi, delle associa- Si tratta di una parzialità che si
zioni, dei gruppi. I problemi, le risorse colloca in contatto con la complessità
sono, probabilmente, da esplorare, da delle situazioni, non di un movimento
approfondire con le persone, proprio superficiale orientato all’impegnarsi
con loro possiamo apprendere a cono- poco a fondo.
scerci, a riconoscerci per costruire un Nella parzialità riconosciamo al
tratto di ascolto e di possibile progetto. soggetto e ai differenti interlocutori
Se ci lasciamo prendere dall’urgenza di del territorio un valore, una funzione,
risolvere, dalla rabbia perché non pos- una reciprocità, da progettare e co-
siamo dare né fare tanto, se coltiviamo, struire. L’approccio parziale accoglie il
anche inconsapevolmente, l’onnipo- potere delle persone, dei gruppi, delle
tenza, rischiamo di perdere la lucidità organizzazioni, inteso come influen-
strategica, sostituendoci alla persona, zamento, contributo di idee, di culture
in nome del suo “presunto bene”. I pro- differenti, di tratti faticosi unitamente a
cessi dell’accoglienza sono necessa- slanci prepositivi. Non si tratta di subi-
riamente parziali: c’è la nostra parte e re la forza, i contenuti distruttivi degli
quella delle donne e degli uomini che interlocutori, ricerchiamo, piuttosto, un
incontriamo, le problematiche si sono ascolto attivo e progettuale, una com-
formate negli anni, esprimono la storia prensione più approfondita dei proble-
di vita delle persone, proprio per questo mi e delle risorse, uno sguardo stra-
la conoscenza non può essere imme- tegico che si muove nel possibile, al
diata, abbiamo bisogno di approfondi- riparo da idealizzazioni generali e pre-
re le ragioni, la consistenza dei disagi, costituite. Ad esempio: un uomo Mol-
dei fatti critici, delle fragilità di relazioni davo può rivolgersi alla Caritas perché
affettive, sociali. Solo accogliendo la cerca un posto per dormire, non ha i do-
nostra parte come parziale possiamo cumenti, alterna tratti di lucidità a mo-
17
apprendere a vedere, riconoscere, ac- menti di confusione e disorientamento,
Antonella Morlini 17ogni tanto va alla mensa, è conosciuto rispetto alle problematiche in primo da un centro di ascolto parrocchiale piano, aprendo alla necessità di colla- dove in passato andava a chiedere soldi borare, di interagire con altri volontari, e vestiti. L’approccio parziale quali mo- operatori, responsabili, amministratori. vimenti incoraggia? Un colloquio di ap- Non ci è chiesto di soddisfare la totalità profondimento, il contatto con il servizio delle esigenze, obiettivo peraltro non re- sociale territoriale, il confronto con i vo- alistico, bensì di approfondire e iniziare lontari della parrocchia, unitamente alla a costruire in relazione con una parte ricerca di un posto letto, di un alloggio di problematica, di risorsa, di vita della condiviso, temporaneo. Alcune azioni persona, della famiglia. L’avvio parziale saranno possibili nell’arco di alcuni gior- del percorso favorirà l’emergere di altre ni, altre richiederanno tempi più lunghi. esperienze, difficoltà e potenzialità, nel Non per questo siamo inconcludenti, divenire del lavoro, del progetto, dell’in- anzi, abbiamo iniziato a conoscere e ad contro avremo la possibilità di cogliere i agire, riconoscendo le differenti parti di tratti di fissità, di tenuta, di investimento lavoro, i possibili interlocutori. L’approc- nella prospettiva, di paura riguardo al cio parziale implica porsi al servizio del presente. Come si colloca l’approccio percorso con la persona, la famiglia, i parziale in contatto con persone, si- soggetti della comunità territoriale, nei tuazioni differenti? L’emergere di altre processi di progettazione e di lavoro identità, culture è accolto in relazione rintracciamo qualche bandolo di com- con le nostre idee, approcci alla vita, alla prensione strategica. Non è di aiuto fare convivenza. Nell’interazione rintraccia- l’elenco particolareggiato dei bisogni mo la possibilità di esplicitare le ragioni della persona Moldava, diventa utile, che sostengono il modo di pensare e di piuttosto, iniziare a esplorare una parte agire. Siamo parziali, ma non ripiegati di problema, valutando le risorse della né impauriti, investiamo nella relazio- persona, del contesto, in relazione con ne che apre ad un possibile contatto di il percorso possibile. Lo sguardo par- comprensione e di costruzione proget- ziale ci fa vedere che cosa c’è di altro tuale. 18 Antonella Morlini
1. QUAL È IL VALORE E L’UTILITÀ ad esplorarle. L’obiettivo non è ricevere
DEL LIMITE? delle risposte precise ed esaurienti, si
tratta, piuttosto, di apprendere a incon-
Il confine, il limite ci appaiono spesso trare il limite della signora, il contenuto
come ostacoli da superare, come linee è proprio questo: il contatto con il suo
di demarcazione incomprensibili e in- sé non è possibile, però parla volentie-
sensate. Si tratta di un pensiero che na- ri, cerca un posto dove andare. Il senso
sce, forse, dalla paura di erigere muri, del limite diventa espressione del ri-
separazioni tra le persone, i gruppi, i conoscimento dell’altra persona, delle
popoli, oppure dall’idea che senza de- sue risorse, delle problematiche evi-
limitazioni siamo liberi di fare quello denti, dell’avvio possibile di un interven-
che ci pare buono e utile. Mi pare che to, di un confronto, quindi del percorso.
il senso del limite possa essere inteso Anche il nostro di limite è significativo:
anche come fatto che esprime il nostro ci sentiamo affaticati/e a comunicare
e l’altrui confine, quale spazio che dice che cosa possiamo offrire e che cosa,
di noi e delle persone che accogliamo. invece, non è possibile costruire, abbia-
Nel limite c’è innanzi tutto la percezione mo segnalato la necessità di rivolgersi
della fisionomia delle persone, dei loro ai servizi socio-sanitari della Azienda
percorsi, delle esperienze significati- USL, ma non è stato colto. Che cosa ne
ve che hanno contribuito a formarle. facciamo di queste percezioni, dei con-
Se una donna in situazione di disagio tenuti che emergono nelle interazioni?
psicosociale racconta di sé contenuti Cerchiamo di renderli utili: forse c’è
sempre diversi e scarsamente atten- bisogno di un altro incontro per appro-
dibili ci sta presentando il suo limite: fondire, forse possiamo chiedere alle/
forse è disorientata o ha paura, proba- ai professioniste/i del servizio sociale
bilmente non riesce a stare in contatto territoriale se conoscono la persona o
con se stessa e con le altre persone, qualche altro componente del nucleo
le ragioni non le conosciamo, possia- familiare, probabilmente possiamo
19
mo iniziare, sia pure faticosamente, scrivere i principali contenuti emersi e
Antonella Morlini 19riprenderli in mano dopo qualche gior- cogliamo o degli altri soggetti del ter-
no con un/una collega dell’équipe, del ritorio: “Quella” signora non sa fare la
gruppo di volontariato. Nello spazio del spesa, quante volte le abbiamo detto di
limite, del confine c’è il contenuto più acquistare i beni di prima necessità per
impegnativo e quindi utile per avvia- lei e i figli. E noi continuiamo ad assi-
re qualche tratto di progettazione, di sterla? Ha valore quello che facciamo o
lavoro. Spesso il limite ci infastidisce dobbiamo interrompere il sostegno?”;
perché vorremmo mettere da parte la “Il signor M. potrebbe lavorare, è sano e
fatica di pensiero, di rielaborazione che noi ci siamo fatti in quattro per trovargli
l’incontro, l’accoglienza delle persone una occupazione temporanea in quella
portano con sé, eppure in questo in- impresa agricola, ci siamo tanto racco-
terrogarsi un po’ più a fondo possiamo mandati con lui perché andasse e non
rintracciare lo spessore umano, emoti- ci facesse fare una brutta figura, invece
vo, sociale, del servizio, dell’impegno: si è dato malato dopo due giorni, è un
allarghiamo gli orizzonti di conoscen- fannullone!”. “Noi siamo dei volontari e
za dei contesti di vita, accresciamo la facciamo tutto il possibile con spirito
comprensione delle situazioni di realtà, di servizio e in piena gratuità, perché il
investiamo nella ricerca di inediti con- comune, l’Azienda USL sono così lenti
fronti, interazioni progettuali nel terri- e burocratici nei loro percorsi?” Il limi-
torio. Il limite – confine può diventare te degli interlocutori rischia di apparirci
spazio percorribile con altre persone, ingiustificato, se non ci fosse potrem-
gruppi, organizzazioni, istituzioni, un mo realizzare pienamente gli obiettivi
terreno scomodo, disarmonico, eppure prefissati, eppure questo approccio
ricco di potenzialità, di sviluppi. porta alla deriva, sviluppa accanimen-
Il limite può anche essere inteso to, rabbia, la presunzione di essere nel
quale riconoscimento del possibile, del giusto, perché a sbagliare sono le altre
pensabile, del fattibile. In questo senso persone. Ci sono dei fatti, delle situa-
possiamo patire la limitazione e rin- zioni che non sono affrontabili offren-
correre le “colpe” delle persone che ac- do risorse adeguate e tenuta, di certo è
20 Antonella Morliniun movimento importante e costruttivo lazione delle ipotesi, delle problemati-
ma non basta. La comprensione delle che, delle risorse. Ciascun interlocuto-
persone si sviluppa lentamente, con re ha dei limiti, è naturale, proprio per
tanti limiti, i tempi di maturazione sono questa ragione abbiamo bisogno di
diversi dalle nostre attese, il rischio di riconoscerli, di esplicitarli, di renderli
cronicità, di fissità è alto, ciò nonostan- utili e progettuali. Solo vedendo la fra-
te qualche tratto di interazione c’è e gilità, la limitazione quali parti ineludi-
delle parziali acquisizioni si affacciano. bili dell’impegno, del lavoro dell’acco-
Il contatto con il limite delle persone, glienza possiamo porci al servizio dei
dei gruppi, delle organizzazioni ci fa molteplici e complessi percorsi, in una
vedere che cosa è possibile proporre, a relazione esplicita, di contenuto con i
quali risorse possiamo fare riferimen- differenti interlocutori. Nell’accoglienza
to, con quale strategia intraprendere il c’è il limite quale misura delle energie,
percorso. L’accoglienza del limite non delle risorse, delle prospettive che con
vuole dire accontentarsi, bensì aprirsi le persone possiamo immaginare e co-
alle reali possibilità delle persone, del struire. Perché i limiti sono visti come
contesto, alla ricerca degli spazi pos- impedimenti, blocchi e non come con-
sibili di azione. Il possibile non è già tenuto che appartiene alle persone, alle
dato e non risponde alle nostre attese, organizzazioni? D’impatto vorremmo
è, piuttosto, l’esito delle interazioni che eliminarli, sembra innaturale ricercare
costruiamo sia con le persone accolte le ragioni dei limiti, le circostanze che
sia con i differenti soggetti pubblici e li hanno rafforzati, il senso di impoten-
di privato sociale, emerge piano piano za e quindi anche quello di potenza
dal lavoro di tessitura, di approfondi- rischiano di avere il sopravvento, al-
mento, di progettazione che insieme lontanandoci dalle situazioni di realtà,
intraprendiamo. In questo senso il limi- dalla loro complessità. Se accogliamo
te non è semplicemente limitante, apre le ragioni che hanno prodotto i limiti
alla individuazione degli spazi possibili possiamo più lucidamente intravedere
21
di dialogo, di confronto, di messa in re- le collaborazioni possibili, i problemi
Antonella Morlini 21non affrontabili nell’immediato, diven- sta lavorando per inserirlo in un gruppo ta interessante interagire con sogget- terapeutico. L’osservazione prosegue, il ti distanti dalle nostre visioni sociali, dialogo con i vicini e i volontari c’è, ad emotive. Ad esempio: una mamma oggi l’allontanamento della mamma e con due bambini di 6 e 2 anni è stata dei due bambini non sembra urgente. maltrattata dal marito, i vicini di casa Se abbiamo già in mente la soluzione preoccupati fanno la segnalazione, il gli interlocutori sono limitati e inadem- servizio sociale interviene e cerca di pienti, se cogliamo le ragioni delle scel- capire la situazione. Anche i volontari te, dei movimenti progettuali possimo si fanno vivi perché sono preoccupati apprendere a interagire, a collaborare. per la tenuta economica, sociale, edu- cativa della famiglia. Passati dieci gior- ni i vicini di casa e i volontari diventano 1.2 CHE COSA È RISORSA impazienti: “Perché il servizio sociale NEI PERCORSI DI ACCOGLIENZA? non interviene mettendo la mamma e i due bambini in comunità di accoglien- La principale risorsa è la problematica za? Aspettano che lo sfratto diventi della persona, della famiglia, nelle diffi- esecutivo, che il marito faccia un ge- coltà, nei disagi, nelle asperità di vita ci sto disperato e tragico?”. Il limite degli sono anche gli esili bandoli per riappro- interlocutori apre al giudizio serrato e priarsi del cammino, del senso, delle perentorio, se invece approfondiamo potenzialità sepolte. Nello stare male, le ragioni comprendiamo qualche trat- se accogliamo di entrare in contatto to del percorso: il servizio sociale ha con altri soggetti, interlocutori, abbia- già realizzato due incontri domiciliari, mo la possibilità di comprendere, di so- i bambini sono sostenuti e accompa- stenere, di cogliere qualche appiglio gnati alla scuola primaria e al nido, la affettivo, relazionale, sociale. La possi- signora ha iniziato un corso di italiano, bilità di stare sufficientemente bene è il marito si è messo a bere da quando spesso una conquista, non un punto di ha perso il lavoro, l’assistente sociale partenza, emerge dall’attraversamento 22 Antonella Morlini
di tratti di complessità, che aprono a perché non risolvono l’impossibile, ma
risorse personali inattese. La difficoltà affrontano il possibile, perché non ali-
non può essere illusoriamente rimos- mentano fantasie onnipotenti, ma so-
sa, eliminata, può diventare più affer- stengono, accompagnano momenti di
rabile, perché contenuta, ricompresa, realtà, nel mondo, con interlocutori affi-
parzialmente condivisa. Il disagio dabili. E allora i problemi diventano la
esprime le fragilità, le cronicità delle nostra essenziale risorsa, perché ri-
persone accolte e anche le passioni, le comprendono la complessità delle per-
esigenze più profonde, le paure che sone, non solo l’evidente malessere, il
possono essere raccontate e vissute, comportamento aggressivo e sfidante.
senza rimanerne tramortite/i. La fatica In contatto con le problematiche i ser-
di vivere sembra prendere totalmente vizi, le équipe, i gruppi di volontariato
le donne, gli uomini che incontriamo, il apprendono ad interagire, a costruire i
dolore balza agli occhi e prende consi- percorsi di accoglienza: ricostruendo,
stenza nei racconti che le persone fan- sia pure parzialmente, la storia di vita
no. L’ascolto comprensivo ed elaborati- delle persone; individuando una risorsa
vo restituisce alla persona il valore, il relazionale, educativa, economica che
fatto che la sua vita non coincide inte- possa sostenere ma non assistere
ramente con il disagio, la sofferenza, la completamente, con il rischio di impo-
frustrazione per lo stato economico, verire le energie potenziali delle donne,
sociale in cui si trova, così il percorso degli uomini, delle famiglie; valutando
può iniziare, tra pretese e riconosci- le risorse informali attivabili affinché le
menti, tra rabbie e senso di realtà, tra persone non si sentano troppo sole; va-
fiducia e impossibilità a capire. La ric- lorizzando le tante iniziative sociali,
chezza delle potenzialità è in questi istruttive, culturali offerte dalla comu-
ambivalenti tratti di lavoro, la possibili- nità territorio. Non si tratta di trasfor-
tà d’intravedere uno spiraglio rinnovato mare i vincoli in risorse bensì di rintrac-
di vita emerge da questi confronti diffi- ciare nei problemi le parti utili di
23
cili, inconcludenti, eppure significativi, conoscenza, di sensibilità, di intrapren-
Antonella Morlini 23denza, per farne un rinnovato punto di nella comprensione e comunicazione inizio, di ridefinizione. Si tratta di movi- allargata del senso e dell’utilità dell’ac- menti progettuali travagliati, talvolta coglienza; gli operatori, i responsabili conflittuali, discontinui, eppure anche dedicano tempo ed energie conosciti- produttivi, di valore, di senso. Nei per- ve per entrare nel merito delle diverse corsi di accoglienza un’altra risorsa tipologie di persone incontrate, per ap- cruciale è la progettazione: gettare lo prendere a costruire percorsi differen- sguardo in avanti per intuire le ipotesi ziati e utili; la collaborazione tra i diffe- di lavoro più pertinenti rispetto alla renti interlocutori del territorio è complessità delle situazioni, costruire approfondita e coltivata nel tempo, con le persone e i soggetti del territorio sebbene gli approcci all’impegno, al risorse di relazione, sociali di acco- servizio siano a tratti distanti. Operare glienza, promuovere orientamenti che progettualmente implica riconoscere i riconoscono il valore del sostegno, vincoli e le risorse del contesto sociale, dell’accompagnamento, con una logi- organizzativo di cui siamo parte, per ca di emancipazione e non di totale as- ricercare spazi di confronto e di azione sistenza. La laboriosità dei processi di che rafforzino la possibilità di accoglie- accoglienza può incoraggiare un ap- re e di sostenere nel possibile. Lo proccio prevalentemente programma- sguardo progettuale si prende cura del- torio, volto a precisare quali sono gli le condizioni che facilitano i processi spazi, i tempi, i ruoli di ciascuno degli di accoglienza, aprendo e sostenendo operatori, dei volontari: di certo un la- interlocuzioni con i soggetti già attivi voro necessario, significativo, che può nel territorio e con quelli potenzialmen- entrare in relazione con lo sguardo te interessati. L’azione progettuale ri- strategico, e quindi progettuale, riguar- nuncia all’autoreferenzialità, al ricono- do all’inserimento delle persone. Il la- scimento esclusivo dei propri meriti, voro di progettazione ricomprende la per incoraggiare intraprese difficili, programmazione, ma non solo: le éq- orientate al coinvolgimento dei cittadi- uipe, i gruppi di volontariato investono ni, dei gruppi, delle istituzioni. I diffe- 24 Antonella Morlini
renti contributi prendono spessore e cuno di noi lo accompagna la prima
crescono nell’interazione, nel precisare volta. Lei che cosa ne dice?” Al telefono
i processi di lavoro e di organizzazione, l’operatore si confronta con l’assisten-
nel valutare i punti di forza e i nodi criti- te sociale che a sua volta evidenzia:”-
ci delle esperienze costruite. Fare pro- Grazie per le informazioni accurate,
getto è impegnativo perché implica te- prima incontro io il signor A, poi solleci-
nersi in apertura anche quando gli altri tiamo una visita psichiatrica di appro-
soggetti non sono così costruttivi, il la- fondimento. Quello che state facendo
voro di tessitura tra le persone e con le è molto utile, compresa l’osservazione,
organizzazioni è incessante, a tratti il monitoraggio, per quanto possibile,
“sfinente”, eppure così necessario per della situazione”. I due interlocutori
non rinchiudersi nelle proprie abitudini, hanno bisogno l’uno dell’altro, non si
nelle attività ormai consolidate. Non gettano addosso responsabilità, parti
cerchiamo la collaborazione con tutti i mancanti, colgono che possono intera-
soggetti, le differenze, quando sono gire per costruire, si sono incamminati
aspre, possono impedire il dialogo e in un percorso di progettazione, senza
rendere strumentali, inutili gli incontri; pretendere di controllare tutta la realtà,
pensiamo, piuttosto, alla individuazio- accogliendo il divenire del lavoro e l’in-
ne di interlocutori sufficientemente certezza. Probabilmente emergeranno
onesti e consapevoli di non riuscire a problemi, fatti difficili da comprendere,
fare strada da soli nella complessità lo sguardo progettuale accoglie il mo-
delle situazioni. Quando emergono spi- vimento di entrare in contatto, nel meri-
ragli progettuali ce ne rendiamo conto: to dei vissuti, dei contenuti, delle scelte
“Avremmo bisogno di approfondire il possibili. In questo senso una risorsa
percorso del signor A., viene alla men- strategica dell’accoglienza è l’organiz-
sa, al centro di ascolto, è andato una zazione, intesa quale progettazione
volta al nostro ambulatorio, ma non è delle condizioni per operare, dei pro-
sufficiente. Possiamo chiedere al servi- cessi di lavoro essenziali per condurre
25
zio di salute mentale una visita? Qual- e coordinare i differenti percorsi. Ab-
Antonella Morlini 25biamo bisogno di organizzarci per ve- le funzioni differenti rischia di prevale- dere, comprendere effettivamente le re, come se il collega responsabile persone in situazione di disagio, i con- fosse un persecutore o per naturale in- testi, i limiti, le risorse, la progettualità vidia verso la competenza riconosciu- possibili e sostenibile. Per costruire ta. Eppure l’esercizio della funzione di percorsi complessi ci è di aiuto un’or- autorità, nel senso etimologico di ge- ganizzazione altrettanto articolata: con nerare movimenti autorevoli, imprendi- funzioni differenziate e tra loro in inte- tivi, è significativo per contenere il razione esplicita riguardo al merito del- gruppo di lavoro, per coordinarlo ri- le situazioni, alle logiche di impegno e spetto alle ipotesi e agli scopi del pro- di lavoro. Non basta sapere chi è il re- getto, del servizio. L’accoglienza dei sponsabile e quali sono gli operatori processi di differenziazione è un movi- che fanno parte del gruppo, abbiamo mento strategico per apprendere a col- necessità di approfondire i contenuti locarsi nell’organizzazione, interagen- per coglierne la effettiva consistenza, il do nel merito dei contenuti, delle legame con le funzioni dell’organizza- esperienze, sviluppando comprensioni zione. La somma delle identità perso- complesse, articolate della realtà di cui nali non costituisce l’organizzazione, siamo parte. La dissimmetria non im- che può essere costruita quando i re- plica perdita di importanza, di valore, sponsabili, gli operatori, i volontari en- anzi, significa creare delle condizioni trano in relazione con il progetto, con il governate, esplicite, valutabili, di lavo- servizio, con il percorso, in processi ro, di riconoscimento dei differenti con- progettati, governati, coordinati. L’orga- tributi. I processi organizzativi non nizzarsi può aprire a fatiche di ricono- sono pensati come spazi divisi e pre- scimento delle dissimmetrie: “Siamo determinati per sempre, precisano gli una grande famiglia, siamo tutti uguali, orientamenti dell’istituzione, dei gruppi che bisogno c’è del coordinatore? A di lavoro, in relazione con le competen- turno tutti possiamo fare il verbale, tira- ze, gli strumenti, le risorse, i vincoli, le re le fila del lavoro”. A tratti la paura del- possibilità di innovazione. Organizzarsi 26 Antonella Morlini
significa pensare a come realizzare il oppure sottovalutarli eccessivamente,
valore, il senso, i percorsi dell’acco- al punto da non comprendere i dubbi,
glienza. le fatiche dei colleghi operatori, volon-
tari, cittadini. Forse ci è chiesto di ad-
dentrarci, in gruppo e in relazione gli
1.3 GLI INTERROGATIVI E LE uni con gli altri, nella complessità, co-
PROSPETTIVE DELL’ACCOGLIENZA gliendo il nostro limite e le possibilità
di intraprendere. L’accoglienza apre,
I fatti del mondo sembrano scorag- potenzialmente, ad un movimento
giare l’accoglienza, ci sentiamo sotto di reciprocità, di riconoscimento, sia
assedio, la barbarie si affaccia con pre- pure parziale, incoraggia l’emersione
potenza e ci rende vulnerabili, sempre dei problemi e dei percorsi costruibili.
più impauriti, è naturale e comprensi- Probabilmente possiamo continuare
bile. Possiamo ancora accogliere? Il ad apprendere, a conoscere, ad incon-
movimento dell’accoglienza attraversa trare, per cogliere i limiti, le potenzialità
i confini e le situazioni, ne abbiamo bi- delle vite, dei percorsi, delle comunità
sogno per vivere, per sentirci parte del territoriali.
mondo e riconosciuti, apre a compren- La misura dell’accoglienza è data
sioni difficili e nuove, che nutrono l’e- dalle strutture, dai progetti, dalle col-
sperienza di tratti vitali. Possiamo non laborazioni che riusciamo ad attivare,
accogliere un migrante nelle nostre ad accompagnare, emerge dalla con-
case, ma abbiamo bisogno di sentirci sistenza della preparazione, della de-
accolti a scuola, al lavoro, nelle attivi- dizione degli operatori, dei volontari,
tà di tempo libero. Possiamo offrire dei responsabili, delle persone attente
tempo volontario per accompagnare e generose. Forse la fisonomia dell’ac-
le persone in situazione di difficoltà, coglienza dipende dal senso di comu-
mantenendo qualche tratto di giudizio nità e di realtà che insieme riusciamo
lapidario, qualche paura. Possiamo so- a rappresentarci, a comunicare, prende
27
pravvalutare troppo i problemi, i rischi, spessore dalla qualità delle interazioni
Antonella Morlini 27che cerchiamo di costruire per affron- e coinvolti. I percorsi di accoglienza si tare i problemi e sostenere i percorsi. muovono nel molteplice: convivono ap- Le risorse materiali, gestionali sono procci sociali semplificatori con scelte necessarie, unitamente allo sguardo complesse, tratti conflittuali e collabo- progettuale complesso che riusciamo razioni, prendono vigore le parti ambi- a tenere, a coltivare, in relazione con i valenti e anche i contenuti articolati. Il differenti soggetti della comunità terri- disorientamento ci accompagna, forse torio. La sensibilità non è già data, ha ci infastidisce, eppure fa pensare e ri- bisogno di essere alimentata, rigenera- orienta: perché siamo così arrabbiati ta, in contatto con le problematiche del e vorremmo avere subito più risorse? nostro tempo, con i percorsi di vita, di Perché siamo così certi di avere ragio- esperienza delle persone. ne? Quali prospettive riusciamo a intravede- L’accoglienza è laboriosa, apre a do- re? L’accoglienza esprime un movimen- mande che attraversano la superficie, to verso l’incertezza, nella direzione l’evidenza, per afferrare qualche traccia della ricerca esplorativa, ci riconsegna inedita di riflessione, di esperienza. il senso del fare parte del mondo, oltre Ringrazio la Caritas diocesana per che della famiglia, del gruppo di amici, la possibilità di condividere un tratto si- del team di lavoro, dell’associazione di gnificativo di cammino. volontariato. Nell’accogliere facciamo esperienza di contatto con differenti persone, realtà, situazioni, viviamo l’u- Antonella Morlini, psicosociologa, scita, parziale, dai nostri confini abitua- formatrice e consulente li di pensiero, di progettualità, ci tocca ricollocare qualche frettolosa interpre- tazione riguardo alle persone, siamo sollecitati a guardare l’orizzonte sen- tendocene parte, non solo come “spet- tatori”, bensì anche quali soggetti attivi 28 Antonella Morlini
Animare e formare le comunità
parrocchiali all’accoglienza:
dall’emergenza alla quotidianità
ascoltando e accompagnando
nella prevalente funzione pedagogica
Valerio Corghi
E’ stato molto emozionante ripercorre- lità, progetti e opere segno il proprio
re questi quattordici anni di esperien- impegno di animazione e formazione
za di accoglienza della nostra Caritas sul territorio ancor prima del progetto
Diocesana per l’occasione di questa di Accoglienza Invernale.
pubblicazione. E allora provo a fare un salto indietro
Non mi sarei mai aspettato di poter nel tempo…
ripercorrere diverse sensazioni, stati Ricordo quel famoso inverno del
d’animo, aspetti che ricordavo molto 2002.03 durante il quale, difronte ad
bene, oppure per nulla, di un cammino una nevicata particolare, in stretta si-
così impegnativo, coinvolgente, signi- nergia con l’Armadio del Povero allora
ficativo e faticoso allo stesso tempo. aperto in centro città, ora diffuso in di-
Tutto ciò, del resto, ha continuato a verse Caritas parrocchiali per la distri-
caratterizzare quanto nel corso del buzione di abiti, iniziammo ad incon-
tempo è stato fatto, è nato, cresciuto, trare al Centro d’Ascolto Diocesano di
consolidato, maturato, cambiato, si sera molte persone in difficoltà abitati-
è avuto il privilegio di accompagnare, va. Fu l’inverno dei 50 sacchi a pelo do-
amare… nati dalla nostra amministrazione co-
Il tema dell’accoglienza è prerogativa munale e della così detta ”Emergenza
importante della Caritas che ha sem- freddo” che durò poco più di un mese.
pre investito, in diverse forme, moda- Fin da subito, allargando a dismisura
Valerio Corghi 29Puoi anche leggere