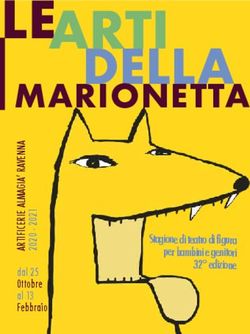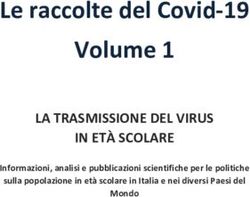AGGIORNAMENTO SULLE PATOLOGIE EMERGENTI - Alessandro Dondo - 10/11/2020 IZSPLV
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
AGGIORNAMENTO SULLE PATOLOGIE EMERGENTI
Alessandro Dondo
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d’Aosta
S.C. Diagnostica Generale
10/11/2020
IZSPLVEMERGENZE VETERINARIE Definizione: “ ogni situazione in cui il personale ed i mezzi disponibili in un determinato territorio risultano insufficienti all’attuazione di un efficace intervento sanitario. Si tratta di avvenimenti improvvisi che richiedono un’azione decisa ed immediata e che possono essere dovuti a cause epidemiche, naturali o tecnologiche” (Oms)
DEFINIZIONI MALATTIA EMERGENTE: malattia «nuova» - agente patogeno sconosciuto con impatto significativo - diffusione in nuove aree di patogeni conosciuti; - Ampliamento spettro d’ospite di patogeni conosciuti; - Agente patogeno adattato all’uomo (AIDS, Ebola, SARS, IA, SARS-COV2) MALATTIA RIEMERGENTE: malattia infettiva che modifica la sua frequenza e/o distribuzione geografica rispetto al passato o dopo un periodo di controllo efficace
FATTORI CHE CONDIZIONANO IL SUCCESSO DELL’INTERVENTO:
• INDIVIDUAZIONE PRECOCE DEL FOCOLAIO
• RAPIDITA’ NELLA DIAGNOSI (conferma) DI LABORATORIO
• IMMEDIATA ADOZIONE ED APPLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI
POLIZIA VETERINARIA NEL FOCOLAIO E SUL TERRITORIO
• TEMPESTIVITA’ NEGLI ABBATTIMENTI E DISTRUZIONI
• RAPIDITA’, ACCURATEZZA ED EFFICACIA DELL’INDAGINE
EPIDEMIOLOGICA
• VIGILANZA E REPRESSIONE DEGLI ILLECITI
• GESTIONE DELL’INFORMAZIONE
• LIQUIDAZIONE SOLLECITA DEGLI INDENNIZZI SE PREVISTICompiti IZS - emergenza sanitaria • assicurare intervento diagnostico I°livello • inviare i campioni al Centro nazionale di referenza • raccogliere e trasmettere dati relativi all’indagine epidemiologica • elaborare una valutazione sulle misure adottate Compiti centro di referenza • Diagnosi eziologica di II° livello • Raccogliere i dati epidemiologici • Mantenere i collegamenti con i Centri di Referenza comunitari e internazionali
MODALITA’ OPERATIVE
OPERAZIONI PRELIMINARI
Indossare idonei DPI
•Cuffie per capelli monouso
•Mascherine monouso
•Camici monouso
•Guanti monouso
Mezzi di protezione individuale DPI
•Sovrascarpe monousoSTRUTTURA COMPLESSA DIAGNOSTICA GENERALE Laboratorio Patologia Animale, Laboratorio Ittiopatologia e Laboratorio Diagnostica Specialistica e rabbia Campi d’attività: Ricerca scientifica sperimentale veterinaria ed accertamento dello stato sanitario degli animali Esame clinico Esame necroscopico Esame anatomopatologico Prescrizione terapie Consulenza tecnica all’utenza Esami parassitologici Esami batteriologici Esami con tecniche immunoenzimatiche Esami sierologici Prove biologiche Esami biotossicologici Esami con Immunofluorescenza diretta Esami con tecniche immunocromatografiche Esami per ricerca virus rabido Identificazione di rettili I laboratori sono dotati di attrezzature adeguate e sono collegati alla rete informatica dell’Ente.
protocolli diagnostici & complessità
Diagnostica delle malattie virali
Materiale d’esame
(essudati, trasudati, escreti, frammenti d’organo, prelievi bioptici, liquidi organici, ecc.)
Senza isolamento Microscopia elettronica
Ricerca di Ag virale con anticorpi marcati
Sonde di acidi nucleici
Con isolamento
colture di cellule uova embrionate infezione sperimentale
-effetto citopatico -morte embrionale -attitudine patogena
-lesioni cellulari -comparsa di emoagglutinina -riproduzione malattia
-emadsorbimento -arresto sviluppo embrione,
emorragie, ecc.
Tecniche di biologia molecolareprotocolli diagnostici alcuni esempi……
PROTOCOLLO DIAGNOSTICO - feto bovino
LABORATORIO PATOLOGIA ANIMALE SEDE DI TORINO
Valutazione della anamnesi individuale e d’allevamento
Esame anatomopatologico del feto e degli invogli fetali per valutazione
lesioni macroscopiche e eventuale sospetto diagnostico
Prelievo in sede di necroscopia degli organi e liquidi biologici per
esecuzione esami di laboratorio
Il protocollo diagnostico in uso prevede la ricerca (Ag) di:
• Germi patogeni
• Brucella spp. • BVD
• Campylobacter foetus • IBR
• Chlamydiophila spp. • PI3
• Listeria monocytogenes • BHV4
• Salmonella spp.
• Miceti Principale obiettivo di Sanità Pubblica
• Neospora
E’ possibile eseguire approfondimenti diagnostici mediante campioni di siero per la ricerca di
Leptospira, Neospora e agenti viraliWorkflow identificazione M. tb complex
su base genetica
M. tuberculosis
M. avium
M. spp
M. tb complex Spoligotyping M. bovis
Multiplex PCR VNTR
Colonia isolata
RDs M. microti
RDmic M. tuberculosis
Gyr B M. africanum
RFLP IS6110Collaborazione & scambio conoscenze
Oggi la collaborazione tra laboratori diagnostici del nostro
territorio e a livello internazionale risulta particolarmente
importante in quanto:
• la globalizzazione dei mercati associata ai cambiamenti
climatici verificatesi negli ultimi anni aumenta il rischio di
patologie relegate in paesi geograficamente lontani (es.
BT, WND,…)
• rende possibile lo scambio di esperienze e conoscenze di
malattie altrimenti studiate solo accademicamente
• facilita la possibilità di diversificare l’approccio e le
metodologie per contrastare patologie in differenti contesti
geografici
• favorisce la possibilità di mettere a punto metodologie
diagnostiche validate, sensibili, specifiche per essere pronti
a fronteggiare emergenze sanitarieCollaborazione & scambio conoscenze
alcuni esempiTubercolosi umana e animale: aspetti
clinico epidemiologici della tubercolosi
bovina in Italia
Area Tecnica Diagnostica e Sanità Animale
Alessandro DondoBTB
Honey badger,
genet etc.
Prof. Anita Michel
Department of veterinary tropical disease
University of Pretoria – South AfricaMalattie emergenti e riemergenti: determinanti Mutazioni genetiche Modifica della suscettibilità dell’uomo
Malattie emergenti e riemergenti: determinanti Cambiamenti: -nel serbatoio dell’infezione (habitat, nicchia ecologica, specie aliene) -nei vettori competenti -nel comportamento dell’uomo (velocità degli spostamenti, urbanizzazione, globalizzazione) -nell’ambiente (deforestazione, dighe, disastri ambientali) -nell’ecosistema (cambiamento climatico, rialzo termico) -demografici (aumento della popolazione, invecchiamento, impoverimento)
Malattie emergenti e riemergenti: determinanti Aumento: - dei flussi migratori - degli scambi di merci - Degli allevamenti intensivi - Dei contatti tra fauna selvatica, domestica e uomo
Malattie emergenti e riemergenti: determinanti
Malattie emergenti e riemergenti
Il 70% delle malattie emergenti
sono zoonosi e tra queste più
della metà riconoscono la fauna
selvatica come serbatoio
Kate E. Jones, Nikkita G. Patel, Marc A. Levy, Adam Storeygard, Deborah Balk, John L. Gittleman & Peter Daszak.. (2008).
Global trends in emerging infectious diseases.
Nature 451, 990-993.Malattie emergenti e riemergenti alcuni esempi: • 1982 E.Coli O157, Malattia di Lyme, USA • 1983 HIV, USA • 1993 Hantavirus, USA • 1994 Hendra virus, Australia • 1996 variante CJD, UK • 1997 influenza umana da H5N1, Hong Kong • 1999 Encefalite West Nile (USA), Nipah virus nel suino (Malesia) • 2003 SARS • 2004 Influenza aviaria, Asia, Europa,Africa • 2012 Middle East respiratory syndrome, (MERS-CoV) • 2013 Influenza aviaria H7N9 Cina • 2014 Ebola
Un gruppo di lavoro, formato da esperti provenienti da diversi paesi membri, hanno individuato 53 malattie infettive e non infettive da monitorare, per la loro importanza per la fauna selvatica e per la salute umana e animale. L'interfaccia WAHIS -Wild consente ora la consultazione delle informazioni sulle malattie della fauna selvatica non comprese nell'elenco ufficiale OIE.
Malattie emergenti e riemergenti: impatto • Salute umana • Salute animale (patrimonio zootecnico, biodiversità) • Perdite economiche (morie animali zootecnici, blocco delle movimentazioni commerciali o turistiche, aumento delle procedure di controllo) • Problemi di ordine pubblico
…..dal Piano Fauna Selvatica – Regione Piemonte
…..dal Piano Fauna Selvatica – Regione Piemonte
HPAI in Europa: H5N8-H5N5 (2016-2017)
HPAI in Italia: H5N5-H5N8 (2016-2017)
INFLUENZA AVIARIA
• Incremento di frequenza, dimensioni e durata
delle epidemie
• Potenzialità zoonosiche accresciute per i sottotipi
H5 e H7 che hanno infettato l'uomo in molte
occasioni nel corso di focolai nel pollame
MALATTIA EMERGENTEINFLUENZA AVIARIA
Infezione che colpisce gli uccelli causata da qualsiasi virus
dell'influenza di tipo A che ha un indice di patogenicità intravenosa in
polli di 6 settimane maggiore di 1.2 OPPURE qualsiasi virus
dell'influenza di tipo A appartenente ai sottotipi H5 e H7 (OIE)
Orthomyxoviridae
ssRNA segmentato
Riassortimento geneticoINFLUENZA AVIARIA: classificazione
SOTTOTIPI sulla base di due antigeni di superficie: Neuroaminidasi (N) ed
Emoagglutinina (H)
Superinfezione Antigenic shift NUOVO
SOTTOTIPO PANDEMIA
Gli uccelli sono dotati di recettori per
tutte le N e H tutte le
combinazioni MIXING VESSELLINFLUENZA AVIARIA: classificazione
Alta patogenicità e Bassa patogenicità in base alla presenza di AA
basici nel sito di clivaggio della H
Alta (HPAI) Bassa (LPAI)
- Elevata mortalità - Mortalità moderata
- Infezioni sistemiche - Infezioni localizzate
I più frequenti sono H5, H7 e più
Ai fini della loro diffusione sono raramente H9 che infettano uccelli
svantaggiati da un punto di vista domestici come HPAI. Le condizioni di
biologico-evolutivo poiché alta densità di allevamento intensivo
portano a morte l’animale favoriscono elevati tassi d’infezione e
rapidamente quindi passaggi con aumento delle
probabilità di un antigenic drift
(mutazione puntiforme) verso un HPAIINFLUENZA AVIARIA: Uccelli migratori Reservoir naturale ti tutti gli influenza virus A come HPAI e fonte di focolai primari nei domestici. Le morti e gli isolamenti di HPAI in uccelli selvatici sono solitamente correlate a contatti con domestici in corso di epidemie da HPAI (SPILL-OVER) Tuttavia è nota la loro capacità assieme alle anatre domestiche di diffondere ceppi di HAPAI in forma asintomatica.
INFLUENZA AVIARIA: clinica e patologia
Incubazione: h/giorni
Specie: tutte ma il tacchino è la più sensibile
HPAI LPAI
- morte improvvisa - Sintomi respiratori
- Sintomi nervosi - Sintomi digestivi
- Calo produzione - Calo produzione
- Sintomi gastroenterici
- Emorragie cresta bargigli
Lesioni D/D:
- Lesioni da setticemia - Malattia di Newcastle
- Congestione/emorragie generalizzate - Colera aviare
- Laringotracheite infettiva
- avvelenamenti acuti
- setticemieINFLUENZA AVIARIA: salto di specie (1) Condizioni necessarie per epidemia nella popolazione umana: Trasmissione diretta all’uomo e replicazione Caratteristiche antigeniche nuove per le quali la popolazione umana risulti immunologicamente vergine Trasmissione interumana (fino ad ora pochi casi, in condizioni particolari e mai oltre la 1° generazione)
INFLUENZA AVIARIA: salto di specie (2) Condizioni necessarie per epidemia nella popolazione umana: COME? “riassortimento genetico” tra virus umano e aviario mediante superinfezione in uomo o maiale (MIXING VESSEL PANDEMIA) graduale mutazione adattativa FATTORI FAVORENTI: Persistenza epidemia nel pollame (↑tasso infezione= ↑cicli replicativi= ↑mutazioni adattative) Stretta coabitazione tra uomo e pollame (Sud-Est Asiatico) Macellazione di animali sintomatici (Sud-Est Asiatico)
…..dal Piano Fauna Selvatica – Regione Piemonte
Peste Suina Africana (PSA)
Famiglia Asfaviridae
Genere Asfavirus
ds DNA
Molto resistente (anche nei prodotti animali)
Non induce la produzione di Ig neutralizzanti
VACCINI
TEST DI SIERONEUTRALIZZAZIONE
PORTATORI CRONICI/SERBATOI VIRALIPeste Suina Africana (PSA):spread
Fonte - Laboratorio nazionale di referenza per le Pesti Suine
Fonte - Laboratorio nazionale di referenza per le Pesti Suine
Peste Suina Africana: patogenesi • Via oronasale • Incubazione 4-19 gg • Viremia persistente (anche mesi) • Patologia sistemica • Alta morbilità e alta mortalità • Quadri anatomopatologici emorragici
Fonte - Laboratorio nazionale di referenza per le Pesti Suine criticità
Peste Suina Africana: D/D
PESTE SUINA AFRICANA (PSA)
PESTE SUINA CLASSICA
a) Rene a uovo di tacchino con
(PSC) emorragie confluenti nel
a) Rene a uovo di tacchino bacinetto
b) Cistite emorragica VS b) Cistite emorragica
c) Infarti marginali della milza c) Infarti marginali della milza e
d) Linfoadenite emorragica a splenite emorragica
cartina geografica d) Linfoadenite emorragica
(ematomi)
Emorragie epiglottide e tonsille
INOLTRE: (PATOGNOMONICO)
- Setticemie batteriche
- Malrossino
- PDNSLYSSAVIRUS
…..dal Piano Fauna Selvatica – Regione Piemonte
RABBIA – TECNICHE DIAGNOSTICHE DI
LABORATORIO
• IMMUNOFLUORESCENZA DIRETTA (FAT): test di elezione
• ISOLAMENTO DEL VIRUS IN COLTURA CELLULARE (RTCIT): test di
conferma. Importante per la tipizzazione dei ceppi e il confronto con gli
isolati degli stati confinanti
• INOCULAZIONE INTRACEREBRALE NEL TOPINO (MIT): test di conferma
• ESAME ISTOLOGICO
• IMMUNOISTOCHIMICA
• MICROSCOPIA ELETTRONICA
• RT-PCR: diagnosi di routine; utilizzabile anche per indagini epidemiologiche
e prova di conferma in casi particolari (chirottteri)
• ESAME SIEROLOGICO: virus neutralizzazione con anticorpi fluorescenti
(RFFIT/FAVN). Non utilizzato per la diagnosi di routine; applicabili per
indagini di sieroprevalenza e per i controlli di efficacia dei vaccini…..fonte – FAO and National Reference Centre for Rabies
TITOLAZIONE DEGLI ANTICORPI (FAVN TEST) Valutazione della risposta immunitaria dopo la vaccinazione antirabbica mediante test di virus neutralizzazione con anticorpi fluorescenti (FAVN) Un titolo ≥ 0,5 UI/ml viene considerato protettivo. Eseguibile presso laboratori riconosciuti da UE
Malattie emergenti e riemergenti: vettori
stretta correlazione tra modificazioni ambientali/climatiche e gli insetti
- Estensione verso nord degli areali di
Aumento della temperatura globale insetti tipicamente tropicali
Aumento delle precipitazioni - Amento del tasso riproduttivo degli insetti
-Destagionalizzazione dei periodi di attività
Prevenzione= impedire l’entrata di agenti patogeni in territori in cui sono presenti vettori
e condizioni idoneo per una loro endemizzazione
Alcuni Esempi:
- Crimean Congo Haemorragic Fever (Est Europeo) N.B. ripopolamento lepri
- Leishmaniosi (trasmessa da flebotomi con 500.000 nuovi casi annui)
- Blue tongue (trasmessa da Culicoidi e considerata esotica fino al 2008)
- Chikungunya (trasmessa da zanzare del genere Aedes; nel 2007 casi italiani
correlati a un viaggiatore dall’India)
- Dengue (trasmessa da zanzare del genere Aedes ; barriera rappresentata da un
limite climatico. Duraturo?)…..dal Piano Fauna Selvatica – Regione Piemonte
…..dal Piano Fauna Selvatica – Regione Piemonte
Fonte – CDR Brucellosi IZS Teramo
CONSIDERAZIONI:
brucellosi nel cinghiale
L’isolamento dell’agente eziologico in tutte le classi d’età indica:
possibilità di infezione prima della pubertà
ruolo dell’adulto come potenziale diffusore d’infezione, non solo come
portatore di anticorpi
L’isolamento da organi genitali senza lesioni conferma i dati
bibliografici relativi a scarse conseguenze dell’infezione sulla fertilità
Si può considerare pressoché nullo, in Piemonte, il rischio di passaggio
dell’infezione dal cinghiale al suino, non essendo diffusa la pratica
dell’allevamento estensivo
Corso di aggiornamento sulle zoonosi emergenti, Fossano 24-25 maggio 2007Fonte – CDR Brucellosi IZS Teramo
Fonte – CDR Brucellosi IZS Teramo
Bioterrorismo?
Fonte – CDR Brucellosi IZS Teramo
Fonte – CDR Brucellosi IZS Teramo
Fonte – CDR Brucellosi IZS Teramo
Può essere considerata una emergenza sanitaria & veterinaria?
vediamo il perché…………………
BIOTERRORISMO
CONCETTI DI BASE
Tratto da “CBRNE - Biological Warfare Agents” - Daniel J Dire, MD, FACEP, FAAP, FAAEM, Clinical
Assistant Professor, Department of Emergency Medicine, University of Texas-Houston - www.emedicine.comCriteri preliminari per sospettare un attacco biologico Comparsa di malattia non endemica Inusuale spettro di antibiotico-resistenza del ceppo isolato Quadro clinico atipico Mancata correlazione fra malattia e distribuzione temporale e/o geografica Altre incongruenze (morbilità, mortalità, modalità di comparsa)
Indicazioni di un possibile attacco La malattia è inusuale per l’area colpita Presenza contemporanea di più malattie inusuali nella stessa popolazione Unica sorgente d’infezione per una grave epidemia Apparente disseminazione per aerosol Morbilità e mortalità molto elevate tra la popolazione a rischio Malattia localizzata in un’area geografica circoscritta Minore incidenza in persone che lavorano in edifici dotati di un buon impianto di filtrazione dell’aria Decesso di animali di specie differenti Assenza di vettori biologici specifici
….E speriamo che qualcuno non cominci a spedire buste con pulci più o meno infette. Da “Bioterrorismo: contagiare è difficile” articolo pubblicato su "Il Mattino" il 26 ottobre 2001
Ecco il perché…………………. LINEE GUIDA PER PREVENZIONE RISCHIO BIOLOGICO Protocollo operativo in fase di monitoraggio Principali agenti biologici oggetto di controllo: Bacillus anthracis; Francisella tularensis; Yersinia pestis; Brucella sp.
Francisella tularensis
• Gram negativo
• Forma coccobacillare
• Immobile
• Asporigeno
• Parassita intracellulare
obbligatoTularemia: diffusione mondiale Aree endemiche (in grigio)
Fonti di contagio Manipolazione di materiale contaminato e colture batteriche Inalazione di aerosol infetto Contatto diretto di mucose (congiuntiva oculare) Ingestione di acqua o cibo inquinati Contatto diretto con animali infetti (soprattutto lagomorfi e roditori) zecche, pulci, zanzare Non è segnalato il contagio inter-umano
Manifestazioni cliniche
Forma ulcero-ghiandolare
21-87% dei casi
dovuta abitualmente alla
puntura di zecca o al
contatto con animali
infetti.
Segno iniziale è una
tumefazione linfonodale
accompagnata dalla
comparsa di una papula
rossa e dolente che va
incontro a necrosi,
lasciando un’ulcera dal
bordo sollevato.Manifestazioni cliniche
Forma ghiandolare
3-20% dei casi
linfonodi congesti e
aumentati di volume,
tendenti alla
suppurazione nella
zona colpita.
Assenza di ulcere
cutanee.F. tularensis come arma biologica Elementi a favore dell’utilizzo di questo germe come arma biologica sono soprattutto: bassa carica infettante (1-10 microrganismi per via respiratoria), facilità di disseminazione e elevato potere patogeno. Durante gli anni ’30 l’impiego bellico di F. tularensis è stato studiato dai laboratori giapponesi nel corso dell’occupazione della Cina. Si presume che anche le epidemie di tularemia che hanno colpito migliaia di soldati durante la II guerra mondiale siano state originate da una disseminazione intenzionale dell’agente.
Malattie emergenti e riemergenti: come affrontarle?
Sforzo multinazionale per limitare il rischio di
diffusione di queste malattie mediante una
rete di sorveglianza mondiale
approccio ‘One Health’
Salute umana
Salute
animale EcosistemiMalattie emergenti e riemergenti: approccio ‘One health’
Collaborazione tra scienze umane, animali e
ambientali
Costruzione di sistemi di sorveglianza
multidisciplinari e internazionali per prevenire il
superamento delle barriere naturali da parte delle
MI
Applicazione delle norme sanitarie internazionali
(OMS, OIE)
Comunicazione e ricerca scientifica congiunte
Attenzione e cooperazione per la gestione dalle
realtà epidemiologiche dei paesi a risorse limitateMalattie emergenti e riemergenti: controllo e prevenzione
Raccolta sistematica di dati riguardo:
Incidenza – Prevalenza - Morbilità e Mortalità - Rischio di
contagio - Velocità di diffusione - Evoluzione potenziale
dell’agente - Dimensione della popolazione a rischio - Area
geografica - Costi
Sistema di Sistema di
sorveglianza allarme rapidoIl pericolo che non ti aspetti ………………………….!? Grazie per l’attenzione
Puoi anche leggere