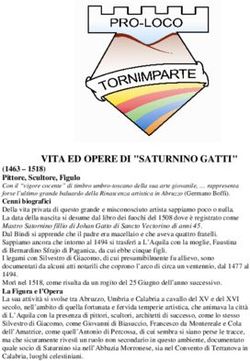Strumenti e metodi dell'ICR in circostanze emergenziali. Il ruolo dell'ICR nell'alluvione di Firenze (1966), nel sisma dell'Abruzzo del 6 aprile ...
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Strumenti e metodi dell'ICR in circostanze emergenziali. Il ruolo dell'ICR nell'alluvione di Firenze (1966), nel sisma dell'Abruzzo del 6 aprile 2009 e nel sisma dell'Italia centrale del 24 agosto 2016
STRUMENTI E METODI DELL’ICR IN CIRCOSTANZE EMERGENZIALI. IL RUOLO DELL’ICR NELL’ALLUVIONE DI FIRENZE (1966), NEL SISMA DELL’ABRUZZO DEL 6 APRILE 2009 E NEL SISMA DELL’ITALIA CENTRALE DEL 24 AGOSTO 2016 Corso di formazione MiC a cura dell’Istituto Centrale per il Restauro, in collaborazione con la Fondazione Scuola dei Beni e delle Attività Culturali e con la Direzione Generale Educazione Ricerca e Istituti Culturali I parte Arch. Francesca Romana Liserre, “L'esperienza dell'alluvione di Firenze e l'operato di Pasquale Rotondi a favore dell'approccio pluridisciplinare” lunedì 4 aprile ore 10:00 - 11:00 Arch. Maria Elena Corrado, “Carta del Rischio e Vincoli in Rete” lunedì 4 aprile ore 11:00 - 12:00 Arch. Stefania Argenti, “La messa in sicurezza post sisma condotta dall'ICR sul San Salvatore in Campi di Norcia e sul San Benedetto di Norcia” lunedì 4 aprile ore 12:00 - 13:00 II parte Dott.ssa Antonella Basile, Dott.ssa Cristina Lollai, “Tre rilievi provenienti da Amatrice e Accumoli, presentati alla mostra ‘Oltre una sorte avversa. L’arte di Amatrice e Accumoli dal terremoto alla rinascita’ a cura della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Roma e la provincia di Rieti” venerdì 8 aprile ore 10:00-11:00 Dott.ssa Elisabeth Huber, Dott.ssa Lucia Conti, Dott.ssa Giulia Galotta, “Il restauro delle sculture in terracotta danneggiate dal sisma del 2009. Analisi di un caso studio: il presepe con figure a grandezza naturale in terracotta policroma e dorata (XVI secolo), attualmente esposto al MunDA dell’Aquila” venerdì 8 aprile ore 11:00-13:00
Francesca Romana Liserre, “L'esperienza dell'alluvione di Firenze e l'operato di Pasquale Rotondi a favore dell'approccio pluridisciplinare”, durata: 1 lezione da 45 minuti. L’alluvione di Firenze del 1966 segna una pagina drammatica, ma nevralgica nella vita dell’Istituto Centrale del Restauro che ebbe un ruolo importante nell’azione di salvaguardia e recupero degli straordinari beni coinvolti nel disastro. All’indomani dell’evento vengono inviati a Firenze materiali e restauratori e si avvia l’affannoso lavoro per allestire un luogo dove ricoverare le tante opere d’arte danneggiate, in modo da garantirne un’asciugatura graduale e un successivo restauro. La scelta ricade sulla Limonaia del giardino di Boboli, dove i restauratori dell’Istituto si adoperano anche in qualità di carpentieri per isolare l’ambiente, tamponandone le grandi aperture e studiando, con il personale scientifico, le condizioni microclimatiche più adatte per salvare le opere. Le concitate fasi di realizzazione dell’impianto si susseguono attraverso i taccuini di Pasquale Rotondi, allora direttore dell’Istituto, che registra fatti e stati d’animo e riporta con tono affranto la sensazione di impotenza di fronte alla mancanza di tutto, dai gruppi elettrogeni per far luce al tramonto, ai cavi per l’impianto elettrico. Accanto a Pasquale Rotondi compaiono Giovanni Urbani (che coordina i restauratori), Licia Vlad (direttore del reparto archeologico), i restauratori (Francesco Pelessoni, Livio Iacuitti, Raimondo Boenni, Giuseppe Moro, Guido Regoli, Paolo Mora), gli operai specializzati (Piero Mannoni, Vincenzo Regoli, Angelo Pizzi, Eugenio Mancinelli, Sergio Banci, Enzo Pagliani, Renzo Arcangeli, Carlo De Angelis), il fisico Manlio Santini, i chimici (Marisa Laurenzi, Maurizio Marabelli, Salvatore Liberti, Ada Capasso), i microbiologi (Clelia Giacobini, Lidia Barcellona). In un’affannosa lotta contro il tempo, pressoché tutti i dipendenti dell’Istituto appaiono coinvolti e partecipi, chi sul posto, chi svolgendo sperimentazioni nei laboratori romani per fornire risposte sui prodotti più adatti a intervenire tempestivamente e su ampia scala, testando, ad esempio, l’interferenza di alcuni composti chimici con la pellicola pittorica e, in particolare, con i pigmenti, che rischiavano alterazioni inaccettabili. Dai documenti d’archivio emerge, inoltre, il ruolo svolto dall’Istituto come cerniera tra le svariate istituzioni nazionali e internazionali, che si attivano immediatamente per offrire il proprio contributo nell’affrontare problemi che vanno dall’approvvigionamento di materiali e strumenti, all’offerta di personale, alla consulenza scientifica sui metodi e i prodotti più adatti alla situazione, tenendo conto del fattore tempo e dell’alto numero di opere da trattare contemporaneamente. Il pragmatismo mostrato da Pasquale Rotondi in questa circostanza – oltre che innato – è probabilmente forgiato dall’esperienza vissuta durante la Seconda Guerra Mondiale, quando si rende artefice del salvataggio di 10.000 opere d’arte ricoverandole al sicuro della fortezza di Sassocorvaro ed emerge pienamente quando, a dieci giorni dall’evento, segnala al Ministero la totale inadeguatezza delle dotazioni disponibili per tutelare le opere d’arte in situazioni di emergenza. Un appello accorato che possiede, purtroppo, echi molto attuali e richiama la necessità di avere sempre pronto un magazzino di materiali e strumenti da
revisionare e integrare ogni anno, per garantire tempi rapidi e corrette procedure metodologiche di fronte a disastri che mettono a rischio un patrimonio culturale di inestimabile valore. Maria Elena Corrado, “Carta del Rischio e Vincoli in Rete”, durata: 1 lezione da 45 minuti. Si tratta di sistemi informativi territoriali che, grazie alla tecnologia GIS, consentono di confrontare molti dati fra loro e di visualizzare il tutto su mappa. Dagli anni ’90, l’ICR ha studiato e perfezionato a più riprese lo strumento della Carta del Rischio, che nasce come supporto per la prevenzione di danni al patrimonio culturale causati da disastri naturali o antropici, purtroppo in Italia molto frequenti. È però nelle situazioni di emergenza che la Carta del Rischio ha potuto dare prova immediata della sua efficacia, consentendo alle squadre che operano nei territori colpiti da catastrofi, in particolare in occasione degli ultimi sismi, di poter raccogliere molte informazioni utili in tempi brevissimi. Vincoli in Rete, nata nel 2012, è uno strumento che amplia le possibilità di conoscenza del patrimonio culturale e dei suoi rapporti col territorio, perché, in interoperabilità, raccoglie le informazioni delle principali banche dati del MiC (inclusa Carta del Rischio) e consente di caricare anche molte mappe e dati provenienti da altri enti che operano sul territorio per fornire a chi lavora nel settore dei beni culturali quante più informazioni possibili in tempi brevissimi. S. Salvatore in Campi presso Norcia (PG), particolare dopo La fase di messa in sicurezza il crollo avvenuto a seguito del sisma dell’ottobre del 2016 Stefania Argenti, “La messa in sicurezza post sisma condotta dall'ICR sul San Salvatore in Campi di Norcia e sul San Benedetto di Norcia”, durata: 1 lezione da 45 minuti. I danni arrecati alle chiese del San Benedetto e del San Salvatore in Campi di Norcia dallo sciame sismico del 2016 sono stati di gravissima entità. L’ICR è stato immediatamente coinvolto, grazie ad un accordo interistituzionale, nella messa in sicurezza di questi edifici le cui priorità sono state dettate dal livello di vulnerabilità
delle strutture superstiti, dalle peculiarità storico-artistiche degli edifici stessi, dalla
necessità di rendere di nuovo agibili spazi pubblici interdetti a causa degli
intervenuti crolli.
La complessità dei cantieri, condotti sempre in stretto raccordo con la
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria e con la
Soprintendenza Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 è stata
determinata dal fatto che si è dovuto coniugare aspetti legati alla sicurezza degli
operatori e di ciò che ancora non è perduto: la rimozione delle macerie, quindi, è
stata concepita come una operazione controllata, volta a scongiurare ulteriori
crolli o cedimenti di strutture, studiata con interventi che hanno sequenze legate
alla necessità di porre in opera presidi predisposti ad hoc in base al progredire
delle attività.
Lo staff dell’ICR, supportato da ricerche storiche e dai rilievi realizzati
specificatamente nelle fasi preliminari, ha individuato le modalità operative con le
quali effettuare la cernita e selezione delle macerie, con la finalità di recuperare
solo quegli elementi che connotavano architettonicamente ed artisticamente le
chiese quasi completamente crollate; ciò al fine di una possibile futura
ricomposizione delle parti architettoniche caratterizzate da apparati decorativi di
pregio.
In particolare, l’ICR sta conducendo una esperienza pilota nel San Salvatore in
Campi, straordinario esempio di arte medievale umbra, caratterizzato da una
pregevole struttura a pontile (definita anche come iconostasi). Essendo
quest’ultima una architettura nell’architettura decorata con affreschi ed elementi
litici scolpiti di elevato pregio artistico, è stata scelta per mettere a punto, per fasi
successive, un progetto volto a ricomporre questo elemento architettonico nel
rispetto della fragile materia autentica di cui è costituito. Gli apparati decorativi
dell’iconostasi sono, infatti, un tutt’uno con la propria struttura portante; pertanto
l’ICR sta portando avanti una sperimentazione che coniughi la necessità di
recuperare quanto non è andato perduto della architettura con la ricomposizione
in situ, per quanto possibile, degli elementi della stessa, recuperati dalle macerie,
basandosi su criteri antisismici.
Questo progetto architettonico, quindi, vede coinvolto uno staff multidisciplinare
che sta lavorando per trovare soluzioni condivise, che rispettino la materia
autentica che si è salvata e che si è riusciti a recuperare tra le macerie, con le
esigenze di restituire una architettura sicura rispetto alla sua vulnerabilità sismica.
Struttura a pontile (iconostasi) della navata sinistra,
chiesa di S. Salvatore in Campi, Norcia (PG): fasi della
ricomposizione a terra della balaustra litica e dei conci
affrescati presso il deposito di Santo Chiodo a SpoletoAntonella Basile, Cristina Lollai, “Tre rilievi provenienti da Amatrice e Accumoli,
presentati alla mostra ‘Oltre una sorte avversa. L’arte di Amatrice e
Accumoli dal terremoto alla rinascita’ a cura della Soprintendenza Archeologia
Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Roma e la provincia di Rieti”,
durata 1 lezione da 45 minuti.
Le tre opere provengono dal cratere di Amatrice, sono state conservate nel
deposito di beni mobili di Cittaducale e sono contestuali a edifici e fabbricati crollati
o parzialmente abbattuti dal terremoto del 2016. Si tratta di un rilievo raffigurante
un Angelo Annunciante, risalente al XV secolo e proveniente da un edificio privato
di Amatrice, di un’iscrizione documentaria con stemma, analogamente risalente al
XV secolo e originariamente collocata nella Chiesa di Sant’Agostino ad Amatrice,
e di una lapide commemorativa del terremoto del 1703, proveniente dalla Chiesa
di San Francesco ad Accumoli.
Le decorazioni dei tre rilievi presentano un’antologia degli strumenti di lavorazione.
La lezione espone lo studio dei rilievi, delle caratteristiche intrinseche dei materiali
costitutivi e il procedimento della rilevazione e riconoscimento delle tracce degli
strumenti.
Gli strumenti di lavorazione dei materiali lapidei
possono considerarsi come i pennelli per un pittore, e
le lavorazioni, gli stiacciati, i bassorilievi, il mezzo
tondo e il tuttotondo, creano i diversi volumi delle
superfici decorate su cui la rifrazione della luce
accentua ed esalta le decorazioni.
In questo caso i tre rilievi presentano una patinatura
superficiale. L’esposizione degli argomenti affronta lo
studio e la riflessione delle diverse accezioni: della
patina, della patinatura e della pellicola.
Per quanto riguarda l’analisi del contesto storico-
artistico, le tre opere testimoniano dei momenti
importanti per la vita della comunità amatriciana,
come ad esempio il rapporto tra la popolazione e i
frequenti terremoti, tra distruzioni e ricostruzioni, e
l’insediamento degli ordini mendicanti nel territorio
del reatino, avvenuta tra il XIII e il XIV secolo, con le
sue ripercussioni nell’ambito della devozione
popolare.
Bottega Italia centrale,
“Angelo annunciante (o adorante)”,
1400-1425 circa, scultura in pietra
arenariaNel primo caso, l’iscrizione documentaria con stemma, coeva alla realizzazione del portale, menziona un “magister Johannes” dell’Ordine degli Agostiniani, tradizionalmente considerato come l’architetto dell’edificio di culto, ma più probabilmente il responsabile amministrativo del cantiere. La chiesa di Sant’Agostino ad Amatrice costituisce uno dei monumenti più rilevanti dell’architettura religiosa urbana. I conventi degli Agostiniani e dei Francescani, i due maggiori complessi religiosi di Amatrice, si trovavano, rispettivamente, ai limiti orientale e meridionale del centro della città, nel rispetto della consuetudine degli ordini mendicanti di occupare le aree ai margini del territorio urbano. Nel secondo caso, la lapide con iscrizione a lettere capitali, recuperata nel luglio del 2017, documenta la distruzione della Chiesa di San Francesco ad Accumoli, causata da un violento terremoto che il 14 gennaio 1703 ebbe come epicentro Leonessa, Cascia, Norcia e Montereale, nonché la sua ricostruzione per il generoso interessamento di un illustre abitante di Accumoli, Giovanni Pasqualoni. A causa del sisma del XVIII secolo, la città dell’Aquila fu rasa al suolo e morirono circa 6.000 abitanti. Nelle città di Amatrice, Accumoli, Antrodoco e nel Cicolano si contarono migliaia di morti. Il terremoto del 1703, per la sua potenza devastante, è riecheggiato in molte testimonianze epigrafiche della valle del Velino e in varie fonti letterarie. Nel terzo caso, si parlerà dell’analisi stilistica ed iconografica del rilievo dell’ “Angelo Annunciante (o Adorante)” rinvenuto tra le macerie di Amatrice e probabilmente utilizzato come elemento di reimpiego. La presenza dello stiacciato nel bassorilievo consente di collocare stilisticamente la datazione dell’opera al primo Quattrocento, nell’ambito della produzione centroitaliana che si affacciava alle novità apportate da Donatello. L’Angelo, incorniciato da una decorazione a motivi vegetali, è raffigurato stante, con i capelli raccolti e le braccia incrociate sul petto. Il gesto delle braccia incrociate sul petto è documentato fin dall’antichità, presente già nei monumenti funerari egizi. Questa interpretazione nel contesto funerario viene continuata anche in ambito cristiano e applicata alle tipologie dell’uomo di dolori (imago pietatis) e della Dormitio Virginis. Nell’alto Medioevo veniva utilizzato come variante iconografica delle mani giunte, simbolo di preghiera, mutuato dal mondo feudale, che sostituisce gradualmente il gesto dell’orante, diffuso nei primi secoli del Cristianesimo. Questa posa è correlata molto spesso, ma non in maniera esclusiva, a valori trascendenti e mistici. Sono attestati, infatti, esempi di braccia incrociate sul petto come segno di ossequio e di accettazione dell’autorità di un personaggio superiore per rango o che rivesta una posizione di potere. Associato alla figura di Maria, il motivo iconografico viene introdotto dagli artisti toscani nel XIII secolo e trae la sua fortuna dalla circolazione di testi e immagini incentrati sulla devozione della Vergine nell’ambito degli ordini mendicanti.
Elisabeth Huber, Lucia Conti, Giulia Galotta, “Il restauro delle sculture in terracotta danneggiate dal sisma del 2009. Analisi di un caso studio: il presepe con figure a grandezza naturale in terracotta policroma e dorata (XVI secolo), attualmente esposto al MunDA dell’Aquila”, durata: 2 lezioni da 45 minuti. Il presepe fittile di Santa Maria del Ponte, conservato al Museo Nazionale d’Abruzzo a L’Aquila, è stato ricoverato, a seguito dei danni riportati durante il terremoto del 2009, al Museo di Celano. Dopo un primo pronto intervento, il gruppo scultoreo è stato poi trasportato ai laboratori di restauro dell’ICR, per essere sottoposto ad un intervento di restauro completo. Questo avrebbe incluso anche un’approfondita campagna diagnostica, un’accurata documentazione grafica, fotografica, e un filmato dell’intervento. Il presepe, attribuito a Saturnino Gatti e databile alla fine del ‘400, è costituito da tre figure a grandezza naturale (Madonna, San Giuseppe e Bambino). Durante il terremoto, le figure maggiori, composte da varie sezioni ceramiche, hanno riportato fratture e fessurazioni. Oltre a questi danni più recenti, in passato il presepe aveva già subito consistenti restauri, caratterizzati da interventi strutturali ed estetici. Il restauro del gruppo si è svolto da marzo 2011 a marzo 2012. Questo ha compreso la rimozione di gran parte dei precedenti interventi, la pulitura delle superfici, il consolidamento della pellicola pittorica e la revisione degli incollaggi. Particolare attenzione è stata prestata alla restituzione della stabilità strutturale del gruppo e alla presentazione estetica delle figure. Infatti, a restauro concluso, il gruppo ha acquistato una maggior leggibilità nei suoi valori cromatici, evidenziando l’alta qualità della cromia esistente. Infine, per garantire la corretta conservazione del gruppo scultoreo nel suo luogo di provenienza, ad alto rischio tellurico, è stata necessaria la progettazione e realizzazione di un sostegno antisismico. In occasione degli interventi conservativi dell’ICR sono state eseguite indagini scientifiche approfondite, allo scopo di investigare sulle tecniche esecutive originali e gli eventuali rifacimenti. Presso il “Laboratorio di Prove sui materiali” sono stati studiati in particolare i pigmenti utilizzati e alcune forme di alterazione delle lamine metalliche. Parallelamente, per quanto concerne le parti lignee delle sculture (mani e aureole), nel “Laboratorio di Indagini biologiche” sono state eseguite analisi xilotomiche per l’identificazione delle specie legnose impiegate. Sono stati effettuati vari prelievi nel corso del 2011, tenendo conto dei dubbi o problemi che emergevano di volta in volta durante il restauro effettuato presso i nostri laboratori, secondo la consueta modalità operativa propria dei laboratori scientifici dell’ICR.
Presepe in terracotta policroma e dorata del XVI secolo, attualmente esposto al MunDA dell’Aquila, danneggiato dal sisma del 2009, veduta generale dopo il restauro
Puoi anche leggere