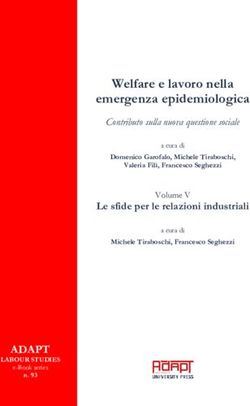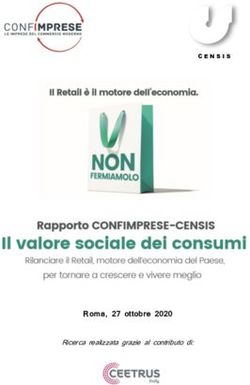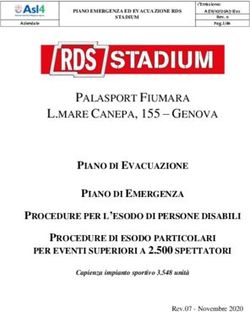SOS UCRAINA Bando Traguardi Solidali - Un dispositivo creato da Psicologi e Mediatori per l'emergenza Ucraina
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
in collaborazione con
Associazione Multietnica dei Mediatori Interculturali ETS
VADEMECUM
SOS UCRAINA
Un dispositivo creato da Psicologi e
Mediatori per l’emergenza Ucraina
Bando Traguardi Solidali
Maggior sostenitore:PREMESSA A.M.M.I. nella frontline dell’emergenza Ucraina In emergenza bisogna salvare! Nell’immediato indispensabilmente la vita, ma una volta fuori pericolo, bisogna salvare anche ciò che resta degli assets e i patrimoni, del futuro delle persone. Si costruiscono nuove identità, si ripristinano percorsi e/o si avviano nuovi orizzonti generando ulteriori strumenti di supporto. Perché la guerra non solo uccide; ma mette anche in ginocchio identità e dignità delle persone che ne sopravvivono, annullando condizioni sociali e professionali. La risposta umanitaria ai bisogni primari diventa però debole senza interventi di accompagnamento e sostegno alla (ri)costruzione del contesto distrutto, ma soprattutto delle persone nell’ampio significato del concetto: ripristino dell’identità sociale, educativa e professionale dell’individuo, vittima dell’emergenza. In A.M.M.I., da mediatori interculturali che attivano il dispositivo di mediazione nell’ambito di un team multidisciplinare pluri- competente, siamo il vettore che mette in connessione, attori, servizi e risorse sul territorio in una rete finalizzata a costruire, mattone per mattone, percorsi di inclusione e accesso ai diritti garantiti per legge in Italia. Il progetto SOS UCRAINA riflette pienamente questa nostra mission e si iscrive tra gli interventi frontline di A.M.M.I. a favore dei richiedenti di protezione di nazionalità ucraina, insieme alla formazione degli operatori pubblici e della Croce Rossa e alla mediazione interculturale on call su richiesta del territorio, dalle scuole, agli ospedali, alle istituzioni locali. Perché proprio come il concetto del Nexus*, non c’è salvezza fino in fondo senza un ripristino e uno sviluppo del dopo; con ciò che rimane o con un reinventarsi della propria identità. Ana Ciuban, Trainer in Mediazione Interculturale e Vicepresidente A.M.M.I. Associazione Multietnica dei Mediatori Interculturali *Nexus: concetto in cooperazione internazionale che presuppone la collaborazione tra gli attori dell’umanitario (emergenza) e quelli dello sviluppo (post-emergenza). 2
INTRODUZIONE
Il progetto SOS UCRAINA è iniziato ufficialmente a giugno 2022
ed è terminato a febbraio 2023, è stato scritto interamente
dall’Associazione A.M.M.I. - Associazione Multietnica dei Mediatori
Interculturali in partenariato con l’Associazione di Volontariato
Psicologi nel Mondo - Torino. La prima attività del progetto è,
in realtà, partita subito dopo l’inizio del conflitto, a marzo 2022,
quando il gruppo di Ester Chicco, Presidentessa di Psicologi nel
Mondo - Torino e Alfredo Mela, hanno contattato l’Associazione
A.M.M.I. in modo da organizzare degli incontri di condivisione e
supervisione rivolti principalmente ai mediatori interculturali. Tale
proposta è nata in quanto avevano sperimentato questa tipologia
di incontri durante la Pandemia, con le insegnanti di alcune
scuole ed avevano riscontrato un’importante partecipazione,
indice dell’importanza di condividere e creare delle connessioni in
tempi di emergenza e crisi. Dopo qualche settimana gli operatori
di A.M.M.I. hanno riscontrato un grande bisogno di mediazione
interculturale considerato il gran numero di arrivi che si è registrato
nei mesi successivi al conflitto (circa 10.000 Fonte IL PIEMONTE PER
L’UCRAINA - Il PiemonteInforma). Pertanto, inerentemente al Bando
“Traiettorie Solidali” pubblicato dalla Fondazione Compagnia di San
Paolo, si è presentato un progetto che potesse offrire un maggior
numero di servizi. Le azioni presentate sono state definite proprio a
partire dagli incontri rivolti ai mediatori ed agli operatori impegnati
nell’emergenza, poiché la loro testimonianza e il loro racconto è
stato fondamentale nell’individuazione dei bisogni di contesto.
Le azioni erogate sono state:
1) creazione di gruppi di supervisione e supporto con mediatori
interculturali e altri operatori direttamente impegnati a supporto di
rifugiati provenienti dall’Ucraina; 2) attività di formazione AD HOC,
compresa di elementi di mediazione interculturale e informazione
generica sulla psicologia dell’emergenza; 3) supporto psicologico
individuale e di gruppo; 4) mediazione interculturale; 5) sostegno ai
mediatori interculturali di lingua ucraina che decideranno di avviare
tale attività professionale, aprendo la partita IVA; 6) attivazione
di laboratori di conversazione in italiano e segretariato sociale.
Quest’ultima azione è stata poi convertita in servizi offerti durante la
formazione e maggiori risorse disponibili per la scuola di lingua italiana.
3Oltre ad attività rivolte ad Enti e Servizi ci si è proposti di scrivere
questo Vademecum per poter in primis raccontare le azioni messe
in campo in modo da lasciare traccia di come si può far fronte alle
situazioni di emergenza, di una possibile metodologia e delle criticità
che si possono incontrare, ma soprattutto, per dar voce ai mediatori
interculturali, i quali più che mai in questo momento, sono coinvolti
personalmente nell’ascolto e nel gestire il ruolo di ponte.
Nel primo capitolo si parlerà dell’importanza di prendersi cura
di chi cura e di ciò che è emerso dagli incontri con i mediatori/
operatori; nel secondo capitolo una nostra mediatrice interculturale
ci racconterà della sua esperienza in questi mesi di lavoro; nel terzo
capitolo l’antropologa Simona Meriano, esperta in violenza di genere
e traffico di esseri umani, descriverà l’importanza del lavoro su di sé
nei contesti in cui operiamo, in riferimento alla formazione ad hoc
rivolta agli interpreti; il quarto capitolo ci descriverà i laboratori di
inclusione svolti presso l’Istituto Comprensivo “Via Sidoli” che rientra
nell’azione 3 “sostegno psicologico di gruppo”; nel quinto capitolo
si parlerà delle caratteristiche generali dei percorsi di sostegno
psicologico erogati e verrà illustrato anche un caso; nel sesto
capitolo, il gruppo di insegnanti e volontari parlerà dell’esperienza
dei laboratori di lingua italiana e infine vi sono le conclusioni.
Speriamo che la lettura di questo breve scritto possa rendere la
complessità del progetto svolto e testimoniare la passione che ogni
collaboratore ha messo nel proprio lavoro.
Simona Torrente, Psicologa e Psicoterapeuta, project manager di SOS UCRAINA
e collaboratrice di A.M.M.I. - Associazione Multietnica dei Mediatori Interculturali
4prendersi cura di chi cura
Le caratteristiche di questa emergenza
Il progetto ha previsto come prima azione degli incontri di
supervisione/condivisione, rivolti principalmente ai mediatori
interculturali, ma estesi anche a tutti gli operatori coinvolti
nell’accoglienza di nuclei provenienti dall’Ucraina. Gli incontri si
sono svolti circa ogni due settimane nel corso di 10 mesi in modalità
prevalentemente online, poiché gli operatori operano su un territorio
molto vasto ed è stato difficile trovare un luogo che potesse essere
raggiungibile per tutti. Ogni incontro è durato due ore ciascuno e
sono stati condotti sempre da una professionista di A.M.M.I. e una di
Psicologi nel Mondo. Il gruppo è stato eterogeneo in quanto hanno
partecipato sia operatori provenienti da vari servizi sia Pubblici sia
Privati e, ovviamente, molti mediatori/interpreti.
Tali incontri sono stati fondamentali per diverse ragioni. Oltre,
infatti, al sostegno emotivo e alla possibilità di significazione e
contestualizzazione di ciò che ogni operatore, in particolare il
mediatore, stava vivendo, ci ha permesso in primis di comprendere le
caratteristiche di questa emergenza ed i bisogni delle persone accolte
nel Territorio. Ogni flusso migratorio, infatti, ha le sue specificità
e peculiarità che variano a seconda del paese di provenienza, del
tipo di migrazione, volontaria o forzata, dal paese ospitante e dalle
sue risorse umane ed economiche e dalle leggi che dispongono le
pratiche burocratiche per il rilascio dei Permessi di Soggiorno.
Le informazioni raccolte durante gli incontri sono state fondamentali
alla direzione delle azioni disposte dal progetto e al trattamento
specifico dei disagi emersi nelle prese in carico psicologiche e
negli interventi nelle varie Istituzioni. Nello specifico, quindi, i temi
principali emersi durante gli incontri sono: la mancanza di un progetto
migratorio delle famiglie attualmente accolte, la difficoltà dei bambini
e soprattutto degli adolescenti di frequentare la scuola, la dispersione
delle informazioni e, infine, il coinvolgimento emotivo dei mediatori.
Il primo tema, ovvero la mancanza di un progetto migratorio è stato
sicuramente il più ricorrente durante tutti gli incontri.
Chi scappa da Paesi africani o asiatici, come si registra nelle
Accoglienze Straordinarie gestite dalla Prefettura, è disposta a
non tornare più a casa pur di restare in Europa. Ciò comporta una
grande motivazione a radicarsi sul Territorio che favorisce l’adesione
a percorsi scolastici e di inserimento nel tessuto sociale italiano.
5Le famiglie ucraine, invece, hanno un progetto totalmente differente:
per loro l’Italia, e L’Europa in generale, sono una casa transitoria, in
cui attendere al sicuro la possibilità di tornare in Paese, dalle proprie
famiglie e spesso dai propri mariti, una volta cessato il conflitto.
L’attesa e l’indecisione tra il rimanere e il ritornare sono, quindi, temi
quotidiani per gli operatori e le mediatrici che lavorano nei contesti
di accoglienza e che rendono estremamente difficile la costruzione
di un progetto di integrazione. Questa oscillazione è presente altresì
sull’umore delle persone ucraine accolte. Rimanere in Europa è
sicuramente un’opzione favorevole sotto molti punti di vista, ed in
alcuni casi l’unica opzione, ma lo stare bene e il radicarsi qua, per
molti, porta con sé un senso di colpa e di tradimento nei confronti di
chi è rimasto a casa a combattere e resistere.
L’oscillazione quindi, non è solo dovuta a fattori esterni, come
l’andamento del conflitto, ma bensì anche da fattori interni come
quanto pesa la separazione con la Terra e la famiglia d’origine e la
condizione dei propri famigliari (Sayad, 2016). Tale tema è la causa della
difficoltà dei bambini e soprattutto degli adolescenti a frequentare
la scuola, problema riscontrato soprattutto a partire da settembre
2022. Molti di loro, infatti, rifiutano di andare a scuola o di imparare
la lingua italiana, in primis proprio perché vivono l’oscillazione delle
mamme tra il desiderio di ricostruire una vita qui e il bisogno di
ritornare dai cari in Ucraina. Inoltre, chi ha esperienza nel lavoro con
i migranti sa bene quanto può essere difficile imparare una lingua
nuova. Questa è, infatti, intrinsecamente legata alla definizione di chi
siamo e di come ci rapportiamo con il mondo. L’apprendimento che
di per sé è legato ad una perdita di una conoscenza vecchia in favore
di una nuova, richiede dunque una disponibilità a lasciar andare una
parte di sé al fine di mettere in gioco nuove parti (Boszormenyi-nagy
e Spark, 1988). Tale meccanismo, proprio per il suo forte legame con
la nostra identità, può essere estremamente complesso per chi vive
o ha vissuto una migrazione forzata. È importante precisare che
molte delle famiglie accolte hanno uno o più minori a carico con
disabilità, questo perché, come spesso accade nei Paesi in guerra,
i primi che scappano solo coloro che presentano delle fragilità
sanitarie. Pertanto i bambini e gli adolescenti ucraini sono chiamati
all’arduo compito di inserirsi in un contesto pieno di diversità,
6fisica, intellettiva e culturale unita alla precarietà del progetto
migratorio dei genitori (Bini, 2017). Da ciò ne deriva una grande
fatica da parte degli operatori a interagire con giovani adolescenti
arrabbiati o ritirati in sé stessi, a creare un ponte tra la famiglia
e la scuola ed a costruire il senso dell’andare a scuola in Italia.
Per ciò che riguarda la dispersione delle informazioni la criticità
più grande si è registrata nei nuclei con problemi sanitari gravi,
dovuto alle lunghe liste d’attesa, la difficoltà a tradurre il materiale
precedente in Italiano ed il complesso sistema burocratico.
Infine, un elemento di cui si è parlato molto è il coinvolgimento
del mediatore stesso. Tale elemento va riportato come parte
integrante delle caratteristiche dell’emergenza poiché a differenza
di altri flussi a cui abbiamo assistito negli anni precedenti, come ad
esempio l’emergenza afgana verificatasi circa un anno prima, tutti
mediatori sono stati coinvolti in prima persona dal conflitto: tutte
(per la maggior parte sono donne) hanno parenti in Ucraina e tutte
hanno dovuto affrontare situazioni familiari complesse, ospitare
partenti in fuga e affrontare perdite e lutti. Perciò come ha detto
una mediatrice che da tempo collabora con diverse organizzazioni
nel territorio torinese, ad un convegno organizzato da A.M.M.I.,
tenutosi lo scorso 2 dicembre dal titolo “Il corpo e la Terra”, che
aveva come fulcro proprio il tema della guerra in Ucraina e della
violenza di genere, “Ogni qualvolta che si richiede un intervento
di mediazione, oltre alla complessità del caso, bisogna aggiungere
anche il peso della nostra sofferenza e la fatica che stiamo facendo
ad assistere i nostri cari” citando Hanna Horina, mediatrice di A.M.M.I.
Simona Torrente, A.M.M.I. - Associazione Multietnica dei Mediatori
Interculturali
Bibliografia
Bini, E. (2017). Famiglie migranti con minori disabili. Prospettive inclusive
nel sistema socio-sanitario e scolastico italiano.
Boszormenyi Nagy, I., Spark, G. (1988). Lealtà invisibili.
La reciprocità nella terapia familiare intergenerazionale, Astrolabio.
Sayad, A. (2016). La double absence. Des illusions de l’émigré aux souffrances
de l’immigré. Média Diffusion.
7
EMERGENZAprendersi cura di chi cura
Sostenere chi sostiene
In ogni situazione di emergenza, come evidenzia l’esperienza
accumulata dagli psicologi in molte situazioni di disastri, vi sono
diverse categorie di vittime, esposte a molteplici rischi per la propria
salute mentale. Tra queste, ovviamente si collocano in primo luogo
le vittime dirette, vale a dire la popolazione colpita da una calamità
naturale o, peggio, da un evento causato dall’azione umana. Subito
dopo occorre considerare le persone che hanno legami emotivi
profondi con le vittime dirette, in primo luogo i loro familiari ed
amici. Ad un terzo livello, tuttavia, vanno posti anche i soccorritori,
ovvero le persone che a vario titolo si prendono cura delle prime due
categorie di vittime. In alcune situazioni esse stesse sono esposte a
rischi anche mortali: si pensi a chi opera in zone di guerra o interviene
ad estrarre le vittime di un terremoto da edifici pericolanti. Tuttavia,
anche quando questi rischi per la salute fisica (o per la vita stessa)
sono assenti, chi si prende cura di persone che sono state esposte
ad eventi traumatici corre a sua volta il rischio di subire conseguenze
psicologiche anche gravi, di essere colpito da depressione o da altri
sintomi post-traumatici non dissimili da quelli delle altre vittime.
Per questo è necessario che chi si prende cura degli altri ponga
attenzione a prendersi cura anche di sé stesso. Chi si occupa dei
profughi dell’Ucraina si trova esattamente in queste condizioni: deve
aiutare persone fuggite da una guerra, che hanno subito spesso dei
lutti e che hanno lasciato in patria persone care e sono in ansia per la
loro sorte; ascoltano racconti di fatti terribili e di violenze inaudite;
8oltre a ciò debbono spesso anche occuparsi di questioni pratiche e
di aspetti burocratici, in una situazione complessa che aumenta il
livello di stress.
D’altra parte, tra coloro che si prendono cura ci sono delle distinzioni
di cui tener conto (Sbattella, Tettamanzi, 2013). Alcuni sono dei
professionisti, che hanno una preparazione specifica non solo di
natura tecnica, ma anche emozionale: hanno competenze utili
ed un’esperienza ad operare nell’emergenza. Medici, psicologi,
infermieri, personale della protezione civile, ed anche mediatori
culturali, assistenti sociali ed altri ancora sono tra questi. Altri, invece,
sono volontari: nel caso dell’emergenza Ucraina vanno considerati
tra questi anche gli interpreti volontari che hanno affiancato i
mediatori culturali nell’opera di traduzione, senza avere ricevuto
analoga formazione. In questo caso, poi, c’è un’altra variabile da tener
presente: quella che dipende dall’essere o meno di origine ucraina.
A differenza degli italiani, i mediatori culturali e gli interpreti ucraini
non sono solo dei “soccorritori”: quasi sempre hanno un ulteriore
coinvolgimento emotivo, ancor più pressante, per il fatto di avere
parenti ed amici rimasti in patria e per condividere l’angoscia e la
rabbia per vedere il proprio paese coinvolto in una guerra, per di
più da parte di un altro paese con cui esistono elementi in comune.
Essi hanno un percorso migratorio che li ha condotti in Italia molto
diverso da quello di chi fugge dalla guerra e questo crea una distanza
che si sovrappone in modo complesso con la condivisione di una
lingua e di una tradizione culturale.
Per loro, dunque, è particolarmente importante poter parlare,
comunicare il proprio vissuto e le proprie emozioni, condividere
con altri le difficoltà incontrate nella propria attività professionale,
le strategie messe in atto per difendere la propria integrità psichica
ed anche i momenti di gioia e di soddisfazione per i risultati del
proprio lavoro. Questo richiede, tuttavia, un dispositivo adeguato
e quello più adatto alla situazione ci è sembrato un dispositivo di
gruppo, condotto da psicologi, con la presenza di una pluralità di
voci e di competenze. Un gruppo di parola, vincolato dall’obbligo
di riservatezza, con finalità non terapeutiche ma di prevenzione del
9disagio e di sostegno ai compiti professionali o di quelli liberamente assunti dai volontari. Del resto, la psicologia di comunità e le esperienze maturate in questo ambito hanno messo in luce l’importanza di un lavoro su sé stessi fatto in gruppo. Il gruppo permette di far avvertire a ciascuno un sostegno rappresentato da una piccola collettività, permette di comprendere che le proprie difficoltà sono condivise anche da altri, mette ciascuno a contatto con le strategie adottate dagli altri per far fronte ai problemi, ha in alcuni momenti anche una valenza formativa, grazie a spiegazioni proposte da chi conduce o da altri partecipanti. In sostanza, dunque, è uno strumento di rafforzamento della resilienza tanto a livello personale quanto anche a livello di gruppo e serve a consolidare una rete di sostegno sulla quale si sa di poter contare (Procentese, Novara, Esposito, 2022). Alfredo Mela, sociologo , Psicologi nel Mondo - Torino Bibliografia Procentese F., Novara C., Esposito F. 2022 Emergenze collettive, in C. Arcidiacono, N. De Piccoli, T. Mannarini, E. Marta (eds.) Psicologia di comunità, vol. 2, Metodologia, ricerca e intervento, pp. 120-135. Sbattella F., Tettamanzi, M. (2013), Fondamenti di psicologia dell’emergenza, Angeli, Milano. 10
la posizione del mediatore
Scegliere il mestiere della vita non è facile.
Il mediatore interculturale è una persona che svolge il suo lavoro
tra uno straniero ed un interlocutore italiano, cercando di aiutare il
primo a capire cosa vuole l’operatore per ottenere, ad esempio, un
documento o un servizio, per poi tradurre all’utente ciò che viene
rimandato. Spesso si pensa che per svolgere questa attività servano
pochi strumenti, giusto un po’ di conoscenze su come funzionano le
pratiche. Però per capire meglio la teoria dobbiamo fare la pratica
altrimenti tutto sembra così semplice e lineare. Solo nel momento
in cui si lavora, e si cerca di farlo nel miglior modo possibile, si inizia
a capire che cosa significa svolgere il vero ruolo del mediatore
interculturale, con tutte le sue sfide e difficoltà.
Quando mi confronto con i miei colleghi, e ci lamentiamo delle
difficoltà incontrate con le persone, ci dobbiamo ricordare che, se
uno straniero non avesse problemi relativi all’integrazione e alle
pratiche, il nostro mestiere sarebbe inutile. Quindi, dobbiamo essere
pronti a diverse difficoltà non solo burocratiche, ma anche personali
come pregiudizi, autostima e razzismo. Tener conto del peso dei
traumi psicologici che portano a depressione, dipendenze, dubbi,
incertezze ecc. che rendono il comportamento delle persone che ci
cercano instabile e ambivalente e che rischia di essere interpretato
come poco rispettoso. In tutto questo è fondamentale non perdere
di vista noi stessi e salvaguardare la nostra posizione e il nostro
mandato.
Perciò un mediatore non può, e non deve, essere da solo durante
interventi, infatti, di solito con lui lavorano diverse figure
come: operatori sociali, antropologi, assistenti sociali, Psicologi,
insegnanti, educatori, infermieri, educatori professionali, impiegati
amministrativi ed Avvocati.
Per riprendere ciò che la dott.ssa Meriano ci ha insegnato in questi
mesi di collaborazione insieme è importante capire chi siamo,
rimanere saldi con la nostra presenza e professionalità ed unire la
preparazione all’esperienza, perché per un determinato caso una
prassi può funzionare molto bene come non funzionare per nulla,
perciò si deve essere pronti a mettersi sempre in gioco.
11Io sono diventata mediatrice interculturale a ridosso dell’inizio
della guerra in Ucraina. L’inizio del conflitto ci ha catapultati in una
situazione di grande confusione: solo nei primi mesi sono arrivate più
di 10.000 persone, ma in Piemonte eravamo solo 1000 residenti di cui
pochissimi mediatori. Perciò la quantità di lavoro è stata moltissima
e ci sono arrivate richieste di ogni tipo: dalla mamma con il figlio/a
disabile che aveva bisogno di medicine a persone che cercavano
di ricongiungersi con i familiari sparsi sul Territorio. Perciò abbiamo
dovuto fin da subito, imparare a distinguere le richieste più urgenti e
al contempo risolvibili, come succede in ogni emergenza.
Conseguentemente, è stato importante mettere dei confini
personali: mi sono spesso dovuta chiedere dove finisce la mediatrice
interculturale e dove inizia la persona Iryna con i suoi bisogni. Perchè
non potevo, e non posso tuttora, permettere che i sentimenti
prendano il sopravvento.
Questa emergenza ci ha quindi messo di fronte ad una grande
difficoltà soprattutto per quanto riguarda la gestione delle emozioni.
In particolare il vissuto più difficile è stato il senso di colpa e di
tradimento: per essere qua e non vicina ai miei connazionali rimasti
in Patria a combattere e per avere una posizione più agiata rispetto
alle persone che stavano scappando. Tale aspetto è stato tra quelli
che più di tutti ci ha messo in difficoltà nella gestione dei confini.
Sotto questo aspetto è stato fondamentale l’aiuto offerto dagli
incontri condotti da A.M.M.I. e Psicologi nel Mondo e una formazione
specifica che ho svolto poco dopo l’inizio della guerra. In questa
sede, riprendendo i concetti della Teoria Psicologica dell’Analisi
Transazionale, mi è stato illustrato come nelle relazioni d’aiuto ci
possiamo assumere nei confronti dell’altro tre diverse posizioni: il
bambino, che è quello più istintivo e meno mediato, che si attiva
con capricci e proteste per ottenere attenzione; l’adulto che è
la nostra posizione più mediata e quella centrata sia sui bisogni
dell’altro sia sui propri; e il genitore che è quello visto come buono
e onnipotente, che si attiva in modo protettivo per difendere l’altro
come se fosse “il suo piccolo bambino”. Questo passaggio è stato
per me importantissimo, poiché ho capito che talvolta gli utenti
assumono la posizione del bambino, perché sono indifesi e non sono
12
MEDIAZIONEin grado di effettuare richieste pensate, a causa della situazione di
emergenza in cui si trovano.
Quello che è fondamentale evitare, per noi mediatori, è di posizionarsi
nel ruolo genitoriale, poiché attivare il sistema di cure in modo così
forte per tutti è estenuante, e inoltre, il livello di protezione di un
genitore non può essere garantito e questo porta disillusione da
parte degli utenti e un grande senso di impotenza per noi. È quindi
importante stare nella posizione dell’adulto in modo da trattare
anche i beneficiari come adulti e favorire l’emersione delle loro
risorse. In ultimo, una delle più grandi sfide è quella di conquistare
la fiducia delle mamme e delle donne sfollate, poiché le persone che
scappano dalla guerra e che già si sentono tradite sotto molti punti
di vista, hanno difficoltà ad affidarsi a qualcuno di estraneo. Perciò è
stato importante, innanzitutto non rimanere sola e avere una rete di
professionisti disponibili ad intervenire, poiché il mediatore non può
fare tutto, e infine riuscire, attraverso un attento lavoro si di me a
trasmettere tranquillità e serenità.
Concludo dicendo che i professionisti non si nasce, ma si diventa
grazie all’esperienza e alle sconfitte che il mondo lavorativo mette
davanti a ognuno di noi.
Iryna Kupchyk, Mediatrice Interculturale, collaboratrice di A.M.M.I.
Associazione Multietnica dei Mediatori Interculturali
13‘
Il lavoro su di sE
Relazione di aiuto e lavoro su di sé
Chiedersi “chi sono e cosa sto facendo” è il primo passo nella direzione
del lavoro su di sé, dove presenza, attenzione e auto-osservazione
rappresentano le parole chiave su cui si fonda una relazione di aiuto
sana ed equilibrata.
Nella misura in cui l’altro ci fa da specchio, nell’incontro dobbiamo
necessariamente trovare il nostro centro, consapevoli che non
possiamo impedire alle emozioni di attraversarci, né ai pensieri
di prendere forma nella nostra mente, cosa che avviene spesso
in modo automatico ed incontrollato. Che lo vogliamo o no, la
relazione con l’altra persona fa vibrare il nostro corpo emotivo e
le vibrazioni raggiungono lo spazio mentale, attivando pregiudizi
e preoccupazioni. I pensieri sono legati alla dimensione temporale,
evocano immagini, ricordi, sensazioni, e può risultare difficile
distinguere ciò che ci appartiene da ciò che appartiene all’altro.
La relazione di aiuto, soprattutto in situazioni estreme, per essere
efficace ha bisogno di competenze e di preparazione, perché ci
porta ad identificarci con le parti frantumate di chi ha subito traumi
e violenze, per questa ragione è di fondamentale importanza
mantenere la centratura su di sé. L’identificazione con la sofferenza
dell’altro può causare malessere fisico, bloccare il plesso solare,
provocare stati di ansia, reazioni del tutto normali, ma che vanno
riconosciute e possibilmente condivise in gruppo o in supervisione.
La sensazione negativa che sopraggiunge non va rifiutata, ma
osservata in stato di presenza, con un approccio di tipo olistico, in
cui la mediazione interculturale sia parte di un intervento articolato
che coinvolga le diverse figure professionali della rete.
Lavorare su di sé significa prima di tutto far luce sulla propria
motivazione ad aiutare, diventare consapevoli che per mettersi
in gioco in situazioni di disagio e sofferenza non basta la buona
volontà, ma servono attenzione e capacità di centrarsi nel ruolo.
Soltanto la presenza consente di sperimentare relazioni autentiche,
non meccaniche e al contempo non confusive. Il senso del confine è
un altro concetto fondamentale che richiede la massima attenzione:
il contesto in cui avviene la relazione è un contesto specifico, che ha
dei confini ben precisi nello spazio-tempo e che va delimitato anche
nella propria sfera emotiva e affettiva nel momento in cui si accoglie
14
RELAZIONEl’altro, soprattutto se è della stessa cultura e provenienza. Nessuna
improvvisazione quindi, ma consapevolezza empatica e lavoro
permanente su di sé, aspetti sui quali il gruppo ha potuto riflettere,
sperimentandosi attraverso la condivisione e il gioco di ruolo.
In sintesi, i temi trattati durante l’incontro sono stati:
Presenza: partire sempre dal lavoro su di sé, centrarsi nel ruolo,
ricerca di consapevolezza, attenzione, auto-osservazione, crescita
personale/professionale.
Preparazione: importanza della formazione permanente, di studiare,
informarsi, acquisire competenze specifiche e metodologie.
Pratica: valorizzazione delle esperienze personali, importanza di
sperimentarsi sul campo in relazioni autentiche e pensate.
Supervisione: avere uno spazio in cui poter portare difficoltà, criticità,
stati d’animo.
Rete: contribuire a creare una rete di soggetti con i quali lavorare in
sinergia, nel riconoscimento dei diversi ruoli e professionalità.
Senso e direzione: mettere in atto azioni dotate di senso e definire
con gli attori coinvolti strategie e obiettivi degli interventi.
Simona Meriano, antropologa ed esperta antitratta, collaboratrice A.M.M.I.
Associazione Multietnica dei Mediatori Interculturali
15
DI AIUTOIL LAVORO NELLE SCUOLE L’intervento in Via Sidoli Nell’ambito dell’azione di sostegno psicologico di gruppo, è stato effettuato un intervento in due classi dell’istituto Comprensivo “Via Sidoli”, alla quale sono iscritti, dallo scorso settembre, alcuni allievi ucraini scappati dal conflitto che faticano ad aderire al progetto scolastico: assenze frequenti, difficoltà nell’apprendimento della lingua e nell’interazione con i coetanei. Tale lavoro è stato richiesto proprio dall’insegnante responsabile dell’inclusione, in quanto l’Istituto presenta già una grande eterogeneità di provenienza di allievi. Pertanto, al posto dell’azione di sostegno psicologico di gruppo, si è deciso di svolgere dei laboratori in due classi della scuola secondaria dove sono state riscontrate le criticità maggiori di inserimento. L’intervento, tenendo conto dei tempi emergenziali, è stato strutturato nel seguente modo: Incontro di 2 ore con gli insegnanti delle classi; 3 incontri di 2 ore in ciascuna nelle due classi della secondaria; Incontro di 2 ore di restituzione e riflessione con gli insegnanti sulle attività svolte con i ragazzi. L’obiettivo dell’intervento è stato quello di creare un contesto che innanzitutto consentisse ai ragazzi, tutti e non solo gli allievi ucraini, di star bene a scuola e lavorare, attraverso il gioco, allo svelamento ed al superamento di stereotipi e pregiudizi. A nostro parere non si può prescindere dal consentire ai ragazzi di sperimentare il piacere di giocare insieme ed il piacere del confronto. Inoltre, per lavorare sull’inclusione non si può concentrarsi su una sola provenienza, come quella ucraina in questo caso, poiché essa è da intendere come un processo che si estende a tutti gli attori presenti nel sistema scuola a partire dagli insegnanti. Nell’incontro con i professori abbiamo raccolto le informazioni sui singoli ragazzi e sulle dinamiche di gruppo, ed abbiamo sperimentato insieme un assaggio del potere socializzante del gioco. Gli interventi delle classi sono stati svolti da almeno 2 psicologi, un osservatore e una mediatrice di lingua ucraina, alla presenza degli insegnanti. 16
Oltre agli allievi ucraini c’erano altri ragazzi con difficoltà linguistica
che sono stati aiutati nelle attività dalla preziosa traduzione di
compagni che padroneggiano maggiormente l’italiano.
Con le classi abbiamo lavorato con l’utilizzo dei linguaggi universali
(il linguaggio corporeo, l’immagine, la musica, ecc..) partendo dal
rinforzo dell’identità dei ragazzi per facilitare l’apertura verso l’altro.
Gli strumenti utilizzati sono stati giochi per attivare le dinamiche
di gruppo, giochi espressivi e simbolici che potessero consentire ai
ragazzi di lavorare sui propri bisogni e desideri, sulla propria identità
e sull’importanza del riconoscimento e dell’incontro con l’altro.
Il disegno è stato utilizzato come possibilità di esprimere emozioni,
pensieri, e desideri.
Abbiamo utilizzato anche gruppi di confronto per sperimentare il
piacere di raccontarsi ed essere ascoltati e accolti dal gruppo.
La risposta dei ragazzi alle proposte è stata molto favorevole:
hanno spontaneamente attivato strategie di sostegno reciproco
e manifestato curiosità rispetto alle differenze culturali e sociali,
riuscendo in modo sorprendente ad andare oltre alcuni tra i più
comuni stereotipi. È emersa altresì una significativa attenzione
al mondo degli adulti, dimostrandosi ricettivi alle proposte che
hanno valorizzato gli aspetti relazionali. Inoltre, gli allievi di origine
ucraina sono stati entusiasti di poter usufruire della presenza della
mediatrice la quale ha permesso loro di condividere degli aspetti di
sé con la classe.
Ovviamente vi sono state alcune criticità. La più rilevante riguarda,
come spesso accade, il tempo: sole due ore di incontro con gli
insegnanti non sono sufficienti a creare un gruppo di lavoro
(insegnanti, psicologi e mediatori) sufficientemente allineato sulle
modalità dell’intervento. In una situazione non emergenziale il lavoro
può durare anche tutto un semestre e anche tutto l’anno scolastico.
Maria Dolcemascolo, Psicologa e Psicoterapeuta, collaboratrice Psicologi
nel Mondo - Torino
17Il sostegno psicologico La guerra è un evento estremamente pervasivo e in grado di marchiare irreversibilmente la vita delle persone e delle comunità, sia fisicamente sia psicologicamente. Irascibilità, umore depresso, incubi notturni, ricordi intrusivi e insonnia sono tra i sintomi che definiscono il Disturbo Post-Traumatico da Stress (DPTS) che, proprio a partire dall’osservazione e dal trattamento della sofferenza mostrata dai veterani di chi aveva vissuto la seconda guerra mondiale e del Vietnam, è stato concettualizzato e definito nella sua attuale dicitura (Van Der Kolk, 2020). I nuclei ucraini accolti nel territorio sono composti quasi unicamente da donne single o con figli, in quanto agli uomini non è permesso uscire dall’Ucraina. Pertanto la solitudine di molte madri con figli piccoli o in età scolare, sradicate dalla loro rete familiare, è certamente motivo di disagio e sofferenza. Per loro, la perdita o la distanza dai familiari, i cambiamenti legati alla scuola dei figli e la precarietà in cui vivono, legata all’incertezza rispetto all’andamento del conflitto e al progetto migratorio, costituiscono un rischio psico evolutivo per i minori e altresì per gli adulti che li accompagnano. Il progetto si è proposto di offrire un dispositivo di cura relativo alla salute psicofisica, idoneo a sostenere chi fugge da questa guerra, che potesse, accogliere la moltitudine di emozioni inespresse e confuse, prevenire ove possibile, l’insorgere di sintomi riferibili al DPTS, alleviare la condizione di sofferenza nelle situazioni in cui il disturbo si è già insediato e nello specifico guidare le persone nella ricerca di senso di ciò che è accaduto e della loro permanenza in Italia. Sono stati messi a disposizione di tutte le organizzazioni che si sono occupate dell’emergenza Ucraina cinque percorsi di sostegno psicologico da 10 incontri ciascuno con setting etnoclinico, in modo da offrire uno spazio di cura che tenga in conto delle differenze culturali presenti tra il paziente e il curante e che, perciò, prevede l’utilizzo della mediazione interculturale (per approfondimenti si legga Coppo, 2003; Taliani 2006; Beneduce 2007). I beneficiari che hanno richiesto i sostegni psicologici provengono da istituzioni e organizzazioni differenti. Hanno aderito ai percorsi donne single, madri con minori a carico, adolescenti ed una donna adulta disabile. 18
Parlare di risultati in ambito psicologico è sempre complesso, poiché
è difficile individuare degli indicatori di buona riuscita, considerato
che non è poco comune la situazione in cui gli effetti del percorso si
manifestano a distanza di molto tempo. Perciò mi limiterò a descrivere
alcune delle caratteristiche relative alle richieste di intervento, alle
risorse disponibili ed, infine, vi presenteremo il riassunto di un caso.
Premetto che tutte le mediatrici hanno insistito molto sulla
difficoltà dei beneficiari a comprendere il dispositivo psicologico in
quanto, come spesso accade, la debolezza è, spesso, fortemente
stigmatizzata tra le persone ucraine. In particolare in Ucraina, come
in tutti i Paesi dell’Unione Sovietica, la fragilità psicofisica era, in
un passato non troppo lontano, fonte di emarginazione. Ciò ha
certamente lasciato un segno importante che si rende visibile nel
pregiudizio nei confronti della condizione di vulnerabilità. Pertanto
le mediatrici hanno avuto il difficile compito di rassicurare le persone
ed accompagnarle a verbalizzare la loro richiesta di aiuto, in modo
che questa fosse accettabile innanzitutto per loro stesse.
Uno dei temi ricorrenti dell’emergenza ucraina è l’introversione
e l’opposizione di alcuni adolescenti verso la scuola ed è stato
pertanto affrontato anche in alcuni dei percorsi psicologici, sia
a livello familiare sia individualmente. Tale fase della vita è già
di per sé critica, poiché inizia il percorso di separazione dalle
proprie famiglie d’origine e la ricerca della propria identità. Tutto
ciò diventa ancora più complesso se si scappa da un conflitto e
si è catapultati in un nuovo Paese molto lontano dal proprio. La
letteratura in ambito etnoclinico ha moltissimi riferimenti rispetto
ai rischi psico evolutivi dei ragazz* migranti (si veda Sironi 2007;
Moro 2014; Ranieri e Bruschi 2018). In tal senso, al di là dei temi
affrontati nello specifico, di cui si potrebbe parlare per moltissime
pagine, in questo contesto è stato importante innanzitutto
ridefinire i sintomi dei ragazz* che spesso sono visti come “testardi”
“pigri” o “poco collaborativi”, per poter invece dar spazio alla paura
legata alle incertezze che sono tra le cause principali delle chiusure
e opposizioni. Inoltre, è stato fondamentale focalizzarsi sulla rete
da costruire intorno al ragazzo/a (scuola, struttura, famiglia) in
modo da contrastare il senso di solitudine che spesso accompagna
i migranti forzati.
19IL CASO O Infine, come accennato nei precedenti capitoli, in molti dei nuclei presenti vi sono persone con disabilità più o meno gravi. Pertanto, il percorso migratorio ha certamente influenzato la percezione delle proprie risorse fisiche e mentali a disposizione. A tal proposito il caso presentato illustra il percorso di Olga, inviato da un Centro specializzato in servizi rivolti a persone disabili (di cui non faremo il nome per proteggere la Privacy) e preso in carico da Simona Guida, Psicoterapeuta e collaboratrice di Psicologi nel Mondo - Torino, insieme alla mediatrice interculturale Hanna Horina. Il caso di O. O., una giovane donna ucraina di 33 anni, è fuggita da Karkhiv grazie ad un corridoio umanitario ed è giunta a Torino nel marzo 2022. L’istituto in Ucraina dove lei viveva, sia per via della sua disabilità motoria sia perchè da sempre abbandonata dai genitori, ha subito alcuni danni strutturali a seguito dei bombardamenti. All’inizio dei colloqui (settembre 2022), cominciati dopo che O. era qui in Italia da sei mesi, abbiamo affrontato insieme il grande tema pervasivo inerente alla questione se stare in Italia oppure ritornare in Ucraina. Infatti O. si descriveva così: “ho un piede in Italia e l’altro in Ucraina”. Abbiamo approfittato della sua contingente immersione in una nuova cultura (non solo la cultura italiana ma anche una nuova cultura qui in Italia della disabilità come evento possibile lungo il ciclo di vita di una persona) per nutrire progressivamente una positiva identità di persona disabile. Attraverso l’analisi di nuovi abiti ed accessori “all’italiana” (soprattutto nei primi mesi O. disponeva di pochi capi e necessitava di abiti, calzature e vestiti per la stagione invernale e per il freddo) lei ha individuato il suo stile personale preferito, aspetto dell’identità quasi inesistente nella persona istituzionalizzata. A ciò abbiamo aggiunto scambi e contaminazioni interculturali, su modi di dire idiomatici, abitudini quotidiane degli italiani, celebrazioni, arte e naturalmente reciproche degustazioni culinarie tra pasticceria ucraina (O. ha confezionato per l’organizzazione inviante e per me una torta al miele multistrato deliziosa, tipica ucraina) e delizie torinesi come i gianduiotti, i basin ëd Turin e vari dolci natalizi. Anche il fatto di poter lavorare per alcune ore al giorno in un bar gestito dalla stessa organizzazione ospitante ha contribuito a 20
stimolare in lei la costruzione di un’identità personale nuova,
dal momento che in Ucraina le persone con disabilità certificata
generalmente non lavorano con stipendio. Un certo senso di disagio
per essere qui in salvo -al contrario di amici o altri ospiti della struttura
a Karkhiv rimasti in Ucraina- ha spesso all’inizio fatto sorgere in lei il
pensiero e la volontà di spedire da qui generi alimentari e di conforto
(persino destinati alla sua famiglia, che lei descrive come da sempre
dedita all’alcool, alla violenza intrafamiliare e cronicamente in stato
di emergenza sociale). Ha avuto, ed ha tuttora, parecchie difficoltà
nell’imparare bene l’italiano.
O. riferisce di continui incubi notturni sulla guerra, su cui lei è peraltro
costantemente informata anche grazie ai quotidiani e numerosissimi
contatti video, audio e via WhatsApp con amici e conoscenti ucraini
nonchè tramite l’utilizzo di alcune app di aggiornamento. Nel tempo
ha perso progressivamente il controllo su quanto ha lasciato di
personale nella sua stanza a Kharkiv, oggetti di vario tipo, abiti, cibo
e la sua stessa pensione di invalidità.
È pervasivo il desiderio di lavorare per non pensare alla guerra, cioè di
fare per non pensare. Abbiamo infatti avuto modo di riflettere insieme
su come lo stress traumatico, situazione che naturalmente anche
lei vive benché qui in Italia, preveda una costante iperattivazione
generale (diurna e notturna) ed una sostanziale incapacità di valutare
le diverse rilevanze degli stimoli (O. soprassalta ad ogni rumore
improvviso che sente in città o attorno a sé).
Per Natale O. decide di fare un’esperienza che non ha mai fatto
prima: scegliere in piena libertà decisionale di compiere un viaggio
(Flixbus + aereo) da sola fino a Tallinn, Estonia, per andare a trovare
un’amica ucraina (con disabilità motoria) lì evacuata. Al suo ritorno
mi parla dell’esperienza in termini positivi per la sua netta percezione
di autoefficacia e per l’aumentata conseguente autostima, ma in
termini negativi a causa della situazione di insicurezza sociale che ha
avvertito anche lì, per via delle molte persone divenute filo putiniane.
Conclude che, ora come ora, desidera fortemente restare in Italia,
stabilirsi meglio con la residenza qui, una casa ed un lavoro.
Simona Guida, Psicologa e Psicoterapeuta Psicologi nel Mondo - Torino
Simona Torrente, A.M.M.I. - Associazione Multietnica dei Mediatori Interculturali
21Bibliografia Beneduce, R. (2007). Etnopsichiatria. Sofferenza mentale e alterità fra Storia, dominio e cultura (pp. 1-399). Carocci. Coppo, P. (2003). Tra psiche e culture. Elementi di etnopsichiatria. Torino: Bollati Boringhieri. Moro, M. R. (2014). Rischio e creatività in adolescenza in una società multiculturale. Rischio e creatività in adolescenza in una società multiculturale, 21-31. Rainieri, C., & Bruschi, G. Famiglia, adolescenza e migrazione: il percorso dell’identità nelle generazioni. CAMBIA-MENTI. Sironi, F. (2007). Psychopathologie des violences collectives. Odile Jacob. Taliani, S. (2006). Altri corpi. Antropologia ed etnopsicologia della migrazione (Vol. 1, pp. 11-296). Unicopli. Van der Kolk, B. (2020). Corpo accusa il colpo: Mente, corpo e cervello nell’elaborazione delle memorie traumatiche. Raffaello Cortina Editore. 22
La scuola di lingua italiana
La durata del corso, gli obiettivi
La scuola di italiano nell’ambito del progetto SOS UCRAINA si è posta
l’obiettivo di rispondere al forte bisogno linguistico e comunicativo
delle persone immigrate in Italia dall’Ucraina a causa del conflitto. Si
rendeva, quindi, necessario fornire strumenti di base per avvicinarsi
alla lingua italiana, conoscere il nuovo contesto culturale e avere
opportunità di contatto con persone italofone in un contesto di
accoglienza e scambio reciproco, anche per favorire occasioni per
una presa di distanza da esperienze traumatiche.
Per ampliare l’offerta formativa e in funzione delle richieste
pervenute, sono stati attivati due corsi:
uno in orario mattutino, dal 29 settembre al 15 dicembre 2022, il
lunedì e giovedì mattina, per un totale di 48 ore;
uno in orario pomeridiano, dal 3 novembre al 13 dicembre 2022, il
lunedì e giovedì pomeriggio, per un totale di 12 ore.
Il corso di 48 ore ha visto impegnato un gruppo di 5 volontari
della scuola Penny Wirton Torino e un’insegnante di italiano L2,
componente dello staff di A.M.M.I.
Il corso pomeridiano è stato animato da un gruppo di tre volontarie
della scuola Penny Wirton Torino.
I due corsi sono stati frequentati da ventuno studenti in totale.
La ricognizione dei bisogni
I bisogni formativi sono stati esaminati nel corso di colloqui
iniziali, che hanno permesso non solo di stabilire le competenze, le
aspettative, le aree di interesse degli studenti, ma anche di creare
un clima disteso e delle condizioni favorevoli all’interazione e ad un
apprendimento efficace.
Gli studenti sono stati raggruppati per gruppi di livello, A0, A1, A2, in
modo da adattare il percorso alle esigenze di ciascuno.
I volontari e la docente di italiano L2 hanno condiviso la
programmazione, le strategie e le informazioni sull’andamento del
corso e sui suoi contenuti.
La logistica
Le lezioni si sono svolte presso gli spazi dell’Associazione Psicologi nel
mondo, presso il servizio Passepartout della Città di Torino, in corso
23Unione Sovietica 220 d, uno spazio accogliente e ben organizzato. Grazie al buon numero di volontari coinvolti è stato possibile seguire quasi individualmente gli studenti e soddisfare così le diverse esigenze, personalizzando i percorsi di insegnamento. Le metodologie e gli strumenti didattici Si è lavorato sull’acquisizione e lo sviluppo contestuale delle quattro aree di competenza linguistica, personalizzando l’approccio e gli strumenti: 1) la comprensione orale 2) la produzione orale 3) la comprensione scritta 4) la produzione scritta In ciascun incontro si è affrontato un tema specifico connesso all’esperienza e alle necessità del quotidiano (la presentazione di sé, la famiglia, la casa, i vestiti e il cibo, i negozi, la città e i mezzi di trasporto, il tempo libero, il lavoro, la scuola, etc.), creando occasioni di apprendimento e consolidamento di lessico, strutture grammaticali e funzioni comunicative. Il lavoro in piccoli gruppi, se di livello omogeneo, ha favorito l’interazione, il supporto reciproco e il rinforzo della comprensione e della produzione orale. Il buon livello di scolarità di gran parte di studenti e studentesse ha reso più agevole la comprensione scritta e gli esercizi di scrittura. Gli strumenti di controllo del lavoro In classe è stato utilizzato un registro delle presenze e dopo ogni lezione veniva steso un breve report per condividere il lavoro svolto fra la docente di italiano L2 e i volontari. Questo ha permesso un lavoro sinergico tra le due realtà. La frequenza e la partecipazione Si è riscontrata una buona partecipazione e un’alta motivazione da parte degli studenti. La maggior parte di loro ha frequentato assiduamente e con entusiasmo quasi tutti gli appuntamenti. Il totale di partecipanti nel gruppo A0 è stato 3, si è dovuta affrontare una difficoltà iniziale anche nella semplice spiegazione di esercizi. 24
Non è stato possibile utilizzare alcuna lingua veicolare. Si è notato
un lento, ma significativo miglioramento nell’acquisizione di nozioni
base come il saluto, l’espressione del proprio stato d’animo, la
propria presentazione, la conoscenza di base dei numeri. È stato
necessario ad ogni lezione riprendere sempre tutto dall’inizio, sia
per ripassare sia per constatare il livello di acquisizione. L’interazione
è stata buona, nonostante le difficoltà di comunicazione.
All’interno del gruppo di livello A1/A2 si è creato un buon clima di
collaborazione e il livello di motivazione delle studentesse è stato
costante. Si è lavorato sugli aspetti grammaticali, ma soprattutto
sulla conversazione e anche sulla produzione orale. L’interesse e la
motivazione durante le lezioni sono stati alti.
Le lezioni individuali e/o per piccoli gruppi condotte dai volontari
hanno contribuito a rinforzare gli aspetti presi in esame con la
docente di italiano L2 e, grazie alla personalizzazione dei percorsi
per ciascuno, è stato possibile mantenere una buona frequenza e
un accompagnamento mirato per tutti, compresa la studentessa
con competenza B1, che è riuscita a continuare il suo percorso
individualmente.
I risultati didattici ottenuti
Il fatto che i partecipanti siano stati raggruppati per livello ha
facilitato molto il lavoro: la coesione fra gli studenti e la presenza
di un buon clima hanno permesso sia di lavorare con ritmi piuttosto
costanti durante le ore di ciascun incontro, sia di mantenere un buon
livello di attenzione.
Ci si è focalizzati molto sulla condivisione di esperienze personali,
sulla narrazione e sulla conoscenza reciproca. Alcuni studenti
avevano già frequentato dei corsi di lingua italiana e pertanto
avevano già familiarità con l’ambiente “scolastico”.
Il loro coinvolgimento, la costanza e l’entusiasmo con cui hanno
affrontato questa esperienza hanno permesso di ottenere buoni
risultati a fine corso.
Il successo del corso è dimostrato dalla richiesta di molti dei
partecipanti di proseguire le lezioni di italiano, per cui sono stati
inseriti, a partire da gennaio 2023, negli orari della Scuola Penny
Wirton Torino, con un ampliamento dei suoi orari di apertura.
25Criticità Alla ristrettezza del numero di ore di lezione si è cercato di sopperire offrendo a tutte e tutti la possibilità di proseguire lo studio all’interno dell’orario dei corsi di italiano nelle due sedi, Corso Unione Sovietica e Via Biella. Alle difficoltà comunicative e allo spaesamento spesso si accompagna la difficoltà a immaginare un nuovo progetto legato alla propria permanenza in Italia; questo porta ad una minore disponibilità ad apprendere e utilizzare la lingua italiana, in particolare tra gli adulti di età matura e tra gli adolescenti e all’incertezza legata alla mancanza di concrete prospettive per un proprio futuro prossimo in Ucraina o nel nostro paese. Un’altra criticità deriva dalla condizione di isolamento della maggior parte delle persone, che hanno pochi contatti con il contesto in cui si trovano e sono spesso limitate all’interno di strutture non sempre attente alle loro esigenze di vita e consuetudini. Emerge, infine, con particolare evidenza, l’indefinitezza della condizione vissuta, che si ripercuote anche sulla quotidianità. Punti di forza L’insegnamento dell’italiano è stato estremamente interessante e coinvolgente, perché indirizzato a persone desiderose di apprendere con rapidità, ma in modo preciso e corretto, al fine di un migliore inserimento nel nuovo contesto e talvolta per la ricerca del lavoro. Il senso di responsabilità è stato alto. Il metodo di insegnamento, basato su testi specifici e ben strutturati, ha permesso loro di progredire in modo generalmente rapido. Fra gli altri elementi i docenti evidenziano: - la frequenza costante il grande impegno, che ha portato, nella maggior parte dei casi, ad un miglioramento - l’interesse e la motivazione, che sono sfociati nella prosecuzione della partecipazione ai corsi, al di fuori del progetto - l’efficacia del lavoro in gruppo, che si è dimostrato positivo specialmente per gli studenti di livello più alto, che hanno avuto maggiori possibilità di fare conversazione e di confrontarsi - i buoni rapporti tra gli studenti e la condivisione di un’esperienza dolorosa comune 26
- gli ottimi rapporti con gli insegnanti e il riconoscimento da parte
degli studenti dell’accoglienza nei loro confronti.
Opportunità e sfide
In alcuni casi l’apparente difficoltà iniziale dovuta alla presenza
di un gruppo di studentesse anche con livelli diversi, si è rivelata
nei fatti un vantaggio per l’apprendimento, perché ha facilitato
l’apprendimento fra pari e il supporto dei più deboli da parte di
coloro che possedevano maggiori competenze.
Inoltre, la condivisione di esperienze, situazioni, paure, insicurezze
spesso ha rappresentato un fattore importante per queste persone,
evitando la percezione di essere “l’Altro”, “la minoranza”, o perlomeno
affievolendola a favore di un senso di appartenenza e partecipazione
in condizione di parità. Persone, mamme, figlie, amiche, sorelle,
maestre di danza, copywriter, parrucchiere sono solo alcuni dei
diversi ruoli con cui si sono presentate queste donne che hanno
deciso di mettersi in gioco e ricominciare da capo, trovando in
questo corso uno spazio per farlo.
27Un’occasione, seppur minima rispetto a tutto ciò che è stato lasciato indietro, per sentirsi parte di qualcosa, di un piccolo gruppo sociale caratterizzato da un’eterogeneità capace di arricchire e colmare, temporaneamente, un immenso vuoto. Il documento raccoglie i contributi di: Beatrice Bordignon, Federica Carlino, Gabriella De Vito, Claudia Golzio, Maria Teresa Ingicco, Andrea Mela – volontari della scuola Penny Wirton Torino Katerina Pyroutkovà, docente di L2 presso l’A.M.M.I. - Associazione Multietnica dei Mediatori Interculturali 28
Puoi anche leggere