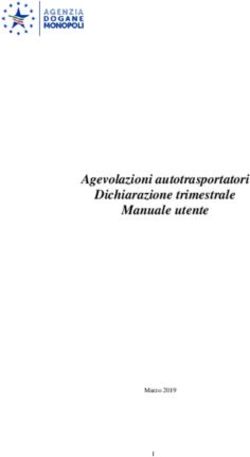SOCIOLINGUISTICA A (A.A. 2018-19, UNIV. PAVIA) - CHIARA MELUZZI (PHD)
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Il corso fino ad ora…
1. Definizione di SL 11. La sociofonetica
2. Il lavoro del SL 12. Sociofonetica in Italia/1
3. Le nozioni di base/1 13. Sociofonetica in Italia/2
4. Le nozioni di base/2 14. Sociolinguistica storica
5. Lingue d’Italia 15. Le variabili SL in
6. Minoranze linguistiche prospettiva storica
7. Multilinguismo e contatto 16. Applicazioni della SL
8. La SL laboviana storica
9. Altre chiavi interpretative 17. La socio-pragmatica
10. Il mutamento linguistico 18. Conclusioni
2Lezione 10
O Il mutamento linguistico (27 ott.)
O Innovazione e mutamento
O Mutamento dal basso vs. mutamento dall’alto
O Standardizzazione e de-standardizzazione
O Riferimenti bibliografici: Berruto (1995), cap. 5.4; Berruto & Cerruti
(2015), cap. 4.6.
O Approfondimenti: Auer P. (2005), Europe's sociolinguistic unity,
or: A typology of European dialect/standard constellations. In
Persepctives on Variation, Berlin/New York, 7-42; Cerruti, M. (2014)
From Language Contact to Language Variation. A case-study of Contact-
Induced Grammaticalization in Italo-Romance, Journal of Language
Contact 7, 288-308; Cerruti M., Crocco C., & Marzo S. (Eds.) (2016)
Towards a new standard. Theoretical and empirical studies on the
restandardization of Italian, Berlin: Mouton de Gruyter; Dal Negro,
S. & Guerini, F. (2007) Contatto. Dinamiche ed esiti del plurilinguismo,
Roma: Aracne; Kristiansen T. & N. Coupland (eds.). 2011. Standard
Languages and Language Standards in a Changing Europe, Oslo.Modelli di variazione
O Il centro della SL è la variazione, considerata come proprietà del
sistema linguistico
O Alcuni elementi della lingua sono correlati a significati sociali
O Il modello principale per descrivere la variazione è, in SL, quello
laboviano, che vede la variazione come (pp. 136-7)
O Interna al sistema linguistico
O Operante ‘in superficie’, non sulle strutture linguistiche profonde
O Interna alla grammatica di una lingua, che è l’unica a disposizione di
un parlante nativo
O La variabilità sia inoltre fatto costitutivo delle regole
O Rispetto alla CL il modello laboviano prevede che (p. 137)
O La grammatica di una CL sia rispecchiata in quella di un individuo
parte di quella CL
O Tutti i membri della CL condividono lo stesso insieme di regole variabili
O I giudizi di grammaticalità dei parlanti non riflettono differenze
strutturali
Berruto & Cerruti (2015: 136: 139)Labov vs. Chosmky
O Quello di Labov è però uno dei modelli di varazione
O Si oppone all’approccio generativista tradizionale secondo
il quale
O La variazione è data dalla scelta fra strutture/regole diverse
O Ogni struttura/regola è realizzata categoricamente
O La scelta di regole corrisponde alla scelta tra grammatiche
diverse
O Quindi, un parlante nativo ha competenza in più
grammatiche
O Il concetto di ‘grammatica della CL’ non è pertinente
O I giudizi di grammaticalità dei parlanti riflettono differenze
strutturali
O La variazione è dunque esterna al sistema linguisticoIl ‘programma minimalista’
O Da Chomsky (1995) è un paradigma generativo tra i più diffusi
O Mira a ridurre al minimo l’apparato teorico necessario per
spiegare le frasi
O Le ‘regole’ vengono ridotte a ‘principi’ e a ‘parametri’ che operano
sulla grammatica universale (G.U.)
O I principi sono universali in tutte le grammatiche delle lingue
O I parametri danno contro delle differenze strutturali dalle lingue (es.
soggetto espresso/soggetto nullo)
O Per spiegare differenze parametriche intralinguistiche si fa
ricorso ad altri sotto-modelli
O Il modello di Henry (2005) postula l’esistenza di più di due
grammatiche per spiegare le differenze parametriche: ogni
grammatica contiene un parametro che attiva un valore in base al
contesto
O Adger & Smith (2005) invece spiegano la variazione come un
meccasnismo separato rispetto al sistema linguistico, che è legato
alla sola scelta degli elementi lessicaliUn dialogo impossibile (?)
O Generativismo e sociolinguistica vedono la
variazione in maniera opposta
O Interna e ‘innata’ a qualsiasi sistema linguistico (SL)
O Esterna al sistema linguistico e quasi ‘accidentale’
(generativismo)
O Storicamente, lavorano anche su una parte del
sistema molto diversa e diversamente soggetta a
variazione intra-linguistica
O Fonetica/fonologia -> alta variabilità (SL)
O Sintassi -> maggiore stabilità (generativismo)
O Le proposte di dialogo tra le due discipline sono
poche e non hanno avuto grande successoIl mutamento linguistico
O La variazione NON è mutamento!
O Variazione: sincronica
O Mutamento: diacronico
O Il mutamento linguistico è (quasi sempre) ingenerato da
fenomeni di variazione
O Detta altrimenti: la variazione linguistica può ingenerare un
mutamento linguistico in un certo lasso di tempo (in genere,
più di una generazione)
O C’è una condizione essenziale perché si possa affermare che
si è verificato un mutamento
O Una nuova forma o struttura si deve diffondere e deve essere
accettata dalla comunità parlante
O A quel punto può iniziare a ‘stratificarsi’ e a variare nuovamente
O Il mutamento linguistico, quindi è sempre legato a una fase di
INNOVAZIONE (= introduzione della nuova forma)
Berruto & Cerruti (2015: 139-142)Le fasi del mutamento
O Fase I: la nuova forma viene introdotta nella produzione di un
parlante (o un gruppo circoscritto di parlanti)
O Fase II (‘innovazione’): la nuova forma si diffonde nel
comportamento linguistico di quel parlante (es. situazione d’uso,
norme d’uso)
O Fase III: la nuova forma si diffonde, con quel comportamento
linguistico, ad altri parlanti (o gruppi di parlanti)
O Fase IV: la nuova forma viene in generale adottata da tutta la
comunità -> mutamento
O Nota: la fase II e la III prevedono una compresenza di ‘vecchia’ e
‘nuova’ forma.
O Sul piano SL questo si traduce in una grande variazione in
queste fasi.
O È un processo per certi versi simile al passaggio basiletto-mesoletti-
acroletto, oppure al processo di koineizzazioneInnovazioni senza mutamento?
O Spesso una innovazione linguistica NON genera un
mutamento
O In questo caso due varianti si trovano a convivere nel
repertorio di una comunità e l’uso dell’una o dell’altra variante
è regolata da precise ‘norme d’uso (es. situazione
comunicativa, covert-/overt- prestige)
O Es. (ing) / [ɪŋ] stand. Vs. [ɪn] sub-stand.
O Il mutamento si può osservare SOLO in diacronia
O Reale (nell’altro di più generazioni)
O Apparente = assumendo che i comportamenti ling. degli anziani
riflettano le fasi antezioni del processo in corso.
O Nota: il percorso «lineare» di mutamento può essere interrotto
od ostacolato da molti fattori
O Introduzione di una nuova variante concorrente
O Cambiamento dell’atteggiamento linguistico dei parlanti nei
confronti di quella variante e/o del gruppo linguistico portatore
dell’innovazione
O Politiche linguistiche (es. revitalizzazione della varietà ‘antica’)Changes
from above & from below
O Distinzione ‘classica’ del paradigma laboviano
O La distinzione è data dal gruppo linguistico che introduce la variante innovativa
O Changes from above (mutamenti dall’alto)
O Originano nelle classi sociali dominanti
O Changes from below (mutamenti dal basso)
O Originano nelle classi sociali più basse
O MA la distinzione tiene anche conto della consapevolezza sociale dei parlanti di una
CL di fronte all’innovazione
O «Above» social awareness = i tratti linguistici innovatori godono di prestigio sociale (in
quella CL)
O «Below» social awareness = i tratti linguistici innovatori hanno origine nel parlato
spontaneo non accurato e, almeno nelle prime fasi, non c’è consapevolezza sociale
dell’innovazione e dei suoi eventuali valori di maggiore o minore prestigio
O Quindi, la distinzione tra questi due tipi di mutamento riguarda
contemporaneamente
O La dimensione diastratica (classe sociale che introduce l’innovazione)
O La dimensione diafasica (parlato spontaneo o controllato)
O L’attribuzione di un valore di prestigio all’innovazione
O Questa visione del mutamento rientra pienamente in una ‘distribuzione laboviana’
della variabiliDiffusione delle innovazioni
O Rappresenta il modo con cui
tipicamente una innovazione
si diffonde
O All’inizio la forma innovativa
% aumenta gradualmente la
diffusione
sua diffusione
della O L’innovazione a un certo
forme punto cresce rapidamente
O un cambiamento forte negli
atteggiamenti linguistici dei
parlanti
O Cambiamento generazionale
forte (fattori esterni e/o
tempo interni alla CL)
O L’innovazione raggiunge poi
Curva sigmoidale una fase di ‘assestamento’
dell’innovazione SL O Il mutamento linguistico si è
(o ‘andamento a esse’) compiutoInnovazioni & Adozioni
O Dubois & Horvath (1999) studiano la diffusione di tratti innovatori nel
cosiddetto Cajun English (Louisiana, USA)
O Età dei parlanti
O Network dei parlanti
O Notano un drastico cambiamento nell’atteggiamento verso il Cajun dovuto a
una politica di revitalizzazione (e anche a una fortuna commerciale
economica)
O Lo studio porta gli studiosi a distinguere tra ADOZIONI di nuove forme e
INNOVAZIONI linguistiche
O ADOZIONI: la nuova variante introdotta è in realtà già parte della norma di
un’altra comunità (contatto ling.)
O Componente soprattutto sociale con una dimensione linguistica
O INNOVAZIONI: i cambiamenti sono originati all’interno della stessa comunità
linguistica
O Componente soprattutto linguistica con una dimensione sociale
O Questa terminologia sarebbe, secondo gli autori, più precisa del laboviano
«changes from above/from below)
O Tiene conto indubbiamente del contatto trasversale in situazioni appunto di
bilinguismo bicomunitario (o monocomunitario)
Kiesling, S. F. (2011) Linguistic Variation and Change, Edinburgh: Edinburgh University Press, pp. 87-89.Unire le nozioni:
sociofonetica &
language attrition
C. Celata, R. Nodari, N. Nagy (2017) «Inter-speaker and
cross-generation patterns of variation in phonetic and
phonological attrition», conference presentation at Plasticity of
native language phonetic and phonological domains in the
context of bilingualism Colloquium, 11° International
Symposium of Bilingualism, Limerick, 15 June 2017.The corpus 1° generazione: parlanti che hanno vissuto almeno Nagy (2011) per i primi 18 anni di vita in Calabria 2° generazione: parlanti nati a Toronto o arrivati a Toronto prima dei 6 anni di età. I loro genitori appartengono alla 1° generazione. 3° generazione: parlanti nati a Toronto, da genitori appartenenti alla 2° generazione.
Il repertorio linguistico dei parlanti
1° generazione di immigrati
- L1
Calabrese (dialetto/lingua)
Italiano regionale Calabrese
- L2
Toronto English
2° e 3° generazione di immigrati
- L1
Toronto English
- Heritage language
Italiano regionale calabreseHeritage languages
“The heritage speakers performed significantly better
than L2 learners and closer to native speakers in the
phonology and pronunciation test on VOT values.”
(Au et al. 2002)
“early heritage language experience can, but does not
necessarily, result in a phonological advantage over L2
learners with respect to tone” (Chang & Yao 2016)
“Many of these individuals have acquired these languages
“the range of proficiency in the as a first language (L1) to some degree – either
heritage language varies monolingually or simultaneously with the majority
considerably: while some have language – but, for a variety of reasons, their heritage
limited productive ability … others language became their secondary/second language”
are as proficient as native speakers” (Montrul 2008)
(Montrul 2005)
“people who […] have cultural connections to and
know languages other than English. These languages
are not “foreign” to particular individuals or
communities; instead, they are familiar in a variety
of ways” (Kelleher 2010)Domanda di ricerca
O Variabile linguistica: Long-Lag VOT (allungamento del VOT > aspirazione)
O Valori sociofonetici (v. Nodari 2017)
O L’aspirazione delle occlusive sorde è una variabile sociofonetica nell’italiano
regionale calabrese
O È legata all’identità regionale, a una attitudine positiva verso il dialetto e a
una attitudine negativa verso la scuola
O Problema metodologico
O Una diversa realizzazione del VOT si ritrova anche nell’inglese di Toronto
MA non ha valore sociofonetico
O Una variazione sociofonetica rispetto al VOT si trova in altre varietà
d’inglese (v. Scobbie 2006, Docherty 2011)
O Tuttavia anche in questi casi la variabilità del VOT NON ha gli stessi
correlati sociofonetici che presenta nel Calabrese
O Domanda di ricerca: qual è il legame tra variazione sociofonetica in
un processo di language attrition?
O Ossia, vi è una language attrition attraverso la perdita del valore
indessicale della variazione sociofoneticaI dati
O 21 parlanti
O 4 della I generazione
O 9 della II generazione
O 8 della terza generazione
O Protocollo di ricerca
O Conversazioni spontanee in Calabrese-Italiano
O Estrazione di 2930 items lessicali with /p t k/
O 1497 in posizioone (V)CV con seconda vocale tonica
O 1433 in posizione C.CV con seconda vocale atona
O Codifica UDITIVA dei token come aspirati o non-aspirati
O Misure acustiche di durata di VOT, fase occlusiva, vocale
seguenteCosa cerchiamo?
O Se viene mantenuta una variazione sociofonetica nei
due fenomeni salienti, ossia nella variazione
O della durata del VOT (variabile fonetica)
O della distribuzione dell’aspirazione nei diversi contesti
lessicali (distribuzione fonotattica)
O Se ci sono differenze (come da attese) tra la prima
generazione e le altre
O Nella prima, la variazione sociofonetica dovrebbe essere
ancora intatta
O Nella seconda e terza generazione un processo di
language attrition potrebbe portare alla perdita
progressiva della variazione sociofonetica
O Domanda: di tutta la variabilità sociofonetica? O solo di
una parte? E se sì, quale?Risultati 1: Il VOT
Calabrian Italian p t k
Sorianello (1996) word list 25 ms 50 ms 67 ms
Nodari (2017) conversation 34 ms 41 ms 48 ms
(raw values)
Current study p t k
(V)CV First generation 38 ms 31 ms
Second generation 43 ms 41 ms 43 ms
Third generation 43 ms 40 ms 47 ms
C.CV First generation 23 ms 34 ms 36 ms
Second generation 34 ms 43 ms 49 ms
Third generation 37 ms 50 ms 68 msRisultati 1: Il VOT
n.s. n.s.
T K T K
Fixed effects:
Estimate Std. Error t value
(Intercept) 0.252664 0.050997 4.955
GenerationSECOND -0.004042 0.037603 -0.107 Fixed effects:
GenerationTHIRD 0.022208 0.043178 0.514 Estimate Std. Error t value
Obstruent_placeP -0.085366 0.022586 -3.780 (Intercept) 0.27661 0.03943 7.016
Obstruent_placeT -0.032612 0.016826 -1.938 GenerationSECOND -0.03152 0.04291 -0.735
Vowel_height_nonhigh -0.028250 0.009220 -3.064 GenerationTHIRD -0.04419 0.04684 -0.944
GenerationSECOND:Obstruent_placeP 0.043322 0.034030 1.273 Obstruent_placeP -0.05663 0.01867 -3.032
GenerationTHIRD:Obstruent_placeP -0.051280 0.044441 -1.154 Obstruent_placeT -0.04199 0.01750 -2.399
GenerationSECOND:Obstruent_placeT 0.032439 0.021818 1.487 Vowel_height_nonhigh -0.07449 0.01530 -4.868
GenerationTHIRD:Obstruent_placeT -0.005585 0.027493 -2.203n.s. n.s.
T K T K
La variabile è: allungamento del VOT nella /t/
Nella prima e nella seconda generazione non c’è differenza
statisticamente significativa del VOT tra /t/ e /k/.
Questo vuol dire che la /t/ rimane caratterizzata da un allungamento
del VOT
mantenimento di una variazione già presente nella L1
La terza generazione invece distingue chiaramente il VOT dei tre
fonemi: assenza dellaRisultati 2/ distribuzione
dell’aspirazione nei diversi
contesti fonotattici
50%Focus sui parlanti della II e III gen.
50%
Parlanti molto diversi
tra loro, eppure Fattore ETA’: il primo ha 57
entrambi appartenenti anni, il secondo 14
alla 2° generazione
Attenzione:
le variabili diastratiche
si intrecciano tra loro!Risultati 2/commento
O 7 parlanti mostrano una distribuzione fonotattica
dell’aspirazione non più «Calabrese» ma più aderente
a un modello «English»
O Perdita del valore sociofonetico associato
all’aspirazione
O 5 parlanti mantengono invece la variazione
sociofonetica legata all’aspirazione
O Sono tutti parlanti della I generazione
O Rimane incerto il motivo del mantenimento
O Tratto identitario legato all’essere Calabresi?
O Tratto identitario legato all’essere Italiani in generale?
O C’è un valore sociale legato all’aspirazione nella
consapevolezza linguistica di questi parlanti?Discussione dei risultati
O Un quadro più completo si ha dall’osservazione congiunta SIA della distribuzione di
una variabile fonetica per se SIA dalla variazione fonottatica in cui quella variabile si
inserisce
O Le 2 dimensioni NON sono necessariamente sovrapposte e concomitanti in un
processo di language attrition
O La I generazione ha mantenuto la variazione sociofonetica in tutte le variabili
considerate
O La III generazione ha subito un processo di language attrition rispetto a queste
varianti (caratterizzanti del Calabrese)
O La II generazione mostra la maggiore variabilità
O Rispetto al VOT mantiene la differenza sociofonetica
O I risultati sono più variabili e legati molto alla produzione del singolo parlante per
quanto riguarda l’aspirazione nei diversi contesti fonotattici
O A livello di «Heritage Language» viene confermata la grande variabilità individuale tra
i diversi parlanti
O Sarebbe opportuno indagare questa variabilità in situazioni dialogiche inter-
generazionaliFine lezione 10
(ven. 27 ott.)
Lezione 14:
La Sociolinguistica Storica
Riferimenti bibliografici: -
Approfondimenti: Hernández-Campoy J. M. & J. C. Conde-Silvestre (eds.) (2012) The Handbook of Historical Sociolinguistics,
London: Wiley-Blackwell; Mancini, M. (2007) ‘Testi epigrafici e sociolinguistica storica: le “defixiones” sannite’, in R.
Giacomelli & A. Robbiati Bianchi (a cura di) Le lingue dell’Italia antica oltre il latino: lasciamo parlare i testi, Incontri di
studio 50: 29-61; Meluzzi, C. (2017) “Problemi e prospettive della sociolinguistica storica”, in P. Cordin & A. Parenti (eds.)
“Problemi e prospettive della linguistica storica. Atti del XL Convegno annuale della Società Italiana di Glottologia”;
Romaine, S. (1982) Socio-Historical Linguistics: Its Status and Methodology, Cambridge, Cambridge University Press.Puoi anche leggere