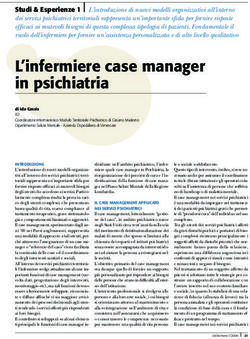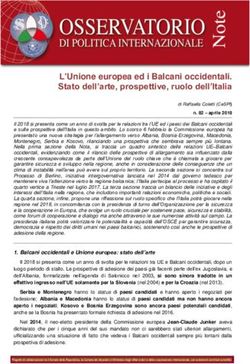Programma di italiano - IIS BOSCARDIN
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
IIS BOSCARDIN, VICENZA
A.S. 2018/2019
Classe 4D Liceo artistico
docente Giorgio Donazzolo
Programma di italiano
Libro di testo: Baldi Giusso Razetti Zaccaria, L'attualità della letteratura. Dalle origini all'età della
Controriforma
6. L'ETA' DELLA CONTRORIFORMA
Percorso 2 Tasso
1. La vita
6. Incontro con l'Opera: la Gerusalemme liberata
T6 La morte di Clorinda
libro di testo: Baldi Giusso Razetti Zaccaria, L'attualità della letteratura. Dal Barocco al
Romanticismo
1. L'ETA' DEL BAROCCO E DELLA SCIENZA NUOVA
Lo scenario (cenni)
Percorso 4 Shakespeare
1. La vita
8. Incontro con l'Opera: Amleto
T3 Il dubbio amletico: la “lucida follia” di Amleto e l'ingenuo candore di Ofelia
T4 L'”ombra tra Amleto e Gertrude
Percorso 6 Galileo
1. La vita
2. L'elaborazione del pensiero scientifico e il metodo galileiano
4. Il Saggiatore
T2 La favola dei suoni
5. Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo
T4 a Contro l'ipse dixit
T4 b Disperazione di Simplicio
Proiezione del film Galileo di Liliana Cavani
3. L'ILLUMINISMO
Lo scenario (cenni)
Percorso 1 La nascita del romanzo moderno in Inghilterra
T1 Swift, Il viaggio a Brobdignang (fotocopia)
T2 Defoe, Come salvai la pelle
Defoe, L’incontro con Venerdì (fotocopia)Percorso 2 L'illuminismo in Francia T2 Voltaire, La conclusione (del Candide) T4 Rousseau, Il primo che, cinto un terreno, affermò “questo è mio” Percorso 3 L'illuminismo in Italia T1 Beccaria, Contro la tortura e la pena di morte Percorso 4 Goldoni 1. La vita 2. La visione del mondo: Goldoni e l'illuminismo 3. La riforma della commedia 6. Incontro con l'Opera: La locandiera (visione integrale) Percorso 5 Parini 1. La vita 2. Parini e gli illuministi 4. Incontro con l'Opera: Il Giorno T2 Il giovin signore inizia la sua giornata 4. L'ETA' NAPOLEONICA Percorso 1 Neoclassicismo e Preromanticismo in Europa e in Italia T1 Winckelmann, La statua di Apollo: il mondo antico come paradiso perduto Goethe, Brani in fotocopia da “I dolori del giovane Werther” Percorso 2 Foscolo 1. La vita 2. La cultura e le idee 3. Le Ultime lettere di Jacopo Ortis T1 Il sacrificio della nostra patria è consumato T3 La lettera da Ventimiglia T4 Illusioni e mondo classico 2. Le Odi e i Sonetti T6 Alla sera T7 In morte del fratello Giovanni T8 A Zacinto 5. Incontro con l'Opera: Dei Sepolcri T10 vv. 1-90, vv.226-295 5. L'ETÀ DEL ROMANTICISMO Lo scenario (fotocopie) Percorso 5 Manzoni 1. La vita 2. Dopo la conversione: la concezione della storia e della letteratura 7. Il Fermo e Lucia e I Promessi Sposi Manzoni e il problema del romanzo Il quadro polemico del Seicento
Il “sugo” della storia e il rifiuto dell'idillio La concezione manzoniana della Provvidenza Il problema della lingua Testi Il Cinque Maggio Dai Promessi Sposi T10 La redenzione di Renzo e la funzione salvifica di Lucia La conversione dell'Innominato (fotocopie) La morte di don Rodrigo (fotocopie) Cecilia (fotocopie) L’incontro di Renzo e Lucia al lazzaretto (fotocopie) T12 La conclusione del romanzo: paradiso domestico e promozione sociale Percorso 6 Leopardi 1. La vita 3. Il pensiero 4. La poetica del vago e dell'indefinito Testi T3 L'infinito T6 A Silvia T8 Il sabato del villaggio T9 Canto notturno di un pastore errante in Asia T11 A se stesso T13 La ginestra o il fiore del deserto (vv. 1 – 51, 237 - 317) DANTE La Divina Commedia, Inferno, canto XXXIII Purgatorio, canti I, VI, XXVIII, Paradiso, canto I
Per le vacanze estive In vista del prossimo anno scolastico … 1. Ripassare il romanticismo (vedere il file in Classroom) Leggere e comprendere un testo a scelta tra Ode al vento occidentale di Shelley, pag. 741 Primo Inno alla Notte di Novalis, pag. 799 L’uccisione dell’albatro: colpa e maledizione di Coleridge, pag. 801 La rovina della casa degli Usher di Poe, pag. 810 Diotima di Hoelderlin, in https://www.aphorism.it/friedrich_holderlin/poesie/diotima/ Accompagnare la lettura con informazioni sull’autore 2. Ripassare e approfondire Leopardi con una comprensione personale e, se possibile, “empatica” della sua opera. Il riferimento è alle seguenti parti del libro: La vita, pag. 934 Il pensiero, pag. 941 La poetica del “vago e dell’indefinito”, pag. 943 L’infinito, pag. 962 A Silvia, pag. 977 Il sabato del villaggio, pag. 987 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, pag. 991 A se stesso, pag. 1002 La ginestra o “il fiore del deserto”, pag. 1011 Per chi volesse, è possibile guardare un video in cui lo scrittore Alessandro D’Avenia parla di Leopardi all’indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=dYr_aaqSM8U 3. Lettura di libri di narrativa italiana È obbligatoria la lettura de Il fu Mattia Pascal di Pirandello e di Se questo è un uomo di Primo Levi. Come detto in classe, consiglio la lettura non durante l’estate ma in periodo successivo (cioè durante l’anno scolastico) È facoltativa la lettura di qualsiasi libro di buona qualità. Impossibile dare indicazioni su libri significativi perché c’è stato un rapidissimo cambiamento dei gusti negli ultimi decenni; indico comunque qualche classico del Novecento, cioè delle opere che rimangono e che costituiscono un bagaglio culturale. Suggerisco la lettura de Il piacere di D’Annunzio, che è un manifesto dell’estetismo, La metamorfosi di Kafka, un breve racconto che narra un incubo modernissimo e inquietante. Per venire al secondo Novecento, prendo spunto dai temi dell’esame di stato per indicare Il giorno della civetta di Sciascia, il primo libro che denuncia la mafia siciliana; in qualche modo si ricollega alla denuncia della criminalità il molto più recente Gomorra di Roberto Saviano, documentatissima e impressionante indagine sulla malavita organizzata degli ultimi decenni (anche se il libro ha ormai più di dieci anni). Per tornare a opere più tipicamente scolastiche, ricordo il nostro grande conterraneo Rigoni Stern, autore di limpide narrazioni sulla vita in montagna e sulla guerra (tra le tante cito Il sergente nella neve e Storia di Tönle) 4. Produzione di un testo scritto (uno solo, cioè pochissimo, ma fatto al massimo, sia come qualità di scrittura che come qualità e quantità di contributi personali). Il titolo è da scegliere tra quelli seguenti, che ho tratto dagli ultimi due compiti svolti in classe. Non è proibito fare più di un tema…
RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI
ATTUALITÀ
Prima traccia
E’ veramente rivoltante il modo in cui la grande massa dei poveri viene trattata dalla società
odierna. (...) Li si costringe a gettare sulla strada tutti i rifiuti e le immondizie, tutta l’acqua sporca,
anzi, spesso tutto il sudiciume più ripugnante e lo sterco, poiché si tolgono ad essi tutti i mezzi per
sbarazzarsene, costringendoli in tal modo ad appestare i propri quartieri. (...) Non contenti di aver
guastato l’atmosfera nelle strade, li si rinserra a dozzine in un’unica stanza, nella quale l’aria che
respirano di notte è ancora più soffocante. (...) Si tolgono loro tutti i piaceri, tranne quelli del sesso
e dell’alcool, mentre ogni giorno li si fa lavorare fino all’estremo limite di tutte le forze fisiche e
morali, eccitandoli così costantemente al più smisurato abuso degli unici piaceri ad essi concessi.
(...) Data questa situazione, come è possibile che la classe più povera sia sana e possa vivere a
lungo? Che altro c’è da aspettarsi, se non una mortalità enorme, continue epidemie, un progressivo
indebolimento fisico della classe operaia?
Friedrich ENGELS, La situazione della classe operaia in Inghilterra,Editori Riuniti, 1972
La frase di Engels è tratta da un libro frutto di esperienze di viaggio compiute dal pensatore
tedesco in Inghilterra nel primo Ottocento. Nella frase l’autore descrive la situazione sociale del
proletariato del tempo ed esprime un giudizio durissimo sulle iniquità del tempo.
A partire da questo spunto, rifletti sul tema dell’ingiustizia sociale, economica e materiale
presente nella realtà odierna.
Seconda traccia
La fragilità è all'origine della comprensione dei bisogni e della sensibilità per capire in quale modo
aiutare ed essere aiutati.
Un umanesimo spinto a conoscere la propria fragilità e a viverla, non a nasconderla come se si
trattasse di una debolezza, di uno scarto vergognoso per la voglia di potere, che si basa sulla forza
reale e semmai sulle sue protesi. Vergognoso per una logica folle in cui il rispetto equivale a fare
paura.
Una civiltà dove la tua fragilità dà forza a quella di un altro e ricade su di te promuovendo salute
sociale che vuol dire serenità. Serenità, non la felicità effimera di un attimo, ma la condizione
continua su cui si possono inserire momenti persino di ebbrezza.
La fragilità come fondamento della saggezza capace di riconoscere che la ricchezza del singolo è
l'altro da sé, e che da soli non si è nemmeno uomini, ma solo dei misantropi che male hanno
interpretato la vita propria e quella dell'insieme sociale.
Vittorino ANDREOLI, L’uomo di vetro. La forza della fragilità, Rizzoli 2008
La citazione proposta, tratta da un saggio dello psichiatra Vittorino Andreoli, pone la
consapevolezza della propria fragilità e della debolezza come elementi di forza autentica nella
condizione umana. Rifletti su questa tematica, facendo riferimento alle tue conoscenze,
esperienze e letture personali.
Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare
la trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto.Terza traccia «Bisogna proporre un fine alla propria vita per viver felice. O gloria letteraria, o fortune, o dignità, una carriera in somma. Io non ho potuto mai concepire che cosa possano godere, come possano viver quegli scioperati e spensierati che (anche maturi o vecchi) passano di godimento in godimento, di trastullo in trastullo, senza aversi mai posto uno scopo a cui mirare abitualmente, senza aver mai detto, fissato, tra se medesimi: a che mi servirà la mia vita? Non ho saputo immaginare che vita sia quella che costoro menano, che morte quella che aspettano. Del resto, tali fini vaglion poco in sé, ma molto vagliono i mezzi, le occupazioni, la speranza, l’immaginarseli come gran beni a forza di assuefazione, di pensare ad essi e di procurarli. L’uomo può ed ha bisogno di fabbricarsi esso stesso de’ beni in tal modo.» G. LEOPARDI, Zibaldone di pensieri, in Tutte le opere, a cura di W. Binni, II, Sansoni, Firenze 1988, p. 4518,3 La citazione tratta dallo Zibaldone di Leopardi propone una sorta di “arte della felicità”: secondo Leopardi la vita trova significato nella ricerca di obiettivi che, se raggiunti, ci immaginiamo possano renderci felici. Rinunciando a questa ricerca, ridurremmo la nostra esistenza a “nuda vita” fatta solo di superficialità e vuotezza. Ritieni che le parole di Leopardi siano vicine alla sensibilità giovanile di oggi? Rifletti al riguardo facendo riferimento alle tue esperienze, conoscenze e letture personali. Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. Quarta traccia “Caro mio, ci sono persone che non potranno mai arrivare in Fantàsia”, disse il signor Coriandoli, “e ci sono invece persone che possono farlo, ma che poi restano là per sempre. E infine ci sono quei pochi che vanno in Fantàsia e tornano anche indietro. Come hai fatto tu. E questi risanano entrambi i mondi.” Michael ENDE, La Storia Infinita, Longanesi, Milano, 1985 Sviluppa la tua riflessione, considerando quale ruolo dovrebbe avere la fantasia nella vita degli individui e quale dovrebbe essere il rapporto fra mondo reale e mondo dell’immaginazione: in che senso, a tuo avviso, chi si sa muovere in tutti due i mondi li “risana entrambi”? Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto. Quinta traccia «Essere pessimisti è più saggio: si dimenticano le delusioni e non si viene ridicolizzati davanti a tutti. Perciò presso le persone sagge l’ottimismo è bandito. L’essenza dell’ottimista non è guardare al di là della situazione presente, ma è una forza vitale, la forza di sperare quando gli altri si rassegnano, la forza di tenere alta la testa quando sembra che tutto fallisca, la forza di sopportare gli insuccessi, una forza che non lascia mai il futuro agli avversari, ma lo rivendica per sé. Esiste certamente anche un ottimismo stupido, vile, che deve essere bandito. Ma nessuno deve disprezzare l’ottimismo inteso come volontà di futuro, anche quando dovesse condurre cento volte all’errore; perché esso è la salute della vita, che non deve essere compromessa da chi è malato.» Dietrich BONHOEFFER, Resistenza e resa. Lettere e scritti dal carcere, Edizioni Paoline, Milano 1988
Dietrich BONHOEFFER fu teologo protestante e oppositore del regime nazista. Morì nel 1945 nel campo di
concentramento di Flossenburg
Rifletti sulla citazione tratta da un testo di Bonhoeffer e, sulla base delle tue conoscenze e dei tuoi studi,
esprimi le tue considerazioni su un duplice modo di guardare al futuro, quello che privilegia una visione
apocalittica e negativa – distruzioni ambientali, crescita demografica incontrollata, espansione dei conflitti
e altro – e quello che, facendo leva sull’etica della responsabilità e dell’impegno, sceglie di credere e
operare per contribuire a cambiare e migliorare la realtà.
Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare
la trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.
TIPOLOGIA A – ANALISI DEL TESTO
Da' colli Euganei, 11 Ottobre 1797
Il sacrificio della patria è consumato: tutto è perduto; e la vita, seppure ne verrà concessa, non ci resterà che
per piangere le nostre sciagure, e la nostra infamia. Il mio nome è nella lista di proscrizione, lo so: ma vuoi
tu ch'io per salvarmi da chi m'opprime mi commetta a chi mi ha tradito? Consola mia madre: vinto dalle sue
lagrime le ho obbedito, e ho lasciato Venezia per evitare le prime persecuzioni, e le più feroci. Or dovrò io
abbandonare anche questa mia solitudine antica, dove, senza perdere dagli occhi il mio sciagurato paese,
posso ancora sperare qualche giorno di pace? Tu mi fai raccapricciare, Lorenzo; quanti sono dunque gli
sventurati? E noi, purtroppo, noi stessi italiani ci laviamo le mani nel sangue degl'italiani. Per me segua che
può. Poiché ho disperato e della mia patria e di me, aspetto tranquillamente la prigione e la morte. Il mio
cadavere almeno non cadrà fra le braccia straniere; il mio nome sarà sommessamente compianto da' pochi
uomini, compagni delle nostre miserie; e le mie ossa poseranno su la terra de' miei padri.
(Foscolo, Ultime lettere di Jacopo Ortis, parte prima)
Comprensione del testo
Contestualizza e riassumi il contenuto del passo in non più di dieci righe.
Analisi del testo
Attraverso un'analisi del lessico e della sintassi dimostra che Foscolo ha scelto un registro aulico.
Individua e spiega le espressioni che si riferiscono al dramma politico vissuto da Jacopo.
Individua e spiega i riferimenti geografici (espliciti ed impliciti).
Approfondimenti
Presenta le vicende vissute da Jacopo Ortis nel romanzo.
Le illusioni sono per Foscolo un modo per contrapporsi con atteggiamento energico e propositivo al
nichilismo che contraddistingue la sua visione del mondo. Spiega l'affermazione ricostruendo il
percorso artistico del poeta di Zante con opportuni riferimenti ai suoi testi
TIPOLOGIA B - ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO
Il tentativo di realizzare i diritti umani è continuamente rimesso in discussione. Le forze che si oppongono
alla loro realizzazione sono numerose: regimi autoritari, strutture governative soverchianti e
onnicomprensive, gruppi organizzati che usano la violenza contro persone innocenti e indifese, più in
generale, gli impulsi aggressivi e la volontà di predominio degli uomini che animano quelle strutture e quei
gruppi. Contro tutti questi «nemici», i diritti umani stentano ad alzare la loro voce.Che fare dunque? Per rispondere, e non con una semplice frase, bisogna avere chiaro in mente che i diritti
umani sono una grande conquista dell’homo societatis sull’homo biologicus. Come ha così bene detto un
grande biologo francese, Jean Hamburger, niente è più falso dell’affermazione secondo cui i diritti umani
sono «diritti naturali», ossia coessenziali alla natura umana, connaturati all’uomo. In realtà, egli ha notato,
l’uomo come essere biologico è portato ad aggredire e soverchiare l’altro, a prevaricare per sopravvivere, e
niente è più lontano da lui dell’altruismo e dell’amore per l’altro: «niente eguaglia la crudeltà, il disprezzo
per l’individuo, l’ingiustizia di cui la natura ha dato prova nello sviluppo della vita». Se «l’uomo naturale»
nutre sentimenti di amore e di tenerezza, è solo per procreare e proteggere la ristretta cerchia dei suoi
consanguinei. I diritti umani, sostiene Hamburger, sono una vittoria dell’io sociale su quello biologico,
perché impongono di limitare i propri impulsi, di rispettare l’altro: «il concetto di diritti dell’uomo non è
ispirato dalla legge naturale della vita, è al contrario ribellione contro la legge naturale».
Se è così, e non mi sembra che Hamburger abbia torto, non si potrà mai porre termine alla tensione tra le
due dimensioni. E si dovrà essere sempre vigili perché l’io biologico non prevalga sull’io sociale.
Ne deriva che anche una protezione relativa e precaria dei diritti umani non si consegue né in un giorno né
in un anno: essa richiede un arco di tempo assai lungo. La tutela internazionale dei diritti umani è come
quei fenomeni naturali – i movimenti tellurici, le glaciazioni, i mutamenti climatici – che si producono
impercettibilmente, in lassi di tempo che sfuggono alla vita dei singoli individui e si misurano nell’arco di
generazioni. Pure i diritti umani operano assai lentamente, anche se – a differenza dei fenomeni naturali –
non si dispiegano da sé, ma solo con il concorso di migliaia di persone, di Organizzazioni non governative e
di Stati. Si tratta, soprattutto, di un processo che non è lineare, ma continuamente spezzato da ricadute,
imbarbarimenti, ristagni, silenzi lunghissimi. Come Nelson Mandela, che ha molto lottato per la libertà, ha
scritto nella sua Autobiografia: «dopo aver scalato una grande collina ho trovato che vi sono ancora molte
più colline da scalare».
Antonio CASSESE, I diritti umani oggi, Economica Laterza, Bari 2009 (prima ed. 2005), pp, 230-231
Antonio Cassese (1937-2011) è stato un giurista, esperto di Diritto internazionale.
Comprensione e analisi
Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti.
Nello svolgimento del discorso viene introdotta una contro-tesi: individuala.
Sul piano argomentativo quale valore assume la citazione del biologo francese, Jean Hamburger?
Spiega l’analogia proposta, nell’ultimo capoverso, fra la tutela internazionale dei diritti umani e i
fenomeni naturali impercettibili.
La citazione in chiusura da Nelson Mandela quale messaggio vuole comunicare al lettore?
Produzione
Esprimi il tuo giudizio in merito all’attualità della violazione dei diritti umani, recentemente ribadita da
gravissimi fatti di cronaca. Scrivi un testo argomentativo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un
discorso coerente e coeso, che puoi, se lo ritieni utile, suddividere in paragrafi.
Compiti aggiuntivi per studenti con debito
E' stato consegnato un programma di recupero individuale agli studenti con debito
Tipologia prova di recupero
La prova di recupero sarà un testo scritto secondo le tipologie dell’esame di stato.
Buone vacanze a tutti
Giorgio DonazzoloPuoi anche leggere