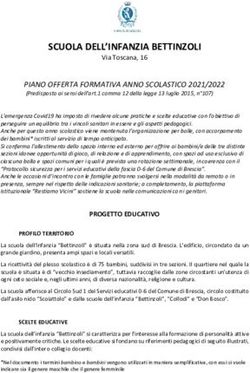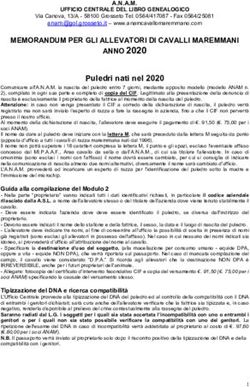PROF. LOREDANA LUCARELLI STP CDS TRIENNALE IN PSICOLOGIA PSICOLOGIA DINAMICA ANNO ACCADEMICO 2019-2020
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Prof. Loredana Lucarelli
STP CdS Triennale in Psicologia
Psicologia Dinamica
Anno Accademico 2019-2020
«E’ vietata la copia e la riproduzione dei contenuti e
immagini in qualsiasi forma. E' inoltre vietata la
redistribuzione e la pubblicazione dei contenuti e
immagini non autorizzata espressamente dall'autore»VALUTAZIONE DELLA PERSONALITÀ
TEST PROIETTIVI
Prof. Loredana Lucarelli
TECNICHE TEST SVILUPPO
VALUTAZIONE E CONSULENZA
CLINICAUso Clinico dei Test Proiettivi
Ø Le tecniche proiettive sono strumenti utili a fare
emergere modalità individuali di risposta che
danno indicazioni sul funzionamento mentale,
sulla struttura di personalità e sull’esperienza
soggettiva del bambino
Ø Il metodo proiettivo si basa sulla presentazione di
materiale poco strutturato/ambiguo che il soggetto
deve ‘interpretare’ e le risposte danno indicazioni
sui suoi conflitti, bisogni emotivi, stati interni etc.Ø Obiettivo clinico generale dei Test Proiettivi è di descrivere il funzionamento psichico del bambino in una prospettiva dinamica; Ø tuttavia il riferimento ‘all’inconscio’, a cui si fa ricorso per interpretare le risposte, rende problematica l’oggettività delle descrizioni psicologiche che scaturiscono dai test proiettivi
ØÈ necessaria una preparazione psicodinamica del clinico e una teoria evolutiva di riferimento che orientano i significati soggettivi del materiale rilevato Ø Infatti,elemento di criticità dei test proiettivi è che spesso non forniscono un vero e proprio sistema di codifica con punteggi, lasciando un grande libertà interpretativa al clinico
ØI metodi proiettivi utilizzano come materiale di indagine la produzione spontanea del soggetto: Disegni, Racconto di storie, Risposte a situazioni stimolo ambigue Ø le forme di espressione libera sono utilizzate in maniera sistematica a partire da una situazione standardizzata, uguale per tutti i soggetti, conferendo al metodo un carattere di obiettività scientifica
Ø Tali metodi si chiamano proiettivi perché si basano sul
meccanismo psicologico della Proiezione:
§ il termine Proiezione è stato introdotto da Sigmund Freud
(1896), per il quale la proiezione consiste nell’attribuire ad
altri, o al mondo esterno, sentimenti e qualità proprie
mediante un processo difensivo inconscio; si riscontra anche
al di fuori della patologia: ad es., il bambino cammina con il
padre in una strada buia e dice: “Dammi la mano perché tu
hai paura” oppure una bambina va a dormire con la
bambola dicendo: “La bambola ha paura di dormire da sola;
ha bisogno di compagnia”. Nel momento in cui la persona si
proietta, cioè esteriorizza i suoi sentimenti, è inconsapevole
che questi siano propri.ü Lo psicologo Frank (1939), che è stato il primo a coniare il termine di METODI PROIETTIVI per lo studio della personalità, in termini più generali definisce la Proiezione: “il processo col quale un soggetto organizza e struttura una esperienza proiettando in questa la sua esperienza interiore, la struttura stessa della sua personalità”.
Ø Condizione essenziale perché un test possa chiamarsi proiettivo è che la situazione-stimolo proposta al soggetto sia non strutturata, ambigua, senza un significato preciso: è nel processo di strutturazione del materiale non strutturato che il soggetto rivela i principi della propria struttura psichica
“Stimoli ambigui e Proiezione” Ø La situazione proiettiva sembra idonea a far emergere il rapporto tra rappresentazione e stimoli esterni proprio perché questi ultimi sono ambigui. Proprio questa caratteristica del materiale dei Test Proiettivi sollecita e attiva risposte legate ad esperienze personali che si traducono nella formulazione verbale con cui i soggetti costruiscono “le loro narrazioni”.
Suddivisione dei Test proiettivi
Ø Lis (1998) propone la seguente suddivisione:
• test grafici (basati sul disegno);
• test tematico-costruttivi (basati sul racconto e/o costruzione);
• test strutturali (basati su macchie);
• test di completamento di parole (completare parole, frasi,
racconti).
Ø Secondo un criterio utile nella pratica clinica, vi è anche la
tendenza a classificare le tecniche proiettive in due
macrocategorie:
§ Test Strutturali (nel cui ambito il test più rappresentativo è il test
di Rorschach), che hanno la finalità di indagare la struttura di
personalità e la sua organizzazione psichica
§ Test Tematici (tra cui il Thematic Apperception Test) che si
propongono, invece, di rilevare i contenuti più pregnanti del
dinamismo psichico del soggetto sottoposto al test (Chabert,
1983; Passi Tognazzo, 1975).TEST PROIETTIVI GRAFICI
Ø Il Disegno come strumento di conoscenza psicologica:
§ Il Disegno, fin dai primi sviluppi della psicologia, è stato
considerato come uno strumento utile alla
comprensione sia della maturazione intellettuale, sia
della personalità dell’individuo.
§ E’ indicativo che uno dei temi per primo utilizzato – il
Disegno della Figura Umana – sia stato considerato
strumento valutativo di entrambe le aree di indagine: 1)
sviluppo cognitivo, attraverso il metodo di F.
Goodenough (1926), 2) studio della personalità,
attraverso il metodo di Karen Machover (1953).Lo sviluppo dell’attività grafica
Ø La conoscenza delle tappe dello sviluppo grafico-
simbolico del bambino è un prerequisito
necessario per interpretare il disegno del bambino
nell’assessment psicodiagnostico.
Ø Gli scarabocchi dei bambini nei primi anni di vita, le
forme realizzate dal bambino più grande e la loro
collocazione nello spazio cambiano in relazione allo
sviluppo cognitivo del bambino e allo sviluppo
globale della sua personalità.Ø Luquet ha individuato, attraverso l’osservazione
sistematica del disegno infantile, alcune fasi evolutive,
ancora oggi riconosciute:
ü Realismo fortuito (fino ai 3 anni) in cui il b. inizia a
guardare le proprie produzioni grafiche cercando
un’analogia, anche vaga o soggettiva, tra esse e una
cosa reale;
ü Realismo mancato (da 3 a 5 anni) in cui il b. decide
prima dell’esecuzione quale oggetto rappresentare, ma
spesso ne risultano disegni incomprensibili anche a lui (il
b. ha difficoltà nel tracciare contorni accurati, trascura
particolari importanti o li colloca in posti sbagliati, non
rispetta le proporzioni);ü Realismo intellettuale (dai 5 ai 7/8 anni) in cui il b. riesce
ad eseguire disegni somiglianti alla realtà, ma il disegno
deve contenere tutti gli elementi reali dell’oggetto, non
c’è considerazione della prospettiva visiva per cui se si
guarda da una certa parte certi elementi non sono visibili;
ü Realismo visivo (verso gli 8/9 anni) il b: si rende conto a
poco a poco delle contraddizioni tra i suoi disegni e la
realtà e cerca di adottare un’unica prospettiva
rappresentando ciò che visibile a lui. In linea con lo
studio di Luquet, Piaget e coll. (1948) hanno descritto lo
sviluppo cognitivo delle relazioni spaziali che
gradualmente consente lo sviluppo della
rappresentazione mentale delle relazioni spaziali, anche
nella visione prospettica.Test cognitivo: Disegno della Figura Umana di
F. Goodenough
Ø L’Autrice ha esaminato circa 3.600 bambini
americani dai 4 agli 11 anni di età
§ Consegna al bambino (al quale vengono forniti
esclusivamente un foglio di carta bianca e una
matita): “Su questo foglio devi disegnare un
ometto. Fallo meglio che puoi, con molta cura e
attenzione”.
§ Nel ritirare il disegno l’esaminatore avrà cura di
segnare sul foglio,oltre al nome del bambino e alla
data, anche la sua età in anni e mesi.Disegno della Figura Umana di F. Goodenough
§ La valutazione viene eseguita assegnando un punto ad
ognuno dei 51 dettagli elencati nello spoglio e che sia
presente nel disegno: presenza della testa, delle gambe, delle
braccia –numero esatto – presenza del tronco, del collo,
degli occhi, del naso, della bocca, labbra, capelli, vestiti,
presenza delle dita, dettagli delle dita corretti, articolazione
delle braccia, articolazione delle gambe, mente e fronte
rappresentati etc.
§ Sarà possibile calcolare anche il Quoziente intellettivo
secondo la formula di Stern: QI= Età mentale/Età
Cronologica; il test presenta una correlazione soddisfacente
con altre prove di intelligenza (> 0.70), tuttavia sono
presenti limiti nella valutazione clinica perché il punteggio
al test può abbassarsi per l’influenza di variabili affettive
(ad es., disturbi d’ansia).Il Disegno come proiezione del mondo interiore
del bambino
Ø Karen Machover ha utilizzato il test del disegno di una
persona come test proiettivo;
• In quanto test proiettivo, e non test di intelligenza, il
disegno della figura umana di Machover può essere
applicato anche a soggetti adulti.
• Si presenta al soggetto un foglio di carta, una matita da
disegno di media durezza e una gomma si dice: “La
prego di disegnare una persona”;
• nel caso di bambini che non possono non comprendere
il termine persona, si può dire “Disegna Qualcuno”. E’
importante che il sesso e l’età non siano determinati
dalla consegna.Draw a Person – DAP Karen Machover
• Quando il disegno del soggetto è terminato, se non
appare chiaro il sesso, e/o l’età della figura disegnata:
chiedere se si tratta di un maschio o di una femmina e
quale età vi si attribuisce.
• Si presenta poi un altro foglio uguale al primo (foglio
bianco A4) e si chiede di disegnare una persona di
sesso opposto: “Ora disegni un maschio” oppure
“Ora disegni una femmina”.Ø INTERPRETAZIONE:
§ l’assunto, alla base dell’interpretazione, è che il
Disegno di una Figura Umana non è altro che
l’immagine della proiezione del proprio corpo, o
meglio dell’immagine soggettiva del proprio Io; non
sempre tuttavia la figura disegnata è la proiezione
dell’immagine del proprio Io attualmente vissuto; a
volte, infatti, può essere la proiezione dell’ideale
dell’Io, o di una persona da cui il soggetto fortemente
dipendente o anche può esprimere il vissuto
soggettivo verso persone del proprio ambiente.Ø Nell’analisi del disegno si tiene conto dei seguenti elementi:
• 1) FORMALI: grandezza, posizione, espressione o atteggiamento
• 2) GRAFOLOGICI: tratto, pressione, movimento, ombreggiatura
(la pressione del tratto corrisponde al grado di energia impiegata
da chi disegna:ad es. un tratto forte è indice di sicurezza, ma può
anche essere indice di impulsività, a volte aggressività; il
movimento è spesso legato ad introversione, anche a creatività e
ricchezza di vita interiore); l’ombreggiatura denota in genere
ansietà
• 3) CONTENUTO: diverse parti del corpo e loro dettagli.Test Disegno della Famiglia
Ø MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE E CONSEGNA:
ü La somministrazione del test del Disegno della Famiglia deve essere
individuale, non prevede limiti di tempo; il materiale necessario è
costituito da matita, gomma da cancellare, fogli formato A4. Diverse
formulazioni della consegna sono state ideate per l’applicazione di
questo test:
§ - disegna la tua famiglia (Porot, 1965);
§ - disegna una famiglia, oppure immagina una famiglia di tua
invenzione e disegnala (Corman, 1967).
Ø La consegna “disegna la tua famiglia” porta il bambino a collegarsi
maggiormente al piano di realtà, anche se, come sottolinea Corman,
la proiezione è sempre attiva per deformare la realtà secondo le
tendenze affettive del soggetto (Corman, 1967, p. 23).
Ø Tuttavia, nel modificare la consegna, Corman ha pensato che la
proiezione dei sentimenti del bambino verrebbe ad essere facilitata
proponendogli un compito più vago, in modo che il bambino sia più
libero di esprimersi, arginando il processo secondario e favorendo il
processo primario.BREVE INTERVISTA DOPO L’ESECUZIONE DEL
TEST (Corman, 1976):
Ø Nominami tutte le persone cominciando dal primo
disegnato: ruolo, sesso ed età (un numero apposto dallo
psicologo indicherà il personaggio disegnato per primo, per
secondo e così via); 2) Chi è il più simpatico in questa
famiglia? Chi è il meno simpatico? 3) Chi è il più felice?
Chi è il meno felice? 4) E tu di questa famiglia chi
preferisci? Per ogni risposta si domanda il perché.
§ Al Disegno della Famiglia (Immagina una Famiglia di tua
invenzione e disegnala), si applica il metodo delle
Preferenze/Identificazioni (Corman, 1976) si termina
dicendo al bambino: “Supponi di far parte di questa
famiglia, chi vorresti essere?” Se il bambino esita si può
aggiungere: “Giochiamo, facciamo finta di essere uno di
questa famiglia, quello che vuoi tu”.§ Nei casi in cui, nonostante la più ampia
formulazione del compito da eseguire, il fanciullo
ha disegnato la propria famiglia, includendo anche
se stesso, potrebbe sembrare superfluo
domandargli di identificarsi, in quanto lo ha già
fatto; in realtà si dimostra ugualmente utile
domandargli: “Quale altro personaggio
desidereresti essere?”
§ Paragone con la famiglia vera: è indispensabile
annotare la composizione della famiglia vera
rilevata attraverso l’anamnesi condotta con i
genitori del bambino; ogni omissione o
deformazione dei personaggi è significativa.Ø Dall’analisi della letteratura scientifica emerge che alcune
variabili sono state ritenute maggiormente indicative
nell’interpretazione del DdF (Corman, 1967; Di Leo, 1973;
Freeman, 1980; Hammer, 1997; Tambelli, Zavattini,
Mossi, 1999):
§ Grandezza dei personaggi: si considera la dimensione
dei personaggi nel disegno; la grandezza è un criterio di
valorizzazione o svalorizzazione di una figura disegnata
rispetto ad un’altra; è importante valutare non solo la
grandezza dell’intera figura, ma anche quella di alcune
singole parti del corpo.
ü Il personaggio valorizzato è anche quello che viene
disegnato per primo, oppure disegnato
proporzionalmente più grande di tutti gli altri, mentre
spesso il personaggio con cui vi sono conflitti è disegnato
più piccolo, messo per ultimo, o da un lato del foglio.§ collocazione delle figure nel disegno: come il bambino usa
lo spazio per collocare se stesso e le altre figure nel foglio.
Secondo Corman (1967), essere al centro del disegno è
indice di valorizzazione. La posizione delle figure nel
disegno, ovvero la vicinanza/lontananza, è in rapporto al
vissuto sul tipo di legame che il bambino sente di avere in
famiglia, ma esprime anche i suoi bisogni affettivi.
§ aggiunta di personaggi/omissione di personaggi: secondo
Corman (1967), il fenomeno della ‘aggiunte’ e ‘mancanze’
evidenzia meccanismi di spostamento e negazione che
possono caratterizzare le dinamiche intrapsichiche del
soggetto. Il fenomeno può evidenziare la tendenza del
bambino a svalorizzare, escludendolo, un familiare ed
indica il livello di conflittualità con il personaggio tralasciato;
diviene segno di grave angoscia relazionale se vengono
omessi i genitori.§ omissione di se stessi: l’omissione di se stessi è considerata
espressione di marcati vissuti di inadeguatezza e di
autosvalorizzazione.
§ omissioni di parti del corpo/deformazioni del corpo: possono
costituire indicatori di deprivazione affettiva, o comunque di
grave conflitto familiare.
§ assenza di particolari/dettagli: è un possibile indicatore di
inibizione emotiva e di inibizione nella comunicazione
affettiva.
§ identificazioni: può esprimere la scelta da parte del bambino di
un personaggio che rappresenta le sue aspirazioni; in questo
caso, come indica Corman (1967), si tratta di una
identificazione di desiderio. Tuttavia il bambino può esprimere
anche una identificazione di difesa, ad esempio quando un
bambino aggressivo si identifica con il padre autoritario e
“forte” che punisce.Il Test del Disegno dell’Albero di Karl Koch
Ø CONSEGNA: “La prego di disegnare un albero da frutta come
meglio può. Potrà usare l’intero foglio.” Ai bambini piccoli che
possono non comprendere l’espressione albero da frutta, si
può semplicemente chiedere di disegnare un “albero”. Si tratta
di un test carta e matita.
Ø La prova dell’Albero appartiene alla categoria dei test proiettivi
§ è considerato basilare il simbolismo spaziale dell’Albero: la
linea di sviluppo dell’albero dal basso verso l’alto suggerisce
diversi significati: passaggio dall’Inconscio al Conscio, dal
germe allo sviluppo, vi è rappresentata cioè la storia della
persona; le tracce vecchie e primitive della vita si concretano
verso il basso, quelle recenti e attuali invece piuttosto verso
l’alto.
§ Inoltre, considerato l’albero simbolo dell’uomo per l’analogia
alla posizione eretta, l’albero disegnato viene a simbolizzare la
persona che lo disegna.Ø Koch fornisce nel Manuale vari indici per l’interpretazione
psicologica del Test sulla base dei vari elementi del disegno
(Radici, basi del fusto, protuberanze del fusto, chioma,
rami, andamento a destra, andamento a sinistra, foglie,
frutti etc.).
Ø Il test dell’albero presenta due limiti:
§ 1) facilità con cui si presta ad interpretazioni brillanti, ma
inferenziali, 2) la sua validazione incompleta. Ciò non
significa che il Test non abbia alcuna validità, ma richiede
grande esperienza, capacità di intuizione e un’estrema
prudenza per arrivare all’interpretazione; il significato
psicologico da prendere in considerazione sarà quello che
non è in contraddizione con gli altri elementi del reattivo e
soprattutto con i dati emersi da tutte le fasi dell’esame
psicodiagnostico.
§ In conclusione, come afferma del resto lo stesso Autore, il
reattivo dell’albero va considerato solo come uno strumento
coadiuvante.Ø Sebbene l’uso clinico dei test grafici consenta,
talvolta, di distinguere fra individui con patologia
e soggetti normali, la valutazione proiettiva in
base ai disegni non ha ancora trovato ampio
accordo tra i ricercatori.
Ø Inoltre il modello evolutivo obbliga a riflettere sul
ruolo che hanno le capacità espressive grafiche
nel disegno: scarse abilità grafiche possono
spesso risultare in classificazioni di falsi positivi
o di psicopatologie; questo aspetto implica una
particolare attenzione soprattutto in età
evolutiva.Ø Nel corso della valutazione diagnostica in età
evolutiva il disegno, pur con i limiti indicati, offre al
clinico un modo non invasivo ed empatico per poter
entrare in contatto con il mondo interno di tutti quei
bambini che spesso non trovano le parole per
esprimere il proprio dolore e malessere.
Ø Attualmente i test grafici sono utilizzati da circa l’81%
degli psicologi infantili (Veltman, Brown, 2002).
Mediante il disegno il bambino è messo in una
condizione facilitante per rivolgere una richiesta di
aiuto; il disegno è fatto per essere visto, non solo per
mostrare le rappresentazioni emotive, ma anche per
comunicare vissuti che non possono essere
rappresentati tramite la parola perché troppo dolorosi o
rimossi (Sacco, 1996).Puoi anche leggere