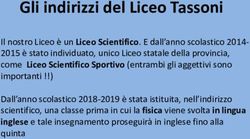MISURE GPS SULL'ALLINEAMENTO STRUTTURALE EOLIE-TINDARI-GIARDINI
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
GNGTS – Atti del 18° Convegno Nazionale / 08.18
G. Puglisi (1), M. Aloisi (2), A. Mostaccio (2) e B. Puglisi (1)
(1)
Istituto Internazionale di Vulcanologia, CNR, Catania
(2)
Sistema Poseidon, Sezione di Messina
MISURE GPS SULL’ALLINEAMENTO STRUTTURALE
EOLIE-TINDARI-GIARDINI
Riassunto. Negli ultimi anni, grazie all’intenso sviluppo sia della configurazione satellitare che degli
algoritmi di calcolo per il trattamento dei dati, le misure GPS sono diventate un importante sistema di
monitoraggio geodetico di strutture geologiche a vasta ed a piccola scala. Nell’ambito di un progetto di
ricerca finanziato dal Gruppo Nazionale per la Vulcanologia (GNV), è stata recentemente istituita la
rete GPS dei Peloritani. I capisaldi sono stati materializzati al fine di investigare le deformazioni lente
del suolo prodotte dal sistema strutturale Tindari-Giardini. La conoscenza del campo cinematico potrà
fornire un significativo contributo alla modellizzazione dei processi geodinamici che coinvolgono l’area
investigata. Inoltre, permetterà un accurato studio della correlazione tra stress tensionale in strutture
tettoniche e vulcanismo eoliano. Viene mostrato un preliminare confronto tra le campagne condotte
nell’ottobre 1996 e nel novembre 1998.
GPS MEASUREMENTS AT AEOLIAN-TINDARI-GIARDINI STRUCTURAL SYSTEM
Abstract. Thanks to the intense development both of satellite constellation and software for data
analysis, the GPS methodology has become a fundamental tool for monitoring geological structures
both at regional and local scale. In the framework of the activities carried out by the Italian
Volcanological National Group (GNV), a GPS network has been installed in the Peloritani chain area
(Sicily). The network was, in particular, designed for investigating deformation along the Aeolian-
Tindari-Giardini regional fault system. The knowledge of the kinematic field will contribute to the
modelling of the active geodynamic processes in this area. Furthermore, this network will hopely
provide useful data to investigate relationships between tensional stresses in the monitored tectonic
fault system and the Aeolian volcanism. We show a preliminary comparison between the two first
surveys, performed in October 1996 and November 1998, respectively.
INQUADRAMENTO STRUTTURALE
Dati geofisici, geologici e geochimici concordano nell’assegnare un ruolo
fondamentale nell’assetto cinematico dell’area eoliana alle strutture orientate NNW-
SSE riferibili al sistema di faglie trascorrenti destre Tindari-Giardini (Ghisetti e
Vezzani, 1982; Barberi et al., 1994; Ventura, 1994; Achilli et al., 1996). Il controllo di
tale sistema strutturale sull’evoluzione del vulcanismo del complesso eruttivo Lipari-
Vulcano, è confermato non solo dalla posizione delle due isole, ma anche dalla
distribuzione delle caldere, dei crateri e delle fratture lungo lo stesso trend (Frazzetta
et al., 1977, 1982; vedi Fig. 1).
Il sistema vulcanico eoliano è costituito da sette isole e da numerosi seamounts
che, ad esclusione del complesso Lipari-Vulcano, descrivono una struttura arcuata
che si estende per circa 80 km, concava verso NNW (Fig. 2). Le aree sommerse più
occidentali, insieme alle isole di Filicudi, Salina e Panarea, sembrano rappresentare i
centri più antichi (Gillot, 1987; Santo et al., 1995; Peccerillo, 1996), mentre le isole di
Alicudi, Lipari, Vulcano e Stromboli costituiscono gli apparati più recenti (Gillot,
1987).GNGTS – Atti del 18° Convegno Nazionale / 08.18
Fig. 1 - Mappa strutturale del complesso Lipari - Vulcano (Frazzetta et al., 1977).
Stromboli
Isole Eolie
Salina Panarea
Alicudi Filicudi Mare Tirreno
Lipari
Vulcano
Golfo di
Patti
Tindari -
Giardini F. Calabria
Sicilia
Mare Ionio
Fig. 2 - Mappa strutturale schematica del sistema Arco Calabro-Peloritano – Tirreno Meridionale
(Finetti e Del Ben, 1986).
In un contesto di convergenza N-S Africa-Europa e di subduzione della placca
Africana al di sotto della placca Euro-Asiatica (Barberi et al., 1973, 1974; Doglioni,
1996), l’area investigata può essere inquadrata come un sistema arco vulcanico –
bacino di retroarco. A conferma di tale strutturazione geodinamica, la sismicitàGNGTS – Atti del 18° Convegno Nazionale / 08.18
regionale profonda (h > 200 km) giace su un piano fortemente inclinato, immergente
verso NW (Caputo et al., 1970; Gasparini et al., 1982; Finetti e Del Ben, 1986). La
convessità del sistema eoliano rivolta ad oriente, ha fatto ipotizzare a Doglioni (1996)
l’esistenza di un flusso profondo del mantello verso est che fa retrocedere e
verticalizza il piano di subduzione. Alternative interpretazioni sono proposte da
Scandone (1979, 1982) e Wezel (1981).
La distribuzione approssimativamente Ovest-Est formata da Alicudi, Filicudi,
Salina, Panarea e diversi seamounts, è interrotta dal trend trasversale NNW-SSE del
complesso Lipari-Vulcano, intersecante l’arco in corrispondenza dell’isola di Salina.
Lo spostamento del sistema eruttivo di circa 5 km verso Sud, insieme all’attività
vulcanica recente lungo il trend trasversale, suggerisce l’esistenza di un’importante
discontinuità crostale. Una ulteriore conferma è costituita dai dati sismologici raccolti
nell’area tra le Isole Eolie e la costa Nord-siciliana (Aloisi et al., 1999; Fig. 3). In
particolare, l’attività sismica recente mostra meccanismi trascorrenti destri e normali
con piano di faglia NNW-SSE (Gasparini, 1982). In terra ferma, la presenza di
strutture con il medesimo trend, da Capo Tindari a Letojanni, è confermata da analisi
morfostrutturali e tettoniche (Ghisetti, 1979). Tale area, in accordo con il citato
disallineamento dell’arco vulcanico, è stata interessata da spostamenti destri di circa
7-10 km durante gli ultimi 2-3 My (Atzori, 1978). In tale contesto, l’attività vulcanica
dell’arco eoliano sarebbe controllata da strutture disposte “en echelon” rispetto alla
struttura principale la cui geometria dà luogo ad una tettonica transtensionale.
40.00°
N
39.00°
38.00°
37.00°
50 km
14.00° 15.00° 16.00° 17.00°
Fig. 3 - Distribuzione epicentrale dal 1978 al 1997 (Aloisi et al., 1999).
Numerosi progetti di ricerca sono stati proposti per lo studio della dinamica
dell’arco vulcanico e del sistema di faglie Tindari-Giardini (Falsaperla et al., 1989;GNGTS – Atti del 18° Convegno Nazionale / 08.18
Achilli et al., 1988, 1996; Bonaccorso et al., 1995; Anzidei et al., 1996). In varie
occasioni è stato osservato che eventi di origine tettonica, localizzati nelle immediate
vicinanze di Vulcano, sono seguiti a breve periodo (1-2 settimane) da una crescita di
eventi di origine vulcanica (Bottari et al., 1984; Falsaperla e Neri, 1986). Misure
geodetiche hanno chiaramente mostrato una forte correlazione tra le deformazioni
dell’area Lipari-Vulcano e la crisi sismica che ha interessato il Golfo di Patti a partire
dal 15 Aprile 1978 (Falsaperla et al., 1989). A conferma del pronunciato controllo
strutturale sulla deformazione, l’orientazione degli assi di strain massimo (E1) e
minimo (E2) risultava quasi perpendicolare alla linea di faglia (Falsaperla et al.,
1989).
Si può pertanto concludere che lo stress tensionale delle principali strutture
tettoniche regionali, quali la Tindari-Giardini, può controllare il vulcanismo eoliano.
Conseguentemente, diventa quasi imperativo condurre una serie di iniziative di
ricerca miranti a quantificare e meglio comprendere la dinamica attuale di tali
strutture, anche ai fini di una più corretta e tempestiva valutazione del rischio
vulcanico.
LA RETE DEI PELORITANI
Nell’ambito di un progetto di ricerca del GNV, al fine di quantificare i movimenti
del sistema Eolie-Tindari-Giardini, una rete geodetica è stata installata nell’area dei
Mt. Peloritani (Fig. 4).
Lipari Surve y Ve rt ice
199 6
Vulcano
199 8
Milazzo
Capo Calavà
Tindari
Rodì San Placido
Montalbano
Mandanici
Roccella
Castelmola
Fig. 4 - Posizione dei capisaldi GPS nell’area dei Peloritani.GNGTS – Atti del 18° Convegno Nazionale / 08.18
I capisaldi sono stati materializzati utilizzando dispositivi autocentranti
tridimensionali uguali a quelli già adottati nella rete GPS dell’Etna (Warnant et al,
1995). Tale configurazione permette di minimizzare gli errori strumentali e di
migliorare la ripetibilità delle misure.
L’Istituto Internazionale di Vulcanologia (IIV), in collaborazione con
l’Osservatorio Vesuviano (OV), ha effettuato nell’ottobre 1995 e 1996 delle misure su
alcuni capisaldi di tale rete in modalità statica utilizzando una strumentazione mista
(Trimble e Leica). Sono state adottate sessioni di misura pari a 6 ore.
Una nuova campagna è stata successivamente condotta dall’IIV nel novembre
1998 utilizzando solo strumentazione Trimble ed aggiungendo un vertice
TYRGEONET (San Placido) ed un vertice etneo (Roccella). È stata adottata una
frequenza di campionamento pari a 30 sec. Per ogni giorno sono state previste tre
differenti tipologie di programmazione. Al fine di consentire l’inquadramento della rete
nel riferimento ITRF, nelle due stazioni permanenti di Milazzo e Montalbano sono
stati installati i ricevitori Trimble 4000SSI con sessioni di misura pari a 24 ore. Una
seconda programmazione è stata effettuata alla stazione permanente di San Placido
dove il ricevitore Trimble 4000SSE ha acquisito per 11 ore. Al fine di massimizzare la
durata delle sessioni ed ottimizzare gli spostamenti delle squadre, un’ultima tipologia,
la cui durata è di 6:10 ore, è stata impostata per i rimanenti vertici.
La strumentazione utilizzata nei due surveys è riassunta in Tab. 1.
Tab. 1 - Strumentazione usata.
Ricevitori 1996 1998
Trimble 4000SSI x x
Trimble 4000SSE x x
Leica System 200 x
ELABORAZIONE DEI DATI E RISULTATI
L’elaborazione e la compensazione sono state effettuate mediante il software
GPSurvey 2.30 (Tab. 2). L’elaborazione dei dati relativi ai singoli lati è stata effettuata
utilizzando le effemeridi precise ed il modello troposferico di Saastamoinen (1973).
La successiva compensazione di tali soluzioni GPS è stata effettuata tramite il
software Trimnet Plus 92.11c. Differenti criteri e modalità operative sono stati adottati
nella compensazione delle due campagne.
In fase di elaborazione della campagna 1998 pochissime misure vengono
rigettate dai tests statistici (t test) e nella maggior parte dei casi sono stati risolti i
problemi nei dati affetti da acquisizioni rumorose o da multipath. Dopo una prima
fase in cui la rete è stata compensata adottando il criterio dei vincoli interni, la rete
misurata nel 1998 è stata vincolata a tre vertici esterni (Noto, Matera e Cagliari) la cui
posizione ed il modello di velocità sono ben noti e costantemente aggiornati tramite
varie tecniche spaziali. Pertanto, i vertici sono stati inseriti nel sistema di riferimento
internazionale, l’ITRF 97 (IERS Terrestrial Reference Frame).GNGTS – Atti del 18° Convegno Nazionale / 08.18
Tab. 2 - Caratteristiche dei due rilievi.
Tabella riassuntiva Survey
Anno 1996 1998
N stazioni 5 9+3(ASI)
N baselines analizzate 8 188
Baselines con ambiguità fissata 8 168
Soluzioni eliminate 0 7
Tecnica Statica Statica
Soluzione Iono free fixed (> 10 km) Iono free fixed (> 10 km)
Effemeridi Precise Precise
Aggiustamento Fully constrained Fully constrained
Stazioni fissate 1 (Tindari) 3 (ASI)
Reference Frame ITRF 97 ITRF 97
Software GPSurvey 2.30 GPSurvey 2.30
Per quanto concerne le misure condotte nel 1996, sono stati elaborati
esclusivamente i dati acquisiti dai ricevitori Trimble, in quanto i dati dei Leica non
sono disponibili in formato Rinex. La compensazione di tale rete è condotta
vincolandola ad un caposaldo scelto in posizione baricentrica (Tindari). In tal modo è
possibile raggiungere due obiettivi: a) valutare la congruenza dei dati acquisiti,
permettendo di evidenziare eventuali misure anomale (p.es. a causa di problemi di
multipath occorsi durante le sessioni), b) rendere le due reti (quella del 1998 e quella
del 1996) confrontabili tra loro almeno in termini di scala. Quest’ultimo aspetto è
particolarmente importante per poter condurre una corretta analisi dello strain
misurato dalla rete. Data l’esiguità delle misure prese in considerazione nel 1996, è
attualmente possibile procedere al confronto di quattro distanze tra le due campagne
di misura. I risultati di tali confronti sono riportati in Tab. 3.
Tab. 2 - Confronto fra i risultati ottenuti.
Vertici Ell. Dist. 1996 (m) Errore (m) Ell. Dist. 1998 (m) Errore (m) 1998-1996
Calavà Rodì 23158.495 0.002 23158.493 0.001 -0.002
Calavà Tindari 11194.490 0.002 11194.479 0.001 -0.011
Rodì Tindari 11970.331 0.002 11970.340 0.001 0.009
Castelmola Mandanici 17200.272 0.006 17200.248 0.002 -0.024
Si evidenzia che tre dei quattro lati hanno subito deformazioni superiori
all’errore stimato. In particolare, due di questi (Calavà-Tindari e Castelmola-
Mandanici) mostrano di aver subito una contrazione, mentre il terzo (Rodì-Tindari) si
è esteso. È interessante rilevare (Fig. 5) che due dei lati che hanno subito
deformazioni significative tagliano l’allineamento principale della Tindari-Giardini con
azimut differenti, il che consente di effettuare una valutazione sulla congruenza dei
movimenti aspettati dal modello geodinamico proposto per tale struttura. Dal
confronto risulta che il lato in contrazione Castelmola-Mandanici ha un azimut di circa
N7E, mentre quello Rodì-Tindari, che si è esteso, è orientato N68W (Fig. 5). Tali dati
sono compatibili con il movimento trascorrente destro della faglia Tindari-Giardini, nel
quale si inserisce bene anche la contrazione registrata dal terzo lato (Calavà-Tindari)GNGTS – Atti del 18° Convegno Nazionale / 08.18
che suggerisce un movimento del vertice di Tindari in direzione di Calavà. Purtroppo,
a causa dei limitati dati disponibili non è possibile procedere ad una analisi più
approfondita circa la cinematica della struttura nel periodo indagato, che consenta,
ad esempio, di pervenire alla determinazione dei principali parametri della
discontinuità sorgente delle deformazioni misurate.
Lipari
Vulcano
Milazzo
Capo Calavà
Tindari
Rodì San Placido
Montalbano
Tindari-
Giardini F. Mandanici
Roccella
Castelmola
Fig. 5 - Mappa schematica del sistema strutturale Tindari-Giardini e baselines attualmente
confrontate.
CONCLUSIONI
La campagna di misure GPS condotta nel dicembre 1998 ha consentito di
completare l’installazione della rete di controllo delle deformazioni legate
all’allineamento strutturale Tindari-Giardini. Le misure effettuate dimostrano come,
allo stato attuale delle ricerche, si sia giunti ad una configurazione ottimale della rete.
I risultati di tale survey sono stati confrontati con quelli della campagna condotta nel
1996.
Il modesto set di confronti disponibili (Tab. 3) non consente allo stato attuale la
presentazione di un modello geodinamico per la struttura investigata. Tuttavia, ad
esclusione della baselines Capo Calavà – Rodì, gli andamenti registrati per i pochi
lati analizzati sembrano essere significativi e compatibili con il meccanismo
dominante dell’area investigata, di tipo trascorrente destro con asse NNW-SSE.
Pertanto, seppure in una fase preliminare, le variazioni osservate confermano la
validità della rete quale strumento per il monitoraggio della dinamica in atto in tale
settore della Sicilia Orientale e ne suggeriscono un adeguato ampliamento sia in
termini di numero di vertici sia di area ricoperta.GNGTS – Atti del 18° Convegno Nazionale / 08.18
BIBLIOGRAFIA
Achilli V., Baldi P., Zerbini S., Broccio F., Cagnetti V., Marsan P., Gubellini A., e Unguendoli M.,
(1988). Comparison between GPS and ground based distance measurements in the Messina
straits Area., Bollettino di Geodesia Teorica e Applicata., Vol 30, 119-120, 361-369.
Achilli V., Berrino G., Obrizzo F., Anzidei M., Casula G., Riguzzi F., Baldi P., Baratin L., Gandolfi S.,
Carniel R., Corrado G., Lanzafame G., Puglisi G., Targa G. e Vettore A., (1996). Geodetic
observations at the Aeolian Islands (Southern Italy), Reports on surveying and geodesy,
Nautilus, 33-47.
Aloisi M., Barberi G., Caccamo D., Mostaccio A., Neri G., Rasà R., e Scaltrito A., (1999). Analisi in
ambiente 1D e 3D della sismicità della Sicilia Orientale e del Tirreno Meridionale, XVIII
Convegno Nazionale GNGTS, Roma, sottomesso.
Anzidei M., Baldi P., Bonini C., Casula G., Gandolfi S., and Riguzzi F., (1996). Geodetic survey across
the Messina straits (southern Italy) Seismogenetic area. Journal of Geodynamics.
Atzori F., Ghisetti F., Pezzino A., e Vezzani L. (1978). Struttura ed evoluzione geodinamica recente
dell’area peloritana (sicilia nord-orientale). Boll. Soc. Geol. It., 97, 31-56.
Barberi F., Gasparini P., Innocenti F. and Villari L., (1973). Volcanism of the Sothern Tyrrhenian Sea
and geodynamic implications. Jour. Geophys. Res., 78, 5221-5232.
Barberi F., Ferrara G., Keller J., Innocenti F., Villari L., (1974). Evolution of the Aeolian arc volcanism.
Earth and Planet. Sci Lett 21, 269-276.
Barberi F., Gandino A., Gioncada A., La Torre P., Sbrana A., Zenucchini C., (1994). The deep
structure of the Eolian Arc (Filicudi-Panarea-Vulcano sector) in light of gravimetric, magnetic
and volcanological data, J. Volcanol. Geotherm. Res., 61, 189-206.
Bonaccorso S., Velardita R., and Villari L., (1995). EDM and tilt mesurements on the Island of Vulcano
(Aeolian Archipelago, Italy): a contribuition to volcanic unrest evaluation. In Proc. Workshop on
“New Challenges for geodesy in volcanoes monitoring”, Walferdange Luxembourg, Chaier du
Centre Europ. del Geodyn. et de Seism. 195-204.
Bottari A., Caccamo D., Falsaperla S., Neri G. (1984) Analisi preliminare dell’attività sismica con
origine nell’area di Vulcano durante il primo semestre 1984. Open-File Rep 2/84, IIV, CNR,
Catania.
Caputo M., Panza GL., Postpischil D., (1970). Deep structure in the Mediterranean Basin. J Gephys
Res 75 (26), 4919-4923.
Doglioni C., (1996). Geodinamica del sistema Appennino-Tirreno, Atti della Scuola di Mineralogia, “La
mineralogia in aree vulcaniche”, 1-10.
Falsaperla S., Neri G. (1986). Seismic monitoring of volcanoes: Vulcano (southern Italy). Workshop
on resumed activity in areas of quiescent volcanism: triggers and precursor. Firenze (Italy). 15-
17 May, 1986. Per Mineralogia 55, 143-152.
Falsaperla S., Frazzetta G., Neri G., Nunnari G., Velardita R., & Villari L., (1989). Volcano monitoring
in the Aeolian Islands (Southern Tyrrenian sea): the Lipari-Vulcano eruptive complex. In IAVCEI
Proceedings in Volcanology 1 “Volcanic Hazards: assesment and monitoring” J.H. Latter (Ed.)
Springer Verlag, New York, 337-356.
Finetti I., Del Ben A., (1986). Gephysical study of the Tyrrhenian opening. Bollettino di Geofisica
Teorica e Applicata, 28, 110, 75-155.
Frazzetta G., Villari A., Villari L., (1977). Ground deformation and geological structures on Vulcano-
Lipari volcanic complex (Aeolian Islands, Italy). IAVCEI – IASPEI Joint General Assemblies,
Durham, Sept 1977.
Frazzetta G., Lanzafame G., Villari L., (1982). Deformazioni e tettonica attiva a Lipari e Vulcano
(Eolie). Mem Soc Geol It, 24, 293-297.
Gasparini C., Iannaccone G., Scandone P., Scarpa R., (1982). Seismotectonics of the Calabrian arc.
Tectonophysics 84, 267-286.
Ghisetti F., (1979). Relazione tra strutture e fasi trascorrenti e distensive lungo i sistemi Messina-
Fiumefreddo, Tindari-Letojanni e Alia-Malvagna (Sicilia nord-orientale): uno studio
microtettonico. Geol. Romana, 11, 35-42.
Ghisetti F., Vezzani L., (1982). Different styles of deformation in the Calabrian arc (southern Italy):
implications for a seismotectonic zoning, Tectonophysics, 85, 149-165.
Gillot, P.Y., (1987). Histoire volcanique des Iles Eoliennes: arc insulaire ou complexe orogénique
annullaire? Doc. Trav. I.G.A.L., 11, 35-42.
Peccerillo A., (1996). Genesi ed evoluzione del magmatismo eoliano, Atti della Scuola di Mineralogia,
“La mineralogia in aree vulcaniche”, 1-9.GNGTS – Atti del 18° Convegno Nazionale / 08.18
Saastamoinen II, (1973). Contribution to the theory of atmospheric refraction, Bulletin Geodesique,
107, 13-34.
Santo A.P., Chen Y., Clark A.H., Farrar E. & Tsegaye Abebe, (1995). 40 Ar/39Ar ages of Filicudi
Island volcanics: implications for the volcanical history of the Aeolian Arc, Italy. Acta Volc., 7,
13-18.
Scandone P., (1979). Origin of the Tyrrhenian Sea and the Calabrian Arc. Boll Soc Geol It, 98, 27-34.
Scandone P., (1982). Structure and evolution of the Calabrian Arc. Earth Evol., 2, 172-180.
Ventura G., (1994). Tectonics, structural evolution and caldera formation on Vulcano island (Aeolian
Archipelago, Southern Tyrrhenian Sea), J. Volcan. Geotherm. Res., 60, 207-224.
Warnant R., Bruininx C, Puglisi G. (1995). The ROB-IIV network on Mt. Etna: first result. Proceed. of
the Workshop New Challenges for Geodesy in Volcanic Monitoring Walferdange - Luxembourg
June 14-16, 1993, in Cahiers du Centre Européen de Géodynamique et de Séismologie, Vol. 8,
115-128.
Wezel C.F., (1981). The structure of the Calabro-Sicilian Arc: Krikogenesis rather than subduction. In
Sedimentary basins of Mediterranean margins, Wezel F. C. ed., Tectonoprint, Bologna, 485-
457.Puoi anche leggere