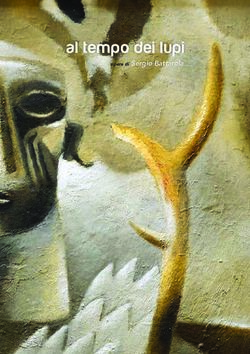LA SUPERBIA IN DANTE: INTIMO CONFLITTO TRA IL DESIDERIO DI GLORIA E LA CONSAPEVOLEZZA DELLA SUA VANITÀ
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA
Facoltà di Lettere e Filosofia
Corso di Laurea in Lettere
Tesi di Laurea triennale
LA SUPERBIA IN DANTE: INTIMO CONFLITTO
TRA IL DESIDERIO DI GLORIA E LA
CONSAPEVOLEZZA DELLA SUA VANITÀ
Relatore: Ch. mo Prof. Aldo Maria Costantini
Laureanda: Sabrina Toppan
Matricola: 810466
Anno Accademico 2008-2009INTRODUZIONE
§ 1. Ritratto di Dante Alighieri: l’uomo, l’intellettuale.
“[…] nel caso di Dante, si
potrebbe intitolare
comodamente Le vite, ché il
personaggio uno diviene, molto
pirandellianamente, i
centomila. Mai però nessuno;
perché Dante è talmente
orgoglioso di essere Dante che
quel nessuno non lo avrebbe
mai accettato”.
(Marcello Vannucci)
I biografi e i commentatori moderni si dimostrano unanimi nel sostenere che Dante ebbe un
intelletto precocissimo, un’innata sensibilità forte e autentica e, a coronamento del ritratto ideale
dell’intellettuale, una memoria che si rivelò sempre eccezionale. Queste sostanzialmente sono le
doti naturali su cui poté contare il poeta, ma probabilmente non sarebbero state sufficienti se una
singolare avidità di conoscenza non avesse, da sempre, animato la sua personalità.
Ha ben ragione il Sollers:
“si direbbe che per Dante l’essenziale sia non esser mai in riposo, di
poter spiegare ogni fenomeno, ogni tratto dei suoi poemi […]”.1
Ben presto si dimostrò (e su questo punto concordano antichi e moderni) un fanciullo precoce,
dall’ingegno sempre pronto e acuto, ma anche un giovinetto sdegnoso, altezzoso e solitario, che
andava distinguendosi per un temperamento artistico tendente all’eccellenza.
1
Cfr. Philippe Sollers, Sur le matérialisme, Parigi, 1973 (trad. it. Milano, 1973), citato in G. Petrocchi, Vita di
Dante, Torino, Laterza, 1983, p. 40.
~1~1.1 La formazione culturale
Altero e disdegnoso, amava circondarsi di pochi amici a lui simili ma, assetato di ideali, avido di
conoscenza e di gloria, sentì fin da subito il bisogno di una scuola più vasta, di un addestramento
più saldo e sicuro. Poco si sa circa gli studi di Dante. La sua cultura, formatasi in un contesto
educativo totalmente diverso da quello attuale, è ricostruibile, in assenza di dati documentari
affidabili, innanzitutto a partire dalle opere. Si ottiene così l'immagine di un attento studioso di
teologia, filosofia, fisica, astronomia, grammatica e retorica: in breve, di tutte le discipline del
Trivium e del Quadrivium previste dalle scuole e dalle Universitates medievali.
Secondo una testimonianza del Convivio (cfr. II, XII, 7), Dante intuì il valore della filosofia e si
diede a frequentare “le scuole de li religiosi e le disputazioni de li filosofanti”. Occorre ricordare,
infatti, che agli studi generali dei domenicani di Santa Maria Novella, dei francescani di Santa
Croce e alla scuola di Spirito Santo degli agostiniani affluivano sia religiosi che laici.
Di tutti i possibili maestri di Dante, solo di Brunetto Latini è possibile tracciare un profilo, il quale
aveva compreso sin da subito l’altezza dell’ingegno e l’avidità di sapere e di gloria del giovane
allievo. Egli stesso si dichiarò “phylosophie domesticus” e conobbe la precisa formulazione di tutti
i problemi che costituiscono il fondamento logico di ogni speculazione.
Si iscrisse all’arte dei medici e degli speziali, assistette alle lezioni dei religiosi e partecipò a
riunioni e dispute secondo l’uso del tempo, distinguendosi sempre per la sottigliezza delle sue
domande e obiezioni (spesso apertamente polemiche, secondo il suo fiero temperamento).
A Firenze il giovane Dante (1291-1294) apprese i principi direttivi delle singole questioni di
filosofia morale e di teologia. A Bologna invece, conobbe il diritto e coltivò la sua passione per
l’arte, come si può ricavare, ad esempio, dal fatto che riuscì a notare l’inizio di una nuova maniera,
diversa dal disegno minuzioso e complesso di Oderisi, che si stava affermando con le miniature di
Franco Bolognese (cfr. Purg., XI, 77-84). Alla teologia si dedicò (forse) anche a Parigi, secondo
quanto riportano Giovanni Villani e Boccaccio. È da ritenere che qui incontrasse tomisti e
bonaventuriani, averroisti ed eclettici, intellettualisti e dogmatici e che da questi incontri abbia
ricavato una sua umana e poetica esperienza, sempre in bilico tra ardore polemico e misura, tra
emozione lirica e passione per le forme speculative.
Molti passi della Comedìa costituiscono l’eco di questa lezione teologica.
~2~La sua immaginazione prende avvio dalla tradizione cristiana e medievale; la parte essenziale che
egli attribuisce alla scienza non deriva da una passiva ricettività, bensì dal culto rigoroso della
dottrina che lo caratterizza. Nel suo ritratto umano confluiscono le esperienze più varie ed è
necessario tenere nel debito conto le rispondenze del sentimento e del costume del tempo, i canoni e
le volontà della sua disciplina intellettuale.
Ad ogni modo, è probabile che il poeta abbia frequentato gli studia religiosi e laici di cui si ha
notizia a Firenze. Alcuni ritengono che Dante abbia studiato presso l'Università di Bologna, ma non
vi sono prove certe in proposito. Sicuramente non fu uomo da accontentarsi, guardò sempre più
lontano, mirò sempre più in alto rispetto a chi lo circondava (Cavalcanti e Lapo, tra tutti) e ogni
volta sentiva crescere dentro di sé una sorta di scontentezza per l’arte propria e di tutti i poeti
volgari. Dovette certamente soffrire di quella frustrazione, di quell’irrequietudine che anima chi si
sente chiamato a cose sempre più alte e cerca intensamente, ma ancora non riesce a trovare.
Un tratto peculiare della personalità dantesca sembra essere proprio l’incessante ricerca di nuove e
sempre più impegnative soluzioni, attraverso cui estrinsecare la tensione che muove il suo spirito
verso traguardi sempre più alti, conoscitivi o morali che siano. La naturale e ovvia conseguenza di
questo lato del suo carattere fu un’inquietudine permanente, la smania di eccellere e di superare tutti
gli altri:
“più imparava e più egli voleva sapere”, osserva Umberto Cosmo, ma ciò che lo
caratterizzò fu appunto “la confidenza nel proprio pensiero, la persuasione che ad
ogni domanda esso possa rispondere, ogni verità riesca a conquistare […]”.1
Una “confidenza” totale, assoluta e per certi versi altezzosa nelle proprie virtù razionali, che ha
spinto molti critici a definire Dante una persona orgogliosa.
Appare opportuno affermare che evidentemente nessun uomo ebbe, più di Dante, consapevolezza
della propria grandezza e che nessuno più di lui sperò di veder riconosciuti i propri meriti artistici.
Dice il Villani nella sua Cronica:
“[…] sanza altra colpa co la detta parte bianca fue cacciato e sbandito di Firenze, e
andossene a lo Studio a Bologna, e poi a Parigi, e in più parti del mondo. Questi fue
grande letterato quasi in ogni scienza, tutto fosse laico; fue sommo poeta e filosafo, e
rettorico perfetto tanto in dittare, versificare, come in aringa parlare, nobilissimo
dicitore, in rima sommo, col più pulito e bello stile che mai fosse in nostra lingua
infino al suo tempo e più innanzi”.2
1
Cfr. U. Cosmo, Vita di Dante, Bari, G. Laterza e Figli, 1930, pp. 46-47.
2
Cfr. G. Villani, Nuova Cronica, vol. 2, edizione a cura di G. Porta, Parma, Guanda, 1991, X, CXXXVI.
~3~Come è già stato detto, non è possibile ricostruire con esattezza l’iter di formazione culturale di
Dante, ma su questa breve descrizione del Villani, tutti sono d’accordo.
1.2 La “biblioteca” di Dante
È quanto mai difficile stabilire sia pur approssimativamente quali furono nel concreto le
caratteristiche e l’estensione delle diverse “biblioteche” cui il poeta poté attingere nel corso della
sua vita, a partire dai giovanili anni della formazione fino alle peregrinazioni imposte dall’esilio.
Senza alcuna pretesa di completezza si può stilare rapidamente un elenco di autori e testi che
sicuramente erano ben noti a Dante, certificati come sono dagli echi presenti nelle sue opere.
Innanzitutto la Bibbia, “libro” dettato, nella convinzione dantesca, direttamente da Dio; molti degli
scritti di Aristotele, naturalmente in traduzione latina e con l’ausilio delle glosse di San Tommaso e
dei filosofi arabi; l’Eneide dell’amato e stimato Virgilio, conosciuta pressoché a memoria tanto
quanto la Bibbia. Subito dopo si nota la pur notevole presenza della Farsaglia di Lucano; la
Tebaide e l’Achilleide di Stazio e sicuramente alcune delle opere di Cicerone; infine, anche se meno
accertati, si possono trovare echi delle satire di Persio e della prima Deca di Tito Livio.
Tra gli scrittori cristiani,1 invece, Dante conobbe certamente molte opere della patristica latina
(soprattutto quelle di Agostino, ma anche testi di Girolamo, Gregorio Magno e molti altri) ed ebbe
grande dimestichezza con i trattati teologici a lui più vicini nel tempo, in particolare quelli ad opera
di Anselmo d’Aosta, Alberto Magno, Tommaso d’Aquino e Bonaventura da Bagnoregio.
Sulla conoscenza non mediata di opere appartenenti alla cultura islamica invece, non esistono prove
dirette e concrete; al contrario, per quanto concerne la letteratura volgare di argomento sacro (quasi
esclusivamente di ambito franco – italiano), che per ovvi motivi di spazio non è possibile elencare,
Dante fu avido lettore e sicuramente frequentò molti di questi autori.
È opinione diffusa che tra tutte le fonti sopracitate, il poeta abbia privilegiato gli scritti più
spiccatamente mistici, come ha avuto modo di dimostrare il Muresu:
“[…] né certo è un caso che nella Commedia egli abbia dato il compito di guida
ultima e suprema a Bernardo di Chiaravalle, il santo che, prendendo il posto di
Beatrice, lo introduce alla diretta visione di Dio”.2
1
Tra questi è sicuramente da includere anche Boezio, indipendentemente da quanto sia stato accertato
storicamente, in virtù della sua precisa collocazione in Paradiso.
2
Cfr. G. Muresu, Intervista su Dante, in “Letteratura italiana antica”, VII, (2006), to. I, pp. 274-275.
~4~Da questa breve rassegna risulta sufficientemente dimostrato che Dante fu di sicuro un lettore
onnivoro, avido di conoscenza e che soprattutto fu dotato di una memoria prodigiosa, tenuta
costantemente in esercizio e affinata in virtù del fatto che non fa scienza, / sanza lo ritenere, avere
inteso (cfr. Par., V, 41-42).
§ 2. I commentatori antichi
Numerosi biografi e commentatori antichi si sono cimentati nella ricostruzione della vita e del
ritratto umano dell’illustrissimo poeta. Tra i maggiori (oltre a Boccaccio, ovviamente), sono da
ricordare Giovanni e Filippo Villani, Benvenuto da Imola, Francesco da Buti, Leonardo Bruni e
Giannozzo Manetti, i quali hanno attinto notizie intorno all’Alighieri principalmente dal Trattatello
in laude di Dante di Giovanni Boccaccio.
Più volte nel corso del tempo si è accusato il Boccaccio di aver scritto non la storia della vita di
Dante, ma un romanzo, un’opera di sentimento e fantasia; più uno sfogo di vendetta contro i nemici
e i detrattori del sommo poeta, nei quali probabilmente voleva colpire i propri.
L’elemento retorico e leggendario, infatti, prevale sul dato storico: i tempi, le circostanze e il modo
di intendere la compilazione di una vita però, non potevano fornire al Boccaccio l’oggettività che
oggi si richiede. In ogni caso, in virtù del “buio” che circonda gli avvenimenti della puerizia e della
giovinezza di Dante, così come quelli riguardanti l’esilio e i viaggi che ne conseguirono, il
Trattatello costituisce il più antico e prezioso documento biografico, la storia più completa e
“sicura” della vita di Dante – specie per quanto concerne le notizie relative al suo amore per
Beatrice e Gemma, ai costumi e alle cure familiari, alle usanze e alle fattezze stesse del poeta. Le
fonti orali cui attinge, infatti, sono quasi sempre limpide e sicure: si tratta soprattutto di notizie
apprese direttamente presso il popolo e, in misura maggiore, estrapolate dai detti del tempo.
Come specifica Boccaccio stesso, l’opera si propone di trattare “DE ORIGINE VITA, STUDIIS ET
MORIBUS VIRI CLARISSIMI DANTIS ALIGERII FLORENTINI, POETE ILLUSTRIS, ET DE
OPERIBUS COMPOSITIS AB EODEM, INCIPIT FELICITER.”1
1
Cfr. G. Boccaccio, Trattatello in laude di Dante, in Tutte le opere di Giovanni Boccaccio, a cura di Vittore
Branca, vol. III, ed. Ricci, Milano, Mondadori, 1974.
~5~Non mi soffermo sui dati strettamente biografici, in quanto è mio interesse specifico gettare luce sul
ritratto dell’uomo Dante nell’immaginario e nella mentalità degli antichi, sulla figura del poeta che
è giunta fino a noi.
Che genere di uomo fu realmente l’Alighieri? Egli stesso, nella sua opera, ci fornisce non poche
notizie a riguardo e, in particolare, confessa abbastanza apertamente un aspetto che da sempre lo
contraddistinse e che, a fasi alterne, può essere considerato una virtù o, al contrario, una colpa: il
suo desiderio di eccellenza, quell’aspirazione alla fama e all’onore che sta alla base di tutta la sua
vita e di conseguenza, della sua opera.
2.1 Dante superbo o magnanimo?
Mi sembra opportuno iniziare questa “inchiesta” con una mirata osservazione del Villani:
“Questo Dante per lo suo savere fue alquanto presuntuoso e schifo e isdegnoso, e
quasi a guisa di filosafo mal grazioso non bene sapea conversare co’ laici; ma per
l’altre sue virtudi e scienza e valore di tanto cittadino ne pare che si convenga di
dargli perpetua memoria in questa nostra cronica, con tutto che per le sue nobili
opere lasciateci in iscritture facciamo di lui vero testimonio e onorabile fama a la
nostra cittade”.1
Di opinione non dissimile era anche il Boccaccio:
“Fu il nostro poeta, oltre alle cose predette, d’animo alto e disdegnoso molto […].
Molto, simigliamente, presunse di sé […] quasi esso solo fosse colui che tra tutti
valesse”.2
Così il Petrarca, che descrive un Dante eccellentissimo come poeta volgare, ma un po’ troppo
altezzoso, sdegnoso e loquace. Egli, raccogliendo una tradizione esistente ancora al suo tempo a
Verona, racconta che “l’Alighieri dapprima tenuto in grande onore, perdette a poco a poco la grazia
di Cangrande per la sua alterigia e la sua libertà di parola”. 3
E lo stesso Cavalcanti, il “primo amico”, non può fare a meno di notare in un suo sonetto che
Solevanti spiacer persone molte, tuttor fuggivi l’annoiosa gente.4
1
Cfr. G. Villani, Nuova Cronica cit., X, CXXXVI.
2
Cfr. G. Boccaccio, Trattatello cit., XXV.
3
Cfr. Petrarca, in Dizionario biografico degli italiani, Istituto dell’Enciclopedia Italiana fondata da G. Treccani,
vol. 2, Roma, 1960, p. 423.
4
Cfr. G. Cavalcanti, Rime, a cura di D. De Robertis, Torino, Einaudi, XLI. I’ vegno ‘l giorno a te ‘nfinite volte
(vv. 5-6).
~6~Anche per quanto concerne il suo innato desiderio di gloria e onori, tutti i commentatori antichi
sono d’accordo. Il Boccaccio parla di “una laudevole vaghezza di perpetua fama” che lo spinsero
ad accettare “li vani onori che alli pubblici uficii congiunti sono” e aggiunge che “per vaghezza di
più solennemente dimostrare le sue passioni e di gloria, sollecitamente” si dedicò alla poesia. Per
concludere, il fedele e ammirato Boccaccio, ammette che il suo amato Dante “vaghissimo fu e
d’onore e di pompa per avventura più che alla sua inclita virtù non si sarebbe richiesto”.1
Anche il Manetti non dimentica di sottolineare il
“suo innato desiderio di gloria”, a causa del quale “fu forse più desideroso di onori
e di gloria di quanto convenga a un così grande e serio filosofo”.2
Così come Francesco da Buti, secondo il quale Dante ebbe gran “sollecitudine delli onori pubblici
della sua città, ai quali ardentemente intese […]”.3
In definitiva, si può affermare che Dante, nella mentalità degli antichi, si configurava già come
poeta sommo ed illustre intellettuale a tutto tondo. Come è stato detto, tutti concordano sulla sua
altezza d’ingegno e avidità di sapere, ma appare unanime anche l’opinione circa la sua altezzosità
(derivante appunto dalla consapevolezza delle proprie eccellenti doti) e la sua brama di onore e
gloria.
A questo punto, ritengo opportuno analizzare il concetto di superbia, così come era inteso al tempo.
1
Cfr. G. Boccaccio, Trattatello cit., XX.
2
Cfr. G. Manetti, Vite di Dante, Petrarca e Boccaccio, Palermo, Sellerio, 2003, p. 111.
3
Cfr. Le vite di Dante, Petrarca e Boccaccio scritte fino al secolo decimosesto, a cura di Angelo Solerti,
Milano, Vallardi, 1904, p. 79.
~7~2.2 La superbia1 nella mentalità medievale
Tommaso nella Summa theologiae definisce la superbia come “amore disordinato della propria
eccellenza”, ossia tutto ciò che innalza la propria persona e che viene ricercato appunto in vista di
mettere in rilievo, attribuire fregio a se stessi.
Gregorio Magno e Tommaso pongono la superbia non tra i vizi capitali, ma al di sopra di essi,
madre e regina di tutti i vizi in quanto, sebbene non tutti i peccati siano di superbia, l’orgoglio può
condurre a qualsiasi colpa. In particolare, dalla superbia derivano presunzione, ambizione,
vanagloria ed essa conduce a durezza e intransigenza verso gli altri. Si tratta di un vizio antisociale
e sta all’origine di gran parte dei conflitti tra gli uomini, che li spinge ad usare una misura diversa
per sé e per gli altri.
È un vizio, insomma, che spinge all’esagerata stima della propria persona e delle proprie capacità
(reali o presunte), correlata ad un atteggiamento esteriore di “superiorità” e disprezzo verso gli altri,
considerati sempre inferiori. Per Tommaso è “un’interna tumefazione della mente” i cui effetti
principali sono: considerare assai le proprie perfezioni reali e apparenti e a dissimulare i difetti;
persuadersi di avere una perfezione superiore a quella che realmente si possiede; attribuire non a
Dio, ma a se stessi i doni posseduti, sia naturali che soprannaturali; grande stima della propria
perfezione e compiacimento in essa; aspirazione a grandi cose, svincolo alla soggezione di chiunque
stimandosi più perfetti di tutti; aspirazione alle dignità e agli onori come dovuti a sé, a preferenza di
tutti gli altri; dolore, ira e lamenti quando non si riesce a conseguirli; rifiuto di soggezione ai
superiori, di cui il superbo si stima più prudente e i cui ordini (almeno nel proprio interno)
disprezza; talvolta ribellione a Dio stesso, quasi che di lui non si abbia bisogno – massimo atto di
superbia, peccato mortale.
Agostino, infine, definisce la superbia come “desiderio di altezza perversa” e descrive la natura
dialettica di un vizio che mentre spinge verso l’alto, precipita verso il basso: lo smodato desiderio di
innalzamento provoca la più rovinosa delle cadute in quanto, aspirare ad un’eccellenza che si pone
in conflitto con la volontà di Dio e l’ordine da lui stabilito, ne sovverte i parametri morali.
Nella teologia cattolica, la superbia è considerata il più grave dei peccati capitali in quanto consiste
in una considerazione talmente alta di se stessi al punto da stimarsi come principio e fine del
proprio essere, disconoscendo così la propria natura di creatura di Dio e offendendo quindi il
Creatore.
1
Per la spiegazione del lemma superbia si veda F. FORTI, superbia e superbi, “voce” dell’Enciclopedia
Dantesca, Istituto dell’Enciclopedia Italiana fondata da G. Treccani, Roma, 1970 ss., vol. V, pp. 484-487 e
bibliografia ivi citata.
~8~Ma Dante corrisponde davvero a tali definizioni? Sarà interessante analizzare anche il concetto di
magnanimità.
2.3 La magnanimità nel pensiero medievale1
Come è noto, l’Etica Nicomachea2 pone la magnanimità come virtù media tra l’eccesso della
presunzione e il difetto della pusillanimità. A tale prospettiva Dante aderisce pienamente e da ciò
sfocia la netta contrapposizione fra pusillanimità e magnanimità, che è motivo ricorrente dei primi
canti della Commedia e uno dei motivi portanti che attraversa tutto il poema (si veda a riguardo
l’opposizione, ben avvertibile, tra i vilissimi del vestibolo e gli spiriti magni).
Secondo l'Etica aristotelica, appunto, la magnanimità (megalopsichia) è quella virtù acquisitrice e
moderatrice di onori e fama. Magnanimo è colui che si ritiene degno di onori e fama perché ne è
veramente degno, senza ricadere nel difetto che è la pusillanimità (micropsichia), il vizio di chi non
si ritiene degno di onori e fama, o nell’eccesso della presunzione (chaymotes), che spinge ad ambire
a questi onori senza esserne degno.
Il magnanimo, per essere tale, non deve inoltre peccare d'audacia (megalocindinia) aspirando ad
imprese al di fuori delle sue capacità, pur di ottenere la gloria.3
Magnanimo è quindi chi si stima degno di grandi cose (essendone, però, effettivamente degno), ma
è anche chi, padroneggiando se stesso, si rende più disponibile e generoso nei confronti degli altri.
Aristotele trattando il concetto di magnanimità evidenzia, con la sua consueta finezza psicologica,
come magnanimo sia colui che sa perseguire veramente grandi cose e, quindi, per questo si
autostima; al contrario: "Chi si stima diversamente dal suo reale valore è sciocco, e nessuno di
coloro che vivono secondo virtù è sciocco o scervellato".
Il magnanimo, sempre secondo Aristotele, si comporta in modo adeguato alla sua natura in base
all'onore, che è il più "grande dei beni esteriori".
Di contro, il pusillanime difetta nello stimarsi: "Sia in rapporto a se stesso sia in confronto con ciò
di cui si ritiene degno il magnanimo"; mentre il vanitoso: "Eccede in rapporto a se stesso, ma certo
non in confronto con il magnanimo".1
1
Cito come fonte imprescindibile di questo paragrafo F. Forti, Magnanimitade: studi su un tema dantesco,
Bologna, Patron, 1977.
2
Cfr. Aristoteles, Etica Nicomachea, a cura di M. Zanatta, Milano, Rizzoli, 1991, IV libro.
3
Il che riporta a un confronto con l’Ulisse dantesco. Due sono essenzialmente i caratteri di questo
personaggio: l’astuzia e l’inesauribile sete di conoscenza, quest’ultima basilare nella personalità dantesca.
Eroe che per amor di conoscenza aveva abbandonato patria e famiglia, era la figura nella quale Dante
poteva specchiarsi. L’ardimento di Ulisse si esplica nell’affrontare l’oceano sconosciuto, ma anche nella
precedente esplorazione del Mediterraneo occidentale.
~9~In conclusione, Aristotele ritiene che il magnanimo, in quanto degno delle cose più grandi, dovrà
essere anche "l'uomo più perfetto" e, quindi, virtuoso e buono.
Lo stesso Dante ha riflettuto attentamente sulla natura della magnanimità, concetto ben familiare
per lui, ed è giunto alla definizione di virtù moderatrice e acquistatrice de’ grandi onori e fama,2
intesa come una delle undici virtù morali diversamente da diversi filosofi […] distinte e numerate.
Nella Firenze del secondo Duecento, si incontravano la tradizione arabo-latina del testo aristotelico,
alla quale faceva capo la versione di Taddeo Alderotto, per tramite di questo il sesto libro del
Tesoro di Brunetto Latini3 e la tradizione greco – latina del testo commentato da Tommaso.
Taddeo e Brunetto divulgarono con le loro versioni il compendio della Nicomachea, in cui il
carattere della magnanimità è presentato sotto una luce particolare e da cui deriva il famoso giudizio
negativo di Dante sulla versione. Nella definizione infatti, che Taddeo traduce in questo modo:
“Magnanimo si è colui che è acconcio a grandissimi fatti e rallegrasi e gode di fare grandi cose”,
appare sottolineato il carattere attivo del magnanimo.
Da qui la confusione tra magnanimità e magnificenza che spesso regna tra i seguaci delle
concezioni cavalleresche – cortesi: Boccaccio ad esempio, vede negli spiriti magni “gli spiriti di
coloro li quali nella presente vita furono di grande animo e furono nelle loro operazioni
magnifichi”.4
Dante invece, si trovò a riflettere attentamente sul concetto aristotelico – come dimostrano la
definizione nel Convivio (I, XI, 18 e ss.) e un passo del De Vulgari Eloquentia (II, VII, 2) – e giunse
a distinguere nettamente la magnanimità dalla magnificenza. In ogni caso rimase fermo sul carattere
attivistico che la tradizione araba aveva conferito alla magnanimità e che era stato confermato dalle
glosse di Tommaso: sotto questa luce, gli spiriti magni del testo dantesco vanno intesi come
magnanimi nel senso aristotelico, cioè dotati della virtù della magnanimità così come Dante la
intendeva.
Seguendo le glosse di Tommaso, si può dire che essere degni d’onore significa mirare al massimo
nelle varie virtù, specialmente al massimo in sapienza, fortezza, temperanza e giustizia.
1
Cfr. Aristoteles, Etica nicomachea cit., IV.
2
Cfr. Convivio, IV, XVII, 5.
3
Cfr. C. Marchesi, Il compendio volgare dell’Etica Nich. e le fonti del VI libro del Trésor, in “Giornale storico
della letteratura italiana”, XLII, (1903), pp. 1-74; ID., L’Etica Nicomachea nella tradizione latina medievale,
Messina, 1904, App., pp. XLI-LXXXVI.
4
Cfr. G. Boccaccio, Esposizioni sopra la “Comedia” di Dante, a cura di Giorgio Padoan, in Tutte le opere di
Giovanni Boccaccio, a cura di Vittore Branca, vol. VI, Milano, Mondadori, 1965.
~ 10 ~L’onore è appunto il riconoscimento di aver raggiunto tale massimo nelle virtù più importanti e
costituisce il più grande dei beni esteriori in quanto è il solo che si attribuisce anche a Dio.
Pur essendo, come è stato detto, un bene esteriore, questa esteriorità non può turbare la serenità del
magnanimo, la cui virtù consiste appunto nel sapersi degno di tale onore e nella moderata gioia con
cui lo riceve, che implica disprezzo dei piccoli onori e indifferenza per gli onori mancati.1
Si prenda ora in considerazione l’atteggiamento fisico attribuito da Aristotele al magnanimo
(secondo il commento di Tommaso):
“[…] motus magnanimi videtur esse gravis, et vox videtur esse gravis, et locutio eius
esse stabilis et tarda. […]. Patet ergo quod ipsa affectio magnanimi requirit
gravitatem vocis, et tarditatem locutionis et motus”.2
Similmente, il compendio alessandrino di Taddeo Alderotto recitava: “ed è nel movimento tardo e
grave nella parola e fermo nel favellare […]” che si deve ricercare il tratto distintivo del
magnanimo, parole che riecheggiano nella ben più solenne e famosa terzina dantesca:
Genti v’eran con occhi tardi e gravi,
di grande autorità ne’ lor sembianti:
parlavan rado, con voci soavi.
(Inf. IV, 112-114)
dedicata agli spiriti magni del castello.
Farò a questo punto, un tentativo per ricostruire l’immagine di Dante, così come si presentava agli
occhi degli antichi.
Nel capitolo XX del suo Trattatello, Boccaccio descrive “Fattezze e costumi di Dante”:
“Fu adunque questo nostro poeta di mediocre statura, e, poi che alla matura età fu
pervenuto, andò alquanto curvetto, e era il suo andare grave e mansueto,
d'onestissimi panni sempre vestito in quell'abito che era alla sua maturità
convenevole. Il suo volto fu lungo, e il naso aquilino, e gli occhi anzi grossi che
piccioli, le mascelle grandi, e dal labbro di sotto era quel di sopra avanzato; e il
colore era bruno, e i capelli e la barba spessi, neri e crespi, e sempre nella faccia
malinconico e pensoso.
1
Cfr. Aristoteles, Etica … cit., IV, VII, IX, XI.
2
Cito da S. Thomae … Opera omnia, t. XXI, Parma, 1866, pp. 130-136.
~ 11 ~Ne' costumi domestici e publici mirabilemente fu ordinato e composto, e in tutti più
che alcuno altro cortese e civile.
Nel cibo e nel poto fu modestissimo, sì in prenderlo all'ore ordinate e sì in non
trapassare il segno della necessità, quel prendendo; né alcuna curiosità ebbe mai
più in uno che in uno altro: li dilicati lodava, e il più si pasceva di grossi, oltre modo
biasimando coloro, li quali gran parte del loro studio pongono e in avere le cose
elette e quelle fare con somma diligenzia apparare.
Rade volte, se non domandato, parlava, e quelle pesatamente e con voce conveniente
alla materia di che diceva; non pertanto, là dove si richiedeva, eloquentissimo fu e
facundo, e con ottima e pronta prolazione.
Dilettossi similemente d'essere solitario e rimoto dalle genti, acciò che le sue
contemplazioni non gli fossero interrotte”.1
Secondo Manetti il suo “portamento era grave, austero, dall’aria sempre seria e meditabonda”,2
simile all’opinione di Francesco da Buti secondo il quale Dante “fu di gravi e pesati costumi nella
sua vita, sì che […] parrà a ciascuno degna di fede la sua autorità”3 e di Filippo Villani che,
rifacendosi al Trattatello scrive:
“[…] incessu tam gravi, mansuetoque aspectu, tistisque illi in facie severitas inerat
… melancolico habitu obsolesceret. Fuit insuper mirabili morum praeditus
honestate, omnique actu ordinato atque compositus, vitae continentissimae, cibi
potusque parcissimus, lautae delicataeque vitae laudator […] sollertissimus et
impiger in agendis, in locutione tardissimus”; continua il Villani circa il carattere del
poeta: “Fuit insuper animi altissimi et infracti, et qui abominaretur pusillanimes;
ingenii praeacuti, atque intellectus proponendum divini […]. Fuit tamen, quod
negari non potest, avidissimus aurae popularis, cupidusque gloriae et honoris”.4
Infine, il Bruni lo definisce “animo altero”, un uomo “molto pulito, di statura decente, e di grato
aspetto e pieno di gravità: parlatore rado e tardo, ma nelle sue risposte molto sottile […]” del quale
stupisce sopra ogni altra cosa “la grandezza e la dolcezza del dire suo prudente sentenzioso e
grave”.5
Sembra quindi più che lecito affermare che da tutto ciò emerge il ritratto di un Dante più
magnanimo che superbo, su cui concordano quasi tutti i commentatori antichi.
1
Cfr. G. Boccaccio, Trattatello … cit., XX.
2
Cfr. G. Manetti, Vite di Dante … cit., p.103.
3
Cfr. Vite di Dante … cit., a cura di A. Solerti, p. 80.
4
Ibid. pp. 87-88.
5
Cfr. L. Bruni, Le vite di Dante e del Petrarca, Roma, Archivio Guido Izzi, 1987, pp. 45 e 50.
~ 12 ~È essenziale tenere in debita considerazione che essi, pur sottolineando il suo caratteristico e
spiccato desiderio di gloria (spesso anche smodato, nessuno lo nega!), non si sentirono mai in
facoltà di condannarlo.
Continua, infatti, il Boccaccio:1
“Ma che? Qual vita è tanto umile, che dalla dolcezza della gloria non sia toccata? E
per questa vaghezza credo che oltre ad ogni altro studio amasse la poesia […]”; più
avanti lo dice esplicitamente: “oh isdegno laudevole di magnanimo, quanto
virilmente operasti […] fu questo valente uomo in tutte le sue avversità fortissimo”.
Parole che riecheggiano nelle pagine del Manetti:
“fu forse più desideroso di onori e di gloria di quanto convenga … ma anche eccelsi
filosofi […] vinti dal suo incredibile fascino […]” e concorda col Boccaccio quando
afferma che “infiammato da questo naturale desiderio di gloria insito nell’animo
umano, il nostro poeta fu preso da eccezionale amore per la poesia”.2
Si interroga giustamente Boccaccio: “Ma chi sarà tra’ mortali giusto giudice a condennarlo? Non
io”.
Magnanimo l’uomo, eccellente il poeta insomma: “d’altissimo ingegno e di sottile invenzione fu, sì
come le sue opere troppo più manifestano agl’intendenti che non potrebbono fare le mie lettere”
conclude il Boccaccio; Leonardo Bruni sostiene che Dante divenne poeta “per iscenza, per studio,
per disciplina ed arte e prudenzia”, il primato del quale sta “nella rima volgare, nella quale è
eccellentissimo sopra ogni altro […] tutti Dante di gran lunga soverchiò […] è opinione di chi
intende, che non sarà mai uomo che Dante vantaggi in dire in rima”.3
Primato assoluto che viene ribadito dal Manetti: “scrisse molte ottime opere […] e non solo superò
di gran lunga tutti i suoi contemporanei, ma la grazia e lo stile dei suoi testi stimolarono i migliori
fra i posteri a imitare una così squisita eleganza”.4
Per concludere, risulta interessante l’opinione di Giambattista Vico, espressa nel suo Giudizio sopra
Dante5 (1729). I caratteri nativi dell’uomo che sarebbero destinati a rispecchiarsi nell’arte, erano
stati:
1
Cfr. G. Boccaccio, Trattatello cit., XXV.
2
Cfr. G. Manetti, Vite di Dante … cit., pp. 111-113.
3
Cfr. L. Bruni, Le vite di Dante … cit., pp. 47 e 49-50.
4
Cfr. G. Manetti, Vite di Dante … cit., pp. 105-107.
5
Nell’edizione: Milano, Ferrari, 1836, vol. VI, pp. 49 e ss.
~ 13 ~Puoi anche leggere