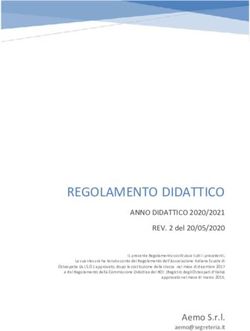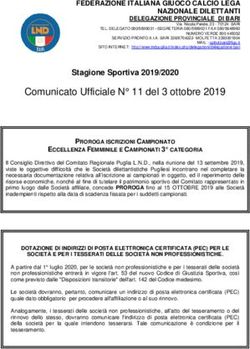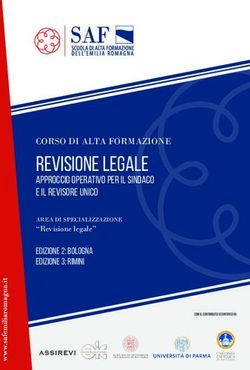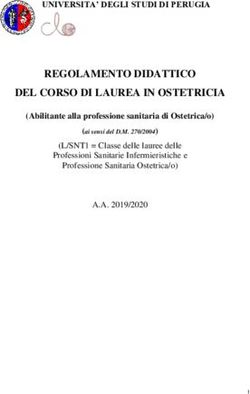LA PROFESSIONE DI GUIDA ALPINA NELL'ORDINAMENTO INTERNO E COMUNITARIO - dott.ssa Antonella Rovri
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
LA PROFESSIONE DI GUIDA ALPINA
NELL’ORDINAMENTO INTERNO E COMUNITARIO
dott.ssa Antonella Rovri
30 settembre 2011LA PROFESSIONE DI GUIDA ALPINA
NELL’ORDINAMENTO INTERNO E COMUNITARIO
1. LA FIGURA PROFESSIONALE DELLA GUIDA ALPINA: L’EVOLUZIONE DEL QUADRO
NORMATIVO
La definizione della figura giuridica della guida alpina è stata oggetto per molti anni di
continue oscillazioni e solo grazie ai più recenti interventi legislativi si è avviata verso una più
precisa collocazione nel panorama delle professioni turistiche.
All’inizio le attività di guida e portatore alpino erano ricomprese tra i c.d. “mestieri
girovaghi” e assoggettate alla disciplina dettata dall’articolo 124 del t.u. di p.s. del 1926 (r.d. 6
novembre 1926, n. 1848 e relativo regolamento di esecuzione r.d. 21 gennaio 1929, n. 62), poi
sostanzialmente trasfusa nella legislazione di p.s. successiva (artt. 123 e 125, t.u.l.p.s. 18 giugno
1931, n. 773 e artt. 234-241 del relativo regolamento di esecuzione r.d. 6 maggio 1940, n. 635)1.
Tale disposizione subordinava l’esercizio di tali mestieri all’obbligo di munirsi della licenza
del Questore2, il cui rilascio era subordinato al possesso dei normali requisiti di moralità e richiedeva
altresì l’esito favorevole di un esame3 da sostenersi avanti una commissione provinciale di nomina
prefettizia.
Il legislatore statale intendeva, con tale disciplina, sottoporre l’attività delle guide alpine ad
un costante controllo amministrativo ispirato ad una logica di tutela della pubblica sicurezza, della
fede e dell’incolumità pubblica.
Il successivo passaggio delle funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni, operato
dall’articolo 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, determinò il trasferimento al Sindaco del potere di
rilasciare le relative licenze di pubblica sicurezza, lasciando peraltro immutata la precedente
disciplina normativa4.
Solo con l’approvazione della legge 17 maggio 1983, n. 217 (legge quadro per il turismo),
che definiva analiticamente le professioni turistiche (art. 11)5 e ne disciplinava le forme di accesso
1
In questo nucleo di norme il legislatore tende a considerare le attività di cui si parla in una prospettiva in cui i profili di
pubblica sicurezza prevalgono su quelli di tutela del turista- consumatore, aspetto che tenderà a trasformarsi a fronte di una
evoluzione del fenomeno turistico e di una conseguente esigenza di tutela dell’utenza.
2
ART. 123 T.U.L.P.S.: “Per l’esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere, guida o portatore alpino e per
l’abilitazione all’insegnamento dello sci è necessario ottenere la licenza del questore”.
3
Si trattava di un esame vertente, per le guide alpine, sulla topografia della zona in cui il candidato aspirava ad esercitare la
professione, sulla tecnica alpinistica e su nozioni di pronto soccorso; per i portatori su nozioni elementari di tecnica
alpinistica e di pronto soccorso.
4
L’attività della guida alpina continuava ad essere sottoposta ad un costante controllo amministrativo giustificato da motivi
di pubblica sicurezza, di tutela della fede pubblica e dell’incolumità pubblica; aspetto questo che impediva di smarcarla
dalla qualificazione di“mestiere” per traghettarla in quella di “professione”. In tal senso, Luca Righi, Professioni turistiche,
in Dig. Disc. Pubb., 200, 574.
5
“Le regioni accertano i requisiti per l'esercizio delle professioni di guida turistica, interprete turistico, accompagnatore
turistico o corriere, organizzatore professionale di congressi, istruttore nautico, maestro di sci, guida alpina, aspirante guida
alpina o portatore alpino, guida speleologica, animatore turistico ed ogni altra professione attinente al turismo. (…)
È guida alpina chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone in scalate o gite in alta montagna.
E’ aspirante guida alpina o portatore alpino chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone in
ascensioni di difficoltà non superiore al terzo grado; in ascensioni superiori può fungere da capo cordata sole se assieme a
guida alpina. (..)
-1-mediante affidamento delle competenze amministrative alle regioni, si sancì il passaggio definitivo
dell’attività di guida alpina dalla categoria dei “mestieri” a quella delle libere professioni. Si trattò di
un passaggio legislativo che realizzò una vera e propria “emancipazione” delle guide alpine in quanto
consentì di abbandonare progressivamente la tradizionale prospettiva legata prevalentemente alla
tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, a favore della cura preminente di interessi turistici e di
polizia amministrativa6.
In questa fase, l’esigenza di specificità richiesta dalla materia favorì l’assunzione di un ruolo
centrale delle Regioni e Province autonome nel normare aspetti che, sebbene formalmente “di
dettaglio”, si rivelarono sostanzialmente assi portanti della disciplina di settore. E, infatti, la
legislazione regionale e provinciale elaborata, a partire dal 1983, entro gli ampi parametri normativi
indicati dalla disciplina statale di principio, finì per definire esattamente il profilo professionale della
guida alpina, individuare i requisiti idonei a garantire un adeguato livello delle prestazioni,
predisporre strumenti validi per l’accertamento delle capacità tecnico-professionali e, infine, tracciare
i confini territoriali di esercizio della professione.
Dalla genericità della legge quadro n. 217/83 ne derivò chiaramente una notevole disparità di
trattamento nel territorio delle diverse Regioni e Province autonome, soprattutto sotto il profilo del
livello tecnico-culturale richiesto ai candidati per il superamento degli esami; tale situazione rese
necessaria l’emanazione di una apposita legge quadro che non si occupasse dell’intera materia del
turismo ma regolasse in maniera uniforme la sola attività professionale della guida alpina.
A pochi anni di distanza dalla prima normativa statale di principio in materia di professioni
turistiche e sulla spinta delle pressioni esercitate dalla categoria, si è dunque approdati alla legge
quadro 2 gennaio 1989, n. 6 (Ordinamento della professione di guida alpina)7, legge con la quale si è
dettata una coerente regolamentazione della materia stabilendo i principi fondamentali nel rispetto
dei quali esercitare la potestà legislativa regionale (o provinciale). Secondo la legge statale del 1989,
ancora oggi in vigore8, quella di guida alpina è una “professione” per lo svolgimento della quale ci si
In particolare, le regioni dovranno accertare (…) per i maestri di sci, guide alpine e speleologiche, istruttori di alpinismo e
di sci alpino, adeguate capacità professionali in sede tecnico-operativa accertate alla stregua dei criteri didattici elaborati per
i vari gradi di professionalità dai competenti enti ed associazioni nazionali.”
6
Ed è in questa logica, appunto, che si collocò l’accertamento da parte delle competenti autorità regionali del possesso dei
diversi requisiti previsti, fra cui di prioritaria importanza quelli di competenza e professionalità, nonché l’assoggettamento a
provvedimento autorizzatorio dell’esercizio della professione, in considerazione della sua rilevanza sia sotto il profilo
sociale che sotto quello economico.
7
L’approvazione di una disciplina di principio di cui alla legge n. 6 del 1989 ha fatto acquisire alla guida alpina il carattere
di professione di rilievo nazionale; tale aspetto, secondo la Corte costituzionale, ha costituito motivo essenziale per
giustificare l’intervento del legislatore statale in materia (cfr. sentenza del 1991 sul ricorso proposto da alcune Regioni e
Province autonome contro la citata legge).
8
A seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, che ha collocato la materia del “turismo” fra gli oggetti di
competenza residuale delle Regioni di cui all’articolo 117, comma 4, Cost., dubbi si sono posti circa il valore da attribuirsi
alla legge quadro n. 6/89. Quella di guida alpina è infatti una attività tradizionalmente legata al turismo e non a caso
ricondotta espressamente nella categoria delle “professioni turistiche” dall’articolo 9 della legge n. 217/83.
Invero, con riferimento alla professione di guida alpina – ed analoga riflessione va fatta con riguardo ai maestri di sci -
difficilmente può affermarsi che oggi alle Regioni sia riconosciuta la possibilità di legiferare liberamente al di fuori dei
principi generali di livello nazionale. La collocazione delle “professioni”, senza ulteriori qualificazioni, fra le materie di cui
lo Stato mantiene la riserva a stabilire i principi fondamentali, secondo l’art. 117, comma 3, Cost., giustifica infatti la
permanenza dell’intervento statale anche per quanto concerne l’attività di guida alpina, dato il suo carattere di vera e propria
professione consolidatosi nel tempo. Anche per le tesi più rigidamente ancorate a dati formali, quella di guida alina è infatti
una attività che deve essere ricompresa nel novero delle professioni cd. regolamentate o protette ai sensi dell’art. 2229 c.c.,
essendo soggetta ad una precisa normativa di tipo organizzativo, diretta a configurare l’attività come propria di gruppi
-2-deve munire di apposita abilitazione conseguita previo esame da sostenersi di fronte ad apposite
commissioni di esperti ed al termine di un corso teorico-pratico organizzato su base regionale o
provinciale (art. 7 L. 6/89)9. Il titolo abilitativo costituisce il presupposto per la necessaria iscrizione
in appositi albi professionali tenuti dai collegi delle Regioni o Province autonome nel cui territorio si
intende esercitare (artt. 4 e 5 L. 6/89), collegi a cui spetta ora, in via principale, l’attività di disciplina
e autoregolamentazione dell’intera categoria professionale, sotto il coordinamento generale del
Collegio nazionale (artt. 13-15 L. 6/89).
In sintonia con la legge quadro n. 6/89 la Provincia autonoma di Trento ha elaborato una
propria autonoma disciplina, stabilendo i criteri delle prove d’esame e fissando i programmi dei corsi.
In particolare, con l’approvazione della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 (Nuovo ordinamento
della professione di guida alpina e di maestro di sci nella provincia di Trento) sono stati introdotti
alcuni importanti aspetti innovativi che si possono riassumere come segue:
- istituzione dell’albo provinciale delle guide alpine;
- istituzione del collegio provinciale delle guide alpine;
- affidamento alla Giunta provinciale delle funzioni di vigilanza sull’attività e sul regolare
funzionamento del collegio;
- introduzione di un nuovo regime giuridico relativo ai requisiti di accesso e di svolgimento della
professione di guida alpina nonché ai presupposti per l’apertura di scuole di alpinismo;
- previsione, per l’esercizio abusivo della professione di guida alpina, di una sanzione penale oltre
che amministrativa ai sensi dell’articolo 348 del codice penale (art. 18 l. 6/89).
La richiamata normativa provinciale è stata recentemente oggetto di una importante revisione
ad opera della legge provinciale 11 marzo 2005, n. 3, legge che ha operato una vera e propria
delegificazione della legge provinciale n. 20/93, oltre che istituire la nuova figura professionale
dell’accompagnatore di territorio; le poche ed essenziali norme di legge rimaste ancora in vigore
risultano oggi integrate dalle regole dettate dal decreto del Presidente della Provincia 27 febbraio
2007, n. 3-83/Leg. recante “Regolamento di esecuzione della legge provinciale 23 agosto 1993, n.
20”. Dei tratti salienti di tale riforma si darà conto nel proseguo del presente scritto.
2. OGGETTO DELLA PROFESSIONE
La guida alpina viene definita come quel soggetto che “svolge professionalmente, anche in
modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:
a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in
montagna anche di interesse naturalistico nonché delle attività di torrentismo e di canyoning;
b) accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche;
professionali necessari, ordinati in “albi” o “elenchi”. Il fatto che la professione di cui si tratta sia “turistica” non è dunque
sufficiente per farne fuoriuscire la disciplina dall’ambito della tipologia “concorrente” di competenza.
9
La difficoltà del percorso di formazione nasce dall’esigenza di assicurare alle guide alpine standard minimi di bagaglio
tecnico-culturale e condizioni basilari per l’accesso ad una attività in cui è rilevante sia l’aspetto didattico e ricreativo legato
alla frequentazione di ambienti alpinistici ed al corretto insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche, sia
quello di tutela della sicurezza e incolumità personale di quanti intendano ricorrere alle prestazioni della guida alpina.
-3-c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche con esclusione delle tecniche
sciistiche su piste di discesa e di fondo nonché insegnamento delle tecniche di arrampicata, di
torrentismo e di canyoning.”
Il primo elemento che caratterizza la figura della guida alpina è dunque la sua qualificazione
come “professionista”, termine che non vuole designare la stabilità, la continuità o la non amatorialità
dell’attività esercitata, bensì uno status personale che riconosce e riserva al soggetto il diritto di
svolgere l’attività connessa a quello status.
Tale status sorge a seguito dell’accertamento delle capacità tecniche del soggetto e della
conseguente iscrizione all’albo professionale, inquadrando giuridicamente l’attività dello stesso nella
categoria delle cd. “professioni intellettuali”; tali professioni sono disciplinate all’articolo 2229 del
codice civile che attribuisce al legislatore il compito di determinare “le professioni intellettuali per
l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi”.
Con riferimento alla figura della guida alpina, la sua qualificazione quale “professionista
intellettuale” si ricava dalla legge quadro 2 gennaio 1989, n. 6 e dalla legge provinciale 23 agosto
1993, n. 20, che condizionano lo svolgimento dell’attività alpinistica come sopra precisata al
possesso di un titolo abilitativo nonché all’iscrizione nell’apposito albo professionale tenuto dal
collegio delle guide alpine.
Non esiste dunque un modo professionale ed un modo amatoriale di svolgere l’attività
alpinistica in quanto l’obbligo di iscrizione all’albo professionale la qualifica, ai sensi dell’articolo
2229 c.c. e delle leggi di settore, quale professione intellettuale a prescindere da ogni considerazione
in ordine alle modalità di esercizio.
L’attività professionale svolta dalla guida alpina è comunque compatibile con altra attività
e può avere anche carattere non continuativo; ha per oggetto sia “l’accompagnamento in
ascensioni o in escursioni in ambiente montano nonché nelle attività di torrentismo e di
canyoning” sia “l’insegnamento delle tecniche alpinistiche, sci-alpinistiche, di arrampicata, di
torrentismo e di canyoning”. Da notare che lo svolgimento di tali attività, su qualsiasi terreno e
senza limiti di difficoltà, e comunque laddove possa essere necessario l’uso di tecniche e di
attrezzature alpinistiche, è sempre riservato alle guide alpine; alle stesse non è invece consentito
insegnare le tecniche sciistiche né accompagnare i propri clienti in escursioni sciistiche all’interno
delle stazioni sciistiche attrezzate o su piste da discesa o da fondo, trattandosi di competenze rimesse
in via esclusiva ai maestri di sci.
Alla guida alpina è poi consentito accompagnare persone nelle visite a parchi naturali o a
zone di tutela ambientale nonché ad altre zone di particolare pregio naturalistico, e fornire notizie ed
informazioni di interesse naturalistico, paesaggistico ed ambientale (attività che dovranno
“condividere” con la nuova figura professionale di accompagnatore di territorio).
-4-3. GRADI DELLA PROFESSIONE
La professione di guida alpina è articolata in due gradi che esprimono un differente livello di
preparazione tecnica, didattica e culturale; tali gradi sono propedeutici l’uno rispetto all’altro nel
senso che il raggiungimento del primo grado della professione è condizione per il conseguimento del
secondo grado10.
In tal senso l’articolo 3 della legge provinciale n. 20 del 1993 distingue tra:
a) aspirante guida;
b) guida alpina - maestro di alpinismo.
L’aspirante guida, in ragione della minore maturità professionale, è tenuto a svolgere la
propria attività nel rispetto di taluni limiti imposti dalla legge. In particolare, l’attività di
insegnamento gli è consentita solo alle dipendenze di una scuola di alpinismo e di sci-alpinismo
mentre le attività di accompagnamento sono in genere permesse con la sola esclusione delle
ascensioni di maggior impegno, ascensioni nelle quali l’aspirante guida può accompagnare la
comitiva solo se la stessa è condotta da una guida alpina – maestro di alpinismo.
4. L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GUIDA ALPINA IN PROVINCIA DI TRENTO
La professione di guida alpina può essere esercitata sul territorio provinciale sia stabilmente
che temporaneamente.
Si considera esercizio stabile della professione l’attività svolta dalla guida alpina che abbia
un recapito, anche stagionale, nel territorio della provincia di Trento, ovvero che in essa offra le
proprie prestazioni (art. 4, comma 4, l.p. 20/93).
L’esercizio stabile della professione in provincia di Trento è condizionato al possesso di
un’abilitazione e alla successiva iscrizione all’albo professionale tenuto dal collegio provinciale delle
guide alpine; tale iscrizione abilita all’esercizio della professione non solo nell’ambito della provincia
di Trento ma anche in tutto il territorio nazionale.
E’ ammessa l’iscrizione in più di un albo nel caso in cui la guida alpina o l’aspirante guida
intenda esercitare stabilmente la professione nel territorio di più regioni.
Le guide alpine iscritte in albi professionali di altre regioni o della provincia di Bolzano
possono esercitare stabilmente la professione in provincia di Trento chiedendo il trasferimento
dell’iscrizione all’albo provinciale ovvero un’ulteriore iscrizione oltre a quella già effettuata nell’albo
professionale di provenienza; il trasferimento o l’iscrizione sono disposte dal collegio provinciale
delle guide alpine a condizione che l’interessato risulti, al momento della presentazione della
domanda, residente o domiciliato in un comune della provincia di Trento.
10
Prima dell’entrata in vigore della legge provinciale 11 marzo 2005, n. 3, l’ammissione ai corsi per il conseguimento
dell’abilitazione all’esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo era condizionata anche al possesso da
almeno tre anni della qualifica di aspirante guida.
-5-Si considera esercizio temporaneo della professione l’attività svolta dalla guida alpina che,
iscritta in albo di altra regione o della provincia autonoma di Bolzano, presti la propria attività nel
territorio provinciale in accompagnamento di propri clienti.
Nei casi in cui la guida alpina – maestro di alpinismo iscritta in albi di altre regioni o della
provincia autonoma di Bolzano, intenda svolgere per periodi determinati della durata massima di sei
mesi l’attività di insegnamento in scuole di alpinismo e di sci-alpinismo aventi sede nella provincia
di Trento, può chiedere l’aggregazione temporanea all’albo provinciale, conservando l’iscrizione
all’albo della regione o provincia di appartenenza.
La guida alpina – maestro di alpinismo iscritta all’albo provinciale, che svolga
temporaneamente l’attività di insegnamento in scuole di alpinismo in altre regioni o nella provincia
autonoma di Bolzano, conserva l’iscrizione nell’albo della provincia di Trento.
5. ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
L’iter formativo per l’ottenimento dell’abilitazione quale guida alpina risulta particolarmente
severo ed articolato al fine di assicurare ai candidati standard minimi di bagaglio tecnico-culturale e
condizioni basilari per l’accesso ad una attività in cui è rilevante sia l’aspetto di tutela della sicurezza
e incolumità personale di quanti intendano ricorrere alle prestazioni della guida alpina, sia quello
didattico e ricreativo legato all’accompagnamento ed al corretto insegnamento delle tecniche
alpinistiche e sci-alpinistiche.
In particolare, l’abilitazione all’esercizio della professione come aspirante guida si consegue
mediante la frequenza degli appositi corsi tecnico-pratici, didattici e culturali ed il superamento dei
relativi esami; per l’accesso all’attività di guida alpina – maestro di alpinismo sono invece previsti
corsi ed esami a contenuto meramente tecnico-pratico.
L’ammissione ai corsi per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di
aspirante guida è subordinata al superamento di una prova attitudinale che va ripetuta se entro 5 anni
il candidato non supera tutti gli esami per l’ottenimento dell’abilitazione11. Durante la prova
attitudinale la sottocommissione tecnica è tenuta a verificare che il candidato abbia già svolto una
attività alpinistica non inferiore a quella stabilita dalla Giunta provinciale con apposita deliberazione;
a tal fine la sottocommissione tecnica si avvale delle indicazioni fornite dallo stesso candidato nel
curriculum alpinistico allegato alla domanda di partecipazione12.
11
Il termine dei cinque anni può essere sospeso per un periodo non superiore a tre anni nel caso in cui il candidato attesti
con apposita documentazione medica l’impossibilità a partecipare ai corsi o agli esami per sopravvenuta inidoneità
psicofisica di durata non inferiore ad un anno.
12
L’articolo 2 del nuovo regolamento di esecuzione della legge provinciale n. 20 del 1993 ridisegna il contenuto della
prova attitudinale che risulta così articolata:
a) un esame scritto con domande a risposta sintetica o multipla vertente in materia di turismo, con particolare riferimento
alla legislazione turistica provinciale, geografia ed ambiente della provincia di Trento, storia locale e storia
dell’alpinismo, flora e fauna presenti nel territorio provinciale, meteorologia e topografia, primo soccorso;
b) un colloquio diretto a verificare l’attività alpinistica già svolta dal candidato;
c) un esame pratico per l’accertamento della capacità tecnica e dell’attitudine del candidato a svolgere l’attività specifica
della professione di guida alpina.
-6-Al termine di ciascuna tipologia di corsi i candidati sono ammessi ai relativi esami che
consistono in prove tecnico-pratica, didattica e culturale da sostenersi davanti alle due
sottocommissioni che compongono la commissione esaminatrice13.
In particolare, per le prove culturali è competente la sottocommissione culturale composta
dal presidente della commissione esaminatrice, il presidente del collegio provinciale delle guide
alpine e da cinque esperti nelle materie culturali connesse alla professione di guida alpina. Le prove
tecnico-pratica e didattica sono invece espletate dalla sottocommissione tecnica composta dal
presidente del collegio provinciale delle guide alpine e da quattro istruttori per guide alpine.
Una volta ottenuta l’abilitazione quale aspirante guida, lo stesso deve conseguire il grado di
guida alpina – maestro di alpinismo entro il decimo anno successivo. Il mancato conseguimento
comporta la decadenza dell’iscrizione all’albo professionale.
Nel corso dell’iter formativo il candidato, che abbia già frequentato corsi aventi contenuto
analogo a quelli previsti per il conseguimento del titolo abilitativo di aspirante guida o di guida
alpina-maestro di alpinismo, può chiedere alla commissione esaminatrice il riconoscimento di uno o
più crediti formativi; l’accoglimento di tale istanza consente al richiedente di essere esonerato dalla
frequenza dei corrispondenti corsi ottenendo una sorta di “sconto” nel percorso di formazione.
6. ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE PROVINCIALE DELLE GUIDE ALPINE
L’iscrizione all’albo provinciale degli aspiranti guida o delle guide alpine – maestri di
alpinismo è condizione essenziale per l’esercizio stabile della professione in provincia di Trento.
Per l’iscrizione all’albo provinciale occorre il possesso dei seguenti requisiti:
a) abilitazione all’esercizio della professione di aspirante guida o di guida alpina-maestro di
alpinismo;
b) cittadinanza italiana o di altro stato straniero;
c) residenza o domicilio in un comune della provincia di Trento,
d) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
e) idoneità psico-fisica allo svolgimento della professione;
f) assenza di condanne penali che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della
professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione14;
g) età minima di 21 anni per le guide alpine – maestri di alpinismo.
L’iscrizione all’albo delle guide alpine – maestri di alpinismo comporta la decadenza
dell’iscrizione all’albo degli aspiranti guida.
13
La commissione esaminatrice per le guide alpine è chiamata ad esprimere alla Giunta provinciale il proprio
parere in ordine alle modalità di ammissione, di organizzazione e di valutazione della prova attitudinale, dei
corsi e degli esami per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di guida, nonché dei
relativi corsi di aggiornamento. I membri della commissione esaminatrice durano in carica tre anni e sono gli
stessi che compongono le due sottocommissioni tecnica e culturale.
14
La riabilitazione è un provvedimento che estingue le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna;
tale beneficio è concesso al condannato che abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta ed abbia
eseguito le obbligazioni civili nascenti dal reato (es.: risarcimento del danno).
-7-L’albo professionale è tenuto dal collegio provinciale delle guide alpine che rilascia, all’atto
dell’iscrizione, una tessera; tale documento costituisce titolo di riconoscimento professionale e,
pertanto, ogni guida alpina deve recarla con sé durante lo svolgimento della propria attività e
mostrarla, ove richiesto, ai soggetti abilitati a svolgere funzioni di vigilanza.
L’iscrizione all’albo è valida per quattro anni ed è rinnovata a seguito della frequenza nel
quadriennio antecedente di un corso di aggiornamento professionale e comunque solo ove
permangano i requisiti di iscrizione.
Sono esonerate dai corsi di aggiornamento le guide alpine – maestri di alpinismo che nel
quadriennio di validità della rispettiva iscrizione all’albo professionale abbiano rivestito per almeno
un anno la qualifica di istruttore di guida alpina – maestro di alpinismo. Allo stesso modo, la
frequenza, da parte dell’aspirante guida, dell’intero corso per il conseguimento dell’abilitazione
all’esercizio della professione di guida alpina – maestro di alpinismo equivale alla frequenza di un
corso di aggiornamento.
Il collegio provinciale delle guide alpine dispone la cancellazione dall’albo in caso di perdita
sopravvenuta dei requisiti previsti per l’iscrizione (come l’idoneità psico-fisica o una condanna
penale che comporta l’interdizione dall’esercizio della professione) ovvero in caso di trasferimento
dell’iscritto nell’albo di altra regione o della provincia autonoma di Bolzano. La cancellazione
dall’albo può essere altresì la conseguenza dell’applicazione da parte dello stesso collegio di una
sanzione disciplinare a seguito dell’accertamento di un comportamento deontologicamente scorretto
da parte di un iscritto.
7. COLLEGIO PROVINCIALE DELLE GUIDE ALPINE
Il collegio provinciale delle guide alpine, organo di autodisciplina e di autogoverno della
professione, è costituito dalle guide alpine-maestri di alpinismo e dagli aspiranti guida, iscritti nei
rispettivi albi provinciali, nonché dalle guide alpine – maestri di alpinismo e dagli aspiranti guida che
abbiano cessato l’attività per anzianità o invalidità e siano residenti nel territorio provinciale.
Sono organi del collegio:
a) l’assemblea;
b) il consiglio direttivo;
c) il presidente.
a) L’ASSEMBLEA
E’ composta da tutti i membri del collegio ed i suoi compiti sono:
- eleggere il consiglio direttivo e il presidente del collegio delle guide alpine;
- approvare annualmente il bilancio consuntivo del collegio predisposto dal consiglio direttivo;
- pronunciarsi su ogni questione che le venga sottoposta dal consiglio direttivo o sulla quale una
pronuncia dell’assemblea venga richiesta da almeno un terzo dei componenti.
-8-L’assemblea si riunisce di diritto una volta l’anno in occasione dell’approvazione del bilancio
e tutte le volte che lo decida il consiglio direttivo ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un terzo
dei componenti l’assemblea stessa.
b) IL CONSIGLIO DIRETTIVO
E’ composto da 11 rappresentanti eletti da tutti i membri del collegio, fra gli appartenenti allo
stesso e scelti in numero non inferiore a 9 fra le guide alpine – maestri di alpinismo. Il consiglio
direttivo dura in carica tre anni e le sue funzioni sono:
- svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta degli albi professionali, nonché l’iscrizione nei
medesimi ed il rinnovo della stessa;
- vigilare sull’osservanza delle regole della deontologia professionale, nonché applicare le sanzioni
disciplinari;
- mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative di altre categorie
professionali, nonché di guide alpine di altri Paesi;
- dare parere, ove richiesto, alla Provincia e alle autorità amministrative su tutte le questioni che
coinvolgono l’ordinamento e la disciplina della professione, nonché l’attività delle guide alpine;
- collaborare con le competenti autorità provinciali e statali, anche sulla base di apposite
convenzioni, ai fini del tracciamento e del mantenimento di sentieri e itinerari alpini, della
costruzione e del mantenimento di rifugi e bivacchi, delle opere di disgaggio e in genere di tutto
quanto riguarda la tutela dell’ambiente naturale montano e la promozione dell’alpinismo e del
turismo montano;
- collaborare con le competenti autorità provinciali, anche sulla base di apposite convenzioni, ai
fini della definizione dei programmi dei corsi di formazione e dei criteri per le prove d’esame,
nonché dello svolgimento dei corsi stessi;
- contribuire alla diffusione della conoscenza e del rispetto dell’ambiente montano e della pratica
dell’alpinismo;
- stabilire la misura del contributo annuale a carico degli iscritti;
- svolgere ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge.
Il consiglio direttivo si riunisce ogni volta che lo decide il presidente ovvero ne faccia
richiesta motivata almeno un quinto dei componenti.
c) IL PRESIDENTE
E’ eletto dall’assemblea tra i propri membri appartenenti alla categoria delle guide alpine –
maestri di alpinismo. Esso esercita funzioni di rappresentanza del collegio verso l’esterno; svolge
inoltre compiti di coordinamento e provvede alla convocazione dell’assemblea e del consiglio
direttivo.
-9-8. SCUOLE DI ALPINISMO E DI SCI-ALPINISMO
Il regime normativo applicato a chi intende aprire in provincia di Trento una scuola di
alpinismo e di sci-alpinismo per il coordinamento tecnico-funzionale dell’attività di insegnamento
delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche è di tipo autorizzatorio.
In particolare, il servizio provinciale competente in materia di turismo autorizza l’apertura di
tali scuole ove siano organizzate da almeno tre guide alpine e posseggano i seguenti requisiti:
- la direzione è affidata ad una guida alpina – maestro di alpinismo iscritta all’albo della provincia
di Trento;
- l’attività di insegnamento deve essere svolta esclusivamente da guide alpine – maestri di
alpinismo o da aspiranti guide iscritti all’albo della provincia di Trento e il numero degli aspiranti
non deve superare quello delle guide alpine – maestri di alpinismo;
- l’approvazione di un atto costitutivo, di uno statuto e di un regolamento della scuola;
- un’adeguata copertura assicurativa contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguenti
all’esercizio della professione;
- l’impegno della scuola a prestare la propria opera nelle operazioni straordinarie di soccorso ed a
collaborare con gli enti ed operatori turistici nelle azioni promozionali, pubblicitarie ed operative
intese ad incrementare l’afflusso turistico nel territorio provinciale.
L’autorizzazione è revocata, previo contraddittorio con la scuola, qualora vengano a mancare
la copertura assicurativa o il numero minimo di tre guide alpine richiesto per l’apertura.
9. SANZIONI E VIGILANZA
Le funzioni di vigilanza sull’osservanza delle disposizioni contenute nella legge provinciale
20/93 sono esercitate dalla Provincia per mezzo dei dipendenti del Servizio competente in materia di
turismo. A tal fine, il Servizio provinciale può disporre ispezioni e accertamenti anche nelle scuole di
alpinismo e di sci-alpinismo e richiedere in visione, se necessario, atti e documenti delle scuole
stesse.
Le sanzioni amministrative previste dalla legge provinciale 20/93 si applicano nei seguenti
casi:
- esercizio abusivo della professione, indipendentemente dalla sanzione penale (sanzione
amministrativa da euro 600 a euro 1.800); alla medesima sanzione è soggetta l’agenzia di viaggio
o la scuola di alpinismo e di sci-alpinismo qualora si avvalga di soggetti privi delle abilitazioni di
aspirante guida e di guida alpina-maestro di alpinismo;
- violazione dell’obbligo di iscrizione all’albo provinciale (sanzione amministrativa da euro 200 a
euro 600);
- apertura di “scuole di alpinismo e di sci-alpinismo” sprovviste dell’autorizzazione (sanzione
amministrativa da euro 400 a euro 1.200 a carico di ciascuna persona che pratichi l’attività di
insegnamento nell’ambito dell’organizzazione abusiva);
- 10 -- violazione di ogni altra norma relativa alla professione di guida alpina contenuta nella legge
provinciale n. 20 del 1993 e nel suo regolamento di esecuzione (sanzione amministrativa da euro
200 a euro 600).
Le sanzioni amministrative sono raddoppiate qualora la stessa violazione sia commessa per
due volte nel corso di cinque anni (cd. recidiva specifica).
Nell’esercizio della propria professione la guida alpina è altresì soggetta a:
- sanzioni penali derivanti da possibili incidenti occorsi ai propri clienti durante lo svolgimento
dell’attività;
- sanzioni disciplinari applicate dal collegio provinciale delle guide alpine a seguito della
violazione delle norme di deontologia professionale (ammonizione scritta, censura, sospensione
dell’albo, radiazione).
10. LA LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE DELLE GUIDE ALPINE NELL’UNIONE EUROPEA
Un aspetto assai importante della professione di guida alpina è costituito dall’applicazione
delle norme comunitarie che garantiscono la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi
in ambito comunitario degli esercenti le diverse professioni.
Le richiamate libertà sono state riconosciute dal Trattato CE (Trattato del 25.03.1957) e
disciplinate in via generale dagli artt. 42-48 per il diritto di stabilimento e dagli artt. 49-56 per la
libera prestazione dei servizi all’interno dell’Unione Europea15. Le norme del Trattato Ce affermano
con decisione il divieto di imporre ogni forma di restrizione sia alla libertà di stabilimento dei
cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro (art. 43), sia alla libera
prestazione dei servizi da parte di cittadini stabiliti in un paese della Comunità che non sia quello del
destinatario della prestazione (art. 49)16.
Occorre subito chiarire che si tratta di due nozioni diverse: la libertà di stabilimento,
nozione assai ampia, comporta la possibilità, per un cittadino comunitario, di partecipare in maniera
stabile e continuativa alla vita economica di uno Stato membro diverso dal proprio Stato di origine e
di trarne vantaggio.
La libera prestazione di servizi, invece, persegue un obiettivo per così dire più limitato,
essendo assicurato al singolo l’esercizio di un’attività economica in uno Stato membro diverso da
quello in cui il prestatore è stabilito ed “integrato”: la prestazione è, per definizione, attività
15
La numerazione degli articoli è quella del Trattato CE nella versione consolidata, integrata con le modifiche apportate dal
trattato di Nizza del 26.02.2001, pubblicata nella G.U.C.E. del 24.12.2002 n. C 325, in vigore dal 01.02.2003; nella
versione approvata il 25 marzo 1957 la disciplina che si richiama era contenuta agli artt. 52-58 per la libertà di stabilimento
e agli artt. 59-66 per la libera prestazione dei servizi.
16
Le norme citate impongono quindi la soppressione di tutte le discriminazioni che colpiscono il prestatore di un servizio
“in ragione della sua cittadinanza o del fatto che egli è stabilito in uno Stato membro diverso da quello in cui la
prestazione deve essere fornita” (v. Cause riunite 62/81 e 63/81, sent. del 03.02.1982, Seco c. EVI; v. in senso conforme;
Causa 33/74, sent. del 03.12.1974, Johannes Henricus Maria Van Binsbergen c. Bedrijfsvereniging Metaalnijverheid; Cause
110/78 e 111/78, sent. del 18.01.1979, Pubblico Ministero a A.S.B.L. c. Willy Van Wesemal ed altri; Causa 220/83, sent.
del 02.12.1986, Commissione delle Comunità europee c. repubblica francese; Causa 353/89, sent. del 25.07.1991,
Commissione delle Comunità europee c. Regno dei Paesi Bassi, Causa 154/89, sent. del 26.02.1989, Commissione delle
Comunità europee c. Francia).
- 11 -temporanea, limitata nel tempo, occasionale, senza integrazione, dunque, della persona nel contesto
economico e sociale dello Stato membro.
Stabilimento e prestazione possono essere subordinati, da parte dello Stato membro
ospitante, al rispetto di determinate disposizioni legislative e regolamentari che operano una sorta di
riserva all’esercizio di attività specifiche a favore di soggetti titolari di un diploma, di un certificato o
di altro titolo ovvero di soggetti iscritti ad un ordine professionale; è il caso appunto dell’attività di
guida alpina.
Per quanto riguarda, in particolare, la disciplina della libertà di stabilimento delle guide
alpine straniere in Italia, è necessario richiamare il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
decreto con il quale si è dato ingresso in Italia alla nuova Direttiva 2005/36/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 7 settembre 200517. Il nuovo decreto ha di fatto recepito quasi
integralmente il contenuto del precedente decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 di attuazione
della Direttiva 92/51 CEE del 18 giugno 1992: quanto alle procedure di riconoscimento
dell’equivalenza del titolo professionale straniero di guida alpina non si registrano dunque particolari
novità rispetto a quanto applicato a partire dal 1994.
La richiamata normativa comunitaria impone alla guida alpina, intenzionata ad esercitare la
professione in Italia, di chiedere il riconoscimento del titolo mediante l’invio di una domanda
all’autorità competente.
Si noti da subito che, nel recepire la nuova direttiva comunitaria, il legislatore nazionale ha
introdotto interessanti novità circa l’individuazione del livello di governo competente al
riconoscimento dell’equivalenza dei titoli professionali di guida alpina. In particolare, mentre
l’abrogato d.lgs. 319/94 risolveva per una competenza ministeriale esclusiva18, il d.lgs. 206/2007
sancisce all’articolo 5, comma 1, che competenti a ricevere le domande di riconoscimento e ad
assumere le relative decisioni sono “le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano per le professioni per le quali sussiste competenza esclusiva, ai sensi dei rispettivi
statuti”19, mentre negli altri casi residua una competenza statale20.
Coerentemente a tale disposizione la Provincia di Trento ha sancito all’articolo 4, comma 4
quater, della legge provinciale n. 20 del 1993, che “il riconoscimento professionale è effettuato dalla
17
La Direttiva 2005/36/CE rappresenta oggi l’unico riferimento normativo a livello comunitario in tema di riconoscimento
delle qualifiche professionali. Prima di tale intervento normativo, la materia risultava regolata da un corpo di norme
comunitarie molto articolato approvato nel corso degli ultimi quarant’anni al fine di istituire e disciplinare i regimi di
riconoscimento delle varie qualifiche professionali. Ne era emerso un quadro legislativo molto diversificato, di difficile
applicazione, burocraticamente appesantito. La nuova direttiva ha operato una vera e propria revisione del regime di
riconoscimento delle qualifiche professionali, consolidando il contenuto di quindici diverse direttive in un quadro giuridico
unico e coerente.
18
In particolare, per la guida alpina, così come per il maestro di sci, la competenza era ricondotta al Ministero per i Beni e
le Attività Culturali - UfficioRapporti con gli Organismi Sportivi -.
19
Il riconoscimento della competenza all’applicazione diretta della direttiva comunitaria è stato fortemente voluto dalla
Valle d’Aosta che, in sede di parere della Conferenza Stato- Regioni, ha chiesto, e poi ottenuto, l’inserimento della lettera
m) e dunque la possibilità di procedere ad una propria ed autonoma istruttoria e decisione circa le istanze di riconoscimento.
20
A norma dell’articolo 5, comma 1, del d.lgs. 206/2007, le autorità statali abilitate al riconoscimento dei titoli
professionali sono, in generale, i ministeri competenti per materia. Interessante è evidenziare che per la figura della guida
alpina potrebbe ritenersi competente sia la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la
competitività del turismo, trattandosi di attività che riguarda il settore turistico (lettera b), sia il Ministero titolare della
vigilanza per le professioni che necessitano, per il loro esercizio, dell’iscrizione in Ordini, Collegi, albi, registri o elenchi
(lettera c). Si ripropone dunque anche in questo caso la questione della riconduzione di tale attività alla materia del
“turismo” ovvero a quella delle “professioni regolamentate”.
- 12 -struttura provinciale competente in materia di turismo sulla base della valutazione delle qualifiche
professionali acquisite all'estero, espressa nell'ambito di una conferenza di servizi appositamente
indetta ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi
per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale
e norme in materia di procedimento amministrativo)”.
Quale che sia l’autorità competente, il d.lgs. 206/2007 impone alla stessa, una volta ricevuta
l’istanza di riconoscimento, di avviare la fase istruttoria accertando la completezza della
documentazione trasmessa, richiedendo eventuali integrazioni e procedendo all’indizione di una
conferenza di servizi per l’esame dei titoli prodotti (art. 16)21. La conferenza così indetta procede ad
accertare il livello di qualifica professionale del richiedente che deve essere almeno equivalente al
livello immediatamente inferiore a quello richiesto in Italia; se invece il richiedente proviene da uno
Stato membro nel quale l’accesso alla professione di guida alpina non è regolamentato, e cioè non
dipende dal possesso di qualifiche professionali determinate, alla conferenza compete verificare che
questi, oltre a possedere un titolo di formazione, abbia maturato due anni di esperienza professionale
a tempo pieno nel corso dei dieci anni precedenti (art. 21).
Ove la conferenza di servizi ravvisi differenze sostanziali tra la formazione acquisita dal
richiedente e quella impartita sul territorio italiano, segnala all’autorità competente la necessità di
applicare delle misure di compensazione.
L’articolo 22 del d.lgs. 206/2007 precisa che tali misure possono consistere sia in un tirocinio
di adattamento per un determinato periodo non superiore a tre anni, sia in una prova attitudinale, a
scelta del richiedente. Se questo si pone tuttavia come principio generale, diversa disciplina trova
applicazione per la guida alpina; il comma 2 del medesimo articolo prevede infatti l’obbligo per
questi di sottoporsi necessariamente ad una prova attitudinale per ottenere il riconoscimento dei
relativi titoli professionali, escludendo in tal modo la facoltà di scelta tra le due misure
compensative22.
La prova attitudinale, che si articola generalmente in una prova pratica e in una prova orale
nelle materie in cui è carente la formazione del richiedente, non può essere ripetuta prima di sei mesi
in caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione senza valida giustificazione (art. 23).
Le materie oggetto della prova sono comunque indicate nel decreto di riconoscimento che
l’autorità competente è tenuta ad adottare nel termine di quattro mesi dalla presentazione della
documentazione completa da parte dell’interessato.
Il decreto di riconoscimento attribuisce al beneficiario il diritto di accedere alla professione
di guida alpina alle stesse condizioni previste per i cittadini nazionali e dunque iscrivendosi all'albo
professionale della regione o provincia autonoma nella quale intende esercitare l’attività; l’esercizio
21
A norma dell’articolo 16, commi 3 e 4, del d.lgs. 206/2007, alla conferenza di servizi partecipano le autorità individuate
come competenti dall’articolo 5 del decreto, il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie ed il Ministero
degli affari esteri ed è inoltre sentito un rappresentante del collegio professionale interessato.
22
La ragione di tale disposizione affonda le sue radici nella domanda di deroga di data 11 maggio 2000 presentata
dall’Italia ai sensi dell’articolo 14 della precedente direttiva 92/51/CEE; nella stessa le autorità italiane sostengono che “la
prova attitudinale costituisce il modo più efficace per valutare la competenza tecnica del candidato e la capacità di
quest’ultimo a gestire ed organizzare i soccorsi, mentre queste non possono essere certificate al termine di un semplice
tirocinio di adattamento”. A fronte di tale istanza, la Commissione delle Comunità Europee, con decisione assunta in data
25 luglio 2000, ha “autorizzato le autorità italiane ad imporre al migrante un prova attitudinale”; tale decisione è stata
dapprima recepita dall’articolo 8 del d.lgs. 319/94, come modificato dall’articolo 19 della legge comunitaria 2000, e poi
successivamente dall’articolo 22, comma 2, del d.lgs. 206/2007.
- 13 -della professione è chiaramente subordinato al rispetto delle condizioni richieste dalla normativa
vigente alle guide alpine italiane.
Quanto riferito per le guide alpine comunitarie “formate” in uno degli Stati membri
dell’Unione europea trova applicazione anche per i cittadini della Confederazione Svizzera e dei
paesi aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo - quali il Liechtenstein, la Norvegia,
l’Islanda - nonché per i cittadini stranieri provenienti da Stati extra-comunitari ai quali l’applicazione
della normativa sopra rappresentata è stata estesa ai sensi del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394
(“Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”); in tal senso, dispone anche
l’articolo 4, commi 4 bis e 4ter, della legge provinciale n. 20 del 199323.
Con riferimento al principio della libera prestazione dei servizi, lo stesso trova oggi la
propria compiuta disciplina nel già richiamato decreto legislativo n. 206/2007. Le disposizioni di tale
decreto stabiliscono che ogni cittadino comunitario legalmente stabilito in uno Stato membro può,
in linea di massima, prestare i suoi servizi temporaneamente e occasionalmente in un altro Stato
membro con il suo titolo professionale di origine, senza dover chiedere il riconoscimento delle sue
qualifiche; tuttavia, se nello Stato membro di stabilimento la professione non è regolamentata, il
prestatore deve comprovare di aver esercitato tale professione per almeno due anni nel corso dei dieci
anni che precedono la prestazione di servizi in altro Stato (art. 9 D.Lgs. 206/2007).
Il prestatore che si sposta per la prima volta da un altro Stato membro sul territorio nazionale
(e dunque anche su quello provinciale) per fornire i propri servizi è tenuto ad informare 30 giorni
prima, salvo i casi di urgenza, l'autorità competente (leggasi: Provincia autonoma di Trento) con una
dichiarazione scritta che deve essere corredata di un certo numero di documenti tra i quali una prova
delle sue qualifiche professionali, un certificato che attesti la nazionalità, una certificazione
dell'autorità competente che attesti che il titolare è legalmente stabilito in uno Stato membro per
esercitare le attività in questione e che non gli è vietato esercitarla, anche su base temporanea, al
momento del rilascio dell'attestato (art. 10 D.Lgs. 206/2007).
Tale dichiarazione, che può essere fornita con qualsiasi mezzo idoneo di comunicazione, ha
validità per l'anno in corso e deve essere rinnovata, se il prestatore intende fornire anche
successivamente servizi temporanei o occasionali in Italia.
L'esercizio della professione da parte delle guide alpine - maestri di alpinismo e degli
aspiranti guida, o figure professionali corrispondenti, provenienti dall'estero con i loro clienti, purché
non svolto in modo stabile nel territorio della provincia di Trento, è consentito in conformità al
regime della libera prestazione dei servizi previsto dal titolo II del decreto legislativo 9 novembre
23
A norma dell’articolo 4, comma 4 bis, della legge provinciale n. 20 del 1993, “per i cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea, della Confederazione svizzera e degli Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo,
firmato a Oporto il 2 maggio 1992, ratificato ai sensi della legge 28 luglio 1993, n. 300, in possesso di qualifiche
professionali per l'esercizio dell'attività di guida alpina o aspirante guida alpina conseguite in tali Stati, l'iscrizione all'albo
professionale della provincia di Trento è subordinata alla procedura di riconoscimento professionale prevista dal decreto
legislativo n. 206 del 2007”. Aggiunge il successivo comma 4 ter che “per i cittadini stranieri provenienti da Stati diversi da
quelli indicati nel comma 4 bis e in possesso di qualifiche professionali per l'esercizio dell'attività di guida alpina o
aspirante guida alpina conseguite in tali Stati l'iscrizione all'albo professionale della provincia di Trento è subordinata al
riconoscimento professionale disposto secondo quanto previsto dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)”.
- 14 -2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche
professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera
circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).
Coerentemente alle citate norme comunitarie, l’articolo 4, comma 3, della l.p. 20/93 consente
alle guide alpine-maestri di alpinismo e aspiranti guida o a figure professionali
corrispondenti provenienti dall’estero con i propri clienti, di svolgere temporaneamente la propria
attività in provincia di Trento senza alcun obbligo di iscrizione all’albo provinciale ed in conformità
al regime della libera prestazione dei servizi previsto dal titolo II del citato decreto legislativo n. 206
del 2007: i beneficiari di tale disciplina sono i cittadini comunitari (o aderenti all’accordo SEE) o
extracomunitari, ossia coloro che hanno la nazionalità di uno Stato membro della Comunità (o di uno
Stato aderente all’accordo SEE) o di uno Stato extra comunitario, che siano stabiliti ed integrati in
uno Stato membro diverso dall’Italia, paese in cui il servizio è prestato (necessario carattere
transfrontaliero della prestazione).
Il riferimento stesso alla provenienza rimanda infatti ad un prestatore “appartenente” ad uno
stato membro diverso da quello italiano perché ivi legalmente stabilito. Una guida alpina stabilita ed
“integrata” in Italia ed in possesso di un titolo abilitativo straniero non può pertanto avvalersi del
principio della libera prestazione dei servizi ma piuttosto percorrere la strada del riconoscimento
delle qualifiche professionali come sopra riferita.
Per l’esercizio di attività saltuaria non sono posti ulteriori limiti se non gli stessi che trovano
applicazione per lo svolgimento della professione nello stato di appartenenza (es.: obbligo di
esercitare l’attività accompagnati da altra guida alpina o di esercitarla alle dipendenze di una scuola
di alpinismo).
Si fornisce di seguito una casistica della disciplina applicabile nelle ipotesi di esercizio
temporaneo o di libera prestazione dei servizi da parte delle guide alpine.
PROVENIENZA ESERCIZIO TEMPORANEO REQUISITI
Residenza, domicilio o
recapito, anche stagionale, in
NO
Trentino
Offerta di prestazioni
professionali ai clienti sul
NO
territorio provinciale
Prestazione professionale nel
territorio provinciale (in SI
accompagnamento di propri
clienti):
se proveniente da altra Regione Iscrizione all’albo della
o Provincia autonoma Regione o Provincia
autonoma di provenienza
se proveniente da uno Stato Titolo abilitativo + dichiarazione
straniero (+ esperienza di due anni negli
ultimi dieci se la professione
non è regolamentata)
- 15 -Puoi anche leggere