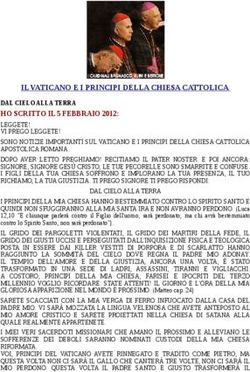La grande cometa del 2020 - Come l'abbiamo vista GIOVANNI BONINI - L'onda Book
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
© 2020 Editoriale Delfino Srl
Via Aurelio Saffi, 9 - 20123 Milano (Italia)
Tel. +39.02.9578.4238
www.londabooks.com
Copertina: L’astro chiomato C/2020 F3 NEOWISE, ripreso dall’autore poco prima
dell’alba, a inizio luglio.
I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adatta-
mento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (microfilm, copie fotostatiche com-
presi), sono riservati per tutti i Paesi.
Nessuna parte di questo libro può essere riprodotta con sistemi elettronici, mec-
canici o altro senza l’autorizzazione scritta dell’Editore.
Impaginazione: Myriam Masiero - Padova (Italia)
Stampa: Mediagraf SpA - Noventa Padovana (PD)
Finito di stampare nel mese di luglio 2020
Prodotto interamente realizzato in Italia
Editoriale Delfino: da sempre sostenitrice del Made in Italy
Codice ISBN: 979-12-80185-02-0
SSION
MADE WITH PA
2 Editoriale DelfinoA chi ancora alza lo sguardo al Cielo, per carpire le infinite meraviglie
della Natura e tenerle in serbo per sé e per gli altri.
Figura D.1. Lo spettacolare astro chiomato C/2020 F3 NEOWISE, con la sua lunga coda di polve-
ri. Immagine del 9 luglio, ripresa mentre iniziava ad albeggiare.
NEOWISE La grande cometa del 2020 Come l’abbiamo vista 34 Editoriale Delfino
Questo libro non è un rigoroso trattato scientifico, bensì
una sorta di “Souvenir spaziale”, un ricordo di una delle
più belle comete degli ultimi anni, resasi ben visibile a
occhio nudo e ancora meglio nelle fotografie a lunga
esposizione o, come si usa oggi, sommando digitalmente
più fotogrammi.
Giovanni Bonini
www.facebook.com/Temporary.Management.Giovanni.Bonini
www.linkedin.com/in/g-bonini-project-management-p6/
NEOWISE La grande cometa del 2020 Come l’abbiamo vista 56 Editoriale Delfino
Indice
09 Prefazione di Andrea Accomazzo.
11 Introduzione.
19 Capitolo 1.
L’astro chiomato C/2020 F3 NEOWISE nel cielo del
mattino.
19 1.1. La mia prima osservazione visuale.
21 1.2. La mia prima osservazione fotografica.
24 1.3. Gli ultimi due giorni della prima decade di luglio.
30 1.4. Le mie ultime levatacce mattutine.
39 Capitolo 2.
La cometa C/2020 F3 NEOWISE nel cielo della sera.
49 Capitolo 3.
L’astro chiomato C/2020 F3 NEOWISE alla minima
distanza dalla Terra.
51 Capitolo 4.
Fotografie dal mondo.
51 4.1. Gerald Rhemann, Austria.
NEOWISE La grande cometa del 2020 Come l’abbiamo vista 756 4.2. James Whitney Young, Stati Uniti.
60 4.3. Lorenzo Tagliaro, Italia.
61 4.4. Petr Horálek, Repubblica Ceca.
66 4.5. Michael Jäger, Austria.
71 Conclusioni.
75 Bibliografia essenziale.
8 Editoriale DelfinoPrefazione
di Andrea Accomazzo
Head
Solar System and Exploration Missions Division
European Space Agency (ESA)
Se ci trovassimo nel XV secolo, Giovanni Bonini sarebbe uno
di quegli scienziati meticolosi che abbiamo visto documentare
in ogni singolo dettaglio la Natura che ci circonda ed i suoi
fenomeni, con il fine ultimo di carpire tutti i segreti. Invece, ho
avuto il piacere di conoscere Giovanni nel XXI secolo, nella
sede dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), dove ha lavorato per
diversi mesi ad un impegnativo progetto di cambiamento nel
centro di controllo.
Da subito mi ha colpito per la sua passione per la Natura, siano
le montagne, le stelle ed anche il genere umano. In Giovanni si
trova la passione genuina per la scoperta, per l’osservazione, per
l’analisi con l’obiettivo di capire a fondo i processi, i meccanismi,
le regole di tutto quello che viene a contatto con lui.
In questo libro Giovanni ci racconta della sua esperienza
personale alla ricerca ed osservazione della cometa NEOWISE,
ovvero uno dei corpi celesti che hanno caratterizzato il 2020,
l’anno del COVID-19. Un anno che mai ci saremmo aspettati di
vivere. Ed in questo bizzarro periodo Giovanni ha preso tutto il
tempo di cui aveva bisogno per proiettarsi nei secoli scorsi ed
andare ad osservare i misteri della Natura a lui tanto cari.
Levatacce, ore di attesa, messa a punto degli strumenti
fotografici, ricerca di informazioni: un diario di bordo per tutti
che, oltre a fornire spiegazioni e dettagli su comete e apparecchi
ottici, trasmette tutta la passione del nostro uomo.
Tutto questo ci ricorda quanto sia fondamentale la curiosità e la
NEOWISE La grande cometa del 2020 Come l’abbiamo vista 9voglia di sapere insita nell’essere umano: è solo grazie a questo
istintivo bisogno di andare oltre, di guardare oltre che si può
pensare ad un’umanità che si evolve e si adatta ad un mondo
che cambia.
Andrea Accomazzo lavora presso l’Agenzia Spaziale Europea
(ESA) come responsabile per le operazioni di volo delle
missioni interplanetarie. Nel corso degli anni ha ricoperto il
ruolo di Flight Director per le missioni Rosetta, BepiColombo
e Solar Orbiter. Il suo Focus si sposta ora sulle missioni di
esplorazione di Marte e della Luna, in particolare con la
campagna di recupero di campioni del suolo marziano prevista
per la fine di questo decennio.
Figura P.1. Da sinistra a destra: Andrea Accomazzo, Giovanni Bonini, Mauro Del Ben
e Stefano Di Lucente, presso il centro di Darmstadt (Germania) dell’Agenzia Spaziale
Europea (ESA).
10 Editoriale DelfinoIntroduzione
Le comete sono corpi minori, facenti parte del Sistema Solare, il
sistema stellare nel quale viviamo.
In genere, il nucleo di un astro chiomato ha un diametro di
pochi chilometri: nulla in confronto a quello dei pianeti o dei loro
satelliti naturali, come la Luna.
Figura I.1. La cometa C/2020 F3 NEOWISE è stata uno degli astri chiomati più
spettacolari degli ultimi anni. Ecco come si presentava la mattina dell’8 luglio, poco
prima dell’alba.
Le comete provengono dai più remoti confini del Sistema Solare,
dove sono ibernate nella nube di Oort, la cui forma è sferica. Per
questa ragione, possono avere delle orbite con le inclinazioni
più disparate.
Ogni tanto, qualcuna di queste “palle di neve sporca” si dirige
verso l’interno del sistema stellare in cui viviamo, “accendendosi”:
NEOWISE La grande cometa del 2020 Come l’abbiamo vista 11a mano a mano che si avvicina al Sole, un astro chiomato inizia
a consumarsi. I suoi ghiacci sublimano, portando con sé una
discreta quantità di polveri. L’attività è tanto più intensa quanto
minore è la distanza dalla nostra stella. Gas e polveri danno
vita alla chioma, che avvolge il nucleo, e alle code, una di gas e
una di polveri, che possono anche apparire sovrapposte per un
effetto meramente prospettico.
Se la cometa passa a breve distanza dal Sole, lo Stress termico
e meccanico, dovuto alle forze di marea, può comportare la
rottura (o fissione) del nucleo, un fenomeno spesso associato
alla “morte” dell’astro chiomato.
Soprattutto le comete più giovani possono avere dei periodi
orbitali di molte migliaia di anni, sebbene non tutti gli astri
chiomati siano periodici. Alcuni di essi, dopo averci fatto visita,
si perdono nel vuoto dello spazio interstellare, percorrendo le
loro orbite paraboliche: le parabole, infatti, non sono delle curve
chiuse, così come le iperboli.
Fino a qui, ecco spiegato ciò che succede dal punto di vista
fisico. Tuttavia, è lecito chiedersi che cosa possa vedere un
osservatore visuale, ubicato sulla superficie del nostro bel
pianeta azzurro. Molto dipende dalla particolare cometa e dalla
geometria dell’incontro, che può essere più o meno favorevole,
perché non è detto che la Terra e l’astro chiomato si trovino
sempre nella medesima posizione l’una rispetto all’altro.
Ecco spiegato, per esempio, come mai la celebre cometa di
Halley, che gli astronomi chiamano 1P/Halley, a volte si è
rivelata estremamente spettacolare, mentre in altri casi non
ha entusiasmato, come in occasione dell’ultimo passaggio al
perielio, che è il punto dell’orbita più vicino al Sole.
Ma perché 1P/Halley? “1P” significa che è il primo astro
chiomato per il quale fu accertata la periodicità. Muovendosi
lungo un’orbita ellittica, torna a farci visita ogni x anni, dove x
rappresenta il periodo orbitale (in anni: 76, nel caso della 1P/
Halley).
12 Editoriale DelfinoFigura I.2. Ecco come si presentavano la chioma, con il falso nucleo, e la coda di
polveri, la mattina del 9 luglio.
In un certo senso, la cometa di Halley è un astro chiomato “a
misura d’uomo”, perché il suo periodo orbitale è confrontabile
con la vita umana. Alcune comete, invece, tornano a farci visita
ben più frequentemente, mentre altre impiegano centinaia o
migliaia di anni per descrivere le loro orbite: sono quelle a lungo
periodo.
NEOWISE La grande cometa del 2020 Come l’abbiamo vista 13Di solito, gli astri chiomati dal breve periodo orbitale sono quelli
più vecchi e consumati, per cui raramente danno spettacolo:
le perturbazioni gravitazionali, spesso riconducibili a qualche
incontro ravvicinato con i pianeti esterni, hanno accorciato il
tragitto di queste comete intorno alla nostra stella. A ogni giro
di boa intorno al Sole, perdono del materiale, consumandosi.
A volte, può capitare che la Terra incontri le polveri disperse
da qualche astro chiomato, capaci di originare una vera e
propria pioggia di stelle cadenti o meteore. Per esempio, le
celebri Lacrime di San Lorenzo o Perseidi, visibili intorno all’11
- 12 agosto di ogni anno, sono legate alla cometa 109P/Swift-
Tuttle. Come si è visto, si tratta del centonovesimo (“109”) astro
chiomato per il quale si è accertata la periodicità (“P”).
Questi detriti spaziali, chiamati meteoroidi, sono disposti lungo
l’orbita della cometa che li ha originati, in genere raggruppati in
vere e proprie nubi, ciascuna delle quali è associata a un ben
preciso passaggio al perielio.
I meteoroidi sono soggetti a due tipi di forze: gravitazionali
(poiché hanno una massa) e di pressione (avendo una superficie).
Queste ultime sono legate alla radiazione solare e dipendono
dalla superficie, che, per una sfera, è una funzione del raggio al
quadrato. Le forze gravitazionali, invece, dipendono dal volume
e, quindi, dal raggio al cubo (sempre nel caso di una sfera). Di
conseguenza, i meteoroidi più piccoli vengono spazzati via
dalla radiazione solare, mentre quelli di maggiori dimensioni
sono fortemente influenzati dalle forze gravitazionali. Questo
spiega come mai le Leonidi del 1998 furono così ricche di
“bolidi” (Fireball), cioè stelle cadenti di eccezionale luminosità,
capaci di rivaleggiare con Venere o persino con la Luna. Nel
1999, invece, le Leonidi diedero vita a una magnifica tempesta
di stelle cadenti (Meteor Storm), ma la percentuale di bolidi fu
molto più bassa rispetto a quella dell’anno prima. Nel 1998,
infatti, la Terra incontrò una nube di detriti molto vecchia, che
era stata “spopolata” dalla pressione della radiazione solare,
14 Editoriale Delfinola quale aveva spinto via le particelle più piccole, lasciando
soltanto i meteoroidi di maggiori dimensioni.
Figura I.3. Il cielo stellato è uno dei più grandi spettacoli naturali ed è alla portata di
tutti. Qui vediamo Sirio e la costellazione di Orione, prossima al tramonto dietro le
Piccole Dolomiti parzialmente innevate.
Perché C/2020 F3 NEOWISE? Si tratta di un astro chiomato nuovo,
mai osservato in precedenza. “C”, quindi, indica che abbiamo a
che fare con una cometa. “2020” è l’anno della sua scoperta.
“F3” significa che è il terzo (“3”) astro chiomato scovato dal 16
al 31 marzo, vale a dire nella metà mese che corrisponde alla
lettera “F”. Infine, “NEOWISE” è il nome dello “scopritore”, in
questo caso il Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE) della
NASA, impegnato nella ricerca e osservazione dei Near-Earth
Objects (NEO).
Questi oggetti, tra i quali ci sono anche le comete, sono
potenzialmente pericolosi per la sopravvivenza della vita
umana. Sfiorando il nostro pianeta e intersecando la nostra
NEOWISE La grande cometa del 2020 Come l’abbiamo vista 15orbita, potrebbero impattare con la Terra. Le conseguenze
sarebbero apocalittiche. Se un asteroide, per esempio, dovesse
cadere nel mare o nell’oceano, darebbe vita a una gigantesca
onda anomala, di proporzioni bibliche e dalle conseguenze a
dir poco devastanti. Se, invece, dovesse impattare con qualche
continente, alzerebbe una tale quantità di polveri da offuscare
l’atmosfera terrestre per molti mesi o anni. La luce del Sole
non potrebbe più raggiungerci. Ci sarebbe un crollo termico
e si arresterebbe la fotosintesi clorofilliana. Quindi, i vegetali
morirebbero e gli erbivori resterebbero senza cibo, seguiti dai
carnivori. Come le pandemie, tutto ciò è già accaduto. Con ogni
probabilità, succederà ancora, anche se non sappiamo quando.
Ecco perché è importante tenere monitorati questi oggetti,
capaci di cancellare la vita sulla Terra.
Un tempo, molti astri chiomati venivano scoperti dagli astrofili.
Famosissimo, per esempio, è il neozelandese William Ashley
Bradfield, scomparso nel 2014: con ogni probabilità, è lui il
“cacciatore di comete” per eccellenza, avendone scoperte ben
diciotto.
Il primo astro chiomato che osservai, l’11 novembre 1987, fu
scoperto proprio da William Ashley Bradfield: si tratta della
C/1987 P1 Bradfield, che si rese facilmente visibile con un
binocolo.
Insieme alle tempeste meteoriche e a un’eclisse totale di Sole,
ammirata dalla ristretta fascia di totalità, gli astri chiomati sono
tra i più grandi spettacoli della Natura. Sebbene ve ne siano
quasi sempre, visibili con un buon telescopio amatoriale, solo
di tanto in tanto le comete diventano così luminose da poter
rivaleggiare con le stelle più brillanti.
Da questo punto di vista, il 2020 si era aperto con delle grandi
illusioni, legate agli astri chiomati C/2019 Y4 ATLAS e C/2020
F8 SWAN. Il nucleo della prima cometa, in particolare, è andato
in frantumi, decretandone la fine.
Per fortuna, le due grandi delusioni legate agli astri chiomati
16 Editoriale DelfinoPuoi anche leggere