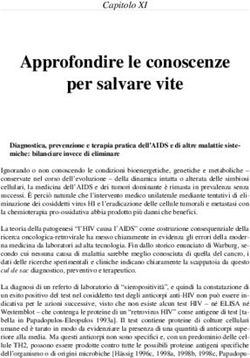LA GESTIONE DELLA PESCA MARITTIMA
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Il Fenomeno Pesca
1. GENERALITÀ
1.1. La pesca professionale marittima
È considerata Pesca marittima ogni attività diretta a catturare esemplari di specie il cui ambiente
abituale o naturale di vita siano le acque marine o del Demanio marittimo, definite come tali dalla
normativa vigente. In funzione delle dimensioni dei natanti, la Pesca professionale è suddivisa in:
a) Piccola pesca: si esercita con barche non superiori alle 10 TSL, abilitate esclusivamente
all'uso dei seguenti attrezzi: reti da posta, ferrettara, palangari, lenze ed arpioni (art. 19 D.M.
26/07/95 sulle licenze di pesca).
b) Pesca costiera locale: si esercita fino ad una distanza di 6 miglia dalla costa con navi fino a
30 TSL. Se la nave è conforme alle prescrizioni di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera
ravvicinata (D.M. 22/ 06/ 82) si può richiedere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fino ad una
distanza di 12 miglia dalla costa (D.M. 19/0412000).
c) Pesca costiera ravvicinata: si esercita fino ad una distanza di 40 miglia dalla costa con navi
da pesca di categoria non inferiore alla terza (art. 2, comma 1 D. Legislativo 30/ 09/ 1994 n. 561,
convertito in legge con la Legge 30 novembre 1994 n. 655).
d) Pesca mediterranea o d'altura: si esercita nelle acque del Mar Mediterraneo con navi non
inferiori alle 30 TSL e con le dotazioni di sicurezza previste.
e) Pesca oceanica: si effettua con navi di prima categoria.
La cattura degli organismi marini può essere effettuata con qualsiasi attrezzo, strumento o
apparecchio, che non contrasti con le disposizioni di Legge. Al fine della disciplina della Pesca gli
attrezzi consentiti sono:
f) Reti, Ami, Strumenti ed Apparecchi.
g) Reti: attrezzi costituiti da filati di qualsiasi natura, intrecciati a maglie di varia grandezza e si
suddividono in varie tipologie in funzione del loro impiego.
h) Ami: strumenti ad uncino muniti di esca, trovano una propria definizione in funzione del
modo d'impiego.
i) Strumenti ed Apparecchi: attrezzi non compresi fra le categorie citate, che sono il frutto della
capacità inventiva dei pescatori. Alcuni di questi apparecchi trovano largo impiego nella Pesca
professionale in particolare in quella dei molluschi.
2 di 58Il Fenomeno Pesca
1.2. Sistemi di pesca professionale consentiti
1.3. Glossario
ACQUACOLTURA Per acquacoltura si intende l'allevamento e la coltivazione di organismi
animali o vegetali in ambienti limitati in cui sia possibile aumentare i
ritmi di crescita o ridurre la mortalità naturale.
BIOMASSA È il peso totale della materia vivente in mare. In genere ci si riferisce al
peso in mare di una popolazione ittica, di uno stock o di una frazione di
esso.
POPOLAZIONE Per popolazione ittica si intende l'insieme degli individui di una stessa
specie che vivono in un' area geografica (o meglio un ecosistema) e
che hanno caratteri comuni trasmissibili per eredità.
RECLUTAMENTO È abbastanza raro che nelle zone nelle quali si esercita la pesca di uno
stock siano rappresentate tutte le classi di età nella stessa proporzione
che nell'insieme della popolazione. Molte specie, infatti, hanno delle
aree di riproduzione nelle quali depongono le uova e nelle quali i
giovani nati stazionano per un certo periodo di tempo. Il reclutamento
si ha quando gli individui più giovani (della nuova generazione, detti
reclute, da cui reclutamento) si uniscono alla popolazione adulta (o allo
3 di 58Il Fenomeno Pesca
stock). In questa maniera le reclute diventano accessibili alla pesca
(sfruttabili).
SFORZO DI PESCA Lo sforzo di pesca rappresenta tutto quanto viene messo in atto per
ottenere una certa quantità di catture in un certo tempo. Perciò
concorrono a determinare lo sforzo di pesca, molti parametri: es. la
potenza motore, la dimensione della rete, le ore di pesca, il numero di
cale, gli strumenti elettronici per identificare i banchi di pesce, etc. In
genere per misurare lo sforzo di pesca si usano unità semplici da
ottenere, ad es. la potenza motore o le TSL. Un indice di sforzo
migliore si ottiene con parametri combinati, ad es. la potenza motore
impiegata per giorno di pesca o per ora di pesca.
STOCK È un termine con il quale si indica l'insieme degli individui di una
popolazione sfruttabili alla pesca. Gli stocks sussistono nell'ambito della
popolazione ed occupano aree minori di quella totale occupata dalla
popolazione. Gli stocks si possono considerare come sotto-insiemi di
una popolazione ittica che vivono in un area delimitata (es. un ampio
golfo o un'area delimitata da una particolare conformazione della
costa).
SOVRA-SFRUTTAMENTO Si ha sovra-sfruttamento alla pesca di uno stocks ittico quando lo stock
stesso non riesce a mantenere i valori di biomassa a causa di un
eccessivo sforzo di pesca applicato su di esso. In pratica la capacità di
riproduzione dello stock (e quindi l'immissione di nuova biomassa), non
riesce ad eguagliare la quantità di pesce sottratta allo stock dalla
pesca.
4 di 58Il Fenomeno Pesca
2. IL FENOMENO PESCA
2.1. Introduzione
La pesca è una delle maggiori attività economiche su scala mondiale. Essa ha avuto un grosso
sviluppo in questo ultimo secolo. Basti dire che all'inizio del 1900 la produzione mondiale
ammontava a circa 4 milioni di t, mentre nel 1970 essa era di circa 70 milioni di t.
Mediamente, a partire dal 1930, le quantità sbarcate sono raddoppiate, sempre su scala mondiale,
ogni dieci anni; così da dieci milioni di t nel 1930, si è passati a 20 milioni di t nel 1940.
Nonostante gli anni della seconda guerra mondiale avessero praticamente fermato l'attività di
pesca, la produzione della pesca nel 1950 ammontava ancora a 20 milioni di t che divenivano 38
nel 1960 e, appunto, 70 milioni di t nel 1970 (Fig. 1),
mentre si è verificato un rallentamento nella crescita delle catture dopo il 1970 (vedi Fig. 2).
In termini monetari, per es. nel 1968, il prodotto sbarcato pari a 68 milioni di t aveva un valore
globale di oltre 10 miliardi di dollari dell' epoca, pari alla metà circa della cifra d'affari del trasporto
marittimo di allora.
5 di 58Il Fenomeno Pesca
Questo grande sviluppo della pesca è passato anche attraverso una sua diversificazione e
specializzazione
Diversificazione e Specializzazione della Pesca
1. Dalle specie demersali alle specie pelagiche
2. Nel 1970 i 2/ 3 del pescato mondiale era costituito da pesce pelagico, di cui il 90%
destinato a farina di pesce
3. Estensione della pesca a paesi in via di sviluppo (Cina, perù, Corea, Tailandia, ecc)
4. Miglioramento nella tecnologia dei battelli da pesca
5. Impianti a terra
6. Catena del freddo
7. Rete di commercializzazione
8. Qualificazione professionale
9. EEZ (Exclusive Economic Zone)
10. Sviluppo dell acquacultura
Mentre prima della seconda guerra mondiale le catture erano costituite principalmente dalle specie
più pregiate (demersali), dopo il 1945, la pesca si è sviluppata su delle specie diverse, in
particolare le specie pelagiche (es. alici, sardine, sgombri) che sono di minor valore commerciale,
ma che sono presenti in maniera massiccia negli oceani. Questo pesce pelagico è in gran parte
destinato a farina di pesce e quindi ad alimentazione animale, anziché umana.
Inoltre, mentre prima del 1940 la quasi totalità della produzione mondiale proveniva dai Paesi
dell'emisfero settentrionale, al termine del conflitto nel 1945, la pesca su scala industriale si è man
mano estesa ai Paesi in via di sviluppo (Perù, Tailandia, Corea, Indonesia, Senegal, Mauritania,
tanto per citarne alcuni).
C'è stato poi un aggiornamento tecnologico della flottiglia molto spinto, con battelli sempre più
grandi e sempre più numerosi, potenti e ad ampio raggio di azione. Si sono formate delle vere e
proprie flotte pescherecce capaci di effettuare campagne di pesca della durata di mesi (soprattutto
negli oceani) e che hanno al seguito navi-fattoria per la trasformazione a bordo del prodotto
pescato.
Radicali innovazioni sono state poi introdotte nella costruzione degli attrezzi da pesca e nelle
dotazioni elettroniche di bordo (ecoscandaglio, radar, sonar, ecc.). Sono ormai di uso comune
apparecchiature elettroniche capaci di distinguere gli echi sonar dei diversi tipi di pesce e di
mostrarli sullo schermo in colorazioni diverse.
La capacità professionale degli equipaggi, con l'avanzamento del grado medio di istruzione, è
notevolmente aumentata.
Tutto questo ha accresciuto enormemente le potenzialità di cattura.
6 di 58Il Fenomeno Pesca
Si è detto "potenzialità" di cattura e non semplicemente cattura, perché, oltre un certo livello,
raddoppiando ad es. le capacità di cattura della flottiglia (ad es. con reti più efficienti e/ o motori
più potenti), non si ottengono catture doppie, ma inferiori e anche di molto, al doppio.
Altri fattori che hanno contribuito all'aumento della pesca mondiale sono stati la trasformazione e
la creazione degli impianti a terra di assistenza al naviglio e di trasformazione del pescato. Si sono
sviluppate le catene del freddo per la conservazione e la commercializzazione del prodotto
congelato e surgelato; si sono sviluppate le reti di commercializzazione. La qualificazione
professionale degli addetti alla pesca è da tempo entrata nella prassi corrente.
2.2. La zona economica esclusiva (EEZ)
Il rapido sviluppo della pesca non è stato omogeneo e si è differenziato da nazione a nazione,
poiché, come tutti i settori economici, anche la crescita della pesca dipende da molti fattori che si
influenzano l'un l'altro. Fattori essenziali sono comunque: la presenza di risorse ittiche in
abbondanza sufficiente, l'esistenza di una capacità tecnologica di prelievo (flottiglia peschereccia
adeguata), gli impianti di trattamento del pescato, le reti di commercializzazione.
Queste ed altre condizioni non si verificano mai contemporaneamente ed in generale si può dire
che i Paesi più avanzati hanno forti incidenze sui costi determinati dalla manodopera, mentre i
Paesi in via di sviluppo hanno manodopera in surplus ed a basso costo. Questi ultimi però risultano
enormemente svantaggiati dal punto di vista tecnologico, degli impianti e della rete commerciale.
Nonostante ciò, la pesca, per molti Paesi in via di sviluppo rappresenta una quota importante del
Prodotto Nazionale Lordo e una spinta allo sfruttamento diretto delle risorse ittiche, in molti casi, è
venuto anche dalla necessità di sfruttare con maggior vantaggio le proprie risorse, anziché farsele
decimare, con scarso utile, dalla pesca dei Paesi industrializzati.
A seguito della necessità di preservare e/ o sfruttare le proprie risorse, tra cui quelle ittiche, dopo
un lungo dibattito internazionale in sede ONU ha preso il via nel 1982 la zona economica esclusiva
(Exclusive Economic Zone, EEZ) in base alla quale gli Stati costieri o insulari possono riservarsi lo
sfruttamento delle risorse marine e quindi anche la pesca, fino a 200 miglia dalla costa.
2.3. Lo sviluppo dell'acquacoltura
Il limite naturale alla sfruttabilità delle risorse di pesca ed i numerosi segnali di sovra-sfruttamento
degli stocks ittici hanno accelerato lo sviluppo dell'acquacoltura. Per molti osservatori
l'acquacoltura rappresenta il futuro della pesca e la sua importanza sarà destinata ad aumentare
continuamente, costituendo una fonte alimentare fondamentale per la popolazione mondiale in
continuo aumento. Infatti, il tasso di crescita dell'acquacoltura nel mondo, tra il 1984 ed il 1995, è
stato di circa il 10% annuo, contro l'1,6% delle catture della pesca in mare. Nel 1995 la produzione
mondiale dell'acquacoltura ha raggiunto circa 24 milioni di t.
7 di 58Il Fenomeno Pesca
2.4. Andamento della produzione mondiale della pesca
Nella seconda figura, si nota il rallentamento della crescita delle catture della pesca a partire dagli
anni '70 a causa del sovra-sfruttamento degli stocks ittici. A partire dallo stesso periodo si assiste
invece ad un incremento sempre maggiore dell' acquacoltura.
Considerando le catture in mare per grandi aree, si può rilevare come una notevole percentuale
della produzione sia concentrata in Cina ed in Asia che insieme hanno raggiunto oltre 60 milioni di
t nel 1996 (50% del totale). Questo semplice dato dimostra l'importanza della pesca per i Paesi in
via di sviluppo, aventi anche una popolazione enorme, come la Cina ed altri Paesi dell' Asia.
Altra considerazione da fare è quella relativa all ammontare della cattura. L'ammontare delle
catture della pesca dei Paesi industrializzati dell'Occidente (Europa, Nord America) si è stabilizzato
da lungo tempo a causa di una pesca che si è industrializzata molti anni prima dei Paesi emergenti
(es. dei Paesi dell' Asia) e che ha raggiunto e superato da molti decenni la soglia del sovra-
sfruttamento degli stocks. Nel 1997 le catture globali della pesca e dell' acquacoltura sono state di
122 milioni di t, contro 121 milioni di t del 1996. Tuttavia, a fronte di un leggero decremento delle
catture in mare (di 0,9 mil. di t), c'è stato un aumento di 1,9 mil. di t nella produzione
dell'acquacoltura.
Nel 1998 la produzione globale è scesa a 115 milioni di t (-6%). È questo il primo calo rilevante
nella storia della pesca industrializzata, non considerando i periodi delle due guerre mondiali. La
ragione di questo calo è data principalmente dalle conseguenze del riscaldamento delle acque,
prodotto dal fenomeno della corrente del Nino (la ormai famosa corrente che lambisce la costa
ovest del Sud-America) che ha influenzato negativamente il reclutamento dei pesci pelagici nei
grandi stocks che vivono nell'Oceano Pacifico, nelle aree adiacenti le coste del Sud-America
(soprattutto l'anchoveta del Perù, una specie di alice pescata massicciamente per la produzione di
farina di pesce). Alcune recenti proiezioni della produzione mondiale della pesca e dell'acquacoltura
eseguite per il 2010, oscillano tra 144 mil. di t (scenario ottimistico) e 107 mil. di t (scenario
pessimistico). Con lo scenario pessimistico la produzione dell' acquacoltura rimane stabile, mentre
il decremento è dovuto unicamente alla pesca in mare. Per contro, la previsione ottimistica indica
un aumento della produzione della pesca dell' 11 %, mentre per l'acquacoltura l'aumento è del
39%.
2.5. Destinazione dei prodotti della pesca e valore della produzione
La produzione della pesca e dell'acquacoltura è diretta per il 75% circa al consumo umano ed il
25% alla trasformazione in farina di pesce o altri prodotti. La quota destinata al consumo umano
diretto viene utilizzata come prodotto fresco per il 45%, il 30% viene congelato ed il restante 25%
viene venduto come prodotto essiccato, affumicato ed inscatolato.
8 di 58Il Fenomeno Pesca
Il valore globale delle catture della pesca nel 1996 è stato di 85 miliardi di dollari USA, circa
180.000 miliardi di lire, mentre il valore della produzione dell'acquacoltura è stato di 47 miliardi di
dollari USA, circa 98.000 miliardi di lire. Si può notare che il valore unitario dei prodotti
dell'acquacoltura è notevolmente superiore a quello della pesca. Infatti, a fronte di produzione
dell'acquacoltura pari a circa 1/ 4 delle catture in mare (24 mil. di t dell'acquacoltura contro 93
milioni di t della pesca), il valore alla vendita dei prodotti dell' acquacoltura è pari ad oltre la metà
del valore dei prodotti della pesca. Ciò è dovuto al fatto che l'acquacoltura alleva le specie di
maggior valore unitario, mentre la pesca opera su risorse selvagge sulle quali non può
predeterminarne né la qualità, né la quantità.
2.6. Consumo pro-capite
Il consumo pro-capite della produzione ittica destinata ad alimentazione umana è notevolmente
aumentato dagli anni '60 ad oggi. Tuttavia, esso è aumentato di meno nei Paesi industrializzati
(dove era già notevole) e di più nei Paesi in via di sviluppo, soprattutto in quelli che hanno avuto
un consistente sviluppo o che hanno puntato molto sulla risorsa pesca come, ad esempio, la Cina.
La Cina ha visto in trenta anni un aumento notevolissimo della produzione (da 4 mil. di t del 1965
a 28 mil. t del 1995) ed un aumento altrettanto forte del consumo pro-capite, passato da 5 kg nel
1965 a 23 kg nel 1995.
Sensibile è anche l'aumento dei consumi pro-capite nel Nord-America, passati da 13 a 22 kg nello
stesso periodo. Ciò, probabilmente è dovuto ad efficaci strategie produttive e commerciali in un'
area dove i consumi sono molto alti.
Da notare che nei Paesi dell' est europeo si ha una inversione di tendenza con i consumi pro-capite
che scendono da 15 kg del 1965 a 12 kg nel 1995. Con ogni probabilità questo effetto è stato
determinato dalla crisi economica seguita ai profondi cambiamenti politici avvenuti in quell'area
dalla fine degli anni '80.
In Africa i consumi procapite di prodotti ittici sono rimasti immutati tra il 1965 ed il 1995, evidente
segno delle crisi che attraversano continuamente i Paesi africani e che non permettono l'adozione
di adeguate misure di sviluppo nemmeno nella pesca e nell'acquacoltura.
2.7. Organizzazioni internazionali per la gestione della pesca
La pesca è un fenomeno rilevante ed a volte determinante nell'economia alimentare di alcuni Paesi
in via di sviluppo. È un settore difficile da gestire a livello internazionale per l'indeterminatezza dei
confini in mare e per le incertezze ed i contrasti che sorgono sullo sfruttamento di determinate
aree di pesca.
Nel tempo si sono costituiti vari organismi internazionali aventi lo scopo di indirizzare o di gestire la
pesca. La struttura internazionale più importante è la FAO (Food and Agriculture Organization),
9 di 58Il Fenomeno Pesca
un'agenzia delle Nazioni Unite. È stata costituita nell'ottobre 1945, con il compito di aumentare i
livelli di nutrizione e gli standard di vita nelle zone povere del mondo, attraverso l'incremento dell'
agricoltura e delle produzioni alimentari. L'attività della FAO si articola su tre grandi settori:
Agricoltura, Pesca e Foreste.
Alla FAO, che ha sede a Roma ed un organico di 4300 persone, attualmente aderiscono 180 Paesi.
Il bilancio annuale della FAO è di circa 700 miliardi di lire cui vanno aggiunti altri 700 miliardi di lire
circa donati da vari Paesi industrializzati per finanziare progetti speciali.
Oltre alla FAO ci sono una quarantina di altri organismi internazionali che si occupano di pesca.
Normalmente sono organizzati per aree geografiche e di essi fanno parte i Paesi rivieraschi che
insistono su quell'area. Molte Commissioni internazionali sono state promosse dalla FAO e nella
loro attività conservano collegamenti e riferimenti con la FAO stessa. Altre Commissioni sono nate
su iniziativa di gruppi di Paesi aventi interessi in una stessa area di pesca.
Le Commissioni internazionali di pesca non si limitano a favorire la discussione dei Paesi membri
ed a stabilire i meccanismi di
ripartizione delle quote di pescato, ma
promuovono la raccolta statistica dei
dati, la formazione professionale e
soprattutto la ricerca scientifica, base
indispensabile per la valutazione della
biomassa pescabile e quindi della
gestione della pesca.
Ad esempio nell'area di mare geo-
politica che ruota intorno al Mar del
Nord agisce una Commissione internazionale denominata ICES (International Council For the
Exploration Of The Sea); Commissione che non è una di quelle della FAO ma costituita dai Paesi
rivieraschi e/ o connessi con l'area regolamentata dalla Commissione. Compito dell ICES è quello di
stabilire le quote di pescato (zona azzurra).
Nel Mediterraneo e nel Mar Nero, un' area geo-politica molto complessa su cui si affacciano ben tre
continenti, agisce una Commissione
FAO denominata GFCM (General
Fishery Council for the Mediterranean).
(vedasi Figura)
Del GFCM fa parte un altro organismo
internazionale come l'Unione Europea e
dal 1997 ne fa parte anche il Giappone,
10 di 58Il Fenomeno Pesca
molto attivo nella pesca in Mediterraneo.
Il GFCM, a differenza dell'ICES, non stabilisce quote di cattura per i singoli Paesi, sia per la
complessità biologica del Mediterraneo, sia per la delicatezza degli equilibri internazionali.
Una delle attività principali delle Commissioni internazionali è la raccolta statistica dei dati. La FAO
ha suddiviso tutti i mari del mondo in aree statistiche.
2.8. La produzione della pesca nel Mediterraneo e in Italia
Le catture del Mediterraneo (compreso il Mar Nero) assommano a circa 1.700.000 t (1993). La
distribuzione di tali catture per area di pesca è mostrata dalla figura 9. Da notare il rilievo delle
catture dell' Adriatico che pur costituendo soltanto un ventesimo della superficie del Mediterraneo
contribuisce al 16% delle catture totali. Anche nelle catture su scala nazionale l'Adriatico ha
assoluto rilievo in quanto fornisce circa il 50% delle catture nazionali.
Questo aspetto è ancor meglio evidenziato nella figura 10. Le quote maggiori di pescato italiano
provengono dall' Adriatico e dal litorale Siciliano.
2.9. La flotta da pesca mondiale
La crescita delle catture della pesca è stata accompagnata da una crescita molto intensa anche
della flotta da pesca. Tuttavia, per le ragioni già esposte sul sovra-sfruttamento degli stocks, alla
crescita della flottiglia non ha corrisposto un proporzionale aumento delle catture. Infatti (Fig. 11),
tra il 1970 ed il 1995, mentre la produzione della pesca in mare aumenta del 25%, le TSL globali
aumentano del 126%. La distribuzione della flottiglia per continenti (Fig. 12) indica una netta
prevalenza dell' Asia con il 47% delle TSL, mentre l'Europa ed il Nord America oscillano all' 11-
12%. È interessante notare il rilevante tonnellaggio della flotta peschereccia della ex-URSS con
ben il 26% del tonnellaggio mondiale.
11 di 58Il Fenomeno Pesca
La flottiglia italiana da pesca, costituisce circa l'8% delle TSL della flottiglia dell'Unione Europea
(Fig. 13). Per quanto riguarda il numero di imbarcazioni, l'Italia, espressione tipica della pesca
mediterranea caratterizzata da imbarcazioni da pesca di piccola dimensione, costituisce, con circa
19.000 imbarcazioni a motore, il 38% della flottiglia europea.
2.10. La necessità della gestione della pesca
Nell'Ottocento la tesi scientifica predominante era che la natura fosse invincibile e che quindi le
risorse ittiche fossero inesauribili. Questo fatto era confortato dal continuo aumento delle quantità
di pesce pescato nei principali mari del mondo. In realtà, già alla fine dell'ottocento, probabilmente
le catture aumentavano non perché ci fosse sempre più pesce ma perché gli attrezzi da pesca
divenivano sempre più efficienti e la tecnologia delle imbarcazioni migliorava. Il cambiamento più
importante fu l'introduzione del motore e della refrigerazione.
In occasione della prima guerra mondiale si verificò una stasi nell'attività di pesca; alla ripresa fu
molto evidente che le popolazioni ittiche del Mare del Nord (ma anche dell' Adriatico) avevano
tratto un grande giovamento da questo periodo di "riposo biologico". Questa fu la prima evidenza
dell'importanza dell'impatto dell'attività di pesca sulle risorse ittiche.
La pesca può essere assimilata ad una attività di predazione (da parte dei pescatori); però la
velocità con cui può aumentare questa predazione (incremento dell'attività di pesca) è molto
12 di 58Il Fenomeno Pesca
superiore (per fattori socio-economici) al tasso naturale di crescita della popolazione naturale di
prede (i pesci).
Poiché i pescatori sono in competizione uno con l'altro, ognuno lavora il più possibile per catturare
una porzione maggiore della popolazione (o meglio dello stock) di pesce, quindi l'entità dello stock
viene ridotta sempre di più. L'unica maniera per risolvere questo problema è di limitare e
regolamentare l'attività dei pescatori, controllando cioè il cosiddetto sforzo di pesca. Questo
comporta obbligatoriamente una gestione delle risorse ittiche.
Un altro fattore che ha determinato la necessità di una gestione della pesca è il problema della
proprietà multinazionale degli stocks ittici. A livello mondiale, la dichiarazione da parte di molti stati
delle zone economiche esclusive (EEZ) fino a 200 miglia dalla propria costa ha portato ad un
cambiamento nel modo di considerare le risorse ittiche. Le cosiddette flottiglie oceaniche, o i
governi a cui appartenevano, hanno dovuto stipulare accordi di pesca con i paesi detentori delle
risorse.
I! bacino del Mediterraneo molto spesso non è abbastanza ampio per permettere l'istituzione di
zone economiche esclusive di 200 miglia e quindi in molti casi sono state adottate le mid-lines tra
paesi dirimpettai sullo stesso mare. I pesci però non conoscono confini in mare e quindi si sono
dovuti istituire degli organismi sovranazionali con il compito di stabilire delle regole comuni per la
gestione delle risorse ittiche. La responsabilità di far osservare queste regole è sempre però dei
singoli stati.
Un esempio classico si è visto a proposito dell ICES (International Council for the Exploration of the
Sea), organizzazione con il compito di dare il parere scientifico sulla pesca nel Mare del Nord. A
questo parere si ricollega l'Unione Europea per la gestione delle risorse attraverso la Common
Fishery Policy (CFP). Per gli stati Mediterranei membri della UE, la Commissione Europea ha
recentemente incominciato ad includere la pesca in Mediterraneo nella CFP, quindi decisioni prese
in sede comunitaria possono essere vincolanti nell'ambito della gestione della pesca in Italia.
Un'altra importante organizzazione è l'ICCAT (International Commission for the Conservation of the
Atlantic Tuna) che si occupa dei tonni e dei grandi pelagici in generale.
Scopo fondamentale della gestione della pesca è di assicurare una produzione sostenibile nel
tempo dagli stocks ittici, attraverso regolamentazioni ed incentivi che promuovano il benessere
sociale ed economico dei pescatori e delle industrie di pesca che sfruttano questa produzione. Per
fare questo l'autorità deve stabilire (sulla base di pareri scientifici), giustificare (politicamente) e
amministrare (far rispettare) una serie di regole per l'attività di pesca.
Il ruolo della ricerca scientifica applicata alla gestione delle risorse biologiche è di fornire, da un
punto di vista biologico, il miglior supporto tecnico possibile alle decisioni gestionali. Qualunque
decisione gestionale tiene in qualche modo conto o fa delle assunzioni sulla dinamica degli stocks:
quindi qualunque scelta è basata su un qualche modello. In una gestione moderna delle risorse i
13 di 58Il Fenomeno Pesca
modelli sono esplicitamente descritti e quindi analizzabili e criticabili scientificamente. La gestione
terrà conto del parere scientifico ma anche dei fattori socioeconomici e politici che partecipano a
costituire il sistema pesca.
Più del 60% di tutti i maggiori stocks ittici del mondo è attualmente sovrasfruttato e probabilmente
la percentuale è anche più alta. Questo è un chiaro indizio delle difficoltà che si incontrano nella
gestione delle risorse. La capacità di pesca di una flotta cresce sempre molto velocemente e
quando la flotta è troppo grande rispetto alla risorsa è molto difficile ridurla perché ciò comporta
perdita di posti di lavoro. Le decisioni perciò andrebbero prese prima di raggiungere questa
situazione, cosa quasi mai possibile.
2.11. Obiettivi di una corretta gestione delle risorse
Alcune delle principali idee di base
della gestione delle risorse possono
essere descritte dal grafico in Figura.
All'aumentare dello sforzo di pesca
(numero pescherecci, potenza
motori, attrezzi più efficienti ecc.) le
catture (quantità di pesce sbarcato)
in un primo momento aumentano e
poi diminuiscono. Questa parabola
può variare nei singoli casi ma la sua
forma generale è abbastanza costante. I costi di produzione invece in generale crescono in
maniera lineare rispetto allo sforzo di pesca: ad esempio più barche, più giorni di pesca, portano
ad un maggior consumo di carburante.
Si possono quindi definire diversi obiettivi della gestione delle risorse ittiche, che non sempre sono
completamente coincidenti per le diverse categorie che ruotano attorno al mondo della pesca e il
risultato dovrà quindi per forza essere una specie di compromesso.
1. Obiettivo biologico: rendimento massimo sostenibile (Maximum Sustainable Yield, MSY),
cioè il tentativo di massimizzare la cattura in peso. Trovare cioè il livello di sforzo di pesca
corrispondente al massimo di catture ottenibili e sostenibili nel lungo periodo.
2. Obiettivo economico: massimo rendimento economico sostenibile, cioè massimizzare il
rendimento economico della pesca amplificando al massimo il divario tra il valore delle
catture e i costi di produzione. In generale si trova ad un livello di sforzo di pesca inferiore a
quello corrispondente al rendimento massimo sostenibile (MSY), perché ad un certo punto i
costi crescono più velocemente dell'aumento delle catture ottenibili.
14 di 58Il Fenomeno Pesca
3. Obiettivo sociale: ottimizzazione del numero di posti di lavoro, spesso in contrasto con
tutti e due gli obiettivi biologico ed economico. Questo obiettivo non può essere illustrato da
un semplice diagramma, poiché la sua complessità è data dalla natura dello sforzo di pesca.
Ad esempio supponendo, in maniera molto semplificata, che due barche da 500 cavalli
abbiano la stessa capacità di cattura di una barca da 1000 cavalli, il risultato biologico
(catture di pesce) sarà lo stesso, ma probabilmente i costi di produzione saranno superiori
per la somma dei consumi delle due barche da 500 cavalli, e quindi il rendimento economico
sarà migliore con una barca sola da 1000. Invece, a livello occupazionale, il risultato sarà
migliore con due barche, non solo perché raddoppiano gli equipaggi ma anche perché tutto
l'indotto (cantieri, retieri, forniture navali ecc.) si avvantaggia avendo un maggior numero di
barche.
2.12. Strumenti della gestione
La gestione delle risorse si basa su due strumenti principali:
- la regolamentazione dello sforzo di pesca
- la regolamentazione della taglia e dell'età di prima cattura degli stocks ittici.
2.12.1 Regolamentazione dello sforzo di pesca
Si basa su quanto descritto nel paragrafo precedente (vedi Fig.) e si può effettuare attraverso:
a) la limitazione del numero, della potenza e delle dimensioni delle imbarcazioni, come, ad
esempio, l'introduzione del sistema di licenze a numero chiuso per le vongolare. In altri paesi
questo sistema è stato applicato in maniera diversa rispetto all'Italia: le licenze sono in vendita
stagione per stagione ad un prezzo stabilito dal governo. Anche gli incentivi alla demolizione per lo
strascico si devono considerare misure di controllo dello sforzo di pesca. Oppure il controllo di
potenza e dimensioni massime delle imbarcazioni; in teoria sarebbe quasi sempre più corretto
considerare la potenza motore, ma poiché questa è più facilmente alterabile delle dimensioni
spesso si ricorre a questa più semplice misura.
b) la limitazione delle catture, stabilendo quantità (quote) massime di pesce sbarcabili. Queste
quote possono essere individuali (per barca, o per barca/ giorno) come per le vongole, o collettive,
relative cioè ad un'intera flotta o nazione, come per i tonni. La determinazione delle quote si basa
generalmente su un parere scientifico di un organismo nazionale o internazionale che considera lo
stato di salute presente e le possibili proiezioni nel futuro di un determinato stock ittico. Questo
parere viene trasmesso all'amministrazione (nazionale o comunitaria) che considerando anche la
situazione socio-economica e le dichiarazioni statistiche (obbligatorie) dei quantitativi catturati
negli anni precedenti, stabilisce una quantità pescabile in quel dato anno e la suddivide in quote
nazionali, oppure per tipologia di flotta. In questo modo le nazioni che hanno flotte più grandi e
15 di 58Il Fenomeno Pesca
con maggiori catture hanno diritto ad una quota più alta. In Mediterraneo questo sistema è stato
adottato solo per il tonno, ma nel Mare del Nord è in uso da parecchi anni anche per molte specie
demersali (catturate dallo strascico) come merluzzo, sogliola ecc.
c) la limitazione del tempo di pesca, mediante l'istituzione di periodi di fermo e la definizione di
un orario giornaliero e/ o settimanale di pesca. È intuitivo come questa misura di controllo dello
sforzo sia la più semplice da adottare in quanto, a differenza delle quote, non richiede un controllo
delle quantità pescate, ed inoltre si adatta bene alla realtà della pesca mediterranea dove le
imbarcazioni usano spesso attrezzi diversi durante l'anno e catturano molte specie differenti.
d) la limitazione o la proibizione totale delle attività di pesca in aree specifiche come la fascia
costiera, i parchi marini e le zone protette. Questo allo scopo di salvaguardare gli stadi giovanili di
alcune specie, oppure le zone di concentrazione di riproduttori, o comunque di istituire delle zone
in cui la densità di risorse ittiche sia più alta per cui poi queste risorse possono diffondersi nelle
zone circostanti per fenomeni naturali come la migrazione.
2.12.2 Controllo della taglia e dell'età alla prima cattura
Si basa su un concetto fondamentale nell'ambito della biologia della pesca e della dinamica delle
popolazioni ittiche. (Vedi Figura).
Dato un quantitativo di pesci nati più o meno nello stesso periodo (una "coorte" o classe di età), il
numero degli individui diminuisce con il tempo a causa della mortalità, ma i singoli individui
(sopravvissuti) crescono di peso per l'accrescimento corporeo individuale. Quindi per un certo
periodo di tempo il peso totale della classe di età crescerà, per poi diminuire quando
l'accrescimento corporeo rallenta e non è più in grado di compensare per le perdite numeriche
dovute alla mortalità. Idealmente si dovrà quindi cercare di pescare quando la classe di età è al
massimo del suo peso totale. Inoltre si deve tener presente che gli individui giovani (piccoli) non
sempre hanno raggiunto la maturità sessuale e quindi è buona regola stabilire una taglia di prima
cattura che permetta ad una consistente porzione della classe di età di arrivare alla riproduzione.
Questo controllo della taglia e dell'età di prima cattura si attua attraverso regolamenti sulla
dimensione della maglia delle reti, degli ami, delle draghe, e sui limiti di taglia minima negli sbarchi
per le singole specie.
16 di 58Il Fenomeno Pesca
2.13. Ricerca applicata alla gestione delle risorse
Compito della ricerca applicata alla pesca è di fornire il miglior supporto dal lato biologico ed
ecologico alle decisioni gestionali. In Italia le principali ricerche sulla pesca sono finanziate nell'
ambito della legge 41/ 82, oppure con finanziamenti comunitari erogati dalla Direzione Generale 14
(pesca) o dalla Direzione Generale 12 (ricerca) della Commissione Europea.
Un breve elenco per tematica dei principali tipi di ricerche finanziate dalla legge 41 nel corso dei
vari piani triennali:
1. Risorse demersali: trawl survey o campagne di prospezione sulle risorse della pesca a
strascico
2. Risorse bentoniche: campagne di prospezione sugli stocks di vongole
3. Risorse pelagiche: ecosurvey o prospezioni acustiche, raccolta dati statistici di cattura e
sforzo per i piccoli pelagici (pesce azzurro); dati statistici, campagne di marcatura per i
grandi pelagici (tonni, pesce spada ecc.)
4. Ricerche sulla tecnologia e sulla selettività degli attrezzi da pesca
5. Ricerche sull'impatto degli attrezzi da pesca sull' eco sistema
6. Ricerche sugli aspetti socioeconomici di pesca e acquacoltura
7. Ricerche di biologia e tecnologia in acquacoltura
2.14. Dinamiche di popolazione
Affinchè sia possibile gestire le risorse ittiche sfruttate dalla pesca è necessario avere una stima
della disponibilità delle medesime in mare. Tali stime possono essere effettuate mediante differenti
metodi, tra cui quelli di dinamica di popolazione, che tengono conto del prelievo della risorsa
effettuato dalla pesca, sia perchè lo stesso non è trascurabile, sia perchè si possono meglio
comprendere quali sono le indicazioni da trarre per la gestione della risorsa.
17 di 58Il Fenomeno Pesca
In generale, i metodi della dinamica di popolazione applicati alla gestione delle risorse ittiche
consentono di stimare le dimensioni degli stock. In alcuni casi, qualora siano disponibili dati relativi
agli stadi più giovani e cioè alle taglie più piccole, i metodi di dinamica possono anche consentire di
stimare le dimensioni dell'intera popolazione.
Per definizione la dinamica di una popolazione animale o vegetale è l'evolversi nel corso del tempo
del numero di individui che costituiscono la popolazione. Si basa su relazioni matematiche tra il
numero di individui in un certo periodo di tempo (t) e il numero di individui nel periodo successivo
(t+ 1). Tale relazione tiene conto del bilancio dei nati e dei morti all'interno della popolazione, ed
eventualmente, se opportuno, dei flussi migratori (immigrati ed emigrati). Gli aspetti relativi ai
morti, ai nati e ai flussi migratori rappresentano il campo di studio specifico della demografia.
In alcuni casi può essere necessario tenere conto anche dell' accrescimento corporeo degli
individui e si esprime quindi la quantità di individui in peso: la biomassa (chilogrammi, tonnellate).
Questa dipende chiaramente sia dal numero di individui che dal loro accrescimento corporeo.
La dinamica di popolazione può essere studiata tenendo conto non solo del tempo ma anche delle
modalità con cui gli individui si distribuiscono all'interno dello spazio in cui la popolazione vive. Nel
caso delle specie sfruttate dalla pesca, questo ulteriore aspetto può avere particolare importanza
se esistono aree in cui la specie vive ma in cui il prelievo da parte dell'uomo è modesto o
inesistente, perché tecnicamente difficoltoso o illegale, come accade nelle zone protette.
Le problematiche a cui si applica la dinamica di popolazione sono svariate. La popolazione può
essere costituita da batteri coltivati su una piastra contenente materiale nutritivo, sui quali si voglia
testare l'efficacia di un antibiotico, ma anche dal popolo di una nazione o da tutti gli esseri umani
del pianeta: capire come cambia il numero di persone ha interesse nella gestione delle risorse
alimentari ed energetiche. E ancora, possiamo esaminare la dinamica di una popolazione di insetti
che infestano colture agricole e, naturalmente, di pesci, molluschi e crostacei pescati dall'uomo. Ne
consegue che la dinamica di popolazione ha molto spesso uno stretto legame con l'ecologia,
ovvero la scienza che studia i rapporti tra gli esseri viventi e tra questi e l'ambiente in cui vivono.
Una popolazione può presentare comportamenti molto diversi tra loro. Il numero di individui
aumenta, diminuisce, rimane costante nell'arco di tempo in cui noi la osserviamo. Ma possiamo
anche osservare tutte queste modalità: si dice che la dimensione della popolazione fluttua nel
tempo. Più è grande l'intervallo di tempo di osservazione e maggiori sono le probabilità di
osservare simili fluttuazioni.
Queste possono essere dovute a cambiamenti verificatisi nell' ambiente in cui vive la popolazione:
un drastico abbassamento della temperatura può modificare il bilancio tra nati e morti a sfavore
dei nati, in modo tale da provocare un declino della popolazione. La dinamica di una popolazione
non è influenzata soltanto dai fattori chimico-fisici dell' ecosistema, ma anche da quella delle
18 di 58Il Fenomeno Pesca
popolazioni di altre specie: possono essere dovute ad esempio a ripetute aggressioni alla
popolazione studiata da parte di un parassita o di un agente patogeno.
Le fluttuazioni possono essere regolari o meno: nel primo caso gli aumenti così come le
diminuzioni si verificano al trascorrere di intervalli di tempo all' incirca uguali. L'entità delle
alterazioni del numero di individui può essere variabile o relativamente costante. Fluttuazioni
regolari possono essere legate ad esempio a cambiamenti che si verificano nell'ambiente secondo
il ciclo delle stagioni.
L'aumento o la diminuzione del numero di individui al trascorrere del tempo, tendenzialmente, non
segue l'andamento di una linea retta. Un disegno esplicativo a riguardo è riportato in Figura,
mentre il grafico ne illustra l'andamento: il numero degli individui che formano la popolazione
(asse verticale del grafico) aumenta al trascorrere del tempo espresso in anni (asse orizzontale).
Nei primi anni la linea appare retta con buona approssimazione, poi curva.
Per comprendere il motivo di questo comportamento è utile far riferimento a un semplice
ragionamento basato sui numeri di pesci disegnati nella Figura 1. Si immagini di avere una
popolazione, all'anno 0 (in cui iniziano le nostre osservazioni), costituita da 4 individui: il bilancio
tra i nati e morti è a favore dei nati e tale da consentire un raddoppio di questo piccolo nucleo
iniziale al trascorrere di un anno, per cui nell'anno 1 avremo 8 individui. Il bilancio tra nati e morti
mantiene invariate le sue caratteristiche in modo da consentire un ulteriore raddoppio della
popolazione al trascorrere di un altro anno: avremo perciò, nell'anno 2, una popolazione di 16
individui. La dimensione della popolazione continua a raddoppiare finchè il bilancio tra nati e morti
non cambia. L'aumento del numero di individui, tuttavia, non è sempre lo stesso al trascorrere dei
diversi anni: dall'anno 0 all'anno 1 la popolazione aumenta di 4 unità, ma dall'anno 1 all'anno 2
aumenta di 8. L'incremento è più grande nel secondo caso, sebbene il tempo trascorso sia lo
stesso. Qualcosa di simile è presente anche nella curva della Figura 2: nel passare dal quarto al
19 di 58Il Fenomeno Pesca
quinto anno la popolazione aumenta di circa 1000 individui, mentre dal settimo all'ottavo anno
l'aumento è di circa 4000. Tale incremento diviene sempre più grande man mano che gli anni
passano.
Nella Figura 3 abbiamo due curve, a e b: nel primo caso la crescita del numero di individui è meno
veloce che nel secondo, in conseguenza di un bilancio tra nati e morti positivo ma inferiore
numericamente. Nella Figura 4 i morti superano i nati e la popolazione declina fino all' estinzione,
sempre secondo un andamento non rettilineo.
L'accrescimento della popolazione riportato nelle Figure 2 e 3 ha una sua espressione matematica
e viene detto esponenziale (declino esponenziale in Figura 4). Esso rappresenta tanto la modalità
di accrescimento quanto il modello più semplice pensato per descrivere la dinamica di una
popolazione. Il modello esponenziale descrive bene determinate situazioni, ma non tutte, cosa che
del resto vale per tutti i modelli matematici impiegati in
dinamica di popolazione. Il principale punto debole di
tale modello è evidente: si suppone che
l'accrescimento della popolazione sia illimitato. Tale
affermazione non è certo realistica.
Da questo punto di vista, il modello logistico mostrato
nella Figura 5 rappresenta un perfezionamento del
modello esponenziale. Si osserva infatti che il numero
di individui aumenta al trascorrere degli anni in modo simile a quello previsto dal modello
esponenziale, ma, progressivamente, questa velocità rallenta fino a quando la dimensione della
popolazione si stabilizza intorno a un valore costante (200000 individui nella figura). Questo valore
massimo oltre il quale la popolazione non cresce più viene chiamato capacità portante ed è
espressione del fatto che le risorse di cibo, acqua, spazio vitale non sono disponibili all'infinito per
gli individui di una popolazione.
Le due curve di crescita previste dai modelli esponenziale e logistico costituiscono i due primi passi
effettuati dalla ricerca scientifica nel campo della dinamica di popolazione.
20 di 58Il Fenomeno Pesca
A seconda della specie o persino o della popolazione esaminata è necessario utilizzare un modello
matematico piuttosto che un altro. Può essere addirittura necessario pensare un modello
matematico per il problema specifico che si affronta. Infine, un modello matematico può descrivere
bene l'andamento di una popolazione pur essendo costruito su presupposti non proprio esatti. Il
modello sarà utile in questo caso per effettuare delle stime (es. abbondanza di uno stock ittico) ma
non per capire in profondità i veri meccanismi che governano la dinamica. Nel caso della dinamica
di popolazione delle specie ittiche sfruttate dalla pesca si utilizzano modelli maggiormente
complessi dei modelli esponenziale e logistico.
Nella Figura 6 sono mostrate le stime della biomassa (tonnellate) dello stock di alici nell' Adriatico
centrale e settentrionale effettuate dai ricercatori dell'IRPEM, relativamente al periodo 1975-1996.
Queste stime sono state ottenute utilizzando due differenti metodi di dinamica di popolazione.
Nonostante i modelli matematici alla base di questi due metodi sfruttino differenti tipi di
informazione sullo stock, i valori di biomassa stimata e l'andamento con cui questa varia nel tempo
sono simili. Il valore minimo di biomassa dello stock di alici è stato ottenuto per il 1987, quando c'è
stata una vera e propria e crisi della pesca delle alici vissuta dalle marinerie adriatiche. Nello stesso
anno si è avuto anche il valore minimo nelle catture di alici stimate dall'IRPEM per tutta l'Italia, la
Slovenia e la Croazia (circa 4000 tonnellate). Sebbene lo stock di alici si stia riprendendo (sempre
Figura 6), non si osservano valori di biomassa elevati come quelli stimati nella seconda metà degli
anni settanta.
Come accennato sopra, i dati utilizzati dai modelli matematici applicati alla dinamica di popolazione
delle specie pescate possono appartenere a differenti categorie. I dati relativi al prelievo della
risorsa sono i più importanti: sono i cosiddetti dati di cattura e rappresentano la mortalità
provocata nello stock dalla attività di pesca. Le quantità sbarcate non sempre però coincidono con
la cattura perché esiste il cosiddetto scarto, che è la parte di cattura (specie, quantitativi e/ o
taglie) che viene rigettata subito in mare perché, non trovando collocazione sul mercato, non è
economicamente valida. Ad esempio, secondo una stima dell'IRPEM, in Adriatico i quantitativi
21 di 58Il Fenomeno Pesca
ributtati in mare di sardina di piccola taglia nel periodo 1987-1999 variano dalle 900 alle 4000
tonnellate annue.
Non solo i fattori economici influenzano il prelievo di risorse ittiche da parte dell'uomo, ma anche
quelli socio-politici. Ad esempio, nella Figura 7 sono riportati i dati di cattura relativi allo stock di
sardine nell' Adriatico centrale e settentrionale, relativamente al periodo 1975-1999 (raccolti ed
elaborati dall'IRPEM). Si può notare un più netto declino delle catture presso le marinerie delle
coste slovene e croate a partire dal 1990, che non è stato causato da un crollo della biomassa di
sardine in mare, ma dagli eventi bellici che hanno interessato quei paesi.
Oltre alla mortalità nello stock dovuta alla pesca è necessario tenere conto anche di quella dovuta
a cause cosiddette naturali, utilizzando diversi parametri tra cui, ad esempio, la durata massima
della vita. Un esempio di elevata mortalità naturale è costituito dal calo degli stock di alici del mar
Nero e del mar d'Azov, di cui si ritiene sia responsabile, almeno in buona parte, uno Ctenoforo
(piccoli animali planctonici simili, a grandi linee, alle meduse) introdotto accidentalmente
dall'oceano Atlantico. La sua azione negativa è dovuta alla predazione di uova e larve di alice e alla
competizione per il cibo (plancton) con gli adulti. Poiché nel mar Nero non c'è un predatore di
questa specie di ctenofori (come avviene invece nell' ambiente originario), la sua introduzione
accidentale ha provocato un incremento della mortalità naturale dello stock.
A volte invece si può trattare della comparsa massiccia di microrganismi in grado di uccidere talune
specie di pesci, come è avvenuto per le morie di proporzioni catastrofiche verificatesi nel 1991 in
alcuni estuari del Nord Carolina e del Maryland (USA, oceano Atlantico) a carico soprattutto delle
aringhe.
Un dato molto importante utilizzato dai metodi di dinamica di popolazione applicata alle risorse
ittiche, è costituito dallo sforzo di pesca, ovvero dalla "intensità" con cui il predatore uomo cerca di
catturare la preda, che nella fattispecie è rappresentata dallo stock. Lo sforzo è direttamente
proporzionale al numero di imbarcazioni impegnate nell' attività di pesca, al numero di giornate di
pesca (è quindi influenzato anche dalle condizioni meteorologiche), alle dimensioni delle
imbarcazioni, alla tecnologia presente a bordo delle stesse (es. eco-scandaglio), alla potenza
motore che consente all'imbarcazione maggiori spostamenti, ecc.
Il rapporto tra la cattura e lo sforzo di pesca costituisce un indice dell' abbondanza della risorsa in
mare. Per spiegare questo concetto facciamo ricorso al seguente esempio ipotetico: la flotta
peschereccia adriatica cattura, nell' anno A, 40000 tonnellate di sardine impiegando a tale scopo
uno sforzo di pesca pari a x. Con stesso sforzo di pesca x, nell' anno successivo B, la flotta cattura
un quantitativo di sardine pari a 20000 tonnellate. Ci sono buoni motivi per pensare che la
disponibilità in mare dello stock di sardine sia diminuita nell' anno B, dal momento che a parità di
sforzo di pesca la cattura si è dimezzata. Il rapporto tra cattura e sforzo riassume numericamente
tutto questo.
22 di 58Il Fenomeno Pesca
Altre informazioni utilizzate dai metodi di dinamica di popolazione riguardano l'accrescimento
corporeo (lunghezza e peso) e l'età. Ovviamente, questi dati non possono essere raccolti sull'
intero stock, bensì su piccole porzioni rappresentative della realtà presente in mare (campioni).
Una delle funzioni dei dati relativi all' accrescimento corporeo è quella di trasformare in numero di
pesci i dati di cattura normalmente espressi in peso, poiché molti metodi di dinamica si basano su
modelli matematici che effettuano i loro calcoli in termini di numero di pesci. Il risultato, cioè la
stima dell'abbondanza della risorsa in mare effettuata con questi metodi è pure espressa in
numero di individui e richiede altre informazioni sull'accrescimento per essere trasformata di nuovo
in peso, cioè in biomassa in mare.
Conoscere l'età degli individui che compongono una popolazione equivale in genere a disporre di
una informazione preziosa ai fini dello studio della sua dinamica, essendo le leggi con cui si
manifestano i fenomeni naturali (morte, riproduzione) fortemente legate all'età. Un banale
esempio ne renderà subito un'idea: si immagini il destino di una popolazione composta da individui
non più in età idonea per la riproduzione!
Il metodo principale utilizzato per conoscere l'età di un pesce consiste nella lettura delle squame o
degli otoliti. É importante sapere che, durante le diverse fasi di accrescimento, il carbonato di
calcio si deposita più o meno velocemente in maniera concentrica in queste strutture, in modo
sostanzialmente analogo a quanto accade per gli alberi. Generalmente, nel corso di un anno si ha
la deposizione di due anelli, uno chiaro (accrescimento veloce) e uno scuro (accrescimento lento).
Infine, un parametro importante nella dinamica di popolazione applicata agli stock ittici è
rappresentato dall'indice di reclutamento. Le reclute sono quegli individui giovani che entrano a far
parte dello stock, che è la frazione di popolazione che viene pescata. Conoscendo la lunghezza e
l'età delle reclute, si può calcolare l'indice di reclutamento annuale che consente di avere un'idea di
quanti giovani individui si aggiungono ogni anno allo stock.
Il reclutamento è tanto più grande quanto più elevate sono le probabilità di sopravvivenza che
hanno i giovani prima di entrare nello stock. Tali probabilità sono fortemente condizionate da
parametri biologici (disponibilità di cibo, intensità della predazione, ecc.) a loro volta influenzati da
parametri ambientali (correnti marine, temperatura, ecc.) che possono variare notevolmente di
anno in anno. Ne consegue che la dinamica di uno stock ittico presenta anch'essa, nella maggior
parte dei casi, ampie fluttuazioni.
Tutto ciò dà un'idea di quanto sia complesso e articolato lo studio della dinamica di una
popolazione e di quante competenze esso richieda (matematiche, statistiche, biologiche,
oceanografiche, ecc.).
23 di 58Il Fenomeno Pesca
3. LA GESTIONE DELLA FASCIA COSTIERA
3.1. Definizione di fascia costiera
Dal punto di vista giuridico la fascia costiera viene definita come quell'area di mare compresa
all'interno della batimetrica dei 50 m o delle tre miglia dalla costa, laddove i fondali sono poco
profondi e degradano lentamente verso il largo.
Dal punto di vista bionomico essa rappresenta gran parte del sistema litorale, estendendosi dal
sopralitorale, che è la zona interessata dagli spruzzi del moto ondoso, all'infralitorale, ovvero quella
zona il cui limite inferiore coincide con la possibilità di esistenza delle alghe fotofile e delle
fanerogame marine e quindi varia in base al grado di penetrazione della luce che dipende, a sua
volta, dal grado di trasparenza dell'acqua. Tale area è interessata, innanzitutto, dalla variabilità dei
parametri fisico-chimici quali, ad esempio, temperatura e densità delle acque che, a causa della
bassa profondità dei fondali e degli apporti fluviali, possono subire notevoli variazioni nel corso dell'
anno rispetto alle acque del largo.
Un' altra caratteristica della fascia costiera è costituita dalla grande varietà di ambienti marini in
essa presenti. Particolare, ad esempio, il biotopo della prateria di Posidonia oceanica, che un
tempo era molto diffuso nei mari italiani, compreso l'Alto Adriatico, mentre attualmente è presente
solo in aree limitate a causa di diversi fattori, come l'inquinamento e la pesca a strascico, in
particolare la pesca con i rapidi che, arando il fondo con le loro lame, sradicano la vegetazione
esistente.
Inoltre, nella fascia costiera hanno luogo processi bio-ecologici di vitale importanza per l'ambiente
marino quali: apporto di nutrienti e di particellato organico tramite corsi d'acqua, scarichi urbani e
dilavamento del terreno dovuto alle piogge; organicazione dei sali minerali grazie all' attività
fotosintetica dei vegetali (alghe e fanerogame marine), con il conseguente innesco delle catene
trofiche; distribuzione dell'energia primaria (nutrienti), secondaria (vegetali) e terziaria (animali)
nei diversi reticoli trofici dell'ecosistema marino tramite fenomeni come la migrazione delle specie,
la predazione, le correnti e il moto ondoso.
Infine, da un punto di vista socio-economico, la fascia costiera è l'area in cui opera la piccola pesca
locale con tutti gli attrezzi che la caratterizzano (reti da posta, nasse, nassini per gasteropodi, ecc.)
e che sono altamente validi dal punto di vista ecologico in quanto non sono inquinanti, non
danneggiano i fondali e presentano una notevole selettività sia nei confronti delle specie che delle
taglie catturate. All'interno di tale area vengono però svolte sia altre forme di pesca, quali la pesca
dei bivalvi con draghe idrauliche e, anche se illegalmente, la pesca a strascico, che altre molteplici
attività, come ad esempio il turismo nelle sue diverse espressioni (balneazione, pesca, immersioni).
Pertanto, nell' ambiente marino, la fascia costiera rappresenta l'area maggiormente soggetta
24 di 58Puoi anche leggere