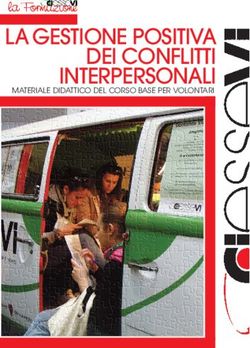La crisi dell'antico regime in Francia 1774-1788
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Roberto Moro
La crisi dell'antico regime in Francia 1774-1788
Parte II
La crisi istituzionale e finanziaria
Opposizione parlamentare e lotta politica - La monarchia assoluta e lo stato -
Deficit e debito pubblico - Gli ultimi ministri
1. Opposizione parlamentare e lotta politica
Nell'ultimo secolo dell'antico regime la vita politica della Francia è
dominata da due organismi che costituiscono il tessuto istituzionale del regno: la
monarchia assoluta con il suo governo, i suoi ministri e un vasto apparato di
funzionari delegati, alla quale compete tutto il potere legislativo ed esecutivo, e
i parlamenti, tribunali superiori dotati di una certa autonomia cui competono il
potere giudiziario e la tutela dei valori morali del regime. L'assenza di una
costituzione scritta, il fenomeno di espansione delle istituzioni, la
sedimentazione storica e le alterne vicende della lotta politica avevano tuttavia
confuso a tal punto le competenze di questi organismi, l'evoluzione dell'assetto
sociale ne aveva così corroso l'individualità e trasformata la struttura da opporre
parlamenti e monarchia e renderli diretta pressione di quella tensione sociale
che attraverso molte incertezze e ambiguità andava da tempo crescendo e
maturava nel ventennio pre-rivoluzionario.
NATURA E COMPETENZA DEL PARLAMENTO. Tribunali istituiti
per rendere giustizia in nome del re, i parlamenti e primo fra tutti il parlamento
di Parigi, nucleo e centro della opposizione al governo, altro non erano alla loro
origine (secoli XIV-XV) che organi della monarchia cui spettava di registrare e
dare esecuzione ai decreti dell'autorità sovrana, ma col tempo essi avevano
conquistato il diritto, o per lo meno imposto la consuetudine, di giudicarli nel
merito, suggerirvi modifiche e impugnarne la legittimità respingendoli (droit de
remontrance). A tanto potere e autonomia, una vera e propria « sovranità »
secondo l'ideologia parlamentare, si era giunti nel corso dei secoli in forza della
1trasformazione dello stato feudale in monarchia assoluta. Proprio per condurre
la sua lotta contro i signori feudali, la monarchia fin dal XIII secolo aveva
costruito un apparato burocratico centralizzato di amministrazione della
giusitizia e ne aveva aperto le porte agli uomini del Terzo italo. E siccome
l'eminente funzione della magistratura dava titolo di nobiltà, accanto
all'aristocrazia di nascita era sorta una nuova aristocrazia di toga che a poco a
poco si era insinuata e definitivamente radicata nel regime del privilegio. Poi,
bisognosa di danaro e costretta a ricorrere alla vendita di cariche e uffici per
impinguare le casse dello stato, la corona aveva progressivamente allargato
l'area di questo nuovo strato sociale complicandone la struttura e accrescendo le
competenze dell'istituzione fino a perderne il controllo. La confusione tra
servizio pubblico e proprietà privata, cui da luogo la venalità degli uffici, aveva
infine trasformato la nobiltà di toga in una sorta di corporazione dominata dallo
spirito di casta e alla ricerca di poteri sempre più vasti, di una assoluta
autonomia, di un attivo ruolo politico. Con la venalità dell'ufficio i magistrati,
creditori di uno stato che non avrebbe mai potuto risarcirli, avevano ottenuto
l'inamovibilità, poi pagando esclusivo di cooptazione nella compagnie che li
aveva allontanati gradualmente dalla loro condizione di origine confondendoli
sempre più nei ranghi dell'aristocrazia. Nei secoli XVII e XVIII l'autorità dei
circa 2000 magistrati che affollano i parlamenti è immensa. Polizia,
legislazione, finanze, assistenza pubblica, istruzione, organizzazione della
reggenza, cassazione di testamenti regi, disciplina ecclesiastica, problemi
religiosi, interpretazione degli statuti, giustizia civile e penale in ultimo appello,
costituzione del regno: non vi è materia che sfugga alla competenza reale o
presunta delle corti sovrane che avocano, intervengono, aprono inchieste e su
tutto giudicano o almeno sputan sentenze. Ne consegue un prestigio per il
magistrato che lo pone al centro della scena sociale e attrae tanto la nobiltà
quanto la borghesia che nella professione della magistratura intravede il più
efficace strumento di ascesa. Ma nel XVIII secolo i 12 parlamenti di Francia
chiudono sistematicamente le porte al Terzo stato. Il fenomeno, già in corso sul
finire del XVII secolo, è nel 1770 un fatto compiuto, e ormai per ambire a una
carica occorrono quasi ovunque le prove dei 4/4 di nobiltà. L'aristocrazia di toga
si confonde così definitivamente con la nobiltà di corte e di spada e ne segue i
destini condividendone la lotta politica e il tentativo di operare una
restaurazione feudale. Con metodo e tono diverso però.
IDEOLOGIA PARLAMENTARE. Più matura e meditata, più articolata
e complessa di quella aristocratica, l'ideologia parlamentare si eleva di molto al
di sopra del semplice e brutale sentimento di classe che aleggia sulla corte e in
seno alla retriva nobiltà di campagna, ricerca alleanze, costruisce un vasto
apparato dottrinario fatto di mediazioni e temporeggiamenti, sviluppa una tattica
precisa e un modello di comportamento politico.
Giuristi sottili e ostinati, educati all'arte del cavillo e della severa
eloquenza, gelosi del loro prestigio e abili nello sfruttare tutto il potere che la
posizione di giudice può dare in una società in cui il diritto non è codificato, i
parlamentari posti a mezza strada tra il popolo e il monarca si assumono il ruolo
di rappresentanti della nazione presso il trono a mano a mano che il potere e la
popolarità degli Stati generali declinano e la loro indefinita proroga lascia la
nazione lenza garanzie e il potere senza freno. E nel XVIII secolo fi assiste
all'ingigantirsi, nello spirito parlamentare, di una profonda vocazione politica
che trova le sue basi in una dui trina capace di assicurare al parlamento un ruolo
di (rbitro nella vita del paese. La Francia, secondo l'ideologia purliimentare, ha
2un governo monarchico temperato da un nucleo di « leggi fondamentali » che
fissano in modo inde-ronnbile i limiti del potere regio e ne dettano la pratica di
((«verno. Consuetudinarie e mai assoggettate a una formale codificazione,
queste leggi sono il risultato di un patto tra un/ione e monarca stipulato nelle
assemblee nazionali, gli Stilli generali, alle quali solo compete di decidere circa
il mutamento costituzionale del regno. In loro assenza le lois fondnmentales
sono affidate al parlamento, organo essenziale del sistema politico, che ha il
compito di controllarne la Applicazione o denunciarne la violazione. Così i
magistrati divengono l'« autorità tutelare » della nazione, i rappresen-liinti del
popolo, i garanti della pace e del bene dei sudditi contro le intraprese del potere
che, sviato da cattivi amministratori o degenerato rispetto alla sua primitiva
funzione, può divenire arbitrario o dispotico. In questo caso la magistratura ha il
dovere di opporsi al potere e il conseguente diritto di respingere l'applicazione o
sospendere l'esecuzione di ogni legge, decreto o ordinanza, anche a firma regia,
emanati dal governo. Che cosa poi in concreto siano queste leggi fondamentali
l'ideologia parlamentare non si è curata di definirlo, ma l'idea che della nazione
si fanno i magistrati non lascia dubbi circa la natura della loro vocazione
politica. Nazione è un insieme di corpi e di ordini organizzati gerarchicamente,
a ciascuno dei quali compete una porzione di potere crescente e decrescente a
seconda della posizione occupata nella gerarchla sociale; privilegi e dignità per-
sonali o di gruppi sociali sono dunque parte essenziale della nazione e devono
riflettersi nel sistema politico. Si tratta insomma della società pluralistica di
ordini dell'antico regime che i parlamentari ritengono principiare appunto
dall'antica struttura degli Stati generali.
Ma ciò che più conta nel valutare il peso e la posizione del parlamento alla
fine dell'antico regime è por mente al fatto che l'idea di dispotismo appena
abbozzata dall'aristocrazia trova in questo strato sociale una sua precisa
dimensione giuridica e politica e che il parlamento costituisce in fondo una sorta
di opposizione costituzionale, pubblica e ufficiale, legalizzata dalla natura stessa
della istituzione e ormai codificata in una precisa procedura.
L'OPPOSIZIONE FINO AL 1774. Infatti, non meno dell'ideologia,
anche l'azione politica, la tattica di opposizione del parlamento hanno raggiunto
piena maturità nell'ultimo secolo dell'antico regime. In sintesi, e dimenticando le
infinite sfumature giuridico-procedurali che può recare in sé, l'azione del
parlamento si sviluppa nel modo seguente: il decreto che gli vien sottoposto per
la registrazione è ritenuto contrario alle leggi fondamentali, ai diritti della pro-
vincia o di una certa comunità, ai privilegi o allo status di una certa persona? il
parlamento deciderà di impugnarlo chiedendone la modificazione o
l'annullamento. Il sovrano, se non intende ritirarlo, potrà seguire la via della
immediata repressione o semplicemente riproporlo ordinandone la registrazione.
Un nuovo rifiuto da parte della corte porrà in atto il meccanismo repressivo
della monarchia assoluta che può giovarsi di due strumenti: il Letto di giustizia
o lo scioglimento, o entrambi. Nel Letto di giustizia la monarchia dispiegava
tutta la sua forza: chiamati al cospetto del monarca, che con la sua presenza
annulla il potere del parlamento (revocando quella che, secondo la dottrina dello
assolutismo, altro non è che una volontaria delega di potere), dei principi del
sangue e dei Pari di Francia, delle più alte autorità dello stato, sorvegliati dalla
guardia del rè, impediti di parlare ad alta voce, i magistrati subivano l'umi-
liazione di vedersi costretti alla registrazione. A volte, in caci più gravi e specie
per i lontani parlamenti di provincia, la procedura repressiva era più spiccia e
brutale. Munito di mandati sovrani, il governatore, militare prelevava i ma-
3gistrati e li inviava in esilio nelle loro terre o in qualche sperduto villaggio. Ma,
trascinati nella loita, i parlamenti avevano pur sempre armi estreme per
rispondere al potere regio: gridando al dispotismo, alla costituzione violata, po-
tevano richiedere la solidarietà di tutta la magistratura e scatenare uno sciopero
giudiziario in tutto il regno tale da paralizzare la vita del paese; investendosi del
loro ruolo di rappresentanti della nazione e dispiegando un'abile propaganda
potevano infine sollevare la popolazione, creare disordini e violente rivolte. La
nobiltà parlamentare disponeva infatti, grazie alla sua elastica dottrina dagli
accenti popolari e a volte quasi democratici, di una vasta rete di solidarietà a
cominciare dalla sua clientela diretta: la borghesia forense, saldamente legata
alla magistratura e a questa moralmente sottomessa. Nei momenti di tempesta
l'ordine degli avvocati forniva le truppe di prima linea al parlamento e allora i
5000 avvocati del regno potevano trascinare nella lotta migliala di procuratori,
notai praticanti, organizzare la resistenza di tutte le magistrature inferiori, di
piccoli ufficiali e buoni borghesi che al conflitto davano proporzioni
preoccupanti. Facendo leva sui residui dello spirito regionalista, richiamando in
vita il ricordo delle antiche autonomie provinciali e cittadine solo a stento
soffocate dall'assolutismo, il parlamento poteva scuotere le città e risvegliare
intere province alla vita politica. Allora con la corruzione, l'intimidazione e
promesse di perdono, trattative sotterranee e concessioni reciproche tra governo
e parlamentari, a poco a poco ritornava la calma.
Solo Luigi XIV aveva trionfato su questa turbolenta noblesse de robe e
sull'istituto parlamentare, vera spina nel fianco dell'assolutismo. Le corti «
sovrane » erano state declassate a semplici corti « superiori » nel 1684 e nel
1687 avevano perso il diritto di rimostranza. Per il resto del regno l'opposizione
parlamentare era morta. Ma nel 1715 la politica e il vento di fronda avevano di
nuovo fatto irruzione nei tribunali portandovi tutte le loro passioni, gli intrighi,
l'eccitazione del dibattito. L'alleanza tra aristocrazia di corte e noblesse de robe
era stata naturale e immediata; mentre i parlamenti riacquistavano il diritto di
rimostranza, a Parigi i magistrati cassavano il testamento del defunto monarca e
decretavano la legittimità della reggenza riaffermando il loro essenziale ruolo
politico. Poi era ricominciata la lotta che avrebbe seguito nel corso del secolo
due principali direttive: la costante censura della gestione finanziaria del regno e
quindi la ostinata opposizione a ogni tentativo di accrescere la pressione fiscale,
e la riaffermazione dell'universalità delle competenze del parlamento e quindi
l'opposizione a ogni riforma istituzionale. Nel 1715 sui problemi finanziari era
subito cominciata l'opposizione alla reggenza che si doveva trascinare per
qualche anno. Nel 1725 nuova opposizione a riforme fiscali che coinvolge molti
parlamenti del regno. Poi negli anni '30 fu sui problemi della religione che la
magistratura diede battaglia. La guerra di successione austriaca aveva per
qualche tempo annullato l'opposizione, ma nel 1750 l'azione parlamentare aveva
ripreso a ostacolare il governo e col tempo assunse una tale violenza da indurre
il monarca, per evitare la paralisi del sistema, a estreme decisioni. Il parlamento
di Parigi fu disciolto e una riforma generale della magistratura fu varata per
abolire definitivamente l'opposizione parlamentare. Ma le corti sovrane erano
troppo intimamente connesse al tessuto istituzionale della monarchia di antico
regime e l'assolutismo ormai troppo debole per trasformare se stesso. Luigi
XVI, richiamando in vita i parlamenti, nel 1774 ripristinava l'opposizione.
2. La monarchia assoluta e lo stato
4All'origine di questa accanita opposizione vi è un fatto essenziale: la
monarchia del XVIII secolo non corrisponde in nulla all'idea che di essa si
fanno gli ordini privilegiati. Essa segue ormai, per forza di inerzia, una linea di
sviluppo tracciata da secoli e giunta a una sorta di apice con l'assolutismo di
Luigi XIV.
La lenta evoluzione della monarchia francese può essere rappresentata
schematicamente in tré tappe fondamentali che segnano gli otto secoli della sua
storia. Dapprima la monarchia feudale indiretta in cui il potere monarchico si
manifesta solo indirettamente sull'insieme della nazione essendo il rè nient'altro
che il primo tra i nobili, il più ricco e più potente, ma sempre situato all'intemo
del rango signorile. Poi la monarchia temperata caratterizzata dal primato della
regalità sulla nobiltà feudale, in cui il potere regio si appoggia su molteplici
strutture sociali e istituzionali facendo opera di mediazione fra i conflitti degli
ordini. Infine la monarchia assoluta divenuta indipendente non solo nei
confronti della nobiltà ma anche nei confronti del Terzo stato, una monarchia
che sovrasta l'intera nazione e governa tramite un corpo di funzionari.
NATURA E IDEOLOGIA DELL'ASSOLUTISMO. Fin dal XVII secolo si
assiste al trionfo della monarchia assoluta. Lo stato prevale sulla nazione, quasi
l'assorbe, e si assume tutte 'e incombenze della vita pubblica. L'assolutismo
però, in guanto sistema politico, non è mai stato oggetto, nella sua pratica, di
una semplice codificazione o di una interpretazione univoca. Nella prima metà
del Seicento, ad esempio, due cardinali ministri hanno fatto prevalere, per un
certo tempo, una forma di governo in cui il primo ministro, ricevendo una
delega revocabile d'autorità, governa all'ombra dell'autorità regia; dopo il 1661,
Luigi XIV impone invece una formula del tutto diversa in base alla quale il
potere regio, raccolto nella persona fisica del monarca, riposa sui ministri e sui
consiglieri ma senza accettare la preminenza di nessuno dei corpi subordinati
dello stato. Solo la volontà del monarca decide nelle scelte politiche e nella
pratica di governo, e questa volontà finirà per affermare che « in Francia la
nazione non è nulla al di fuori della persona fisica del monarca ». Il paese e lo
stato si piegano dunque di fronte alla regalità, si volgono al suo esclusivo
servizio e con essa si identificano in virtù di una visione del mondo che vuole la
vita sociale essere un ordinato meccanismo gerarchico frutto di un supremo
disegno celeste.
Una simile concezione che riconosce al monarca un sacro mandato divino
segnava il punto estremo di una crisi sociale alla quale già si era giunti nella
prima metà del Seicento quando l'aristocrazia feudale in declino, ma ancor
troppo forte per essere distrutta, e i ceti borghesi in ascesa, ma resi deboli da una
sfavorevole congiuntura, si erano impegnati in un drammatico conflitto dagli
incerti obiettivi politici che aveva rischiato di affondare lo stato e il paese negli
orrori della guerra civile. Allora, nell'angoscia della lotta, gli spiriti si erano
volti a una istituzione che garantisse la pace sociale, e la monarchia aveva
costituito ancora una volta la più sicura mediazione tra le accese fazioni e i
sotterranei odi di classe. arto sulle rovine del mondo feudale e del declino della
aristocrazia, lo stato di Luigi XVI doveva tuttavia rappresentare proprio la
sublimazione del sentimento aristocratico; la manifestazione più chiara e più
elevata dell'aggressività, della volontà di comando intollerante di ogni controllo
e di ogni contraddizione del primo tra i nobili del regno su un popolo di sudditi.
« Reputazione, gloria, grandezza, dignità », e tutto quanto ancora si può
raccogliere nel concetto intraducibile di éclat, erano infatti i sentimenti per-
sonali, tratti dall'ideologia aristocratica, di cui il monarca, incapace di sfuggire
5al suo proprio modello di autocrate, si era posto al servizio. Il « mestiere di rè »,
come appunto lo precisava Luigi XIV nelle sue « Memorie al Delfino »,
consisteva nella consapevolezza dell'onnipotenza regia, missione divina del
comando sulla terra, nella possibilità di conoscere le cose segrete e in una
assoluta potestà di influire sulle vicende umane, in cui ne l'economia del paese,
ne tanto meno la vita materiale dei sudditi costituivano materia di governo.
Distruggendo i poteri feudali e le autonomie locali, cristallizzando le libertà
municipali, questa volontà, repressiva più che produttiva, aveva finito col far
prevalere sull'antica suddivisione in ordini la massa indifferenziata dei sudditi e
il tentativo di organizzarla aveva dato luogo a una prima immagine del
totalitarismo inteso appunto come organizzazione delle masse in relazione
diretta alla persona investita del potere. « Solo nella mia persona risiede il
poetre sovrano, — afferma a metà del secolo Luigi XV — a me solo appartiene
il potere legislativo senza menomazione alcuna ne divisione; tutto l'ordine
pubblico emana da me, e i diritti e gli interessi della nazione, di cui si osa fare
un corpo separato dal monarca, sono per natura uniti nelle mie mani, riposano
nella mia persona, ne io devo conto ad alcuno ». Era questa l'ideologia
dell'assolutismo affermatasi nel XVII secolo e alla quale ancora si ispirava
Luigi XVI quando nel 1789 dichiarava agli Stati generali di essere « l'unico e il
solo rappresentante legale della nazione ». E tuttavia, frutto di circostanze
eccezionali, favorito dalla nevrosi della dissoluzione che dominava la società
del Seicento, dallo stato di guerra, da un assetto economico precario,
l'assolutismo del Rè Sole non trovava più nel XVIII secolo le condizioni per la
sua esistenza. Inoltre, sotto i suoi successori, molto meno appassionati al potere,
meno dediti alle fatiche del governo e dell'etichetta, meno certi forse della loro
missione, l'assolutismo doveva rivelare tutte le sue debolezze e i suoi limiti. Fin
dal 1715, lu scomparsa fisica del Rè Sole e la minorità di Luigi XV, nonché
nuove condizioni economiche rendono impossibile nei fatti una guida univoca
della cosa pubblica e l'assolutismo resta un vissuto psicologico più che una
realtà; le maglie del sistema si mostrano larghe, la corte ribelle, i parlamenti
incontrollabili, la scalata al potere possibile; funzionali e ministri riacquistano,
al riparo dell'incerta volontà dei sovrani, una sorta di autonomia; la lotta e l'in-
trigo politico si generalizzano e si trasmettono a tutte le elites. Nel linguaggio
come nell'ideologia della risorta opposizione aristocratica e parlamentare questa
formula monocefala di governo, che ha però perso il controllo del suo stesso
corpo, assume una precisa fisionomia politica: l'assolutismo diviene «
dispotismo », violazione del patto originario tra monarca e nazione, arbitraria
prevaricazione degli istituti costituzionali e delle leggi fondamentali che la
tradizione ha nel corso dei secoli codificato. E anche la macchina dello stato,
lenta e corrotta, groviglio inestricabile di competenze e apparato burocratico in
perenne conflitto, favorisce la similitudine tra questa monarchia degenerata e il
« dispotismo orientale », vaga formula con cui i letterati e gli scienziati politici
del tempo indicano il sistema di governo dei lontani imperi asiatici nemici della
libertà.
Di fatto però l'assolutismo aveva tentato di distruggere, assai di rado aveva
veramente rinnovato; aveva insomma aggiunto nuove funzioni e nuovi istituti
mutilando solo parzialmente il vecchio edificio feudale del paese. Così, accanto
all'apparato centralizzato, erano sopravvissute le ve-stigia delle antiche
autonomie regionali e cittadine; ai vecchi organismi amministrativi si erano
aggiunti nuovi corpi di funzionar!, e questo confuso esercito di burocrati, quasi
un nuovo ordine in seno alla vecchia gerarchia sociale, appariva ormai alla
6mentalità razionalistica e critica del nuovo secolo, al suo empirismo borghese,
null'altro che un caos solo apparentemente organizzato. A cominciare da quella
casa reale, una sorta di ministero dedito alla persona del monarca, la cui
complessa struttura doveva rispondere al disegno assolutistico di organizzare
l'aristocrazia di corte in modo da controllarla, da piegarla alla volontà del
sovrano annullandone ogni forza politica.
LA CASA REALE. Potenziata negli ultimi decenni del regno di Luigi
XIV, la Maison du Roi, ministero posto al vertice della gerarchia politica e
amministrativa dell'antico regime, consta nel Settecento di 22 ripartizioni
suddivise a loro volta in una miriade di sottocomitati che raccolgono uno stuolo
di circa 20.000 aristocratici mantenuti a Versailles a spese della corona e dello
stato. Grande casa, musica del rè, cappella comune, servizi di camera, bocca del
rè, guardaroba, alloggio, grandi scuderie, piccole scuderie, equipaggi di caccia
ecc. sono altrettanti organismi burocratici cui è demandato il compito di
assicurare il funzionamento della corte e dell'etichetta, cioè quell'insieme di
procedure cerimoniali che devono sempre ricordare l'assoluta preminenza del
monarca e la sacralità della sua persona. Allo stesso modo la « Casa militare del
rè », in una decina di reggimenti (gendarmeria della guardia del rè, guardia del
corpo, cavalleggeri, moschettieri neri, moschettieri grigi, guardia francese,
guardia svizzera ecc.), raccoglie 10.000 aristocratici di « razza » il cui compito
si esaurisce in variopinte parate, caroselli, fastosi servizi di guardia. Stipendi e
pensioni cospicue e il fasto della corte avevano richiamato, all'epoca di Luigi
XIV, il meglio dell'aristocrazia a Versailles, le avevano fatto brigare incarichi e
funzioni in questo articolato ministero in cui l'onore di servire il rè si accompa-
gnava all'umiliante rinuncia della propria individualità e autonomia di classe;
ma dal 1715 la nobiltà e la corte avevano in parte abbandonato Versailles e la
casa reale si era ben presto trasformata in un groviglio di fazioni e piccole
clientele in lotta tra loro, fonti di costante debolezza per l'istituto monarchico.
Governo e ministri. Non solo la corte del resto palesava profonde fratture e
agiva quale forza centrifuga del potere monarchico; lo stesso governo, minato
dalla confusione di potere legislativo ed esecutivo, risultava nel XVIII secolo
difficile da controllare. Quattro importanti consigli teoricamente presieduti dal
sovrano (il consiglio di stato, il consiglio degli interni, il consiglio delle finanze,
il consiglio privato) e sei ministeri (delle finanze, della guerra, della marina,
degli esteri, della casa reale, della giustizia) assor-hivaho la quasi totalità delle
funzioni e dei poteri pubblici. All'epoca di Luigi XVI i consigli erano stati
ridotti a un ruolo esclusivamente consultivo, i ministeri agivano in un mnbito di
competenze ristrette; la vecchia aristocrazia era mata allontanata dalle cariche
più importanti, e ministri e consiglieri, nominati dal monarca e forniti di una
delega revocabile, di potere, si erano trasformati in fedeli strumenti della
volontà regia. Ma, anche qui, con la fine del governo personale del Rè Sole e
con l'accresciuta complessità delle funzioni di governo questi organismi
avevano riconquistato uno spazio politico. Mutevoli nelle loro competenze, i
consigli avrebbero dovuto solo sottoporre al rè chiarimenti e utili indicazioni ai
fini di una visione generale della politica. Alcuni consigli però, particolarmente
specializzati, come quelli delle finanze e degli interni, rappresentavano qualcosa
di più: erano organismi burocratici che collazionavano e preparavano testi,
raccoglievano dati, prospettando soluzioni difficili da deformare o criticare
nell'insieme; il loro ruolo pertanto non era più puramente consultivo. Ingigantiti
nella loro dimensione, anche i ministeri possedevano una sorta di autonomia,
avanzavano programmi di riforma, usavano criteri discrezionali
7nell'applicazione di ordinanze e regolamenti, e in più di un caso godevano di un
vero potere decisionale.
Alla periferia e nelle province gli agenti dell'assolutismo erano gli
intendenti (una trentina in tutto il territorio nazionale) che, dotati di vasti poteri,
si sostituivano al vecchio apparato dell'amministrazione feudale. Costoro
operavano attraverso un esercito di sottointendenti, intendenti aggiunti e
sottodelegati, il cui controllo sfuggiva ormai al monarca e al governo. Scelti per
lo più tra famiglie di recente nobiltà o addirittura borghesi e nominati dal
monarca su segnalazione di ministri, cortigiani e grandi ufficiali, questi
funzionari sono all'origine di costanti polemiche e vivaci conflitti tra le province
e il potere centrale. Le loro competenze, che vanno dalla ripartizione e
percezione delle imposte, al contenzioso amministrativo, alla regolamentazione
dei servizi di polizia, fino alla tutela dei domini della | corona, alla revisione dei
conti delle municipalità, alla nomina e revoca di ufficiali subalterni, al controllo
della leva militare, urtano infatti e sovrastano i poteri di magistrature che, pur
mutilate o svuotate delle loro funzioni, preesistevano all'assolutismo e a questo
sono sopravvissute come i governatori, i tribunali locali e le specifiche
istituzioni regionali, provinciali e cittadine.
LE AUTONOMIE LOCALI. Di questi istituti antichi e un tempo vitali
che avevano caratterizzato la monarchia temperata, l'assolutismo ne aveva
risparmiati ben pochi. Nella seconda metà del XVII secolo, come i parlamenti
avevano perso il diritto di rimostranza, così le province avevano perso i loro
Stati provinciali (periodiche assemblee dei tré ordini organizzate a imitazione
degli Stati generali), le città le loro assemblee cittadine. Sindaci e consiglieri
municipali erano divenuti semplici funzionar! nominati dal rè e le cariche da
elettive si erano trasformate in venali, a volte ereditarie. Ma il ricordo delle
antiche autonomie non era andato perduto e contro la spinta accentratrice
dell'assolutismo esso doveva ingigantire nel corso del Settecento. I parlamenti
sapevano poi alimentare questo ricordo e chiamare a raccolta i superstiti relitti
delle antiche autonomie (le corporazioni urbane e le assemblee dei notabili) per
organizzare un fronte di opposizione al governo e al potere.
L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA. Infine, del Confuso
mondo della giustizia al suo più alto grado, cioè a livello parlamentare, già si è
detto. Sfiorando appena il mondo delle magistrature inferiori, fortemente
subordinate al parlamento, vi scorgiamo un groviglio di cariche e uffici in cui a
stento gli storici delle istituzioni e del diritto riescono a orientarsi. Giudici regi,
avvocati del rè, procuratori, notai, costituiscono, come si è detto, un corpo
intermedio in cui si riflette più direttamente la tensione sociale del secolo. Qui,
come negli altri settori dello stato assoluto, aristocrazia e borghesia si
fronteggiano congiungendosi o contrapponendosi in una politica di alleanze che
contribuisce a rendere ancor più precario l'assetto istituzionale, vanificando,
nella realtà, quella concentrazione di potere nelle mani del monarca che le
dottrine assolutiste continuano a proclamare.Prestigio e declino della
monarchia. Eppure, nonostante questi elementi di disgregazione, l'istituto
monarchico e lo stato assoluto vivono nelle coscienze, e questa immensa
concentrazione di potere stupisce e sovrasta le menti del tempo. La natura
monarchica dello stato è indiscutibile come è indiscutibile il potere in sé, e
nessun autore giungerà,prima della rivoluzione, a formulare una dottrina
repubblicana che si adatti in concreto alla società francese.
Nel corso del secolo gli spiriti più avveduti sanno riconoscere nel modello di
monarchia temperata proposta dalla nobiltà di spada e di toga una impossibile
8operazione storica dal sapore decisamente reazionario. Così la generazione che
non ha vissuto gli anni oscuri del regime del Rè Sole, e accetta il primato della
nazione sullo stato e sul monarca, o l'idea di una costituzione che tracci
chiaramente i confini tra autorità legittima e potere arbitrario, ritiene di poter
mettere a profitto l'assolutismo rovesciando i principi su cui è sorto e dunque
senza ricorrere alle antiche istituzioni feudali. Non più il popolo al servizio del
monarca, bensì il monarca al servizio del popolo; non più il mestiere di rè,
peraltro impossibile da esercitare in presenza di un organismo ormai troppo
complesso, ma una vera e propria professione di rè intesa come azione sociale
ispirata dalle leggi e dal metodo della ragione. Il vasto apparato amministrativo
dispiegato da Luigi XIV e cementato dai suoi successori attrae la cultura
dell'illuminismo. Seppure imprecisa alla coscienza del tempo, l'immagine della
futura società industriale trova qualcosa che le è proprio nello stato centralizzato
e autoritario cui si attribuisce il potere di piegare tutto ai suoi fini. Così il
dispotismo diviene, per i sostenitori dello stato e della nazione contro le pretese
restauratrici dell'aristocrazia, uno strumento duttile, possibile da plasmare e
volgere verso un obiettivo di radicale rigenerazione dello stato. Nella prima
metà del secolo nasce la dottrina del « dispotismo illuminato » o « dispotismo
legale » in base alla quale il monarca, arbitro assoluto della vita politica ma
naturalmente conquistato agli ideali di libertà e di progresso del secolo,
dovrebbe operare da sé la trasformazione della società e dare corso a vasti
programmi di emancipazione civile. Nell'entusiasmo della favorevole
congiuntura economica e nel clima di ottimismo diffuso dalla prorompente
cultura dei lumi, questa dottrina e le speranze che suscita avevano assunto
consistenza; le alites borghesi, prudenti e sospettose nell'aderire all'opposizione
antiassolutistica dell'aristocrazia, l'avevano fatta propria con fiducia offrendo
un'ultima concreta opportunità di alleanza tra Terzo stato e monarchia. E
l'avvento di Luigi /XVI, rè celebrato per la sua bontà d'animo, alieno dal fasto
della corte e dagli obblighi dell'etichetta, rè « borghese » per il suo tenore di vita
dimesso e quasi meschino, virtuoso nei suoi affetti familiari, sembra per un
attimo dare concreto fondamento alla dottrina del dispotismo illuminato. Ma il
richiamo dei parlamenti, il fallimento delle riforme proposte da Turgot avevano
sollevato seri dubbi sulla validità della dottrina. L'idea di un sovrano illuminato
e legislatore naufragava già intorno agli anni '70 in un clima di diffuso
pessimismo. La crisi economica del ventennio pre-rivoluzionario avrebbe poi
avuto un effetto decisivo sui giudizi dell'opinione pubblica in merito
all'assolutismo e alla monarchia. Di fronte alla recessione questo sistema
politico e istituzionale, sempre bisognoso di danaro e perennemente insolvente,
cominciava ad apparire nulla più che un debito per il paese, una tratta spiccata
sul futuro della nazione. Di fatto la crisi istituzionale della monarchia assoluta
aveva già toccato il suo culmino e sfocia in una drammatica crisi finanziaria che
apre la strada alla rivoluzione.
3. Deficit e debito pubblico
Quanto costa al paese l'apparato istituzionale dell'antico regime? Nel
1715, alla morte del Rè Sole, le spese dello stato si aggirano intorno ai 147
milioni, ma il debito pubblico supera l'enorme cifra di 1200 milioni, pari forse a
due intere annate di reddito nazionale, a 8-10 anni di entrate. Sulla carta la
monarchia e la corte inghiottono poco più di 7 milioni e mezzo, ma anche le
altre voci della pubblica spesa celano una quantità di stipendi, pensioni, prov-
videnze e vari emolumenti riservati al mondo dei privilegiati, aristocratici o
9borghesi che siano. Così 6 milioni se ne vanno in pensioni, 6 e mezzo in « affari
segreti », 6 sono riservati alla nobiltà di spada, 15 agli stipendi della nobiltà di
toga, più di tré costituiscono il costo di funzionamento del consiglio regio, 1
tiene in vita le legazioni diplo-m.itlche anch'esse riservate alla nobiltà, i 18
milioni della marina coprono a stento le spese di un enorme apparato
burocratico, e così via. Sprovvista del sentimento di avere Un qualunque dovere
nei confronti del paese, la monarchia gestisce il patrimonio nazionale come un
gran signore gestisce) la propria rendita, con prodigalità e incuria.
IL SISTEMA FISCALE. Di fronte a questo regime di spese crescenti e
improvvise il sistema fiscale e i metodi di prelievo si mostrano del tutto
inadeguati a raccogliere i capitali. Le imposte dirette fanno leva sulla «taglia»,
antichissima imposta di origine feudale, che grava per intero sulla popolazione
rurale. Vessatoria e arbitrariamente ripartita, raccolta con infinite difficoltà e
lungaggini burocratiche, essa frutta poco più di 40 milioni nel 1715 e,
nonostante gli sforzi di tutti gli amministratori, resta costante per tutto il corso
del secolo. La «capitazione» (imposta pro capite) e il «decimo» (imposta sul
decimo del reddito individuale), più eque e teoricamente dovute da tutti i sudditi
senza eccezione di rango, sono in pratica così mal applicate e tanto
sistematicamente evase da rendere poco più di 50 milioni e gravare anch'esse
per la maggior parte sulla popolazione rurale, quasi una taglia aggiuntiva.
L'esercito di amministratori preposto alla riscossione di queste imposte dirette
frena ogni sforzo di innovazione e al tempo stesso alimenta lo spirito antifìscale
proprio all'antico regime. 34 uffici di finanza, 32 tribunali di elezione, 450
ricevitori generali e 31 intendenti che operano attraverso uno stuolo di
sottodelegati si disputano l'ammontare delle imposte dispiegando una
innumerevole quantità di conflitti di competenza, giudiziari e amministrativi,
che rendono impossibile il controllo dell'intera amministrazione, la tenuta di
registri contabili e il flusso costante delle entrate. Non meno caotico il sistema
delle imposte indirette: la « gabella » (imposta sul sale), gli «aiuti» (che
raggruppano numerose imposte di consumo), i diritti di dogana, l'imposta sul
tabacco, e altre ancora minori, numerosissime e settoriali, frutto di consuetudini
e tradizioni antiche o comparse in circostanze eccezionali e poi tenute in vita
dalla costante esigenza di danaro della monarchia assoluta. Date in appalto ogni
sei anni a lotti (ferme generale} o singolarmente (fermes particulières),
assicurano allo stato un introito immediato sul capitale versato in cauzione dagli
appaltatori (fermièrs); ma al tempo stesso questa procedura favorisce, in
presenza di una classe politica e di una i burocrazia avida e corrotta, la
speculazione. Infatti al fine di raccogliere i capitali necessari per vincere le gare
di appalto il fermièr è costretto a ricorrere al prestito previsto trasformandosi in
un banchiere in grado di assicurare cospicui interessi ai suoi creditori. Egli
cercherà quindi in ogni modo di rifarsi sul contribuente estendendo al massimo
la pressione fiscale. Secondo una inchiesta dell'epoca rivoluzionaria la sola
ferme generale avrebbe reso più di mille milioni tra il 1715 e il 1789. Soldi che
sarebbero affluiti nelle tasche di poche centinaia di persone. Dopo il 1770 il go-
verno cercherà più volte di distruggere il sistema di appalto tentando una diretta
gestione, ma simili interventi toccavano interessi ben consolidati e pertanto
fallirono. Comunque il reddito delle fermes cresce nel corso del secolo.
L'aumento della produzione e del consumo, l'accresciuta circolazione delle
merci triplicano il valore degli appalti (la ferme generale passa dai 48 milioni
del 1715 ai 150 del 1789), ma con essi crescono le spese dello stato in tale
misura da vanificare ogni beneficio.
10Infine, i rimedi straordinari di cui l'antico regime dispone per aumentare le
entrate sono peggiori del male. Al di là di un aumento della pressione delle
tasse, diretta o indiretta, che il paese non sembra più in grado di sopportare e il
cui risultato pare sempre incerto agli amministratori e al governo, e in assenza
di una capacità o volontà riformatrice del sistema, la monarchia dispone del
ricorso al prestito e della vendita di cariche e uffici. La fede profonda nell'isti-
tuto monarchico, la generale convinzione circa la smisurata ricchezza della
corona rendono ancora nel XVIII secolo possibile un ricorso al prestito. Biglietti
di stato a buon tasse» di sconto, rendite vitalizie e a termine costituiscono un;i
mercé sempre richiesta in un secolo in cui « vivere borghesemente » significa in
fondo vivere di rendita sugli interessi del proprio capitale. Prestare allo stato ad
alto interesse, istituire una rendita vitalizia per i propri figli è dunque una
operazione abbastanza comune nella Francia dell'ani iqo regime. La vendita di
uffici, dunque di impieghi nella pubblica amministrazione, nell'esercito e nella
giusti-xia, praticata con misura nel corso del Settecento, costituisce Infine un
mezzo sicuro per raccogliere capitali che solo col tempo verranno rimborsati
sotto forma di stipendi; ma in questo modo il fardello delle spese si ingigantisce
sul lungo periodo, i guasti e gli intoppi della burocrazia si moltipllcano, il corpo
dello stato insomma si ammala divenendo quella macchina impossibile da
governare che appunto è la monarchia assoluta del XVIII secolo.
È stata infatti l'utilizzazione indiscriminata di questi strumenti eccezionali negli
ultimi decenni del regno di Luigi XIV a ridurre l'erario in condizioni rovinose
dalle quali non si risolleverà più. Nel 1715, di fronte a un debito pubblico di
1200 milioni (così ripartito: 137 di anticipazioni sulle entrate future, 185 di
arretrati, 600 di biglietti di stato, 542 di uffici da rimborsare) e a una spesa
corrente di 147 milioni, il governo dispone di una entrata netta di 69 milioni
(quella lorda di 165 essendo gravata da anticipazioni e altre somme da versare
per interessi sui prestiti). Deficit: 77 milioni.
LA POLITICA FINANZIARIA. Per fronteggiare la drammatica
situazione di bilancio la scienza finanziaria dell'antico regime disponeva di
quattro classici strumenti: la bancarotta, la riduzione delle spese, il ricorso al
prestito, l'aumento della pressione fiscale. Ma nel XVIII secolo il marasma era
tale e il dissesto tanto cronico da rendere inefficaci queste misure.
La bancarotta aveva solo parzialmente salvato lo stato e la monarchia
negli anni della reggenza. Una svalutazione nel 1715 e la riduzione forzata del
debito pubblico ai danni dei creditori avevano a stento contenuto il disavanzo.
Un programma di economie e l'abolizione di un certo numero di uffici avevano
dato poco respiro e diffuso un generale malcontento tra gli aristocratici e i
borghesi colpiti dai provvedimenti. Durante la gestione finanziaria del duca di
Borbone (1722-1729) si era fatto ricorso a qualche espediente fiscale
richiamando in vita vecchi diritti feudali , (come il « diritto di lieto avvenimento
»), ma era anche stata necessaria una nuova svalutazione per portare il deficit
alla cifra, denunciata nel 1724, di soli 4 milioni, cifra peraltro piuttosto
inverosimile e certo ampiamente approssimativa per difetto. Poco o nessun
effetto avevano invece sortito i tentativi di riforma fiscale. Poi il ministro Fleury
ricorse al prestito con l'emissione di rendite e la vendita di uffici (1733), misure
alquanto onerose per lo stato; il tentativo di accrescere la pressione fiscale con
una nuova imposta generale diretta (il decimo) risultò vano e una ondata di
imposte indirette salvò dalla catastrofe la monarchia. Ma nonostante questi
espedienti, intorno agli anni '50 il deficit denunciato era di 30 milioni e la guerra
dei sette anni faceva salire il disavanzo a 130 milioni.
11Tutti gli amministratori si rendevano conto delle necessità di una imposizione
che colpisse equamente i contribuenti e raggiungesse anche i redditi
dell'aristocrazia e di tutti coloro che erano a vario titolo coperti dal regime del
privilegio, ma la vivace opposizione del parlamento che impugnava per
incostituzionalità ogni decreto fiscale e lo spirito di restaurazione aristocratica
che aleggiava a corte e penetrava nel governo resero vano ogni tentativo di
riorganizzazione del sistema. Alla fine del 1769 le casse dello stato erano vuote
ne si sapeva di che pagare le spese dell'anno che stava per cominciare. « Sono
atterrito dal pericolo imminente in cui si trova lo stato » affermava Terray
nell'assumere la gestione finanziaria. Per salvarsi egli diede un nuovo giro di
vite: ricorse al prestito, alla riduzione forzata del debito pubblico, alla vendita di
cariche, e a tutta la forza dello stato per appesantire la pressione fiscale. Misure
affannose, caotiche e contraddittorie, dettate dalle imminenti necessità, misure
che allontanavano solo il pericolo suscitando malessere e gravando infine sul
buon andamento dell'economia. Nonostante ciò nel 1774 il deficit si era
stabilizzato intorno ai 40 milioni.
Un'inversione di tendenza rispetto ai consueti metodi di gestione
finanziaria intervenne con la designazione di Turgot a ministro delle finanze
(1774). Di origine borghese, colto e illuminato, Turgot aderiva alla dottrina del
dispotismo illuminato. Poco seducente e animato da un entusiasmo interiore,
amministratore esperto e buon politico, era salito al governo con un programma
da tempo costruito e pazientemente meditato: « nessuna bancarotta, nessun
aumento di tasse, nessun prestito », solo le riforme del sistema economico e
fiscale, nuove istituzioni politiche e civili avrebbero dovuto sanare il bilancio e
assicurare prosperità alla nazione. Di riforme già se ne erano tentate nel corso
del secolo, piccoli esperimenti erano stati avviati in sede locale, ma Turgot
proponeva un piano globale, anteponeva la nazione al tesoro regio e,
preoccupato forse dei primi sintomi della sfavorevole congiuntura, subordinava
i problemi finanziari a una generale ripresa della vita economica che lo stato
avrebbe dovuto e potuto promuovere. Nei suoi obiettivi le li forme fiscali si
confondevano con quelle economiche e sociali suggerite dalla filosofia dei lumi.
Così il sistema di appalto delle imposte dirette era stato smembrato e sottoposto
a severi controlli; tra mille difficoltà e resistenze era stato liberalizzato il
commercio del grano; le tasse più onerose per la produzione erano state ridotte e
si avanzava l'idea della creazione di un catasto così da permettere una più equa e
rigorosa percezione delle imposte dirette. Altre riforme erano allo studio quando
l'abolizione della corvée regia, vero colpo al sistema feudale, e la decisione di
sciogliere le corporazioni di mestiere per liberalizzare il mercato del lavoro
suscitarono una opposizione insormontabile. Nobiltà, clero e parlamento si
erano coalizzati ancora una volta al fine di evitare l'evoluzione del sistema. Essi
denunciarono l'incostituzionalità delle riforme, le mire dispotiche del ministro,
la palese violazione dei privilegi degli ordini e dei diritti della nazione, e la loro
forza congiunta aveva sopraffatto il governo e la buona volontà del monarca.
4. Gli ultimi ministri
CLUGNY. Il licenziamento di Turgot (avvenuto il 12 maggio 1776) fu
per molti il segnale della fine; alle menti più illuminate pareva ormai chiaro che
l'antico regime non avrebbe più avuto la forza di riformare se stesso. La crisi
economica era cominciata e con essa la reazione feudale; il deficit dello stato,
solo a stento contenuto dalla politica riformatrice (nel 1776 le entrate erano
stimate a 378 milioni, le spese superavano i 402 milioni), incombeva su tutto
12rendendo la monarchia incapace di governare. Allontanato Turgot, la reazione
aristocratica minacciava di scatenarsi su vasta scala: si parlò di possibili rivolte,
si minacciò una formale richiesta degli Stati generali; il programma di riforme
fu definitivamente accantonato e una vivace campagna di stampa accusò la
monarchia di intenti dispotici e rivo-luzionari.
A livello ministeriale, lo strumento di questa reazione fu Clugny, già
intendente di Bordeaux, noto per la sua corruzione e le sue immoralità, e per
qualche mese ministro delle finanze. Costui ritornò ai vecchi espedienti: una
lotteria reale, che raccolse una decina di milioni, avrebbe dovuto assicurare il
pareggio del bilancio. Ormai alla dissestata monarchia di Luigi XVI mancava
solo una guerra per rendere incolmabile il deficit, ed era appunto la guerra di
indipendenza americana quella in cui la Francia si impegnava nel luglio del
1776. Sul piano della spesa pubblica gli effetti di questa guerra furono
sicuramente decisivi (gli stanziamenti della marina passarono da 32 a 72
milioni, per l'esercito da 64 a 67); crollò il credito pubblico e le azioni delle
compagnie di stato registrarono un calo pauroso; i debiti contratti e i prestiti
accordati al giovane stato d'oltre oceano avrebbero gravato per più di vent'anni
sul bilancio dello stato.
Intanto Clugny moriva (18 ottobre 1776) e le speranze della nazione come della
monarchia, entrambe timorose della reazione aristocratica, si volgevano a
Jacques Necker, chiamato a dirigere le finanze del regno.
NECKER. Borghese, straniero, protestante, Necker aveva tutte le
caratteristiche per dispiacere all'aristocrazia. Ma questo uomo venuto dal nulla,
piccolo impiegato di banca ginevrino che pure aveva saputo costruirsi con
abilità e tenacia una immensa fortuna, filantropo incline agli ideali dell'illumi-
nismo, impersonava quel modello del grande banchiere, del finanziere-
banchiere, capace di soggiogare i ceti borghesi conquistandone la fiducia.
Ottimista e rassicurante fino a essere superficiale, egli non dispiaceva neppure
ai sovrani e al governo bisognosi di appoggio in quei difficili frangenti. Se non
la vanità almeno l'ambizione avevano cementato in lui il desiderio di piacere,
costi quel che costi, e di guadagnare il favore dell'opinione pubblica, cioè delle
borghesie che in fondo non avevano condiviso l'audace politica riformatrice di
Turgot i cui lontani orizzonti erano percepibili solo agli intelletti più acuti.
Forse, al di là delle inclinazioni emotive, vi era nella costante ricerca di
popolarità di Necker quel tanto di sfiducia nella dottrina del dispotismo
illuminato che bastava a renderlo consapevole della potenza ici ceti borghesi;
governare senza il loro appoggio era ormai impossibile. Ma il nuovo ministro
non fu all'altezza «.lei suo compito e non seppe utilizzare sino in fondo la
popolarità e il consenso di cui godeva.
Da banchiere qual era egli usò il suo credito per ricorrere al prestito e il
prestito fu lo strumento privilegiato e quasi esclusivo della sua gestione. Così tra
il 1776 e il 1781, cartelle di rendita e biglietti di stato fecero la loro ricomparsa
trionfalmente in Francia e inondarono il mercato finanziario. A tassi di interesse
rovinosi per lo stato i prestiti furono incessantemente lanciati e registrarono
sollecite quanto numerose sottoscrizioni. 24 milioni sono raccolti nel 1776, 25
l'anno successivo, poi 48 milioni nel 1778, altri 10 nell'81. Ma a questi prestiti
diretti e ufficiali, registrati dal parlamento, se ne devono aggiungere molti altri
indiretti e sollecitati dal ministro a mezzo di complesse operazioni finanziarie
che non mancarono di gonfiare oltre misura il debito pubblico. Sicuramente
questo credito accordato allo stato trova la sua spiegazione nella particolare
congiuntura economica. Il ristagno dei prezzi e della produzione agricola, i
13disagi suscitati dalla reazione signorile favoriscono lo spostamento di capitali e
il loro utilizzo a tassi di interesse così elevati (10-25%) da richiamare anche
capitali stranieri. Necker dal canto suo cercava di rafforzare il credito dello stato
rassicurando il pubblico con promesse e facilitazioni di ogni genere: buona parte
degli interessi sarebbero stati esenti da imposte e non si sarebbe fatta una
emissione « senza aver assicurato l'interesse dei creditori »; « le economie e le
riforme compiute nel settore delle finanze — si affermava in un editto del 1779
— hanno assicurato un esatto pareggio tra le entrate e le spese fisse e ordinarie
». Seguendo questa strada pericolosa si giungeva infine al Rendiconto del 1781.
Per la prima volta nella storia di Francia il bilancio dello stato veniva reso pub-
blico, stampato e diffuso in migliaia di esemplari. L'opuscolo, consistente in
un'ampia prefazione in cui Necker faceva l'apologia di se stesso e nelle tabelle
contenenti le voci particolareggiate della spesa e dell'entrata, denunciava una
entrata di 264 milioni e una spesa di 254 milioni. Il deficit risultava dunque
colmato, lo stato libero da impegni mostrava tutti i sintomi di una imminente
prosperità, dopo un secolo di timori la nazione e la monarchia erano salve e
solide. La popolarità di Necker toccava il suo apice e una ulteriore richiesta di
prestito di 70 milioni registrava una offerta di 100.
Si è a lungo discusso sul Rendiconto di Necker, e il suo confronto con altri
dati reperibili ha sollevato polemiche circa la buona o la mala fede del ministro.
In realtà il prospetto di bilancio concerneva solo le spese ordinarie e fisse dello
stato; la labilità delle procedure contabili del tempo e l'assenza di organici criteri
nella stesura degli atti finanziari assolvono in parte il ministro dalle accuse più
dure. Tuttavia il Rendiconto non rispecchiava per nulla la reale situazione della
finanza pubblica. Conti più precisi e completi denunciano, per il 1781, 437
milioni di entrate e 527 milioni di spesa con un passivo di 90 milioni; per il
debito pubblico si è avanzata la cifra di 600 milioni, frutto in buona parte dei
debiti contratti da Necker. Ma il guasto maggiore prodotto dalla politica di
questo ministro stava altrove: non sappiamo in cifre quanto sia costato
all'economia francese questo drenaggio di capitali; sicuramente però esso
contribuì ad aggravare la congiuntura stornando capitali dai settori della
produzione per volgerli verso una macchina dello stato dilapidatrice proprio
mentre l'economia languiva sotto il peso della cattiva metereologia, di un assetto
istituzionale soffocante, della reazione feudale. Del resto, pur nel generale
entusiasmo degli anni '76-'81, i pericoli di una politica finanziaria tutta basata
sul prestito erano stati denunciati da più voci che accusavano il ministro di
favorire il gusto immorale per la speculazione, di ipotecare il futuro, di
abbandonare il paese agli usurai. Ne agli uomini esperti era sfuggita la
superficialità del Rendiconto e nel mondo della finanza insorsero dubbi e disagi.
Inoltre in sei anni di governo Necker si era fatto molti nemici, il clero gli era
sempre stato avverso perché protestante, l'aristocrazia non gli perdonava alcuni
interventi di riduzione delle spese nella casa reale, l'abolizione della manomorta
(decretata nel 1779) era parsa un vero attentato al mondo del privilegio; le
critiche mosse al regime degli intendenti e al sistema di amministrazione cen-
tralizzata, la soppressione di numerose cariche gli avevano alienato le simpatie
della burocrazia; e infine il parlamento si era irrigidito di fronte ai timidi
tentativi di una più equa ripartizione delle imposte.
L'opposizione che aveva tollerato Necker quale abile collettore di capitali gli
sbarrò la strada dell'ascesa al potere e lo costrinse alle dimissioni il 19 maggio
1781.
14JOLY DE FLEURY—D'ORMESSON. Era ormai una esperienza
acquisita che il paese non avrebbe sopportato un aggravamento della pressione
fiscale, che una riforma del sistema di imposizioni avrebbe incontrato
l'insormontabile opposizione del parlamento e degli ordini privilegiati, che le
economie sulla casa reale o sui vari ministeri non potevano risolvere da sole i
problemi della finanza pubblica. Privi del credito di cui aveva goduto Necker, i
nuovi ministri non ebbero più alcuno strumento per frenare il corso degli
avvenimenti. Joly de Fleury, che assumeva il controllo delle finanze dopo le
dimissioni di Necker, apparteneva a una famiglia parlamentare e si sperava che
questo avrebbe facilitato il suo compito spianando gli ostacoli dell'opposizione.
Operò qualche economia e appesantì la pressione fiscale di -una "trentina di
milioni: mezzucci in quelle circostanze! Il tesoro esausto abbisognava di 160
milioni per fronteggiare le spese dell'anno in corso e di 295 per quello succes-
sivo. Non restava che seguire la strada tracciata da Necker, il ricorso al prestito.
Affettando ottimismo Joly de Fleury lanciò una serie di sottoscrizioni per
qualche centinaio di milioni, richiese anticipazioni agli appaltatori delle imposte
e riuscì a rinviare il collasso. Poi vennero gli scontri col parlamento.
Di fronte a un progetto relativo a una nuova imposta generale indiretta (un
ventesimo del reddito) il parlamentoparigino presentò delle rimostranze in cui
dichiarava che le imposte erano cresciute di 100 milioni in vent'anni assorbendo
i redditi del coltivatore e del proprietario, menomando il diritto di proprietà e le
franchigie di singoli individui e delle comunità. I parlamenti provinciali inal-
berarono il vessillo delle autonomie locali e gridarono al dispotismo; alcuni
dichiararono la loro incompetenza a registrare l'imposta e richiesero la
convocazione degli Stati generali. In Franca Contea l'opposizione degenerò:
dopo avere subito la registrazione forzata dell'editto in un Letto di giustizia a
Versailles, i magistrati, rientrati a Besancon, annullarono nuovamente la
registrazione e dichiararono incostituzionale la legge e la procedura di
registrazione coatta. Il parlamento fu sciolto.
Tanti ostacoli vanificarono gli sforzi del governo e, pur approvata, la
nuova tassa non raccolse che una ventina di milioni. Nel marzo 1783 Joly
presentava al rè un rendiconto più veritiero di quello del 1781 e che
naturalmente non ebbe pubblicità; il deficit era stimato a 80 milioni. Qualche
giorno dopo il ministro dimissionava.
Lefevre d'Ormesson che prese il suo posto nell'aprile 1783 ebbe l'acume di
riconoscersi al di sotto delle circostanze. Tentò di ricorrere al prestito, ma senza
successo. Ormai lo stato e con esso la monarchia e il governo erano screditati e
ogni operazione suscitava il panico nel mondo della finanza e presso i
contribuenti. Poi cercò di guadagnare qualcosa sulle imposte indirette
annullando gli appalti già aggiudicati e gestendo direttamente il prelievo, ma le
proteste dei fermièrs, che richiesero un immediato rimborso di 70 milioni,
decisero le sorti del ministro. Prendendo a pretesto nuove spese della corona
d'Ormesson dimissionò il 2 novembre 1783. Calonne, che ne raccolse la non
invidiabile successione, scriverà ricordando quegli anni: «sembra che si sia
sempre camminato nelle tenebre; non potendo intravedere ne il punto da cui si
partiva ne quello verso cui si andava, non ci si occupò che di arrivare, a forza di
sussidi, di anticipazioni e per così dire di sotterfugi, alla fine di ogni anno; non
si è potuto ricoprire i vuoti se non scavandone di più profondi e di più grandi
ancora, ci si è perfino forzati di sviare accuratamente il pubblico e di ingannare
in qualche modo anche se stessi urea il reale stato delle finanze ».
15Puoi anche leggere