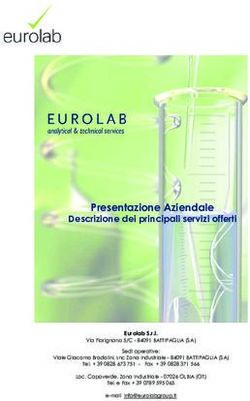L'ANALISI DI COMPARABILITA' - Transfer Pricing - DOTT. FRANCESCO AVELLA, LL.M.
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Transfer Pricing
L’ANALISI DI COMPARABILITA’
DOTT. FRANCESCO AVELLA, LL.M.
Studio Avella e Associati
30 ottobre 2018Riferimenti normativi e di prassi
L’analisi di comparabilità nel transfer pricing
___________________________________
Riferimenti normativi e di prassi
Art. 110, comma 7, del TUIR
DM 14 maggio 2018
Linee Guida OCSE 2017
United Nations Practical Manual on Transfer Pricing for Developing Countries
Circolare Ministero delle Finanze 22 settembre 1980, n. 32
Circolare Agenzia delle Entrate 15 dicembre 2010, n. 58/E
Circolare Guardia di Finanza 1/2018, Volume III
3
34
L’analisi di comparabilità: normativa italiana
_________________________________
Art. 110, comma 7, TUIR
I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato,
che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa
società che controlla l'impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero
stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze
comparabili, se ne deriva un aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se ne deriva
una diminuzione del reddito, secondo le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 31-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
possono essere determinate, sulla base delle migliori pratiche internazionali,
le linee guida per l'applicazione del presente comma.
45
L’analisi di comparabilità: normativa italiana
_________________________________
Art. 3, co. 1 e co. 2, DM 14 maggio 2018 (Nozione di comparabilità)
Un'operazione non controllata si considera comparabile ad un'operazione controllata ai fini dell'applicazione delle
disposizioni del comma 7 dell'art. 110 del TUIR quando:
a) non sussistono differenze significative tali da incidere in maniera rilevante sull'indicatore finanziario utilizzabile in
applicazione del metodo più appropriato;
b) in presenza delle differenze di cui alla lettera a), sia possibile effettuare in modo accurato rettifiche di comparabilità,
così da eliminare o ridurre in modo significativo gli effetti di tali differenze ai fini della comparazione.
Le caratteristiche economicamente rilevanti o fattori di comparabilità che devono essere identificati nelle relazioni
commerciali o finanziarie tra le imprese associate per delineare in modo accurato l'effettiva operazione tra di loro
intercorsa, nonché per determinare se due o più operazioni siano comparabili tra loro, possono essere classificati come
segue:
a) i termini contrattuali delle operazioni;
b) le funzioni svolte da ciascuna delle parti coinvolte nelle operazioni, tenendo conto dei beni strumentali utilizzati e dei
rischi assunti;
c) le caratteristiche dei beni ceduti e dei servizi prestati;
d) le circostanze economiche delle parti e le condizioni di mercato in cui esse operano;
e) le strategie aziendali perseguite dalle parti.
56
L’analisi di comparabilità: principi base
_________________________________
Circolare GdF 1/2018, Volume III, c., 1), (b)
L’analisi di comparabilità riveste un ruolo fondamentale nell’ambito del transfer pricing
Linee Guida OCSE, Capitolo III, A.
La ricerca di comparabili è solo una parte dell’analisi di comparabilità
Non è richiesta una ricerca esaustiva di tutte le possibili fonti di comparabili, poiché è riconosciuto il fatto che
possano esservi limiti nella disponibilità delle informazioni e che la ricerca di dati di comparabili possa essere
gravosa
67
L’analisi di comparabilità: le Convenzioni
_________________________________
Art. 9, par. 1 Modello di Convenzione OCSE 2017
Imprese associate (Associated enterprises)
a) un’impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale
di un’impresa dell’altro Stato contraente; o
b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di
un’impresa di uno Stato contraente e di un’impresa dell’altro Stato contraente.
Necessità di confronto:
• tra le condizioni accettate o imposte tra imprese associate e le condizioni che sarebbero state convenute tra
imprese indipendenti
• della determinazione degli utili che sarebbero stati realizzati in condizioni di libera concorrenza al fine di
determinare l'ammontare dell’eventuale rettifica.
78
L’analisi di comparabilità: Linee Guida OCSE 2017
_________________________________
Definizione (Glossario, Linee Guida OCSE 2017)
Un confronto tra una transazione posta in essere tra imprese associate, da una parte, e una o più transazioni tra
imprese indipendenti, dall'altra. Questi due tipi di transazioni sono comparabili se non esistono differenze che
potrebbero influenzare in modo sostanziale i fattori di cui tener conto nella metodologia (per esempio, il prezzo o
il margine) oppure se è possibile effettuare aggiustamenti ragionevolmente accurati per eliminare gli effetti
materiali di tali differenze.
A comparison of a controlled transaction with an uncontrolled transaction or transactions. Controlled and uncontrolled
transactions are comparable if none of the differences between the transactions could materially affect the factor being
examined in the methodology (e.g. price or margin), or if reasonably accurate adjustments can be made to eliminate the
material effects of any such differences.
89
L’analisi di comparabilità: Linee Guida OCSE 2017
_________________________________
Fattori di comparabilità (Cap. 1, Sez. D, par. 1.36)
L’analisi di comparabilità deve essere svolta identificando i c.d. «cinque fattori di comparabilità» (Cap. 1, par 2.69):
1. Le condizioni contrattuali della transazione
– Contratti scritti e comportamento concreto delle imprese associate
2. Le funzioni svolte da ciascuna delle parti della transazione
– Attività economicamente significative e responsabilità assunte, beni utilizzati o apportati e rischi assunti dalle imprese associate
3. Le caratteristiche dei beni trasferiti o dei servizi prestati
– Beni materiali: caratteristiche fisiche, qualità , affidabilità, disponibilità di approvvigionamento, volume della fornitura
– Servizi: forma giuridica della transazione, tipologia del bene, durata e livello di protezione legale, vantaggi attesi
4. Le condizioni economiche delle parti e del mercato in cui esse operano
– Localizzazione geografica, dimensione dei mercati, grado di concorrenza sui mercati, disponibilità di beni e servizi sostitutivi, i livelli di offerta e domanda sul mercato, potere di acquisto dei
consumatori, costi di produzione, costi dei trasporti, fase di commercializzazione (dettaglio o ingrosso), data e tempo in cui le transazione sono effettuate, esistenza o meno di un ciclo
5. Le strategie aziendali seguite dalle parti
– Modalità di ingresso nel mercato (penetrazione o difesa del mercato), innovazione e sviluppo di nuovi prodotti, grado di diversificazione, valutazione dei cambiamenti politici
Al fine di determinare il prezzo di libera concorrenza, l’analisi di comparabilità deve tenere in considerazione anche i seguenti fattori:
- la concreta utilizzabilità dei metodi di transfer pricing
- eventuali perdite durevoli (Cap. 1, Sez. D, par. 1.129)
- l’effetto delle politiche governative (Cap. 1, Sez. D, par. 1.132)
- le compensazioni volontarie (Cap. 3, Sez. A.3.2)
- economie di localizzazione e altre caratteristiche dei mercati locali (Cap. 1, Sez. D.6)
- sinergie di gruppo (Cap. 1, Sez. D.8)
91
0
L’analisi di comparabilità: Manuale ONU (cenni)
_________________________________
Definizione
L’ONU definisce l’analisi di comparabilità come:
la comprensione delle caratteristiche economicamente significative di una transazione tra imprese associate, e
i ruoli ricoperti dalle parti coinvolte in tale transazione
Il confronto delle condizioni esistenti nelle transazioni intercompany (controlled transaction) con quelle esistenti in
transazioni intercorse tra soggetti indipendenti (uncontrolled transaction)
The term “comparability analysis” is used to designate two distinct but related analytical steps:
1. An understanding of
(a) The economically significant characteristics of the controlled transaction, i.e. the transaction between associated enterprises,
and
(b) The respective roles of the parties to the controlled transaction. This is generally performed through an examination of five
“comparability factors”, see further Paragraph 5.1.6.
2. A comparison between the conditions of the controlled transaction and those in uncontrolled transactions (i.e. transactions
between independent enterprises) taking place in comparable circumstances. The latter are often referred to as “comparable
uncontrolled transactions” or “comparables”.
101
1
L’analisi di comparabilità: Manuale ONU (cenni)
_________________________________
Fattori di comparabilità (Cap. 5, par. 5.1.6)
In linea con le Guidelines dell’OCSE, il Manuale ONU rileva che l’analisi di comparabilità di ogni
singola transazione tra le imprese associate deve essere svolta identificando i c.d. «cinque fattori
di comparabilità» :
1. Le caratteristiche dei beni e servizi trasferiti
2. L’analisi funzionale (funzioni, assets, rischi)
3. Le condizioni contrattuali
4. Le condizioni economiche
5. Le strategie commerciali
Il Manuale ONU (cap. 5, par. 5.2.1), offre un’esemplificazione di un tipico processo di analisi di
comparabilità che segue gli steps elencati nelle Guidelines dell’OCSE (cap. 3)
111
La selezione dei comparables
2
_________________________________
Il processo di selezione dei comparabili
Le Guidelines OCSE identificano un tipico processo di selezione dei comparabili per steps (Cap. III, par. 3.4):
1. individuazione degli anni che devono essere compresi;
2. analisi generale delle circostanze riguardanti il contribuente;
3. comprensione della transazione tra imprese associate in esame, basata in particolare sull’analisi funzionale, al fine di scegliere la
parte da sottoporre a test (ove necessario), il metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento più appropriato alle circostanze
del caso, l’indicatore finanziario che sarà testato (nel caso di un metodo basato sull’utile delle transazioni) e di identificare i
significativi fattori di comparabilità presi in considerazione;
4. revisione dei comparabili interni esistenti, se ve ne sono,
5. identificazione delle fonti di informazioni disponibili sui comparabili esterni qualora tali comparabili esterni siano necessari tenendo
conto del rispettivo grado di affidabilità,
6. selezione del metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento più appropriato e, a seconda del metodo, individuazione
dell’indicatore finanziario più adatto al caso di specie (ad esempio, individuazione dell’indicatore di utile netto, nel caso del metodo
del margine netto della transazione);
7. identificazione dei potenziali comparabili: individuazione delle caratteristiche chiave che devono essere riscontrate nella
transazione tra parti indipendenti affinché la stessa possa essere potenzialmente comparabile, sulla base dei pertinenti fattori della
transazione individuati nella Fase 3 e conformemente ai fattori di comparabilità stabiliti alla Sezione D.1 del Capitolo I;
8. identificazione e applicazione degli aggiustamenti ove appropriati;
9. interpretazione e uso dei dati raccolti e individuazione della remunerazione conforme al principio di libera concorrenza.
121
3
Step 1: identificazione del periodo temporale
_________________________________
L’OCSE non definisce particolari specifiche relativamente al numero di anni da utilizzare nell’analisi di comparabilità
(cap. III, par. 3.75)
Utilizzo del multiple year data nell’analisi di comparabilità consente di:
• ottenere informazioni rilevanti sul business di riferimento che possono avere un impatto rilevante nella valutazione
dei c.d. «cinque fattori di comparabilità» (cap. III, par. 3.77)
• migliorare il processo di selezione dei soggetti terzi comparabili (cap. III, par. 3.78)
L'utilizzo di dati pluriennali non implica necessariamente l'uso di medie pluriennali
L'utilizzo di dati e di medie pluriennali può migliorare l'affidabilità dell’intervallo (cap. III, par. 3.62)
La disponibilità di informazioni contemporanee sulle transazioni tra imprese indipendenti potrebbe essere limitata al
momento della raccolta (cap. III, par. 3.68)
• Data di raccolta: ex ante dei dati ragionevolmente disponibili
• «Necessità di applicare con ragionevolezza gli obblighi documentali di comparabilità» (3.80)
• «Contribuenti ed amministrazione fiscali dovrebbero con giudizio appurare» (3.81)
131
4
Step 1: identificazione del periodo temporale
_________________________________
➢ Dati relativi ad annualità precedenti la transazione:
Raccolti al momento della conclusione delle transazioni ovvero ex ante
Si basano sulle informazioni ragionevolmente disponibili a quel momento.
Includono non soltanto le informazioni su transazioni comparabili di anni precedenti, ma anche quelle che
potrebbero essere avvenuti tra gli anni precedenti e l’anno della transazione tra imprese associate
Se raccolti ex post sono utili per dimostrare che le condizioni di tali transazioni sono coerenti con il principio di
libera concorrenza
➢ Dati relativi ad annualità successive la transazione:
Necessario avere cura di evitare un utilizzo inappropriato
Possono essere utili per comparare i cicli di vita dei prodotti delle transazioni tra imprese associate e indipendenti
al fine di determinare se la transazione tra imprese indipendenti sia un comparabile appropriato nell’applicazione
di un metodo specifico
La condotta ex post delle parti sarà anche utile per delineare con accuratezza la transazione effettivamente
avvenuta
141
5
Step 2: analisi della situazione del contribuente
_________________________________
➢ La broad-based analysis è uno step essenziale dell’analisi di comparabilità:
• Lo studio del mercato di riferimento permette di identificare con un elevato grado di
attendibilità i comparables
• Consente la comprensione delle condizioni sottostati le transazione (c.d. «economic
circumstances»)
➢ Le Guidelines dell’OCSE non forniscono una definizione precisa di mercato di riferimento
➢ L’Agenzia delle Entrate definisce il mercato di riferimento (Circ. n. 32 del 1980) come:
il mercato rilevante, che in linea di principio deve essere (in specie per le vendite di beni materiali) quello
del destinatario dei beni oggetto della transazione.
La scelta di un mercato piuttosto che di un altro (interno anziché estero o viceversa) in base alla sola
considerazione del livello dei prezzi più conveniente per l'Amministrazione non è accettabile in
considerazione dell'inevitabile doppia tassazione che ne conseguirebbe. Quando il mercato estero è quello
rilevante ma quello italiano presenta caratteristiche similari (ipotesi possibile ma difficilmente verificabile) il
riferimento al mercato italiano sarà considerato preferibile.
151
6
Step 3: individuazione delle transazioni
infragruppo
_________________________________
➢ In linea generale, il principio di libera concorrenza dovrebbe essere applicato transazione per
transazione («transaction-by-transaction basis» cap III, par. 3.9)
➢ Ci sono situazioni dove le singole transazioni sono così strettamente legate o contigue che devono essere
trattate congiuntamente
➢ Si tratta di transazioni che presentano la stessa natura o uno stesso legame, quali:
a) alcuni contratti a lungo termine per la fornitura di beni o servizi
b) diritti all’uso di beni immateriali
c) fissazione dei prezzi di una gamma di prodotti strettamente legati
161
7
Step 3: individuazione delle transazioni
infragruppo
_________________________________
Portfolio approach (cap. III, par. 3.10)
➢ Il contribuente raggruppa determinate transazioni allo scopo di guadagnare un rendimento adeguato sull’intero
portafoglio piuttosto che per singolo prodotto
A portfolio approach is a business strategy consisting of a taxpayer bundling certain transactions for the purpose
of earning an appropriate return across the portfolio rather than necessarily on any single product within the
portfolio
➢ Il portfolio approach:
Non può spiegare perdite globali o scarsi risultati prolungati
Non deve essere utilizzato per applicare un metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento a livello della
totalità dell’impresa in casi di transazioni differenti
Non giustifica che un soggetto facente parte di un gruppo multinazionale consegua una remunerazione inferiore
all’intervallo di libera concorrenza
Non deve essere confuso con il package deal: raggruppamento da parte del gruppo multinazionale, in unica
transazione con unico prezzo, di un certo numero di servizi. Può risultare appropriato valutare separatamente i
vari elementi del pacchetto e, tuttavia, dopo aver effettuato una valutazione per singoli elementi, si deve
comunque considerare se il prezzo dell’intero pacchetto considerato nel suo complesso sia conforme all’intervallo
di libera concorrenza (cap. III, par. 3.11)
171
8
Step 3: individuazione delle transazioni
infragruppo
_________________________________
Portfolio approach (art. 5, DM 14 maggio 2018)
➢ In linea con le Guidelines dell’OCSE, il DM prevede che:
Il principio di libera concorrenza è applicato operazione per operazione. Tuttavia se un'impresa associata realizza due o più
operazioni controllate che risultano tra loro strettamente legate, o che formano un complesso unitario, tale da non poter essere
valutate separatamente in maniera affidabile, tali operazioni devono essere aggregate in maniera unitaria ai fini dell'analisi di
comparabilità di cui all'art. 3 e dell'applicazione dei metodi di cui all'art. 4.
➢ Il DM precisa che il presupposto per l’applicazione del portfolio approach debba essere individuato:
Nell’impossibilità oggettiva di valutare in modo affidabile la singola operazione. Si tratta di una valutazione da svolgere caso per
caso e con l’ausilio delle linee guida OCSE che sul punto forniscono una serie di esempi (cap. III, A.3 ss. Linee Guida OCSE 2017)
Nell’esistenza di operazioni strettamente legate
Nell’esistenza di un complesso unitario
181
9
Step 3: individuazione delle transazioni
infragruppo
_________________________________
Selezione della Tested party
➢ L’OCSE definisce la tested party come (Cap. III, par. 3.19 e 3.20):
La parte cui il metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento può essere applicato nel modo più
affidabile
La parte per la quale si possono trovare comparabili maggiormente attendibili
La parte che presenta un’analisi funzionale meno complessa
As a general rule the tested party is the one to which a transfer pricing method can be applied in the most reliable manner and
for which the most reliable comparables can be found, i.e. it will most often be the one that has the less complex functional
analysis.
192
0
Step 4: revisione dei comparabili interni
_________________________________
➢ Per «comparabile interno» si intende una transazione comparabile tra un partecipante alla
transazione controllata e un soggetto indipendente (cap. III, par. 3.27)
…a comparable transaction between one party to the controlled transaction and an independent party (“internal comparable”)
➢ In linea generale è necessaria una preliminare verifica dei comparabili interni, qualora ve ne fossero (cap. III,
par. 3.27)
➢ L’analisi dei comparabili interni:
È, di norma, più semplice e meno costosa
Deve soddisfare i «c.d. cinque fattori di comparabilità» allo stesso modo dei comparabili esterni
È soggetta agli aggiustamenti di comparabilità allo stesso modo dei comparabili esterni
202
1
Step 5: selezione di comparabili esterni
_________________________________
➢ Il criterio geografico è un criterio che deve essere individuato per condurre un’analisi comparabile affidabile
➢ È appropriato utilizzare un'analisi di comparabilità multi-Paese (cap. III, par. 3.35):
Se transazioni simili tra imprese associate sono compiute da un gruppo multinazionale in vari Paesi
Le condizioni economiche di tali Paesi sono ragionevolmente omogenee (cap I, par. 1.113)
I comparabili non nazionali non dovranno essere automaticamente rigettati solo perché non nazionali:
determinare caso per caso se i comparabili non nazionali siano affidabili
Non tutte le banche dati includono lo stesso livello di dettaglio e non tutte possono essere usate con analoga
sicurezza
212
2
Step 5: selezione di comparabili esterni
_________________________________
Utilizzo dei dati di terze parti
➢ A seconda dei principi contabili adottati, i dati di terze parti si dividono in:
I. Company-wide data quando sono determinati a livello di impresa: possono costituire migliori comparabili rispetto
segmented data quando le attività riflesse nei comparabili corrispondono alla serie di transazioni con imprese associate
II. Segmented data quando rappresentano un segmento dell’impresa: possono fornire elementi comparabili migliori dei
primi, perché si focalizzano maggiormente sull’aspetto transazionale
➢ L’uso dei dati di terze parti non riguardanti le transazioni (cap. III, par. 3.37):
Può comunque risultare appropriato se la third party non esegue una gamma di transazioni sensibilmente diverse
(i dati disponibili di terze parti sono spesso aggregati e non segmentati e quindi includono anche dati non riguardanti
le transazioni)
➢ Secondo L’OCSE, in caso di assenza di dati pienamente compatibili e di informazioni disponibili è preferibile un metodo
basato sulla ripartizione degli utili (i.e. «TNMM»)
A transactional profit split method might in appropriate circumstances be considered without comparable data, e.g. where the absence of
comparable data is due to the presence of unique and valuable intangibles contributed by each party to the transaction (see paragraph 2.115).
However, even in cases where comparable data are scarce and imperfect, the selection of the most appropriate transfer pricing method should
be consistent with the functional analysis of the parties, see paragraph 2.2.
222
3
Step 5: individuazione delle fonti disponibili
_________________________________
➢ L’OCSE individua tre tipologie di fonti informative per il reperimento dei dati sui potenziali comparabili con la
tested party:
I. Informazioni confidenziali e non ufficiali riguardanti i soggetti terzi
II. Database commerciali contenenti informazioni comunicate dalle imprese (attraverso i propri bilanci)
III. Informazioni pubbliche come rapporti di settore ovvero documenti pubblicati sul web
➢ Limiti riguardanti i database commerciali (cap. III, par. 3.31):
• non sono presenti in tutti i Paesi, poiché non tutti i Paesi hanno la stessa quantità di informazioni pubbliche
sulle loro società
• non sempre forniscono informazioni sufficientemente dettagliate a sostenere la scelta del metodo di
determinazione dei prezzi di trasferimento.
• non tutte le banche dati includono lo stesso livello di dettaglio e non tutte possono essere usate con analoga
sicurezza
➢ L’ OCSE precisa che l’uso di banche dati commerciali non deve favorire la quantità a scapito della qualità
(cap. III, par. 3.33)
232
4
Step 6: scelta del metodo di determinazione del prezzo
_________________________________
➢ Metodi Tradizionali basati sulla transazione (traditional transaction methods)
I. Metodo del confronto di prezzo (comparable uncontrolled price method)
II. Metodo del prezzo di rivendita (resale price method)
III. Metodo del costo maggiorato (cost plus method)
➢ Metodi transazionali basati sull’utile della transazione (transactional profit methods)
I. Metodo della ripartizione dei profitti (profit split method);
II. Metodo della comparazione dei margini netti delle transazioni (transactional net margin method).
242
5
Step 6: scelta del metodo di determinazione del prezzo
_________________________________
➢ Le raccomandazioni dell’OCSE
I metodi basati sulla transazione sono considerati lo strumento più diretto per stabilire se le condizioni nelle
relazioni commerciali e finanziarie fra imprese associate sono fondate sul principio di libera concorrenza
A parità di condizioni è preferibile un metodo basato sulle transazioni rispetto a un metodo basato sull’utile delle
transazioni
Tra i metodi basati sulle transazioni, il metodo del confronto del prezzo o CUP è il metodo preferibile
➢ Le raccomandazioni del DM 14 maggio 2018
Il DM, sulla scia delle Guidelines, conferma che (art. 4):
I. I metodi imperniati sulla singola operazione conclusa dalle imprese associate (metodi base) devono essere
preferiti ai metodi basati sull’utile generato dalle imprese associate;
II. In casi eccezionali, quando i metodi base non possono essere utilizzati, sia il contribuente sia
l’Amministrazione finanziaria possono applicare i metodi imperniati sull’utile (sia isolatamente sia
congiuntamente ai metodi base).
III. Il contribuente può applicare un metodo diverso dai metodi descritti nelle Linee Guida, qualora dimostri che
nessuno di tali metodi può essere applicato in modo affidabile per valorizzare un'operazione controllata.
252
6
Step 6: scelta del metodo di determinazione del prezzo
_________________________________
Metodo del confronto del prezzo (Comparable Uncontrolled Price Method o CUP)
➢ La corretta applicazione del CUP necessita
I. Un’analisi delle funzioni complessivamente svolte dall‘impresa
II. Un’analisi del mercato rilevante che presenti transazioni comparabili con quelle esaminate
III. Un’analisi della qualità del prodotto dei beni oggetto delle transazioni
IV. L’omogeneità delle caratteristiche merceologiche: sia il Rapporto OCSE del 1979 (parr. 52-53) sia la C.M.
32/E del 1980 identificano tali elementi differenziali nell’esclusività della marca, nell’imballaggio, nella
pubblicità e nella tecnica di commercializzazione, nella presenza di garanzie, nella presenza di vendite
promozionali o di sconti di quantità
262
7
Step 6: scelta del metodo di determinazione del prezzo
_________________________________
Metodo del confronto del prezzo (Comparable Uncontrolled Price Method o CUP)
Vantaggi
✔ È la migliore metodologia per la rappresentazione dei prezzi di mercato
✔ È in linea con quanto previsto dal DM
✔ È un metodo universalmente accettato
✔ È il metodo maggiormente appropriato per l’analisi di transazioni riguardanti commodities
Svantaggi
❌ Risulta difficile l’acquisizione di dati oggettivi
❌ Risultano difficili gli aggiustamenti per differenze relative a qualità dei beni oggetto della transazione e mercati di
riferimento
272
8
Step 6: scelta del metodo di determinazione del prezzo
_________________________________
Metodo del prezzo di rivendita (Resale price)
➢ Il metodo del prezzo di rivendita è applicabile:
I. Se il rivenditore non aggiunge valore al prodotto, limitandosi alla mera commercializzazione dello stesso
II. L’intervallo di tempo tra l’acquisto e la rivendita del bene è così ridotto da trascurare eventuali fattori
distorsivi (tassi di cambio, variazioni di mercato e costi di stoccaggio)
III. È possibile procedere a comparazioni di natura contabile
➢ La C.M. 32/E del 1980 (cap. III, par. 2) precisa che «il suo utilizzo sarà da ritenersi, invece, sconsigliabile
quando, prima della rivendita, i beni subiscono una trasformazione, oppure sono incorporati in un prodotto
più complesso che alteri la loro identità impedendo la distinzione tra il valore dell'articolo finale e quello dei
suoi componenti»
282
9
Step 6: scelta del metodo di determinazione del prezzo
_________________________________
Metodo del prezzo di rivendita (Resale price)
Vantaggi
✔ Non risente delle differenze qualitative dei beni oggetto di transazione
✔ È un metodo semplice e teoricamente di facile applicazione
✔ È un metodo universalmente accettato
✔ È più affidabile quando il rivenditore svolga funzioni di sola commercializzazione
Svantaggi
❌ Risulta meno rigoroso del CUP
❌ È inaffidabile nel caso di sensibili differenze nelle funzioni svolte dalle imprese confrontate
❌ Non è applicabile in caso di funzioni ad alto valore aggiunto
❌ È sensibile alle differenze contabili
❌ In caso di necessità di confronto esterno, richiede una segmentazione dei dati dei comparabili spesso non disponibile
293
0
Step 6: scelta del metodo di determinazione del prezzo
_________________________________
Metodo del costo maggiorato (Cost Plus)
➢ È necessario analizzare le differenze tra le transazioni tra le imprese associate e quelle tra parti indipendenti
che hanno un effetto sulla misura del ricarico, al fine di determinare quali aggiustamenti debbano essere
apportati alle percentuali di ricarico delle transazioni tra parti indipendenti
➢ Le differenze possono essere dovute
I. All’entità e alla tipologia dei costi
II. All’omogeneità contabile
➢ Le differenza sull’entità e la tipologia dei costi possono derivare
I. Da funzioni aventi natura diversa (in tal caso si procederà ad un aggiustamento anche del margine di utile
lordo)
II. Da funzioni aggiuntive (nel qual caso si procederà ad un aggiustamento consistente nel riconoscimento di
una remunerazione per le funzioni aggiuntive)
III. Da maggiore o minore efficienza delle imprese (nel qual caso non si procederà ad alcun aggiustamento)
303
1
Step 6: scelta del metodo di determinazione del prezzo
_________________________________
Metodo del costo maggiorato (Cost Plus)
➢ È importante definire e calcolare la «base di costo» cui applicare il mark-up tenendo in considerazione:
I. Le caratteristiche del bene oggetto della transazione
II. Le funzioni svolte dall’impresa
III. I rischi assunti dall’impresa e le condizioni di mercato
➢ La C.M. 32/E del 1980 (cap. III, par. 3 d)) precisa che al fine di determinare i costi l’A.F. italiana può:
• Basarsi sul sistema di contabilizzazione dei costi adottato dall’impresa
• Apportare modifiche a tale sistema
• Utilizzare un sistema di contabilizzazione completamente differente da quello utilizzato dall’impresa
313
2
Step 6: scelta del metodo di determinazione del prezzo
_________________________________
Metodo del costo maggiorato (Cost Plus)
Vantaggi
✔ Non risente delle differenze qualitative dei beni oggetto di transazione
✔ È un metodo semplice e di facile applicazione
✔ È un metodo universalmente accettato
Svantaggi
❌ Risulta scarsamente affidabile in presenza di sensibili inefficienze nelle funzioni svolte dalle imprese confrontate
❌ È sensibile alle inefficienze strutturali del produttore
❌ Non è applicabile in caso di funzioni ad alto valore aggiunto
❌ È sensibile alle differenze contabili
❌ In caso di necessità di confronto esterno, richiede una segmentazione dei dati dei comparabili spesso non disponibile
323
3
Step 6: scelta del metodo di determinazione del prezzo
_________________________________
Metodo del margine netto della transazione (Transactional net margin method o TNMM)
➢ Il TNMM può essere utilizzato quando:
I. Non sono rinvenibili prodotti strettamente comparabili a quelli in verifica
II. Una delle società del gruppo svolge le funzione più semplice
III. Sono identificabili transazioni effettuate da società simili in termini di prodotti e funzioni svolte
➢ Nell’applicare il TNMM è necessario:
I. Calcolare correttamente gli indici finanziari da confrontare
II. Selezionare transazioni comparabili a quelle oggetto di analisi
III. Scegliere una società del gruppo che non possieda beni immateriali unici
333
4
Step 6: scelta del metodo di determinazione del prezzo
_________________________________
Metodo del margine netto della transazione (Transactional net margin method o TNMM)
Vantaggi
✔ È meno influenzato dalle differenze di transazione rispetto ai metodo tradizionali
✔ I margini netti sono meno influenzati d differenze riscontrabili nelle funzioni
Svantaggi
❌ Risulta difficile determinare il valore di libera concorrenza
❌ I margini netti sono influenzati dalle spese operative che variano da un’impresa a un’altra in modo sensibile
❌ I margini netti sono soggetti agli effetti prodotti dalle forze attive nel settore economico in cui l’impresa opera
❌ Rischia di garantire la profittabilità di una sola parte
343
5
Step 6: scelta del metodo di determinazione del prezzo
_________________________________
Metodo di ripartizione dell’utile (profit split method)
➢ Il profit split consiste nella ripartizione degli utili (e perdite) tra le imprese associate utilizzando un metodo
economicamente valido che si avvicina alla ripartizione degli utili che sarebbe stata prevista e riflessa in un
accordo concluso tra imprese indipendenti
➢ Applicazione del profit split
I. Contribution analysis: consiste nel determinare le contributions di ogni società coinvolta allo scopo di
calcolare il valore normale del combined profit
II. Residual analysis: prevede un applicazione in due fasi
1. Determinazione della remunerazione da riconoscere a ogni società tramite selezione di un metodo tradizionale
2. Gli utili e le perdite che residuano sono ripartite tra le parti delle transazioni in relazione all’analisi dei fatti e
delle circostanze che possono indicare come tale residuo sarebbe stato ripartito tra soggetti non controllati in
analoghe situazioni.
353
6
Step 6: scelta del metodo di determinazione del prezzo
_________________________________
Metodo di ripartizione dell’utile (profit split method)
Vantaggi
✔ È un metodo flessibile
✔ Non genera risultati estremi
✔ Non è un metodo «unilaterale»
Svantaggi
❌ È difficile comparare la singola transazione
❌ I dati sono difficilmente reperibili perché devono essere di elevata qualità
❌ È di difficile applicazione pratica in maniera affidabile
363
7
Step 7: identificazione dei comparables
_________________________________
Additive vs Deductive Approach
➢ L’OCSE identifica due modalità di selezione dei comparables (cap. III, par.3.40):
1. Additive approach: “additive” approach, consists of the person making the search drawing up a list of third parties that are
believed to carry out potentially comparable transactions. Information is then collected on transactions conducted by these third
parties to confirm whether they are in effect acceptable comparables, based on the pre-determined comparability criteria
Basato sulla selezione di soggetti identificati come comparabili dal soggetto che effettua la ricerca
Ricerca di transazioni sono effettuate tra soggetti noti del mercato
Richiede la conoscenza ex ante di soggetti che effettuano transazioni comparabili a quelle della tested party
2. Deductive approach: the “deductive” approach, starts with a wide set of companies that operate in the same sector of
activity, perform similar broad functions and do not present economic characteristics that are obviously different. The list is then
refined using selection criteria and publicly available information (e.g. from databases, Internet sites, information on known
competitors of the taxpayer)
Basato sulla selezione di soggetti comparabili attraverso l’utilizzo di database commerciali
Ricerca di comparabili tra in banche dati tra soggetti che operano nello stesso settore
Richiede ampia disponibilità di informazioni
373
8
Step 7: identificazione dei comparables
_________________________________
Additive vs Deductive Approach
Additive approach pros e cons
✔ Utilizzo di parti terze comparabili già conosciute
✔ Maggiore esattezza delle informazioni se nella disponibilità del soggetto che effettua la ricerca
❌ Minor grado di trasparenza e oggettività rispetto al deductive approach: rischio di «cherry picking»
❌ Minore possibilità di «riproducibilità» rispetto al deductive approach
Deductive approach pros e cons
✔ Maggior grado di affidabilità e trasparenza
✔ Maggior possibilità di replicabilità da parte dell’Amministrazione finanziaria che intende ripetere la selezione
❌ Minore qualità delle informazioni ricavate dal database
➢ L’OCSE non riconosce alcuna preferenza di un approccio rispetto all’altro fermo restando che il risultato della
selezione deve comunque essere trasparente e verificabile (cap. III, par. 3.45)
383
9
Step 8: aggiustamenti di comparabilità
_________________________________
➢ L'opportunità di effettuare aggiustamenti ai fini della comparabilità è questione di giudizio soggettivo
➢ Gli aggiustamenti di comparabilità derivano:
dalle differenti prassi contabili utilizzate nella transazione tra imprese associate e parti indipendenti;
dalla segmentazione dei dati finanziari per eliminare transazioni significative non comparabili;
dagli aggiustamenti per le differenze nel capitale, nelle funzioni, nei beni utilizzati e nei rischi.
➢ Prima di ricorrere ad un aggiustamento di comparabilità è necessario tener conto:
della significatività della differenza per la quale si ipotizza un aggiustamento;
della qualità dei dati aggiustati;
dello scopo dell'aggiustamento;
dell'affidabilità dell'approccio utilizzato per realizzare tale aggiustamento.
394
0
Step 8: aggiustamenti di comparabilità
_________________________________
➢ Il TP non è una scienza esatta perché:
l’applicazione del metodo può determinare una serie di valori, tutti egualmente affidabili;
il principio di libera concorrenza determina solo approssimativamente le condizioni che sarebbero stabilite tra parti indipendenti;
non tutte le transazioni comparabili esaminate hanno lo stesso grado di comparabilità;
ogni metodo potrà produrre un intervallo di valori differente per differenze nella natura del metodo e nella diversità dei dati
utilizzati nell’applicazione dello stesso.
➢ Secondo le Guidelines dell’OCSE nonostante gli aggiustamenti di comparabilità alcune differenze tra le transazioni
tra imprese associate e le transazioni tra imprese indipendenti rimarranno sempre (cap. III, par. 3.51)
➢ Il DM 14 maggio 2018 afferma che:
«la valorizzazione di un'operazione controllata in base al principio di libera concorrenza è determinata applicando il metodo più
appropriato alle circostanze del caso… tenendo conto dei seguenti criteri:... d) il grado di comparabilità tra l'operazione
controllata e l'operazione non controllata, considerando anche l'affidabilità di eventuali rettifiche di comparabilità
necessarie per eliminare gli effetti delle differenze tra le predette operazioni.»
404
1
Step 9: il posizionamento entro l’arm’s length range
_________________________________
➢ Per arm’s length range, l’ OCSE intende «un intervallo di prezzi accettabili per determinare se le condizioni di
una transazione tra imprese associate siano a condizioni di libera concorrenza; tale intervallo è calcolato sia
applicando lo stesso metodo di determinazione del prezzo di trasferimento a più dati comparabili sia
applicando diversi metodi di determinazione del prezzo di trasferimento.» (Glossario, Linee Guida OCSE
2017)
➢ Secondo le Linee Guida OCSE «sarà possibile applicare il principio di libera concorrenza al fine di determinare
un unico valore (ad. es. prezzo o margine) che sia il più affidabile per stabilire se le condizioni delle
transazioni siano concorrenziali» (cap. III, par. 3.55)
➢ Se il prezzo o il margine ricade nell’arm’s length range → NO aggiustamento
➢ Se il prezzo o il margine ricade al di fuori dell’arm’s length range il contribuente dovrà:
presentare argomentazioni a supporto del rispetto del principio di libera concorrenza;
giustificare il posizionamento all’interno dell’intervallo di libera concorrenza;
procedere alla determinazione di un range deverso da quello proposto dall’Amministrazione Finanziaria.
414
2
Step 9: il posizionamento entro l’arm’s length range
_________________________________
Art. 6, DM 14 maggio 2018
1. Si considera conforme al principio di libera concorrenza l'intervallo di valori risultante dall'indicatore finanziario
selezionato in applicazione del metodo più appropriato ai sensi dell'art. 4, qualora gli stessi siano riferibili a un
numero di operazioni non controllate, ognuna delle quali risulti parimenti comparabile all'operazione controllata,
in esito all'analisi di cui all'art. 3.
2. Un'operazione controllata, o un insieme di operazioni controllate aggregate in base all'art. 5, si considerano
realizzati in conformità al principio di libera concorrenza, qualora il relativo indicatore finanziario sia compreso
nell'intervallo di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Se l'indicatore finanziario di un'operazione controllata, o di un insieme di operazioni aggregate in base all'art.5,
non rientra nell'intervallo di libera concorrenza, l'amministrazione finanziaria effettua una rettifica al fine di
riportare il predetto indicatore all'interno dell'intervallo di cui al comma 1, fatti salvi il diritto per l'impresa
associata di presentare elementi che attestino che l'operazione controllata soddisfa il principio di libera
concorrenza, e la potestà per l'amministrazione finanziaria di non tenere conto di tali elementi adducendo idonea
motivazione.
424
3
Step 9: il posizionamento entro l’arm’s length range
_________________________________
➢ Quando rimangano dei difetti di comparabilità potrebbe essere appropriato utilizzare misure tendenti ad
accorpare al centro tali valori, al fine di minimizzare il rischio di errore causato da difetti di comparabilità
residui imprevisti o non quantificabili
➢ Gli indici sintetici più usati sono
la mediana
la media aritmetica
la media ponderata
i percentili
➢ L’OCSE ammette la possibilità che dall’analisi di benchmark possano risultare valori estremi consistenti in
perdite o utili eccezionalmente elevati in quanto non può essere escluso unicamente a causa del fatto che il
risultato proveniente dal "comparabile" proposto sembri semplicemente essere molto diverso dai risultati
osservati per altri "comparabili" proposti (cap. III, par. 3.62)
43Recenti orientamenti giurisprudenziali in tema di analisi di comparabilità
Questioni ricorrenti
4
6
Questioni ricorrenti
_________________________________
➢ Posizionamento nell’arm’s length range
➢ Utilizzo di dati ex post
➢ Società comparabili in perdita
464
7
Esempio
_________________________________
➢ Alfa S.p.A. è un distributore di beni residente in Italia
➢ Documento nazionale per l’annualità 2015 basato su Resale price method (metodo del prezzo di rivendita)
applicato in tempo utile per il versamento delle imposte a giugno 2016
annualità sottoposta a valutazione della congruità transfer price: 2015
periodo riferimento di raccolta dei soggetti comparabili: annualità 2012 - 2013 - 2014
società selezionata come tested party: Alfa S.p.A. che presenta un Gross Margin (PLI) pari al 4,76%
soggetti individuati come comparabili: n. 6 distributori indipendenti residenti in Italia
dichiarazione dei redditi presentata il 30 settembre 2016;
release raccolta comparabili al mese di ottobre 2015
• Nel c.d. approccio ex-ante il contribuente, per valutare la congruità dei prezzi di trasferimento per l’annualità
2015, prende in considerazione un panel di 6 soggetti comparabili con dati economici riferiti al lasso
temporale 2012 - 2014 considerato che, al momento dell’estrazione dei medesimi dati (ad esempio nel mese
di maggio/giugno 2016), non tutte le notizie relative all’annualità 2015 erano disponibili.
474
8
Esempio
_________________________________
➢ I valori ottenuti rendono il seguente intervallo statico (periodo 2012-2014):
N Denominazion Gross
e Margin
1 Alfa S.r.l. 16,82
2 Alfa S.p.A. 14,35
3 Beta S.r.l. 7,8
4 Gamma S.p.A. 5,4
5 Iota S.p.A. 3,2
6 Beta S.p.A. 2,1
Minimo 25° Mediana 75° massimo
2,1 7,75 6,6 12,71 16,82
484
9
Esempio
_________________________________
EU Joint Transfer Pricing forum - Report in compensating adjustments
➢ Il documento ammette la possibilità di effettuare aggiustamenti anche alla fine dell’esercizio prima di compilare
definitivamente la dichiarazione dei redditi. In tale documento si ammette infatti la possibilità di valutare ex post la
congruità dei prezzi di trasferimento, utilizzando i dati disponibili al momento della redazione della dichiarazione dei
redditi
➢ In siffatta ipotesi alcuni Stati consentono, o addirittura richiedono, gli aggiustamenti ai prezzi di trasferimento alla fine
dell’esercizio, prima di chiudere la contabilità o prima di presentare la dichiarazione dei redditi. Conformemente, cfr.
circolare Assonime n. 4/2018
➢ Quando il redattore del set documentale deve “valutare” la congruità dei prezzi di trasferimento per l’annualità 2015 lo
stesso potrebbe anche assumere, quale lasso temporale di riferimento, le annualità 2013, 2014 e 2015 considerando,
prima di chiudere definitivamente la contabilità e al momento di redazione della dichiarazione dei redditi, la
disponibilità di nuovi dati riferiti all’esercizio 2015, rispetto a quelli relativi al 2014 (lasso temporale 2012, 2013 e
2014)
➢ Quali limiti?
49Puoi anche leggere