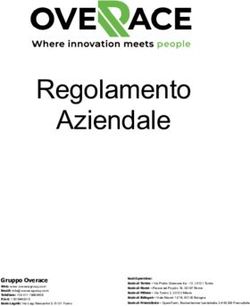JEAN-LUC NANCY E L'IMPERATIVO CATEGORICO - Roma ...
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Mariannina Failla
JEAN-LUC NANCY E L’IMPERATIVO CATEGORICO
Abstract
The essay focuses on J.-L. Nancy’s proposal to interpret the categorical imperative. He conceives the
categorical/hypothetical pair in the light of Aristotelian-scholastic logic, asserting: categorical is an absolute
affirmation of the predicate of a subject, while hypothetical corresponds to the conditional affirmation of a
predicate for a subject. J.-L. Nancy doesn’t only refer to this, but he is also interested in the practical power of
the categorical order of transcendental logic, in the prescriptiveness of that order or, to be more precise, in its
self-prescriptiveness. This order is “the order of the relationship between existents” centrality of kategorèin
in the field of praxis. Nancy considers the Kantian expression “universal law of nature” essential to identify
the meaning of the formulation of the categorical imperative. This meaning will be illustrated with a double
argumentative movement: the comparison with Kantian ethical works (Foundation of the Metaphysics of
Customs and Critique of Practical Reason, in particular Preface and Typical of pure practical judgment), on
the one hand, and the analysis of the critique that Nancy makes of subjectivist or “egotistic” interpretations
of the universalisation of the categorical maximum, on the other. This will be connected with reflections on
the complex relationship between the coercive imperiousness of command and freedom.
Keywords: Categorical Imperative; Transcendental Logic; World; Freedom; Necessity; Obsession
1. Imperativo categorematico
La prima sorpresa che Nancy ci riserba nella sua Prefazione è interpretare la coppia
kantiana di categorico/ipotetico attraverso la logica aristotelico-scolastica, asserendo:
categorico o categorematico è affermazione assoluta del predicato di un soggetto, mentre
ipotetico corrisponde all’affermazione condizionale di un predicato per un soggetto. Ma
è veramente una sorpresa?
Prima ancora che nella Fondazione della metafisica dei costumi, di categorico e ipo-
tetico Kant parla nella parte iniziale dell’Analitica dei concetti puri, laddove affronta
la logica generale, riflettendo sulla forma dei giudizi. Proprio considerando i giudizi
secondo la relazione, egli sostiene che il categorico indica una relazione fra soggetto e
predicato e l’ipotetico fra il Grundsatz (principio o fondamento) e la conseguenza. Sia
Kant sia Nancy convergono, dunque, nel pensare che categorico implichi un legame
necessario ed ipotetico un rapporto condizionale del tipo se A allora B che diventerà
centrale nella riflessione pratica kantiana sull’ipoteticità delle massime dell’abilità, della
prudenza e della ricerca della felicità.
Nancy non si limita, tuttavia, a questo riferimento che, prima ancora di esibire la sua
valenza pratica, è cruciale per la filosofia teoretica kantiana perché prelude al rapporto
fra logica formale e logica trascendentale, alla loro possibile interrelazione – offerta ad
esempio dalla nozione di funzione logica. Il filosofo francese sembra, infatti, guardare e
interessarsi alla potenza pratica dell’ordine categoriale della logica trascendentale, alla
379S pazio aperto
prescrittività di tale ordine o, per meglio dire, alla sua autoprescrittività. È proprio questa
la proposta sorprendente e, per questo, interessante.
Per arrivare al significato etico del “sistema” delle categorie trascendentali, Nancy
fa, infatti, una serie di scelte e di importanti passaggi teoretici. Il primo sembra essere
questo: egli lega, ma forse si può anche asserire “egli subordina” l’apparato trascenden-
tale delle categorie alla funzione predicativa e proprio questo passaggio sembra essere
dettato da Aristotele1. La categoria designa «l’ordine predicativo di un concetto»2, è
dunque in funzione di un giudizio e a questo proposito ci sembra significativo quanto
afferma Nancy:
Del resto non c’è niente di illegittimo a trattare la categoria come il nucleo o l’innesto
di una proposizione categorica (affermativa o imperativa): perché la categoria nel senso
di Kant e di Aristotele, non è il concetto nel senso più generale del termine. Essa designa
l’ordine dei predicati possibili per un giudizio qualunque esso sia (per una proposizione, per
una predicazione): così le categorie di unità (quantità n.d.a.), di esistenza (modalità n.d.a.)
o di comunità (relazione n.d.a.) non consistono tanto di per sé quanto come possibilità di
attribuzione di un giudizio3.
La destinazione predicativa dell’elemento concettuale/categoriale viene riconosciuta
da Kant forse già nel § 12 della Critica della ragione pura in cui connette la nozione ari-
stotelico-scolastica di trascendentale a quella di estensione della predicazione di un con-
cetto. Unum, Verum, Bonum, nell’interpretazione che ne dà Kant, sembrano riguardare
rispettivamente la regola di unificazione dei possibili caratteri predicabili di un concetto
(unità qualitativa tematica del concetto), la regola della predicabilità certa di un concetto
(il Verum) ed infine la regola dell’estensione dei predicati di un concetto, il Bonum come
aretè, ovvero come perfezione predicativa. Nancy, tuttavia, non sembra puntare a questa
riflessione – che Kant mette in relazione all’unità qualitativa delle funzioni logiche dei
giudizi4. Il filosofo francese va ben oltre o ben altrove e considera l’elemento catego-
1 Importante a questo proposito appare il passo di Categorie IV, in cui Aristotele sostiene che la capacità
veridica delle categorie si dà solo nella relazione predicativa; prese di per sé, esse non sono né vere né
false: «Delle cose che si dicono senza nessuna connessione, ciascuna significa o sostanza o quantità,
o qualità, o relazione, o dove, o quando, o giacere, o avere, o agire, o patire. […] Ciascuna delle cose
che sono dette in sé e per sé non costituisce nessuna affermazione, ma è nella connessione di queste
cose fra loro che ha luogo l’affermazione. Infatti sembra che ogni affermazione sia vera o falsa, ma
delle cose che si dicono secondo nessuna connessione nessuna né è vera né è falsa, ad esempio. uomo,
bianco, corre, vince».
2 J.-L. Nancy, “Prefazione all’edizione italiana”, in Id., L’imperativo categorico, BESA Editrice, Nardò
(LE) 2007, p. 9.
3 Ibid.
4 I. Kant, Kritik der reinen Vernunft, in Kants Gesammelte Schriften, Bd. 3. Hrsg. von der königlich
Preußischen Akademie der Wissenschaften, Walter de Gruyter, Berlin 1904; trad. it a cura di P. Chiodi.
Critica della ragion pura, UTET, Torino 2004, § 15 B 131: «Questa unità, che precede a priori tutti i
concetti di congiunzione, non s’identifica con la categoria di unità (§ 10). In realtà tutte le categorie si
fondano su funzioni logiche nel giudizio, ma in queste la congiunzione, e conseguentemente l’unità dei
concetti dati, è già pensata. La categoria presuppone già la congiunzione. È dunque più in alto che va
380S Mariannina Failla
Jean-Luc Nancy e l’imperativo categorico
riale finalizzato a una predicazione pratica, nella quale alla categoricità del giudizio si
connette la sua imperatività. In questo passaggio ha probabilmente luogo l’innesto fra
le categorie, intese come ordine delle predicazioni di un concetto, e la loro destinazione
pratica e mondana. Vediamone i motivi.
La modalità imperativa di un giudizio categorico è: “questa cosa deve essere una”,
“questa comunità d’esistenza deve avvenire”. Se la categoricità ha a che vedere con
l’affermazione assoluta di un predicato, l’imperatività di un giudizio categorico implica
il dover essere di quel predicato, una necessità non più logica, ma pratica. O forse si può
dire l’imperatività diviene il movente, nel senso di ciò che muove ogni necessità logica,
ogni logica mondana. E Nancy incalza sostenendo che il dovere, il dovere accadere, il
dover essere implicano per Kant necessariamente un’azione5, così come del resto recita
la formulazione dell’imperativo «Agisci in modo tale che la tua volontà possa volere che
la massima dell’azione divenga legge universale». L’azione ha qui un potere attuativo,
effettua la predicazione: essa non è volere questa o quella massima, ma è volere l’univer-
salità della legge e asserire questo per Nancy significa volere l’universalità della stessa
razionalità.
Forse proprio in questo slittamento fra legge universale e universalità della razionalità
si può comprendere meglio il legame stabilito da Nancy fra l’apparato categoriale del
soggetto trascendentale e l’imperatività della massima pratica: applicato alle categorie,
il carattere imperativo fa sì che esse si trovino di per sé stesse a comandarsi la propria
finalità, a volere il fine che esse stesse sono: ossia la ragione, il razionale, o l’ordine
ragionevole del mondo.
L’imperativo categorico è proprio l’imperativo della categoria, del concetto o dell’idea,
scrive Nancy nella Prefazione, in quanto è l’imperativo della ragione pura come tale. In
ultima istanza, del resto, non indica e non prescrive nient’altro che l’atto della libertà che è
l’idea stessa o il concetto integrale della ragione. Enuncia l’autoprescrizione della ragione.
Lungi dall’essere autofondatrice, o più esattamente, nel luogo stesso della sua fondazione,
la ragione è autoprescrittiva; è qui, in definitiva, la “chiave di volta” […] della sua stessa
razionalità. Il concetto della ragione si assume come concetto il comando di realizzarsi –
avendo inteso che ciò che è da realizzare, non è dato (non è intuibile)6.
La ragione pura è già pratica fin dall’ordine categoriale del mondo perché assume sé
stessa, e quell’ordine mondano, come ordine da realizzarsi, non dato dalle esperienze
sensibili, bensì ordine da darsi e autoprescriversi.
cercata questa unità (come qualitativa § 12) e precisamente in ciò che contiene lo stesso fondamento
dell’unità di diversi concetti nei giudizi, quindi della stessa possibilità dell’intelletto, persino nel suo
uso logico».
5 Per l’interpretazione dell’azione come “essere-in-rapporto” si veda J.-L. Nancy, Sull’agire. Heidegger
e l’etica, Cronopio, Napoli 2005. Sullo stretto rapporto fra filosofia e azione ed essere-in-comune cfr.
C. Dovolich, D. Gentili (a cura di), Pensare con Jean-Luc Nancy, «B@belonline», 10-11, 2011, http://
romatrepress.uniroma3.it/ojs/index.php/babelonline/issue/view/99 .
6 J.-L. Nancy, “Prefazione all’edizione italiana”, in Id. L’imperativo categorico, cit., p. 11.
381S pazio aperto
2. Eccesso e mondo
L’intera tavola delle categorie assume la propria integralità pratica, in quanto è ordine
mondano che deve realizzarsi, dovere della ragione teoretica e per di più dovere non
regolativo ma attuativo, il quale determina la verità e al tempo stesso la libertà della
ragione. «Praticamente e non formalmente il sistema di questa famosa tavola prescrive
sé stesso come dovere»7, scrive Nancy nella sua Prefazione, e diventa ordine da realiz-
zarsi delle esistenze mondane, l’ordine della loro dignità. Sono il mondo e il suo ordine
ragionevole (la gratuità8 e la dignità dell’umano) a dover essere necessariamente, a do-
versi compiere. Per questo il comando è anche istituzione ontologica, è trama ontologica
dell’esistenza mondana. Il comando, l’imperatività del kategorein, non diventa, così,
una promessa messianica o utopica, non rappresenta l’utopia cristiana di un compimento
al di là del mondano. Esso, al contrario, attua e costituisce il mondano. L’imperatività
implica che il “mondo debba essere”, debba essere messo “assolutamente in opera”9.
Proprio il richiamarsi reciproco e dinamico di ragione (ordine razionale) e mondo indu-
ce a chiedersi quanto, nel pensare l’imperatività del kategorein, abbia influito la lettura
hegeliana della ragione, dell’assoluto, offerta da Nancy. Una lettura in cui l’assoluto,
l’idea, la ragione e il primato del negativo e della differenza sembrano coincidere. Lo
Hegel di Nancy ha a cuore, dunque, una visione dell’infinito come processo che non
può coincidere con la sua cattività, ossia con la sua prigionia nell’iterazione all’infinito
(cattiva infinità):
Ed è così che l’assoluto è quel che è: uguale a se stesso e, quindi, in assoluta quiete, ma
lo è soltanto come non quiete. Il processo o il progresso dell’assoluto è processo o progresso
infinito.
Un processo infinito non va “all’infinito”, come verso il termine sempre differito di una
progressione (questo sarebbe, infatti, ciò che Hegel chiama “cattivo infinito”)10.
L’infinito è dato dalla consapevolezza dell’inestricabile rapporto fra eccesso e limite;
l’infinito è eccedenza dal mondano e sua costitutiva immanenza; esso è, altresì, consape-
volezza della differenza e del movimento che essa innesca verso l’altro da sé. L’infinito
diventa così instabilità, inquietudine di ogni determinatezza, di ogni finitezza. In quanto
differenza, instabilità, inquietudine, l’infinito è anche negatività assoluta. Il negativo
«[..] è il prefisso dell’infinito, in quanto affermazione del fatto che ogni finitezza (e ogni
7 Ivi, p. 10.
8 J.-L. Nancy, Cosa resta della gratuità?, Mimesis-Serie Chicchidoro, Milano-Udine 2018, pp. 34-42.
In queste pagine Nancy recupera una visione esistenziale dell’uso, dello scambio, del riconoscimento
mondani connessi alla gratuità, che non dimentica l’apporto kantiano: «Si dà pertanto ciò che si po-
trebbe chiamare una ragione pratica commerciante – se così si può dire – nel senso kantiano in cui la
ragione è “pratica”, vale a dire attraverso la morale stessa»(ibidem, p. 37).
9 Sul concetto di esistenza in Kant come ‘la promesse d’une pensée du pur survenir de la chose’ si veda
il lavoro prefato da J.-L. Nancy: A. Cariolato, L’existence nue: Essai sur Kant, préface de Jean-Luc
Nancy, Vrin Les èditions de la transparence, Paris 2009.
10 J.-L. Nancy, Hegel. L’inquietudine del negativo, Cronopio, Napoli 2010, p. 22.
382S Mariannina Failla
Jean-Luc Nancy e l’imperativo categorico
essere è finito) eccede in sé la sua determinatezza. Ogni determinatezza è nel rapporto
infinito»11 .
Potremmo dire: ogni finitezza, o la finitezza in quanto tale, contiene in sé la propria
eccedenza e si costituisce come qualcosa di determinato solo in relazione a tale ecceden-
za. Ora questa lettura della mondanità sembra riproporsi nell’interpretazione dell’obbli-
go e consente di interpretare il comando assoluto incondizionato (l’imperativo categori-
co) non come un dover essere che si pone al di là del finito, ma come un incondizionato
che è immanente e al tempo stesso eccedente il mondo. L’ordine categoriale è, infatti,
un ordine che emerge dal mondo, non s’impone o si sovrappone ad esso; nel contempo
esso eccede il mondo stesso proprio per la sua intima natura pratica (il suo essere dovere
a sé stesso). Alludendo all’esegesi di Hegel, potremmo dire che l’imperatività del kate-
gorein è inquietudine morale del finito. Si tratta, nella specificità kantiana, di un assoluto
incondizionato, la cui eccedenza è indice della sottrazione dell’imperatività categoriale
alle valutazioni del più o del meno o dell’equivalente. Con il “comando” abbiamo a che
fare, allora, con una verticalità, che rimanda ad un ordine privo di equivalenze; è l’ordine
sublime12 della dignità umana che non ammette misurazioni, né valutazioni comparative,
prezzi di mercato o misure del proprio diletto.
Così Nancy nel saggio dedicato a Nietzsche interno a L‘imperativo categorico:
Questa verità imperativa e retta non ha più un valore, non deriva più dalla nostra
valutazione perché essa non è più ciò che un soggetto può “tener per vero” secondo i suoi
bisogni o i suoi interessi. È lei piuttosto a tenere il soggetto – e non lo tiene per vero, se così
si può dire…, lo tiene sotto la sua legge. E se il valore come tale è sempre dell’ordine di ciò
che Kant chiama il prezzo – [così come effettivamente Kant fa nei passi corrispondenti a
AA 434-435 della Fondazione della metafisica dei costumi13 n.d.a.] – cioè il valore relativo
a una valutazione, allora la verità di questa rettitudine imperativa non ha un valore relativo,
ma sempre nei termini di Kant, un valore intrinseco, cioè una dignità (Würde)14.
11 Ivi.
12 Sul concetto di sublime e il suo legame con la questione dell’esistenza e dell’essere-nel-mondo si veda
J. L. Nancy, The Sublime Offering, in Jean-Francois Courtine et al. (a cura di), Of the Sublime: Pres-
ence in Question, State University of New York Press, New York 1993, pp. 25-54; [edizione originale
Jean-Francois Courtine et al. (eds.), Du Sublime, Editions Belin, Paris 1988].
13 Si allude al passo della Fondazione in cui Kant distingue fra la dignità, il prezzo di mercato (Mar-
ktpreis) e il prezzo d’affezione (quello legato al piacere procurato dal libero gioco delle nostre facoltà).
un passo questo in cui emerge la differenziazione fra l’ambito economico-sociale, quello sensibile del
piacere, e quello del valore morale dell’autonomia e autodeterminazione della ragione, base della di-
gnità dell’umano. I. Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, Kant’s gesammelte Schriften, vol.
IV, Berlin, De Gruyter 1911, pp. 434-435: «Was sich auf die allgemeinen menschlichen Neigungen
und Bedürfnisse bezieht, hat einen Marktpreis ; das, was, auch ohne ein Bedürfniß vorauszusetzen,
einem gewissen Geschmacke, d. i. einem Wohlgefallen am bloßen zwecklosen Spiel unserer Gemüths-
kräfte, gemäß ist, einen Affectionspreis ; das aber, was die Bedingung ausmacht, unter der allein etwas
Zweck an sich selbst sein kann, hat nicht bloß einen relativen Werth, d. i. einen Preis, sondern einen
innern Werth, d. i. Würde»; trad. it., Fondazione della metafisica dei costumi, Laterza, Bari 2010, p.
103.
14 J.-L. Nancy, La nostra rettitudine! Sulla verità in senso morale in Nietzsche, in Id., L’imperativo ca-
tegorico, cit., p. 95.
383S pazio aperto
La dignità qualifica come sublime la legge, poiché essa rimanda «all’assolutamente
grande, all’incommensurabile nella finitezza»15 e non ad un incondizionato collocato in
un “altrove” religioso o metafisico. La legge è la ragione stessa, il suo divenire mondano;
essa comanda sé stessa e si compie nel “dover esistere” della dignità dell’umano. Certo
ci sono alcuni passi in Hegel. L’inquitudine del negativo, nei quali Nancy differenzia la
ragione kantiana dal divenire “vero” e “libero” della ragione hegeliana16, ma la capacità
della ragione di comandare la propria realizzazione nel mondano, il suo essere in grado
di emergere dal mondano trascendendolo, la sua forza ontologica, basata sul gioco co-
stitutivo di immanenza e trascendenza, fanno sfumare i confini fra la ragione kantiana
e quella hegeliana. Nel concetto di ragione, messo in gioco da Nancy quando ci parla
della imperatività del comando, possiamo vedere, così, in controluce l’inquietudine del
mondo declinata attraverso l’interpretazione dell’assoluto hegeliano.
3. Massima categorica, legge della natura: necessità versus libertà
Grazie all’esegesi di Nancy, possiamo iniziare a pensare l’intima natura pratica della
ragione teoretica, ma il senso che si può ricavare dal rapporto fra ragione pratica e ragio-
ne pura, può apparire spaesante rispetto ad un’altra Prefazione, quella che Kant scrive
per la Critica della ragione pratica. In essa egli ci dice che, potendo avere un concetto
solo «problematico» dell’incondizionato, la ragione pura si deve limitare ad attestare
“la non impossibilità” dell’incondizionato, senza potergli assicurare alcuna “objective
Realität”. Se vuole rimanere critica, la ragione pura può solo dichiarare la possibili-
tà dell’intelligibilità noumenica della libertà poiché arrivare a concepire impossibile e
auto-contraddittorio l’incondizionato implicherebbe ammettere l’impossibilità dell’ide-
azione razionale tout court, lasciando precipitare la ragione stessa nell’«abisso dello
scetticismo». Il concetto “problematico” d’incondizionato ha così lo scopo di salvaguar-
dare l’essenza della ragione (ossia l’ideazione razionale) legittimandola come possibile,
dunque pensabile, ma non può andare oltre, non può conferire realtà (Realität) e tanto
meno effettività oggettive (Wirklichkeit) alla stessa ideazione dell’incondizionato. Sarà
per l’appunto la legge morale, propria della ragione pratica, a fornire realtà oggettiva
all’ideazione razionale della libertà. Nancy sembra voler intervenire proprio su que-
sto nodo problematico, dando però alla ragione teoretica non solo un ruolo terapeutico
(salvare dall’abisso dello scetticismo), ma anche e soprattutto un compito ontologico
asserendo, come abbiamo visto, che la ragione teoretica ha in sé stessa, già nella sua
articolazione categoriale, il motivo, il movente, della propria praticità17. Lo spaesamento
15 Nancy, Il Kategorein dell’eccesso, in Id., L’imperativo categorico, cit., p. 39.
16 Nancy, Hegel. L’inquietudine del negativo, cit., pp. 36-37.
17 L’interpretazione di Nancy ci sembra collocarsi nella scia delle riflessioni di E. Lévinas, Le primat
de la raison pure pratique/Das Primat der reinen praktischen Vernunft, in Nobert Fischer (a cura di),
Kants Metaphysik und Religionsphilosophie, Felix Meiner, Hamburg 2004, pp. 191-205. In questo
saggio Lévinas sottolinea (contro lo strutturalismo francese) il primato della ragione pratica su quella
teoretica dopo aver individuato nelle formulazioni kantiane dell’imperativo categorico la questione
384S Mariannina Failla
Jean-Luc Nancy e l’imperativo categorico
provocato dall’interpretazione di Nancy sarebbe, così, dato dal fatto che a fronteggiarsi,
per poi scoprirsi profondamente uniti, non sono la ragione speculativa da un lato e quel-
la puro-pratica dall’altro, ma i principi di ogni attività sintetica dell’intelletto e il loro
dover essere, ossia il loro dover diventare ordine ragionevole delle esistenze mondane,
ordine che per l’appunto non ci è dato, ma deve darsi, ordine cioè – come si diceva prima
– eccedente il mondo e al tempo stesso richiesto dal mondo. Eppure questo passaggio
– concettuale – che fa del “sistema” delle categorie un “dovere pratico”, il dovere della
propria autorealizzazione, può trovare una sua giustificazione non solo nel fatto che, par-
lando di “sistema” delle categorie, Nancy sembra considerarle in diretta relazione con la
destinazione morale della ragione di cui Kant ci parla nell’Architettonica della ragione
pura. Tale passaggio, tuttavia, trova la sua ragione anche, e forse soprattutto, nella prima
formulazione dell’imperativo che viene spesso citata da Nancy nella Prefazione e in altri
saggi che compongono il libro di cui trattiamo qui.
Ma vediamo più da vicino tale formulazione categorica:
Poiché l’universalità della legge secondo cui accadono effetti costituisce ciò che
propriamente si chiama natura in senso generale (ossia secondo la forma), ossia l’esistenza
delle cose in quanto è determinata secondo leggi universali, allora l’imperativo universale
del dovere potrebbe anche suonare così: agisci come se la massima della tua azione dovesse
diventare, per mezzo della tua volontà, una legge universale della natura18.
Nella prima parte di questa formulazione, quella che riguarda la nozione di natura in
senso generale, sono da notare due elementi essenziali: Kant parla di forma della natura
ed esistenza degli enti. Questi termini compaiono anche nel § 14 dei Prolegomeni ad
ogni futura metafisica che voglia presentarsi come scienza in cui si distingue fra un
concetto di natura formaliter (secondo la forma) e un concetto di natura materialiter (se-
condo la materia), sostenendo che l’elemento formale della natura è l’esistenza degli enti
in quanto determinata da leggi; questa convinzione è ribadita poi nel § 16 in cui il ca-
rattere formale della natura è dato dalla conformità a leggi dell’esistenza degli enti. Ora
secondo i Prolegomeni e la prima parte della formulazione categorica, sopra riportata, il
concetto di natura è dato proprio dal rapporto che sussiste fra esistenza degli enti e legge
universale, fra individui e universalità. Questa idea, in definitiva, è espressa nelle stesse
analogie dell’esperienza. In esse Kant sottolinea come l’esistenza degli enti non si dia
mai in sé, ma solo come loro connessione e relazione. Saranno poi le relazioni formali
del tempo puro a priori (permanenza, successione, reciprocità) ad offrire modalità e li-
ceità alle connessioni fra gli esistenti. Per usare altre parole: a priori potremo trovare solo
i criteri oggettivi non dell’esistenza in sé degli enti mondani, ma delle loro reciproche
relazioni. Nei luoghi citati, il concetto di esistenza si delinea solo come relazionalità fra
gli enti, conforme a legge, sia in senso generale, come conformità a leggi della natura, sia
centrale della relazione intelligibile con l’altro anche se ancora legata al primato del soggetto nella
decifrazione del concetto dell’altro.
18 Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, cit., p. 421; trad. it., cit., p. 75.
385S pazio aperto
in senso più specifico come conformità a modi (regole) della temporalità pura da parte
delle esistenze (materie percettive).
A questo punto potrebbe ben sorprendere che nella seconda parte della formulazione
dell’imperativo categorico, ossia nel passaggio dalla concezione formale della natura al
mondo dell’agire pratico, il termine esistenza cada, non ci sia più e al suo posto subentri
il termine massima, per cui la conformità alla legge universale passa dalle esistenze alle
massime delle azioni. La conformità non è più fra enti esistenti e leggi, come in fondo
sostiene con vigore Nancy, ma fra massime e leggi, detto meglio fra individualità sog-
gettiva della massima e universalità della legge.
Ma è proprio questo il passaggio delicato che secondo Nancy va interpretato corret-
tamente.
Nella sua serrata critica alla morale kantiana, scrive Nancy, Nietzsche suppone che il
rapporto kantiano fra particolarità e universalità della massima sia concepibile in modo
tale che sia l’universale a doversi piegare alla particolarità della massima: «così come
giudico io» (particolarità) «devono giudicare tutti». E Nietzsche «ironizza su un simile
giudizio, esclamando: “Ammira piuttosto in ciò il tuo egoismo! E come il tuo egoismo è
cieco, limitato, senza pretese”»19. Non si tratta di fare dell’imperativo kantiano la formu-
la totalitaria dell’egoismo; l’imperativo non consiste affatto nel «sentire il proprio giu-
dizio come legge universale», ma esattamente nel rovescio, nell’opposto: bisogna, cioè
accettare come «come mio giudizio (come massima) solo quello che si può presentare
come legge universale, perché è la massima stessa a potermi determinare a volerla come
legge e non un io, soprattutto non un io sensibile, patologico a poterla determinare come
tale»20 continua a ricordare Nancy, commentatore del § 335 della Gaia scienza dedicato
alla “rettitudine”.
Nel passaggio dalla legge universale della natura alla massima, il ruolo centrale
dell’imperatività categorica rimane legato strettamente alla legge della natura, al suo
eccedere ogni individuo, si può dire al suo eccedere il soggetto in quanto tale.
L’imperativo finisce così per non identificarsi affatto con l’enunciato di un soggetto,
né di «di un qualche soggetto»21, l’imperativo s’impone al soggetto22.
È forse il ruolo centralissimo affidato alla legge che induce Nancy a cercare la desti-
nazione morale già negli stessi principi categoriali che determinano l’ordine della na-
tura, inteso come tessitura dinamica delle esistenze e loro costitutiva relazione ad una
eccedenza. Per consolidare il ruolo morale, imperativo della legge della natura, Nancy si
spinge fino a citare uno dei passaggi più complessi della Critica della ragione pratica,
19 Nancy, La nostra rettitudine! Sulla verità in senso morale in Nietzsche, in Id., L’imperativo categori-
co, cit., p. 91.
20 Ibidem.
21 Ibidem, p. 93.
22 Su questo punto Nancy si pone agli antipodi di un altro interprete di Kant: Georg Simmel. Il pensatore
tedesco ha, infatti, individuato nell’argomentazione dell’interesse come veicolo dell’universalizza-
zione della massima del soggetto il vulnus ma e al tempo stesso il fulcro insuperabile dell’imperativo
categorico. G. Simmel, Kant: Sechzehn Vorlesungen Gehalten an der Berliner Universität, Duncker &
Humblot, Leipzig 1904, pp. 97-140; trad. it., Kant: Sedici lezioni berlinesi, Edizioni Unicopli, Milano
1999, pp. 161-201.
386S Mariannina Failla
Jean-Luc Nancy e l’imperativo categorico
quello della Tipica, in cui il tipo della legge morale si determina come l’idea della legge
universale della natura. È essenziale qui accennare al ruolo di mediazione della Tipica
fra intelligibilità e natura, fra idealità razionale e pura forma dell’intelletto che ha una
grande importanza per Nancy il quale, interessato al significato categoriale dell’impera-
tivo, cerca nell’intelletto, nella sua legalità, il punto di contatto fra mondanità e raziona-
lità: “la finalità imperativa” è che la massima dell’azione divenga legge universale, abbia
cioè la capacità di connettere insieme le esistenze, questo è il ruolo della legge della
natura, il ruolo anzi l’apporto dell’intelletto alla realizzazione della finalità razionale,
della libertà. La tipica dell’intelletto puro pratico porta sulla scena proprio tale ruolo. In
analogia – potremmo dire con qualche azzardo, come dichiara lo stesso Kant – con lo
schematismo temporale, la legge offre uno schema intellettuale dell’ideazione raziona-
le. Il compito dell’intelletto, messo già in evidenza nel saggio hegeliano stabilendo un
sodalizio, istitutivo del mondano, fra primato del negativo e assoluto, nell’analisi della
morale kantiana, si configura come mediazione fra natura e idealità razionale. L’intel-
letto, infatti, mette in relazione proprio l’ideazione razionale e la forma pensabile della
legge morale che ha la sua determinazione nella forma della legalità in generale della
natura. Si vuole qui ribadire: alle soglie della Dialettica della ragione pratica, Kant è
interessato alla «possibilità» di quel giudizio puro pratico capace di individuare un cri-
terio di uniformità fra individuale e universale, non affidando più all’immaginazione,
ma all’intelletto la mediazione fra normatività della legge e sensibilità. Esso, tramite
la forma di una legge in generale, diviene schema – se è ancora permesso usare questa
parola, scrive lo stesso Kant – della legge morale, poiché è capace di esibire nei singoli
casi concreti la misura ideale della loro possibilità, esattamente quello che Nancy sembra
far valere contro l’interpretazione soggettivista nietzschiana dell’imperativo categorico
kantiano: è la legge a diventare misura ideale della massima consentendo così di giudi-
care in modo puro pratico se sia possibile che il caso particolare contenga in sé la forma
universale della legge pratica.
C’è un altro aspetto dell’interpretazione di Nancy su cui è importante riflettere: quale
rapporto dell’imperativo o comunque della legge morale con la necessità è proposto da
Nancy, e quale visione del male, della sua radicalità ci offre?
L’imperativo – ci dice Nancy – si presenta in modo duplice:
è sovranità senza riserve di un assoluto morale ed è, al tempo stesso, inaccessibile.
Insieme alla sua assolutezza, esso esibisce l’impossibilità di seguirlo, di obbedirgli, di
sottomettervisi. L’imperativo veicolerebbe un comandamento assoluto, dal tono imperioso
che tradisce un gesto coercitivo: esso diventerebbe una tirannia la cui inammissibile
paradossalità sarebbe incrementata dal suo rovescio: l’obbedienza, intesa come obbligo
costrittivo e per questo essa stessa antitesi altrettanto inammissibile della libertà.
L’imperativo verrebbe così a sopprimere la libertà dell’iniziativa e la libertà della de-
liberazione. Agite coercitivamente, queste due libertà, prese insieme, sopprimerebbero
la libertà dell’autodeterminazione, ossia il bene stesso. Esse sopprimerebbero, così, la
387S pazio aperto
capacità di autodeterminazione assoluta, quella che non può e non deve sottoporsi al
comando di alcuno. La libertà è, infatti, contraria ad ogni obbligo, non ha altra autorità
che sé stessa e si dà la sua legge. Nancy affronta qui un tema assolutamente non nuo-
vo. La domanda che attraversa l’ambiente filosofico post-kantiano, infatti, sembra poter
essere riassumibile in questo modo: nell’elaborare il concetto di volontà libera, Kant le
attribuisce il potere di determinarsi sia pro sia contro la legge morale? Oppure la volon-
tà, se vuole essere puro-pratica, può e deve essere determinata solo dalla legge morale,
testimoniando così una sorta di determinismo e coattività intelligibili, che fanno sì che
la volontà sia determinata solo dal bene puro-pratico23? Si potrebbe dire in termini molto
usuali: sembrerebbe che la libertà sia costretta al bene.
Nell’interpretazione di Nancy c’è, tuttavia, una richiesta non trascurabile che vale la
pena analizzare. Bisogna capovolgere la prospettiva: egli ci chiede di non pensare che
sia l’imperatività assoluta della massima categorica a determinare la nostra libertà, bensì
al contrario che sia la libertà ad autodeterminarsi come imperativa. L’imperativo cate-
gorico ci è ancora più vicino quando è questa stessa libertà (conosciuta come uno stato
o come un essere sottratto ad ogni comando esterno) a essere posta o forse è meglio dire
ad essere voluta come un imperativo categorico. È la “forza” della libertà ad autodeter-
minarsi come imperativa. Questo implica, tuttavia, un altro capovolgimento: bisogna
considerare la libertà non solo ratio essendi della legge morale, ma, forse ancor più, sua
ratio cognoscendi.
Ed è questa una distanza produttiva e moltiplicatrice dalla lettera kantiana:
Se la libertà in Kant – scrive Nancy – è la ratio essendi della legge morale quest’ultima
a sua volta è la ratio cognoscendi della libertà (il che fa dell’imperativo l’assai singolare
regime di questa “conoscenza”): per noi, al contrario, la libertà non è pensata né pensabile,
che a condizione di essere al tempo stesso ratio essendi e ratio cognoscendi di ogni legge
morale. Va da sé che essa s’imponga o che debba imporsi. E questa imposizione di sé, più
esattamente non è tale: se non bisognasse imporla o cercare d’imporla contro quelli che
se ne fanno beffe o che la denigrano, la libertà non s’imporrebbe; fiorirebbe, sboccerebbe
spontaneamente, poiché in fin dei conti ha la natura di un’essenziale e pura spontaneità24.
La dinamica oppositiva di libertà e necessità, o più precisamente il suo superamento,
si lega poi per Nancy all’etica dell’ossessivo: cosa vuol dire, però, qui “ossessivo o os-
sessionare”?
Secondo l’etimologia antica – scrive Nancy – ciò che ossessiona (haute) è ciò che
abita (habite) o, secondo l’etimologia più dotta, ciò che riporta all’ovile; hauter appar-
tiene così alla famiglia semantica del focolare (Heim) e l’imperativo categorico potrebbe
23 Per le fonti della disputa fra leibniziani e kantiani sul tema del determinismo o indeterminismo in-
telligibile si veda S. Landucci, Sull’etica di Kant, Guerini e Associati, Milano 1994, pp. 283-340.
La documentazione della discussione – nella prima recezione della filosofia kantiana – sui temi del
determinismo naturale e intelligibile è offerta da R. Bittner (a cura di), Materialen zu Kants Kritik der
praktischen Vernunft, Surhkamp, Frankfurt am Main 1975, pp. 139-323.
24 Nancy, Il Kategorein dell’eccesso, in Id., L’imperativo categorico, cit., p. 18.
388S Mariannina Failla
Jean-Luc Nancy e l’imperativo categorico
inscenare per noi proprio il ruolo della Un-heimlichkeit che ci ossessiona. Il comando
esprimerebbe, così, l’inquietudine per la non-familiarità dell’imperatività necessitante
della legge, per il suo dispotico comando assoluto, ciò che ha fatto irritare o sorride-
re da Hegel a Nietzsche, «da Hegel a noi»25. Proprio di fronte allo spaesamento della
coercizione, Nancy sembrerebbe suggerire: l’idea che sia la libertà ad essere ragione
di sussistenza e di conoscenza della legge, potrebbe riportare questa stessa legge al suo
ovile, che è in definitiva l’umano, il suo ethos. L’etica dell’ossessivo vuole così rendere
familiare l’inquietante o, potremmo dire con Freud, il perturbante26, ossia l’assoluta ver-
ticalità del comando imperativo. Sceglierlo liberamente significa, infatti, trasformarlo in
una pratica familiare, nell’ethos.
Che ne è del male – chiediamo in ultimo – nell’etica dell’ossessivo? Esso è legato
all’opposizione reale cui si trova di fronte il libero arbitrio come sembra in definitiva
proporre lo stesso Ricoeur27? O la strada proposta da Nancy è diversa? Certamente la sua
via interpretativa si distanzia da quella ricoeuriana: in primo luogo il male è implicato
di diritto dalla legge imperativa. Il male non è la corruzione della massima, ma del suo
fondamento e questo vuol dire che la massima non può più “far legge”; il male allora non
è una legge contraria alla massima imperativa quanto piuttosto la disposizione contraria
alla legge tout court, è cioè la disposizione illegislatrice.
Ora proprio perché la legge è la legge di fare la legge (o di far legge) che rivela da sé o
in qualche modo in se stessa l’iscrizione di questa possibilità. Una legge ordinaria lascia il
fuori legge fuori da se stessa per definizione. Ma la legge della legge lo include come colui
al quale essa è necessariamente rivolta, mentre egli, a sua volta, è abbandonato a tutto il
25 Ibidem, p. 16.
26 Solo apparentemente il perturbante implica, per Freud, la contrapposizione antitetica fra familiare,
patrio, natio, affidabile, confortevole (heimlich) e estraniante, spaventoso, disorientante, inquietante
(unheimlich). Ispirandosi ad alcuni passi schellinghiani, Freud afferma che il termine heimlich non
implica solo il familiare, l’accogliente, ma anche ciò che è nascosto, segreto; un-heimlich può essere
inteso, allora, non come opposizione antitetica e irriducibile a ciò che è heimlich, ma come suo svela-
mento; svelamento che Freud denomina ritorno di ciò che è rimasto segreto e nascosto ad opera della
rimozione. Il perturbante allora non è antitetico al familiare, è il ritorno del suo segreto più intimo. S.
Freud, Il perturbante (1919), Opere, Bollati Boringhieri, Torino 1966-1980, vol. IX, p. 86.
27 Il problema del male come affezione dell’autonomia della ragione puro-pratica è analizzato da P.
Ricoeur, Soi-même comme un autre, Édition du Seuil, Paris 1990, pp. 306-309; trad. it., Sé come un
altro, Jaca Book, Milano 1993, pp. 316-319, e Id., Le mal. Un défi à la philosophie et à la theologie,
Labor et Fides, Centre protestant d’études, Genève 1986; trad. it., Il male. Una sfida alla filosofia e alla
teologia, Morcelliana, Brescia 2003. P. Ricoeur mette a fuoco due elementi fondamentali della teoria
kantiana del male: il primo si lega all’interpretazione del male come «opposizione reale» al bene, il
secondo riguarda il concetto di radicalità del male. Se il male è un cattivo uso delle massime della
libertà e non indica la cattiveria del desiderio sensibile – se quindi ha una natura intelligibile come la
legge puro-pratica dell’autonomia della ragione – esso affetta il libero arbitrio, la legge della libertà,
mettendosi sullo stesso piano del rispetto della legge che sta a fondamento del bene. Radicalizzando
in questo modo il male, Kant ha radicalizzato anche l’idea del libero arbitrio. Il male diviene «opposi-
zione reale al rispetto della legge». Esso affetta la libertà come la affetta il rispetto della legge, il libero
arbitrio diviene dunque il luogo di opposizione reale fra le massime. Il male riesce così a svelare la
natura ultima del libero arbitrio, ossia la sua natura conflittuale.
389S pazio aperto
rigore della legge28.
Il male allora non è inversione delle massime, loro perversione, e tanto meno tra-
sgressione della legge29, il male è insito nella legge stessa, è sua negazione assoluta. Con
l’accentuazione di sapore paolino della relazione indissolubile, o della reciproca inter-
connessione di capacità legiferante e disposizione illegislatrice, si vogliono concludere
queste brevi note sulla Prefazione che Nancy scrive per l’edizione italiana della raccolta
di saggi dedicati al comando.
28 Nancy, Il Kategorèin dell’eccesso, in Id., L’imperativo categorico, cit., p. 24 e s.
29 Lo stesso Kant non interpreta la trasgressione (Übertretung) come avvilimento o perversione della
legge, bensì come riconoscimento della sua universalità: «Ora se noi prestiamo attenzione a noi stessi
in ogni trasgressione di un dovere, troviamo che in realtà non vogliamo che una nostra massima debba
diventare una legge universale, perché ciò è impossibile, bensì vogliamo piuttosto che il contrario di
essa debba restare una legge universale». Cfr., Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, cit., p.
424; trad. it. cit., p. 81.
390Puoi anche leggere