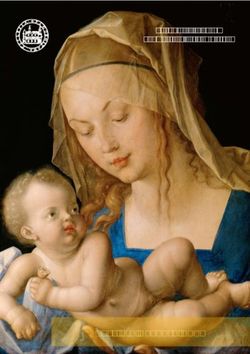SINTESI RAGIONATA DE: "IL TESTAMENTO DI GESU'" DI ROMANO GUARDINI - CORSO DI PERFEZIONAMENTO LITURGICO - MUSICALE
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
CORSO DI PERFEZIONAMENTO
LITURGICO – MUSICALE
(CO.PER.LI.M)
SINTESI RAGIONATA DE: “IL TESTAMENTO
DI GESU’” DI ROMANO GUARDINI
Bondavalli Matteo
Anno 2002 - 2003
1Il Testamento di Gesù: Premessa
“Poco prima di morire, durante l’ultima cena, Gesù fece dono ai suoi
dell’eucaristia, il ‘segno’ nel quale voleva essere ‘ricordato’ per sempre, una sorta di
testamento che avrebbe accompagnato il cammino della Chiesa nella storia”1.
Leggendo queste parole di Romano Guardini, che introducono l’opera trattata,
ripenso a quante volte il ‘testamento’ lasciato da Gesù poco prima di morire sia
continuamente riproposto dalle nostre comunità nelle quali, spesso, rimane solo un ricordo
svuotato del significato. Molti infatti sono gli interrogativi che si possono riscontrare in
questo testo. Interrogativi che nascono dal fatto che “per molti la messa ha acquisito il
carattere di una sacra rappresentazione alla quale il fedele assiste, o di un evento misterioso
che invita alla preghiera”; una visione che “cela il suo reale significato, e ne nasconde
l’insostituibile valore”2.
Con una attenta analisi, l’autore, riesce a mantenere uniti sia l’aspetto teologico
sacramentale che quello antropologico pastorale. Una formazione liturgica, quindi, attenta
sia al dato oggettivo della celebrazione, ai vari aspetti metodologici del suo svolgimento e
alle implicazioni umane di coloro che vi partecipano, in particolar modo analizzando
l’aspetto della preparazione interiore.
1
GUARDINI R., Il testamento di Gesù, Milano, Vita e Pensiero, 1993, citazione presa dal frontespizio del
libro.
2
GUARDINI R., Il testamento di Gesù, Milano, Vita e Pensiero, 1993, p. 25
2La riflessione si articola in due momenti: prima di tutto si cerca di dimostrare che
“perché l’atto liturgico sia serio, occorre una approfondita preparazione interiore”3.
Successivamente, nella seconda parte, l’analisi dell’”essenza della messa” risponde sempre
all’esigenza di una maggiore partecipazione, quindi, una riflessione che possa servire per
una presa di coscienza di quanto accade nella celebrazione liturgica.
Ho scelto quest’opera di Romano Guardini come risposta anche ad alcune domande
che - nella preparazione al sacerdozio, a contatto con differenti comunità parrocchiali, in
un approfondimento teologico apparentemente distante da un vissuto concreto - sono
emerse in quest’ anni. Molte di queste si identificano con quelle dell’autore, prova del
fatto che, come lui stesso scrive: “questo volume ha avuto origine da alcuni discorsi in
preparazione al rito della messa. Il loro scopo non è quello di chiarire l’essenza della
memoria del Signore o di illustrarne la storia, ma di indicare i compiti che essa assegna e il
modo migliore per assolverli”4. Nel corso dell’esposizione intendo presentare la
prospettiva dell’autore, riassumendo quindi una serie di riflessioni apparentemente
ripetitive ma lecite, sempre secondo quanto egli stesso afferma: “le ripetizioni si
giustificano in considerazione dello scopo pratico di questo volume […] guidare il lettore
ad agire correttamente; ma agire equivale ad esercitarsi, ed esercitarsi significa ripetersi”. 5
Ritengo opportuno, prima di presentare il libro, inquadrare, anche se in modo
sintetico, l’autore e l’ambiente in cui è vissuto, al fine di comprendere meglio il suo
interesse liturgico e la conseguente riflessione.
Romano Guardini
L’opera di Guardini offre un tentativo di riflessione sulla liturgia da cui non si può
prescindere. Egli ha cercato il fondamento della liturgia si basi filosofiche. Ha mostrato
che il culto può presentarsi all’uomo come uno degli elementi più autentici della sua
3
GUARDINI R., Il testamento di Gesù, Milano, Vita e Pensiero, 1993, p. 26
4
GUARDINI R., Il testamento di Gesù, Milano, Vita e Pensiero, 1993, p. 25
5
GUARDINI R., Il testamento di Gesù, Milano, Vita e Pensiero, 1993, p. 115
3esistenza. Ha compreso che il linguaggio liturgico si muove nell’area del simbolico e del
ludico.
L’interesse di Guardini per la liturgia nasce dalla sua preoccupazione più generale
per l’uomo moderno e della sua vocazione di educatore. Fin dagli anni ’20 egli ha
diagnosticato lucidamente la crisi che attraversa l’epoca contemporanea e ha tentato di
fondare una risposta, partendo proprio dalla liturgia.
Una delle sue opere più mature è “La fine dell’epoca moderna”. Guardini prende in
considerazione la crisi delle tre idee fondamentali dell’epoca.
La prima crisi è la perdita di fiducia nella razionalità della natura e del mondo.
L’uomo non sente più la natura come un ordine saggio e benigno e il mondo come un tutto
ordinato razionalmente.
La seconda crisi consiste nel passaggio dalla personalità alla massa. L’epoca
moderna si fondava sulla centralità del soggetto; oggi invece si afferma l’uomo della
massa, che non ha affatto la volontà di essere originale, anzi si inserisce spontaneamente
nell’organizzazione.
La terza crisi riguarda la cultura: il distacco dall’esperienza dalla conoscenza e dalla
azione. Adesso l’uomo conosce assai di più di quanto può vedere o sperimentare, per cui i
rapporti con la realtà perdono l’immediatezza. Allo stesso modo i rapporti fra l’uomo e la
sua opera diventano indiretti, astratti, obiettivi.
L’epoca moderna si è nutrita di una ingenua fede nel progresso scientifico. Oggi
comprendiamo che essa si è illusa: si pensava che ogni aumento di conoscenza ( e quindi
di potenza) dell’uomo fosse un bene. Ci si è accorti che l’uomo moderno non è stato
educato ad un uso retto del potere che ha acquistato; sembra addirittura che questa potenza,
che l’uomo ha sottratto all’ambito della “natura”, venga dominata da qualcosa di caotico:
“Quando la coscienza dell’uomo non assume la responsabilità della potenza, ne prendono
possesso i demoni”6. La cultura era nata per rassicurare l’uomo, immerso in una natura
ostile. Oggi il pericolo maggiore non proviene da ciò a cui la scienza non ha ancora dato
6
GUARDINI R., La fine dell’epoca moderna , Brescia, Morcelliana, 1950
4risposta, ma da ciò che essa ha scoperto. L’uomo “ha il potere sulle cose ma non ha ancora
potere sul proprio potere”7.
Nell’epoca moderna la rivelazione viene messa in dubbio. Si afferma una sorta di
autonomia di ogni aspetto della vita (scienza, economia, politica…) e la vita religiosa
perde i contatti con la vita concreta e viene relegata ad alcuni ambiti. Così l’uomo
moderno subisce un indebolimento delle sue disposizioni religiose naturali. Gli eventi della
vita diventano puri fenomeni biologici, da controllare (nascita) o anestetizzare (morte).
L’epoca moderna però non mette in dubbio i valori etici del cristianesimo: tenta il loro
recupero, come valori naturali. Il cristianesimo ha sempre visto con sospetto l’epoca
moderna, proprio per questa sua slealtà nell’appropriarsi dei valori cristiani. L’epoca che
vivremo, secondo Guardini, porterà molta maggiore chiarezza in merito: l’esistenza non
cristiana si manifesterà in modo molto più deciso. Il nuovo paganesimo sarà molto meno
umano di quello antico.
Nel pensiero di Guardini la liturgia si innesta nell’orizzonte più ampio
dell’esperienza religiosa. Per Guardini il concetto viene a noi attraverso la mediazione
dell’occhio. Però quando l’uomo guarda, non coglie solo dei dati immediati, ma in essi può
afferrare un autentico che sta dietro e che appare nei dati. Le cose rivelano un’ulteriorità.
“Tutte le cose sono […] dei plusvalori; ognuna dice più di tutto quello che è : ognuna
allude a qualcosa che essa stessa non è, ma che appartiene e partecipa alla realtà della cosa
come sua origine, senso ultimo […]. Questo originario e universale autentico che sta dietro
ad ogni singola autenticità è la realtà religiosa”. “La religione è la risposta all’ultimamente
autentico che affiora dalla realtà del mondo”. Da qui il concetto di “epifania” che è
l’apparire del divino in forma sensibile. Nel nuovo testamento l’epifania è Gesù Cristo. Nel
tempo della Chiesa è la liturgia. Essa è lo strumento del messaggio di Dio in cui è
impegnato l’uomo nella sua totalità. La liturgia è epifania perché in essa le cose, le parole e
le azioni non servono per scopi utilitaristici, “non servono a nulla, ma rivelano significati”.
Andando alla radice, Guadini, arriva ad affermare che il linguaggio epifanico della liturgia
è capace di restituire l’uomo a se stesso e di curare le malattie della civiltà contemporanea.
Nella crisi di identità che lo assilla, l’uomo può riscoprire la sua vera immagine proprio
7
GUARDINI R., La fine dell’epoca moderna, Brescia, Morcelliana, 1950
5attraverso la liturgia. Da cui la preoccupazione di Guardini, come studioso: trovare un
senso antropologico della liturgia, per poterla ricollocare tra le scienze e per riconsegnarla
all’uomo secolarizzato come una possibilità di esistenza autentica.
I Parte: Il contegno
“L’esperienza insegna che, dietro un imperfetto celebrare, c’è un vivere anch’esso
imperfetto. Se l’Eucaristia è il centro della vita della comunità cristiana, essa ne diviene
anche lo specchio: appannato o distorto o fedele. C’è dunque una ragione profonda che ci
sollecita a considerare il volto delle nostre comunità cristiane a partire dal modo stesso di
celebrare l’Eucaristia, imparando a leggere in trasparenza liturgia e vita”8.
Con queste parole, mons. Adriano Caprioli, vescovo della diocesi di Reggio Emilia
– Guastalla, introduce il tema della lettera pastorale per l’anno 2002-2003: l’Eucaristia.
Una riflessione che riassume l’esperienza del vivere la liturgia a contatto con differenti
comunità parrocchiali. Da questa considerazione possiamo domandarci che cosa significa
celebrare in modo corretto l’Eucaristia, o meglio, quali sono le azioni da svolgere e con
quale modalità, affinché una comunità, possa vivere questo sacramento. Io stesso più volte
mi sono confrontato con questi interrogativi e ho visto che spesso, preoccupato anche da
eventuali servizi liturgici, ho cercato risposte superficiali o finalizzate all’aspetto del “fare”
e non dell’”essere”. È interessante allora notare che la prima parte del libro di Guardini si
riferisca al “contegno che la celebrazione rende possibile e induce”9. Mediante la
trattazione di questo atteggiamento emerge con particolare evidenza il carattere della
partecipazione. Prima quindi di domandarci “che cosa” bisogna fare nella liturgia, occorre
prendere coscienza di chi siamo, scoprendo che il nostro essere anela all’incontro con Dio,
incontro che è reso possibile in modo speciale durante la celebrazione Eucaristica.
8
CAPRIOLI ADRIANO, Cinque pani, due pesci e la folla, lettera pastorale 2002-2003, Reggio Emilia,
Grafitalia 2002, p.5.
9
GUARDINI R., Il testamento di Gesù, Milano, Vita e Pensiero, 1993, p. 115
6Anche semplicemente scorrendo i titoli dei vari capitoli della prima parte è possibile
vedere che alcuni aspetti come il silenzio, il raccoglimento, l’azione sacra, la parola, gli
impedimenti, sono aspetti di un unico atteggiamento da riscoprire.
Se prendiamo ad esempio i “Principi e norme per l’uso del messale romano” notiamo che
in alcune parti il tema del silenzio è trattato, segno questo, che nella celebrazione assume
un carattere non secondario. Nella riflessione di Guardini è posto all’inizio. “Il sacerdote
parla a bassa voce o esegue in silenzio quanto prescrive la liturgia; la comunità partecipa
con gli occhi e con la preghiera. Qual è il significato di questi silenzi? Che cos’è il
silenzio?”10.
Rispondendo a questa domanda colgo l’occasione per precisare una delle linee guida
dell’opera di Guardini.
Come abbiamo detto all’inizio, cercando di introdurre la trattazione, l’autore si
scontra con una visione di liturgia intesa come sacra rappresentazione. Questo in quanto
per molti è sufficiente svolgere una serie di precetti i quali, nell’insieme, danno vita alla
celebrazione. Peggio ancora quando, nell’andare a messa, si crede di doversi predisporre
come semplici spettatori di una manifestazione che ci sta davanti e non chiama in causa più
di tanto la nostra collaborazione. Occorre allora riscoprire prima di tutto il valore di una
comunità riunita nell’atto di celebrare11. Una comunità che celebra richiede quindi l’azione
di ciascuno affinché si possa veramente parlare di comunione. Il rito esige una comunità e
la crea12.
Alla critica nei confronti dell’idea di sacra rappresentazione segue una delle
interessanti definizioni di Guardini riguardo alla messa: “occorre agire per conoscere il suo
carattere essenziale, quello di azione, ‘azione sacra compiuta in Sua memoria’”13. Ecco
quindi una delle idee che ripercorrono tutto il testo. Il Signore, la sera prima di morire, ha
10
GUARDINI R., Il testamento di Gesù, Milano, Vita e Pensiero, 1993, p. 31
11
GUARDINI R., Il testamento di Gesù, Milano, Vita e Pensiero, 1993, nei capitoli: La comunità e la
riparazione del torto – pp. 93-95 e Comunità e Cristo – pp. 96-100.
12
Possiamo fare riferimento a due testi tratti dai padri della Chiesa: IGNAZIO D’ANTIOCHIA, Lettera ai
Filadelfi, 7,1 “fate attenzione a partecipare ad un’unica eucaristia, perché unica è la carne del Signore nostro
Gesù Cristo, unico il calice che ci unisce al suo sangue; unico è l’altare e ugualmente unico è il vescovo con
il suo presbiterio e i suoi diaconi”. CIPRIANO, Epistole, 69,5: “Quando il Signore chiama suo corpo il pane,
che risulta dalla raccolta di molti chicchi di grano, egli indica il nostro popolo, che egli portava radunato in se
stesso”.
13
GUARDINI R., Il testamento di Gesù, Milano, Vita e Pensiero, 1993, p. 27
7fatto determinate azioni lasciando il seguente comando: “fate questo in memoria di me”.
Definendo quindi le caratteristiche di questa azione sacra notiamo come il silenzio sia una
delle condizioni fondamentali. Silenzio che è già la prima azione che ognuno deve
compiere. Silenzio non come spazio vuoto che noi dobbiamo riempire ma condizione
favorevole per renderci conto della Sua presenza. Le caratteristiche del contegno partono
da questo silenzio il quale non deve essere sottovalutato nella sua attuazione. Possiamo
considerare il silenzio come la prima azione della comunità che si riunisce per celebrare, il
presupposto di un atteggiamento interiore idoneo all’ascolto e alla preghiera.
“Silenzio e parola si completano a vicenda”14. Continuando la lettura questa azione sacra
rivela il suo profondo significato e, per questo motivo, il raccoglimento del fedele è un
presupposto determinante. Lo stesso “essere presenti”, in un atteggiamento raccolto, è un
atto interiore che si traduce nel contegno. Raccoglimento e partecipazione sono due
atteggiamenti che si richiamano vicendevolmente, in quanto, secondo le parole di
Guardini, “come la parola può degenerare in vaniloquio, così il silenzio in mutismo”15. E
se affermiamo che la nostra azione è partecipazione, visto che questa stessa espressione
significa “agire insieme a un altro, in questo caso al sacerdote, il quale è presente non per
se stesso ma per la comunità”16, capiamo che a tutti i fedeli vengono richiesti questi
atteggiamenti interiori ed esteriori.
A questo punto occorre compiere un ulteriore passo in avanti. Lasciando al
prossimo capitolo le riflessioni riguardanti il carattere del memoriale, vorrei presentare
questo problema: in una liturgia eucaristica non facciamo una semplice rappresentazione e
nemmeno il ricordo di un fatto che rimane nel passato. Sono passati quasi duemila anni
dall’ultima cena fatta da Gesù ma questo non toglie che la Sua presenza, nella celebrazione
eucaristica, è reale e noi partecipiamo al suo sacrificio. Questa partecipazione richiede da
parte nostra una risposta ad alcune domande: che valore ha la parola che ascolto, che
proclamo, che prego? Dove mi trovo? Che significato ha il tempo della celebrazione?
Com’è possibile vivere oggi un evento del passato?
14
GUARDINI R., Il testamento di Gesù, Milano, Vita e Pensiero, 1993, p. 35
15
GUARDINI R., Il testamento di Gesù, Milano, Vita e Pensiero, 1993, p. 35
16
GUARDINI R., Il testamento di Gesù, Milano, Vita e Pensiero, 1993, p. 49
8Per introdurla cito una delle conclusioni del corso sull’Eucaristia tenuto dal prof,
Mazza Enrico. “Nell’ultima cena ci sono degli oggetti, il pane, il vino, la tavola, il luogo
della celebrazione. […] ci sono dei riti, il rito del pane e quello del calice. Ci sono dei gesti
[…], delle parole e delle preghiere. Dato che l’immagine partecipa ontologicamente del
tipo, tutto ciò che appartiene alla natura dell’ultima cena appartiene anche, per
partecipazione, alla natura dell’eucaristia della Chiesa”17. Con queste parole possiamo
vedere i temi riguardanti i gesti, la mensa, il luogo sacro, il tempo sacro, del libro di
Guardini. Partecipando alla celebrazione eucaristica, il fedele, si ritrova in un luogo (la
Chiesa), in un tempo (il giorno del Signore), vedendo gesti e oggetti (il sacerdote dietro
all’altare, il luogo della proclamazione della parola, etc), che richiedono la riscoperta dei
loro fondamenti teologici. Con estrema sintesi e chiarezza espositiva, Guardini, continua
la sua riflessione cercando di delinearne il significato e dedicando ampio spazio all’aspetto
della parola. Chi partecipa al convito eucaristico, quindi, grazie all’opera di contegno già
delineata precedentemente, è chiamato a stupirsi nuovamente davanti alla venuta del
Signore, in un tempo redento e sacro, ascoltando e dando voce alla parola di Dio. Una
parola proclamata e ascoltata. Parola che esprime questo essere in comunione con Dio.
Parola quindi che assume i connotati della rivelazione: “non dobbiamo limitarci a
concepire idee e comprendere comandi, ma dobbiamo dischiudere l’animo a colui che
viene con potenza divina”18. Parola consacratoria con la quale il sacerdote presta al
Signore la propria voce e Cristo, in lui, pronuncia le parole dell’istituzione. Una parola di
lode e di preghiera nella quale il dialogo intimo fra l’uomo e Dio diventa espressione della
comunione che è Suo dono e nostra responsabilità nell’accoglierlo liberamente.
Oltre alla parola occorre rendersi conto che il luogo nel quale ci troviamo non lo
possiamo paragonare a qualsiasi altro edificio. Quando celebriamo siamo all’interno di una
Chiesa. Ma che cos’è una Chiesa? Secondo le parole di Guardini: “La Chiesa riconosce
che tutto appartiene al regno di Dio, e delimita nel mondo uno spazio negato a ogni uso
17
MAZZA ENRICO, La celebrazione eucaristica, Milano, San Paolo, 1996, pp.346-347
18
GUARDINI R., Il testamento di Gesù, Milano, Vita e Pensiero, 1993, p. 79
9profano e consacrato esclusivamente al culto, in cui il fedele può cogliere una realtà che
non è natura né opera umana: il sacro”19.
Lo stesso tempo è un tempo sacro. La domenica ha un carattere quasi sacramentale.
Ma rendersene conto è molto difficile e occorre veramente molta volontà per evitare che
sia considerata solo come un momento di riposo o svago. Proprio in queste riflessioni
notiamo la distanza fra il nostro ritmo di vita quotidiano nel suo incalzare e la natura di un
tempo che solo Dio può rendere sacro e nel quale siamo chiamati a fermarci al suo
cospetto. La domenica, secondo l’autore, “è in pericolo proprio perché non rientra nel
ritmo naturale della vita. Ciò che è naturale riesce ad affermarsi , ma la domenica affonda
le proprie radici nella rivelazione”20.
Per quanto riguarda i vari oggetti presenti all’interno della liturgia, anche questi
hanno un loro significato il quale viene espresso non nella sua forma originaria ma sempre
e mediante il linguaggio simbolico, il linguaggio dei segni. Quale valore diamo a questi
simboli e come, in base alla nostra esperienza, comprendiamo ciò che devono comunicare?
Anche in questo caso gli atteggiamenti interiori e le predisposizioni, oltre alla conoscenza a
riguardo, sono elementi di un continuo rinnovamento che ognuno è chiamato a compiere.
Non bastano sporadiche occasioni per entrare nel linguaggio dei segni e rimanere in un
atteggiamento di contegno lungo il corso dell’intera celebrazione. Interessante in questa
parte è il continuo collegamento fra dato oggettivo della rivelazione e i vari aspetti
antropologici umani i quali non vengono annullati ma, in quanto creati da Dio, sono in
grado di divenire strumento per questa comprensione, secondo una collaborazione umana
libera e responsabile.
Rimanendo fedele alla natura di questo scritto, finalizzato ad aiutare il fedele per
una adeguata partecipazione alla messa, l’autore evidenzia alcuni impedimenti che, se
abbiamo il coraggio di riconoscerli e analizzarli, possono trasformarsi in suggerimenti per
migliorare il modo con cui partecipiamo alla celebrazione.
Quali sono questi impedimenti che interpellano ognuno di noi? Riassumendo
Gaurdini ne evidenzia tre: l’inadeguatezza, l’abitudine e il sentimentalismo. Possiamo
19
GUARDINI R., Il testamento di Gesù, Milano, Vita e Pensiero, 1993, p. 54
20
GUARDINI R., Il testamento di Gesù, Milano, Vita e Pensiero, 1993, p. 67
10interpellare allora la nostra coscienza e lasciare che, nei confronti dell’azione sacra
compiuta in Sua memoria, delinei ciò che non è conforme a quanto stiamo facendo. Spesso
abituati a quanto, fin da piccoli, abbiamo fatto, non cogliamo più il significato delle parole
del salmista: “Cantate al Signore un canto nuovo”. Come cantare un canto nuovo quando
l’inno rimane sempre il medesimo? “Ciò non significa che il cantore ha creato un nuovo
inno, ma che l’inno deve sgorgare dalla freschezza del cuore. La capacità di rinnovamento
fa parte dell’essenza della vita”21. A queste parole di Guardini mi permetto di aggiungere
che solo rimanendo con Colui che sa fare nuove tutte le cose potremo veramente vivere
l’incontro con Dio come un momento unico e irripetibile. Con lo stesso modo di procede
possiamo considerare anche il caso del sentimentalismo o, in particolare per i sacerdoti e
coloro che svolgono un servizio, il fenomeno dell’inadeguatezza avvertita nell’accostarci a
compiere un’azione che sentiamo distante dal nostro vissuto.
I temi trattati sono molti e il modo con cui Guardini li presenta rivela la sua
attenzione alle predisposizioni interiori del fedele nel vivere la liturgia: una serie di
indicazioni che si possono riassumere nella parola “contegno”, atteggiamento necessario a
cui tutti sono chiamati. Ognuno infatti “è responsabile, per la sua parte, della celebrazione
della messa. Nella misura in cui il singolo è in grado di eliminare una stonatura nell’ambito
dell’ordine stabilito o di apportare un miglioramento, è tenuto a farlo. […] Deve ricordare
che nessuna inadeguatezza può compromettere l’essenza della messa; egli deve entrare in
contatto con l’azione sacra e contribuire alla sua celebrazione”22.
II parte: Essenza della messa
21
GUARDINI R., Il testamento di Gesù, Milano, Vita e Pensiero, 1993, p. 103
22
GUARDINI R., Il testamento di Gesù, Milano, Vita e Pensiero, 1993, p. 111
11“Io, infatti, ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso: il
Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo
spezzò e disse: «Questo è il mio corpo, che è per voi; fate questo in memoria di me». Allo
stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: «Questo calice è la nuova
alleanza nel mio sangue; fate questo, ogni volta che ne bevete, in memoria di me». Ogni
volta infatti che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte
del Signore finché egli venga”23.
Con queste parole di san Paolo possiamo riassumere il contenuto della seconda
parte del libro di Guardini. Nel presentarlo vorrei anche mettere in evidenza il fatto che
queste riflessioni sono un aiuto concreto ad eventuali dubbi o tentazioni che, nel momento
in cui si cerca di vivere la liturgia, possono sorgere in noi. Potremmo infatti chiederci quale
concretezza storica sta alla base della memoria celebrata. Come difenderci ad esempio dal
dubbio che la messa sia la rappresentazione di un mito. Ancora, come vivere nell’oggi un
evento apparentemente celato nel passato? Con quali benefici? È veramente necessaria la
mediazione di una istituzione come la Chiesa per vivere il nostro rapporto di comunione
con Dio?
Quando nei vangeli o in san Paolo leggiamo quello che Gesù ha fatto la notte
precedente alla sua morte, notiamo che Gesù stesso ha istituito questa azione. Si vede bene
nel comando che ha lasciato al termine della cena: “Fate questo in memoria di me”. Ci
accorgiamo allora che per rispettare questa Sua volontà non occorre inventare nuove
modalità, quasi come se l’evento di cui si fa memoria dovesse continuamente essere
rappresentato in modo sempre più affascinante o avvincente. Leggendo con attenzione
quanto troviamo nei vangeli sinottici, nel capitolo sesto di Giovanni, in san Paolo nella
lettera ai Corinzi, comprendiamo che “quanto fu istituito nel cenacolo è stabilito da Dio.
L’uomo non deve creare o decidere o disporre, ma obbedire ed eseguire. Di più: questa
istituzione è assegnata a un’autorità, a una custodia, a un ordinamento particolare”24.
Per non cadere in un atteggiamento fiduciale che ha paura di interrogare le fonti storiche,
occorre rendersi conto che questa istituzione ha un fondamento storico preciso. Non la
23
1 Cor 11, 23-26
24
GUARDINI R., Il testamento di Gesù, Milano, Vita e Pensiero, 1993, p. 119
12possiamo paragonare ai misteri, ad esempio, delle religioni greche nelle quali le azioni
sacre rievocano delle figure religiose del passato. Figure però, come ad esempio Dioniso e
Demetra, che non hanno un fondamento storico ma rimangono nel mito. “Gesù è vissuto
realmente. Era il figlio del Dio vivente fatto uomo. Si è calato nella storia ed è esistito
entro i confini della vita umana, in un determinato paese, in luoghi e in un’epoca che è
stato possibile accertare nei minimi particolari”25. Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, non
è un mito e la sua stessa missione tramandata nei secoli rimane legata ad una verità che ci
riguarda in tutta la nostra totalità.
Se affermiamo allora la storicità dell’evento Cristo, non possiamo negare il modo
con cui ha voluto che le sue parole potessero giungere a noi. Ha desiderato ardentemente
celebrare la Pasqua con i suoi e, proprio questi, sono divenuti i primi interlocutori fra Gesù
e noi. In seguito, nella tradizione della Chiesa, Gesù continuamente si è reso presente fra
coloro che, rispondendo al Suo comando, “fate questo in memoria di me”, hanno celebrato
questa azione sacra istituita da Lui. Abbiamo già detto qual è l’evento sul quale si fonda
l’istituzione dell’eucaristia. Dopo di che, considerando tale evento in relazione con la
morte e risurrezione di Cristo, comprendiamo che il suo amore e la sua missione redentrice
sono il contenuto del memoriale. Sappiamo anche che Gesù ha celebrando la Pasqua con i
suoi, ha utilizzato un memoriale presente nell’antico testamento e portato da Lui stesso a
compimento, rispettandone la forma (cena) ma cambiandone il contenuto26.
L’effettiva storicità di Cristo e della tradizione della Chiesa ci aiutano a
comprendere il carattere reale di quello che facciamo ogni volta che siamo riuniti intorno
alla mensa del Signore. Il pane e il calice non sono semplici segni del suo amore. Se Gesù
avesse utilizzato un’ espressione del tipo: “…questo significa il mio corpo”, oppure
“…questo è espressione del mio sangue” etc, potremmo sentirci esentati da questo
carattere reale. Gesù però utilizza il verbo essere: “questo è il mio corpo”. Veramente
nelle parole della istituzione noi sentiamo Cristo che si rende presente e ci offre ancora una
25
GUARDINI R., Il testamento di Gesù, Milano, Vita e Pensiero, 1993, p. 125
26
Per approfondire questo aspetto: GUARDINI R., Il testamento di Gesù, Milano, Vita e Pensiero, 1993, pp.
127-130: “La memoria della nuova alleanza”.
13volta quel pane che è il suo corpo e il calice del suo sangue. Quando ci riuniamo per
celebrare il nostro rendimento di grazie a Dio, siamo in comunione intorno a quel
medesimo pane e calice sul quale Cristo dice “questo è il mio corpo”, “questo è il calice
del mio sangue”.
Se precedentemente ci chiedevamo in che modo un evento apparentemente celato
nel passato potesse rendersi presente, ora, lasciando parlare le stesse parole dell’autore, ci
rendiamo conto che questo mistero è ancora più grande e affascinante. La nostra azione
sacra infatti ha un suo inizio e una sua fine. “In questo sviluppo limitato nel tempo, che
riflette appieno la nostra esistenza effimera, entra l’eterno. Ciò che in Dio è immutabile, si
fa predente in un evento terreno transitorio”27.
Accingendomi alle conclusioni finali, vorrei presentare un ulteriore aspetto che
ritengo importante. Continuamente Guardini, nello spiegare l’essenza della messa, mette in
rilievo la responsabilità che abbiamo nel fare in modo che l’azione sacra sia conosciuta e
rigorosamente eseguita. Questo non per affermare il valore in se di un determinato
rigorismo liturgico ma perché, se la forma portante della messa è la cena, dallo
svolgimento adeguato di questa forma ne dipende anche la possibilità di vivere la realtà,
l’origine, il presupposto della cena stessa: il sacrificio con cui Cristo ha redento il mondo.
L’autore quindi non afferma il rigorismo nello svolgimento della liturgia in quanto il fine
di questa non è una azione perfetta in quanto tale, ma l’incontro con Cristo che ci invita a
partecipare alla cena e desidera rimanere in comunione con noi. Ecco allora che “celebra
correttamente la messa colui che cerca di comprendere Cristo: chi è, qual è il suo pensiero,
cosa significa per noi – Cristo che si compendia nel Suo amore di redenzione. Non è
casuale che l’azione sacra sia preceduta dalle letture e dalla predica. I testi sacri
contengono sempre un riferimento alla verità di Cristo. Emerge un tratto della Sua
personalità, un evento della sua vita che vuole essere compreso, e conduce alla pienezza di
quella verità che nella consacrazione non è più presente a parole, ma nella sua reale
essenza”28.
27
GUARDINI R., Il testamento di Gesù, Milano, Vita e Pensiero, 1993, p. 144
28
GUARDINI R., Il testamento di Gesù, Milano, Vita e Pensiero, 1993, p. 171
14Il testamento di Gesù: Conclusioni
Come conclusioni vorrei richiamare un’idea dell’autore che ritengo importante e
che ripercorre tutto il testo. In questa esposizione, cercando di capire che cosa sia la messa
e che cosa richieda per essere eseguita, ci siamo resi conto che ogni indicazione dell’autore
è finalizzata a colui che, partecipando all’eucaristia, è chiamato a viverla pienamente con
il dovuto atteggiamento interiore ed esteriore. Abbiamo detto anche che l’uomo è
chiamato ad un rapporto di comunione unico con Dio e da Lui stesso desiderato. La cena
infatti è espressione di questo incontro familiare con Gesù. Un invito che più volte ci viene
rivolto, che sentiamo come esigenza del nostro cuore e che, già partecipandovi, ci rende
nella condizione di beati in quanto invitati alla cena del Signore. Come ogni incontro e
rapporto di comunione, la cena del Signore rispetta la libertà di Dio nell’invitarci ma anche
la nostra responsabilità nel rispondere liberamente a tale invito. L’uomo, già nel decidere
di partecipare al banchetto istituito da Cristo, deve fare i conti con una serie di impedimenti
che richiedono un continuo atto di fede. Ma questo non basta. L’autore infatti afferma che
una delle più grandi difficoltà del vivere bene la messa sta nel fatto che l’azione sacra in
Sua memoria non ha uno scopo o un fine se non quello di essere in comunione con Lui.
Quando infatti progettiamo una determinata cosa, riconosciamo lo scopo di tante nostre
azioni e, più la cosa è importante e più il nostro essere è concentrato nella buona riuscita di
tale fine. Ma nella celebrazione eucaristica questo non avviene. Non avviene in quanto non
abbiamo uno scopo preciso nel vivere questa cena se non quello di rimanere nella
comunione con Dio. Possiamo allora fare l’esempio di un rapporto d’amicizia. Quando
sperimentiamo la bellezza e l’importanza della presenza di una persona, desideriamo fare
esperienza di momenti in cui, senza secondi fini, possiamo gustare la sua vicinanza.
L’incontro fra due che si amano è arricchito dalla medesima presenza delle singole persone
e non servono altri scopi per rendere questo momento importante. La medesima cosa
avviene quando facciamo festa per un determinato evento. Il carattere stesso della festa non
è finalizzato ad ulteriori cose. Nel momento in cui avviene, questa azione ha già in se il suo
scopo. Se pensiamo allora al significato della messa come festa cristiana, rendimento di
15grazie, incontro con l’Amato per eccellenza, sacrificio offerto per la nostra salvezza,
comprendiamo che nella “azione sacra in Sua memoria”, non occorrono ulteriori fini o
scopi per motivare la nostra presenza e le nostre azioni. In questo è racchiuso tutto il
fascino e l’importanza della celebrazione eucaristica ma anche l’inevitabile conversione
che ognuno deve compiere per poter vivere in verità il rapporto d’amore unico e
irripetibile con Dio in Cristo Gesù. “Nella comunione (Cristo) visita ciascuno di noi:
‘Ecco, sto alla porta e busso’29. E nella misura in cui la porta si apre nella verità della fede
e dell’amore, Gesù entra e dona se stesso”30. “Aspettare la sua venuta, invocarla, muoversi
incontro a Cristo, accoglierlo, onorarlo, glorificarlo, non allontanarsi da lui, lasciarsi
condurre nell’intimo della sua comunità: in questo consiste la festa cristiana”31.
Con quest’idea, quindi, credo che le nostre liturgie e la stessa formazione liturgica
non debba mai essere finalizzata a se stessa. Colui che è chiamato a celebrare deve
integrare bene una corretta conoscenza di quanto sta facendo con una profonda interiorità,
affinché il mistero celebrato non sia una rappresentazione ma la ripresentazione reale del
sacrificio con cui Cristo ci ha redenti. Allo stesso modo ogni fedele, liberamente e
responsabilmente, è chiamato a vincere l’eventuale ignoranza liturgica, sapendo che le
nozioni in quanto tali non servono a nulla quando un cuore non è disposto a lasciarsi
infiammare dall’amore di Dio.
In questo modo “la messa acquisterà un significato tutto nuovo. Sentiremo quanto
essa ci è necessaria. Sarà per noi un momento di profondissima pace e sicurezza.
Nell’affanno quotidiano rivolgeremo il nostro pensiero alla messa, e quasi tendendo la
mano ne riceveremo nuova forza”32.
Bibliografia
• GUARDINI, Romano, La fine dell’epoca moderna. Il potere, Brescia, ed.
Morcelliana, 1950 (8ª ed. 1993)
29
Ap 3, 20
30
GUARDINI R., Il testamento di Gesù, Milano, Vita e Pensiero, 1993, p. 166
31
GUARDINI R., Il testamento di Gesù, Milano, Vita e Pensiero, 1993, p. 167
32
GUARDINI R., Il testamento di Gesù, Milano, Vita e Pensiero, 1993, p. 185
16• GUARDINI, Romano, Il testamento di Gesù. Milano, ed. Vita e Pensiero, terza
edizione 1993 (prima edizione, 1950). – Titolo originale, Besinnung von der Feier
der heiligen Messe, 1939.
• MAZZA, Enrico, La celebrazione eucaristica, genesi del rito e sviluppo
dell’interpretazione. Milano, ed. San Paolo, 1996.
• CAPRIOLI, Adriano, Lettera pastorale 2002-2003: Cinque pani, due pesci e la
folla. Reggio Emilia, ed. Grafitalia, 2002.
• AA.VV., I padri apostolici. Roma, ed. Città Nuova, 1998
17Indice
Il Testamento di Gesù: Premessa.......................................................................................2
Romano Guardini...............................................................................................................3
I Parte: Il contegno.............................................................................................................6
II parte: Essenza della messa ...........................................................................................11
Il testamento di Gesù: Conclusioni..................................................................................15
Bibliografia ......................................................................................................................16
Indice ...............................................................................................................................18
18Puoi anche leggere