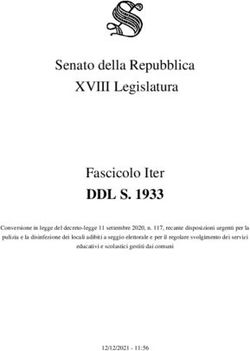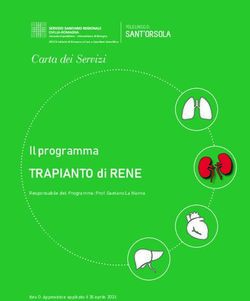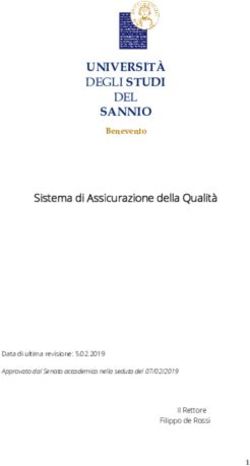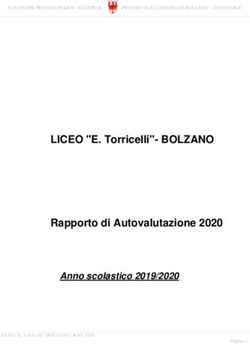IL TESTAMENTO: PROFILI E QUESTIONI - CORSO DI DIRITTO DI FAMIGLIA E DELLE SUCCESSIONI - A.A. 2015/2016 Prof. Giovanni Furgiuele
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
CORSO DI DIRITTO DI FAMIGLIA E DELLE
SUCCESSIONI - A.A. 2015/2016
IL TESTAMENTO: PROFILI E QUESTIONI
Prof. Giovanni Furgiuele
con la collaborazione
della Dott.ssa Giulia Tesi e del Dr. Marco RizzutiProf. Giovanni Furgiuele
DIRITTO DI FAMIGLIA E DELLE SUCCESSIONI
Lezioni a cura dalla Dr.ssa Giulia Tesi
INTRODUZIONE
1. Brevi riflessioni sulla disciplina del rapporto successorio……………………………………………………….pag. 2
CAPITOLO 1
TESTAMENTO E LEGGE
1. Rilievi introduttivi……………………………………………………………………………………………………………….pag. 16
2. Considerazioni generali su testamento e legge……………………………………………………………………...pag. 20
3. Ipotesi specifiche di rapporto fra testamento e legge…………………………………………………………….pag. 27
1INTRODUZIONE
1. Brevi riflessioni sulla disciplina del rapporto successorio.
In questa breve introduzione faremo alcune riflessioni sulla materia
testamentaria. Nel corso parleremo del testamento. Però i profili e le
questioni attinenti al testamento verranno affrontati, comunque,
avendo come riferimento lo Stato italiano.
Questa considerazione iniziale e di partenza serve per delineare le
fonti da cui scaturisce la disciplina del fenomeno che analizzeremo.
Naturalmente, il riferimento alla disciplina dell’ordinamento giuridico
dello Stato italiano rappresenta, al contempo, una caratteristica e un
limite della nostra analisi. Non si esclude, infatti, che in altri
ordinamenti prevalga un’impostazione, per certi aspetti e profili,
diversificata.
Tutto quanto finora detto è vero. Esiste, però, anche un Regolamento
successorio europeo, approvato non molto tempo fa e, in ordine al
quale si tendono a sviluppare profili di considerazione e valutazione
sulla materia successoria, laddove si sia in presenza di situazioni di
carattere particolare. Nello specifico, la tutela è prevista in ordine a
soggetti che risiedono in un certo Stato, rispetto a beni che sono siti in
uno Stato diverso. Esistono, infatti, delle situazioni particolari che
necessitano di un contemperamento. Il Regolamento successorio
europeo, quindi, predispone una disciplina per quelle situazioni in si
ha una molteplicità di riferimenti.
Pur non rifiutando l’utilità del suddetto Regolamento, è opportuno, fin
da ora, sottolineare che i profili e le questioni che verranno affrontate
nel corso avranno come riferimento esclusivo la disciplina prevista
dal codice civile italiano.
2Il codice civile è, quindi, il testo di riferimento, pressoché esclusivo, di
ciò che avremo modo di considerare nel proseguo del corso.
Quando si parla di testamento si fa, inevitabilmente, riferimento alla Successione
testamentaria,
successione testamentaria. Cosa significa testamento e successione successione
legittima e tutela
testamentaria? dei legittimari
Significa che, in ordine a questa particolare situazione, per avere
riferimenti di disciplina, si deve fare riferimento a ciò che è espresso
nell’ambito della lettera del testamento. È il testamento che ci dice
cosa deve essere seguito, nell’ambito delle situazioni di carattere
particolare, successive alla morte di colui che è l’autore del
testamento medesimo.
In altri termini, la successione testamentaria identifica il testamento
come fonte prioritaria di disciplina del rapporto di carattere
successorio.
Detto ciò, bisogna, anche, domandarsi se il testamento sia anche fonte
esclusiva del rapporto successorio.
Definire il testamento quale fonte principale del rapporto successorio,
non significa dire che esso sia anche fonte esclusiva del rapporto
successorio.
Il testamento, infatti, potrebbe fare riferimento ad una pluralità di
ipotesi e non ricomprendere, però, la totalità dei beni e dei rapporti
che fanno capo al de cuius. I rapporti personali del defunto possono,
nella sostanza, andare al di là della materia trattata dal testamento.
In questi casi, si può avere una commistione di fatti: il testamento
viene accompagnato dalla ulteriore fonte che è la legge.
Si può, quindi, avere una successione testamentaria e una successione
di carattere legale che è, appunto, disciplinata dalla legge e prevede
condizioni di carattere particolare.
3Accanto alla successione legittima e alla successione testamentaria, vi
è, poi, un’ulteriore ipotesi. Non è detto, infatti, che la successione
testamentaria debba essere ritenuta fonte esclusiva di disciplina
perché esiste una categoria di soggetti – i legittimari – i quali hanno,
comunque, diritto ad una porzione di eredità.
Il de cuius, infatti, non può evitare che una certa parte del suo
patrimonio ereditario sia destinato a vantaggio di soggetti specifici
che, normalmente, sono i familiari più stretti.
Quando si parla della posizione dei legittimari è spontaneo chiedersi
quanto sia giusto tutto ciò, ovvero quanto sia giusta una disciplina che
valuta i rapporti di carattere patrimoniale in una maniera particolare.
Il soggetto titolare dei suddetti rapporti potrà disporne in una certa
misura, ma non potrà dimenticare che esiste una tutela, di carattere
familiare, che prevale circa la successiva titolarità di certi beni e
rapporti.
Non è possibile dire se ciò sia giusto o sbagliato; il fatto è che, in
questi casi, il diritto si impone.
Naturalmente, se ci poniamo nella logica del diritto di proprietà, è
chiaro che ciò potrebbe non essere giusto. È la legge che, da un punto
di vista della tutela, ritiene di dover preferire non esclusivamente la
volontà del de cuius, ma anche altre posizioni. La morte del de cuius
determina un passaggio di proprietà che, in una certa misura, fa
riferimento alla volontà del defunto; se non c’è la volontà del de cuius,
provvederà la legge in una certa maniera; se è presente la volontà del
de cuius è, comunque, tutelata la posizione dei legittimari.
Quando si parla di regola giuridica non è possibile evitare di
considerare l’esattezza (o la non esattezza) della stessa. Vi possono
essere una pluralità di approcci che possono dar luogo a diverse
ipotesi.
4Il sistema appena descritto è il frutto di una scelta che si impone
perché proviene dall’ordinamento giuridico dello Stato.
Questo è il primo profilo che segnaliamo e che riguarda il testamento
e la successione testamentaria e i loro rapporti con la successione
legittima e con la posizione dei legittimari.
Vediamo, adesso, quali sono i principi generali in materia successoria. Principi generali in
materia successoria
Bisogna, infatti, partire dal presupposto che il testamento si colloca
all’interno di uno schema generale di disciplina del rapporto
successorio.
Innanzitutto, occorre brevemente richiamare l’attenzione su come è
articolata la disciplina del rapporto successorio, all’interno del Libro
II del codice civile. La disciplina prevista dal Libro II, infatti, segue un
certo schema che anticipa l’individuazione del concetto di testamento
e della successiva regolamentazione della successione testamentaria.
Esistono una serie di articoli, i quali danno una certa esposizione circa
il modo con cui si deve valutare la disciplina del rapporto successorio.
In altri termini, la disciplina della successione testamentaria non è il
punto di partenza, ma è un elemento della sequenza della disciplina
generale del rapporto successorio.
Prima del testamento e della disciplina della successione
testamentaria, vi è tutta l’altra parte che è prevista nell’ambito della
disciplina generale del rapporto successorio ed è parte necessaria del
discorso che affronteremo.
Nell’ambito della disciplina generale del rapporto successorio vi è,
innanzitutto, un primo profilo che individua esattamente come si
deve porre il rapporto successorio stesso.
Questo primo profilo è rappresentato dal divieto dei patti successori, Divieto dei patti
successori
di cui all’articolo 458 del codice civile.
5In primo luogo, va detto che l’articolo 458 c.c. è formulato in maniera
non totalmente perfetta, dal punto di vista espositivo.
Nella norma si legge: “Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768 bis
e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della
propria successione. E' del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone
dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora
aperta, o rinunzia ai medesimi”.
Da un punto di vista puramente letterale, il termine patti successori
significa accordi che, come tali, scaturiscono da una duplice
manifestazione di volontà.
Quando si ragione nel senso di una visione che fa riferimento ad una
pluralità di manifestazioni del volere, occorre chiedersi se i suddetti
patti equivalgono al concetto di contratto.
Non è detto che ci sia un’assoluta corrispondenza. Se si parla di patti
come duplice manifestazione di volontà è evidente che non vi è alcuna
diversità rispetto al contratto.
Bisogna, però, fare un’ulteriore considerazione. Il patto in una
compravendita (vendita dietro il pagamento di un prezzo) equivale
totalmente al concetto di contratto: si ha un duplice accordo.
Nel caso del patto successorio siamo all’interno di una situazione di
questo tipo? In una situazione in cui un soggetto si impegna ad
effettuare un testamento e l’altro accetta, chi è che si impegna:
entrambi o uno solo?
Con il patto successorio siamo di fronte ad una situazione in cui un
soggetto effettua un qualcosa che rimane all’interno della sua sfera –
il testatore – ed un altro soggetto che condivide.
Tale situazione non è assimilabile all’idea del contratto inteso in
senso rigoroso. Una cosa è il contratto in cui si hanno manifestazioni
di volontà allineate sulla stessa posizione e, quindi, l’accordo è il
6frutto della volontà concordata; altra cosa è l’ipotesi in cui si ha la
manifestazione di volontà di un soggetto, alla quale l’altra parte non
può far altro che aderire.1
Fatta questa premessa necessaria per chiarire il significato dei
termini impiegati dal codice civile, torniamo a parlare
specificatamente del divieto dei patti successori.
Nell’ambito dell’articolo 458 c.c. si hanno due ipotesi. Una prima
ipotesi – patti successori costitutivi – in cui è necessaria
l’accettazione. Viceversa, nella seconda parte dell’articolo, sono
previste delle ipotesi di patti successori che hanno carattere
esclusivamente unilaterale – patti successori rinunziativi e dispositivi.
Il divieto dei patti successori è un elemento fondamentale della
disciplina generale del rapporto successorio. Esso caratterizza, in
maniera specifica, il nostro ordinamento: in altri ordinamenti (per
esempio, in Francia ed in Germania) si segue, infatti, una diversa
impostazione.
Come abbiamo visto, l’articolo 458 c.c. rinvia a quanto previsto dagli
articoli 768 bis, e seguenti, codice civile. Ciò significa che si esclude
dal divieto dei patti successori il cosiddetto patto di famiglia. Si tratta
di un’apertura che si fonda sulla considerazione del patto di famiglia
come ipotesi tipica di patto successorio. Tuttavia, non si può evitare di
esprimere dubbi circa l’assimilazione fra patto di famiglia e patto
successorio.
La seconda caratteristica della disciplina generale del rapporto Il concetto di
successione
successorio riguarda il concetto di successione.
1L’impostazione suddetta è, in un certo qual modo, confermata dalle parole di Nicolò, in materia di
donazione. L’Autore sosteneva che il donatario non può far altro che accettare. È chiaro, comunque,
che, per rispettare la volontà del donatario, è necessaria la sua accettazione perché nessuno può
imporgli niente. È altrettanto vero che quella situazione giuridica deriva, comunque, dalla
manifestazione di volontà di una sola parte. Discorso diverso, chiaramente, vale nei casi in cui, come
per esempio nella compravendita, è necessaria una duplice manifestazione di volontà.
7La successione è quella situazione giuridica che si realizza nel
momento in cui, rispetto alla titolarità di certi beni, il venir meno della
persona proprietaria dei beni medesimi, dà luogo ad un fenomeno di
sostituzione nella titolarità degli stessi.
Viene, quindi, meno il diritto di proprietà di un soggetto perché esso
scompare e al suo posto interviene un altro soggetto. Chi sia questo
ulteriore soggetto lo si dedurrà dall’applicazione o delle norme
relative alla successione legittima, o dalla norme relative alla
successione testamentaria, oppure, eventualmente, rispetto alla
successione testamentaria, dall’applicazione delle norme relative alla
tutela dei legittimari.
La successione implica un fenomeno di sostituzione: il diritto di
proprietà viene meno perché scompare il titolare del diritto stesso, al
suo posto interverrà o colui a vantaggio del quale si realizza la
successione testamentaria, oppure il soggetto nei confronti del quale
si realizza la successione legittima o dei legittimari.
La terza caratteristica della disciplina generale del rapporto Eredità e legato
successorio è data dalla presenza di due forme di sostituzione nella
titolarità dei beni: l’eredità e il legato. Si tratta di principi di carattere
giuridico.
Cosa significa eredità? Eredità significa una successione in senso
pieno, in modo tale che, rispetto alla titolarità di certi beni, avverrà la
sostituzione a vantaggio di un altro soggetto.
A livello di impostazione giuridica, però, occorre anche considerare
l’ipotesi in cui non si ha un’unica situazione di carattere successorio a
vantaggio di un solo soggetto, ma si hanno una pluralità di rapporti
successori a vantaggio di una pluralità di soggetti. Su questa base, si
tende a differenziare l’eventualità in cui quest’ultima ipotesi si realizzi
in un caso a titolo di erede ed in un altro caso a titolo di legato.
8A tal proposito, bisogna considerare il contenuto dell’articolo 588 c.c.
– “Disposizioni a titolo universale e a titolo particolare” – il quale così
statuisce: “Le disposizioni testamentarie, qualunque sia l'espressione o
la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale e
attribuiscono la qualità di erede, se comprendono l'universalità o una
quota dei beni del testatore. Le altre disposizioni sono a titolo
particolare e attribuiscono la qualità di legatario.
L'indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude
che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore
ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio”.
La suddetta norma che sembra così perentoria è una norma di
carattere giuridico, la quale detta dei criteri, la cui applicazione
costituisce la premessa per farne dedurre, in un caso, la qualità di
erede e, in un altro caso, la qualità di legatario.
L’articolo 588 c.c., in altri termini, è una norma giuridica che, come
tale, fa capo ad un processo di valutazione della disposizione
testamentaria, nel senso che si devono distinguere due modalità di
valutazione del rapporto: se il testatore ha disposto di un certo bene
nella sua totalità, considerandolo come quota, quel singolo bene viene
considerato come quota di eredità; se il testatore ha disposto del bene
come singolo, esso verrà considerato a titolo di legato.
È una valutazione, è un criterio di analisi. Siamo di fronte ad una
disciplina di carattere giuridico che è impostata sulla diversità fra
concetto di quota e concetto di singolo bene. Se il bene è stato
attribuito come singolo bene, è un legato; se il bene è stato attribuito
come quota dell’intero patrimonio, è eredità.
La diversità dei concetti di eredità e legato, chiaramente, dà luogo ad
una disciplina differenziata che è il frutto di una valutazione. Tale
valutazione può essere semplificata se il testatore ha detto
9chiaramente di voler attribuire certi suoi beni a titolo di erede o di
legato; al contrario, nel caso in cui il testatore non sia chiaro, quel
testamento, nell’ipotesi in cui si pongano dei problemi fra soggetti
specifici, dovrà essere interpretato da parte dell’organo giudicante.
In questi casi, l’interpretazione rappresenta una chiave di lettura che
costituisce il modo per risolvere, da un punto di vista giuridico, una
controversia. Non è detto, però, che la chiave di lettura,
l’interpretazione offerta, nei singoli casi, dall’organo giudicante sia
effettivamente quella giusta, o totalmente condivisibile.
Come già detto, l’eredità ed il legato comportano conseguenze
diverse. Innanzitutto, per quanto riguarda la nascita del nuovo titolo
di proprietà. In tal senso, occorre tener presente il contenuto della
disposizione adottata dal testatore che costituisce una premessa che,
però, non esaurisce la questione. Ciò, perché il testatore individua una
certa chiave, una certa soluzione, però, le suddette disposizioni
testamentarie sono destinate a produrre effetti non tanto nell’ambito
della sfera giuridica del de cuius, ma nella sfera giuridica del
destinatario. Sarà, quindi, la manifestazione di volontà del
destinatario che determinerà la chiusura definitiva del rapporto
successorio.
Per queste ragioni, quindi, è necessaria anche l’accettazione del
destinatario, in quanto, nella visione di carattere generale, la
disposizione del de cuius non risulta sufficiente.
Nella sostanza, l’accettazione costituisce il momento di chiusura del
rapporto successorio.
Tralasciando, in questa sede, il fatto che sono previsti appositi termini
di prescrizione entro cui deve essere resa l’accettazione, in termini
generali, occorre sottolineare che essa può essere pura e semplice, o
con beneficio d’inventario.
10Anche la suddetta diversità fra accettazione pura e semplice e
accettazione con beneficio d’inventario ha dei riflessi differenti. Nello
specifico, l’accettazione con beneficio d’inventario implica un limite:
colui che accetta con beneficio d’inventario risponderà dei debiti
ereditari nei limiti della parte di patrimonio che proviene dal de cuius.
Per concludere il discorso sui diversi concetti di eredità e legato, è
prevista una diversa disciplina con cui si avrà il riparto del carico
specifico dei rapporti che scaturiscono da queste ipotesi.
Infine, occorre considerare due ulteriori ipotesi: una è la revoca del Revoca e rinunzia
testamento; l’altra è la rinunzia al rapporto successorio.
Si potrebbe, infatti, pensare che la disposizione testamentaria abbia
carattere definitivo.
In realtà, però, non è così. Nell’ambito della disciplina della
successione testamentaria prevale una logica diversa che, in questo
caso, appare degna di rispetto. Con il testamento, infatti, non si tratta
di tutelare la sfera giuridica di qualcuno come, invece, avviene
nell’ambito del rapporto contrattuale dove occorre tutelare sia la
posizione del proprietario, che quella del destinatario.
Viceversa, nell’ipotesi del testamento le cose sono diverse perché se,
nell’ambito della vita del testatore, si registra un mutamento di
volontà questo è pienamente libero, in quanto il rapporto successorio
non si è ancora esaurito, ma si perfezionerà nel momento successivo
alla morte del de cuius e a seguito dell’accettazione del destinatario
della disposizione.
Fino alla morte del testatore, il rapporto successorio non esiste e,
quindi, non c’è una sfera di titolarità, prevista a vantaggio di un certo
destinatario, che debba essere tutelata.
Per questa ragione, nell’ambito della situazione relativa al rapporto di
carattere testamentario, prevale il potere di revoca. Si tratta, nella
11sostanza, di tutelare la posizione di colui che è, originariamente,
autore di una disposizione testamentaria, il quale ha la possibilità di
modificare la disposizione medesima.
Pertanto, essendo questa la situazione, ciò che è stato realizzato oggi
non è detto che debba essere considerato anche in futuro.
Lo stesso discorso vale, anche, con riguardo alla rinunzia al rapporto
successorio perché, nell’ambito di queste situazioni, non essendoci
una necessaria contestualità (che è, invece, presente nell’accordo
contrattuale) non vi è la necessità di tutelare la posizione della
controparte.
Altra situazione che deve essere considerata, nell’individuazione dei La divisione
principi generali in materia successoria, è quella dell’eventuale
contitolarità di certi beni.
In questi casi, si deve passare attraverso la divisione, fra gli eredi, dei
diversi beni.
Le operazioni di divisione costituiscono un aspetto estremamente
problematico perché ci troviamo di fronte ad una situazione di
contitolarità che deve essere sciolta, con assegnazione della titolarità
distinta, qualora il bene sia divisibile; viceversa, se il bene non è
divisibile, si dovrà procedere alla vendita all’asta dello stesso con
successiva suddivisione del ricavato.
Vi è, poi, un’ulteriore considerazione da fare. Bisogna, infatti, fare L’interpretazione
alcune premesse sul concetto di interpretazione.
Nella attività di carattere giuridico, se c’è un concetto fondamentale
per tutti e per tutte le branche del diritto, questo concetto generale è
quello dell’interpretazione.
Chi svolge l’attività di interpretazione deve farlo in modo intelligente,
non soffermandosi, esclusivamente, sul testo delle norme.
12Il testo della legge rappresenta soltanto una premessa dell’attività di
interpretazione.
In altri termini, il giurista deve saper interpretare e saper dare un
senso.
L’interpretazione è un problema perché non è detto che nel leggere
un certo contesto letterale tutti siano in grado di concordare su di
un’unica lettura interpretativa.
Ci possono essere modalità diverse di espletamento della funzione
interpretativa. La diversità fra giuristi, normalmente, è che non esiste,
nei casi dubbi, un’unanimità generale e concordata di lettura
interpretativa. In questi casi, il senso della norma è quello che risulta
dallo svolgimento dell’attività interpretativa. Non a caso, quindi,
l’attività di interpretazione caratterizza profondamente l’essenza del
giurista.
La disciplina dell’attività di interpretazione la si rinviene, in primo
luogo, nell’ambito dell’articolo 12 delle disposizioni preliminari al
codice civile. esistono, poi, una serie di norme (articoli 1362 – 1371
c.c.) che disciplinano l’interpretazione del contratto. Questi sono, nella
sostanza, tentativi per bloccare il margine di libertà che spetta
all’interprete.
Per quel che qui ci interessa, l’interpretazione costituisce anche un
canale da cui scaturisce la vita di una regola adottata in sede
testamentaria. Come vedremo, esistono tutta una serie di ipotesi,
rispetto alle quali, dallo svolgimento di un’attività di interpretazione,
scaturisce il senso da attribuire ad un determinato testamento.
Quello appena descritto è il panorama dei principi, al cui interno si
può collocare, in maniera significativa, la materia testamentaria.
13Vediamo, adesso, quale sarà l’oggetto del corso.
Per ovvi motivi, non verrà trattata tutta la disciplina del testamento.
Nel corso verranno affrontati alcuni argomenti.
Innanzitutto, il primo argomento concerne il rapporto che deve
essere istituito fra testamento e legge. Ciò significa che l’autonomia
testamentaria costituisce il fondamento di una certa disciplina, ma il
testamento non è l’unica ipotesi di regolamentazione del rapporto
successorio.
Come già abbiamo detto, il testamento sussiste nell’ambito di un
complesso di regole. C’è, nella sostanza, una disciplina di carattere
legale che deve essere rispettata. Il potere di autonomia
testamentaria non è liberissimo. Esso deve essere esercitato in una
certa forma, secondo certe modalità e nel rispetto dei limiti previsti
nell’ambito della situazione di carattere legislativo.
In secondo luogo, si affronteranno le questioni relative alla cosiddetta
capacità testamentaria. Rispetto a ciò, bisogna porsi nell’ambito della
valutazione dell’idoneità di un certo soggetto ad esprimere la sua
volontà testamentaria.
Il terzo argomento sarà quello dell’autonomia testamentaria. In
quest’ottica, il testamento è visto come esercizio di una situazione in
termini di libertà, nel senso di adottare una certa disciplina di
carattere specifico, circa li svolgimento del rapporto successorio.
Tale impostazione implica la considerazione del testamento come
negozio giuridico, ossia come espressione di libertà testamentaria.
Sempre nell’ambito del carattere negoziale del testamento, si innesta
il riferimento, come ulteriore argomento, alla fiducia e alla
simulazione. Fiducia e simulazione come ipotesi che, quindi, devono
essere considerate come situazioni che caratterizzano lo svolgimento
dell’attività testamentaria.
14Altro argomento sarà quello della clausola di diseredazione. Si tratta,
come vedremo, di un argomento di carattere particolare che necessita
di alcune considerazioni.
Verranno, poi, esaminate le questioni relative alla sostituzione
ordinaria e fedecommissaria che costituiscono ulteriori forme di
manifestazione della libertà testamentaria del de cuius.
Successivamente, ci soffermeremo sulle questioni inerenti alla revoca
del testamento.
Vi è, poi, il tema della invalidità ed inefficacia del testamento come
ipotesi di inammissibilità di certe situazioni di carattere
testamentario.
A chiusura del corso, verrà affrontato il problema dell’interpretazione
del testamento, ossia della valutazione delle questioni che si pongono
nell’esercizio dell’attività di interpretazione in sede testamentaria.
15CAPITOLO 1
TESTAMENTO E LEGGE
1. Rilievi introduttivi.
Il primo argomento che verrà preso in considerazione è costituito dal
riferimento al rapporto che intercorre fra testamento e legge. Sono,
quindi, due momenti: uno è il testamento – vale a dire l’atto formato
dal privato – l’altro è la legge – che è il frutto dello svolgimento
dell’attività di carattere normativo.
Per poter comprendere a pieno il rapporto fra testamento e legge, al Testamento e diritto
di la del riferimento al concetto generico di legge, forse sarebbe più
giusto, quantomeno inizialmente, parlare di testamento e diritto. Far
riferimento al rapporto fra testamento e diritto significa costruire il
rapporto in ordine alla valutazione che, in sede giuridica, viene
effettuata dell’atto testamentario costituito dal privato.
La valutazione, in sede giuridica, del testamento si riferisce, quindi,
alla valutazione specifica dell’esercizio dei poteri che spettano ad un
determinato soggetto.
Parlare di testamento e diritto comporta la necessità di una
preliminare precisazione. Parlare del diritto, o meglio ancora parlare
del fenomeno giuridico significa parlare, non solo e non tanto di
singoli atti espressivi di poteri legislativi, ma significa parlare con
riferimento all’esercizio del potere di disciplina di determinate
situazioni che scaturisce da singoli ordinamenti.
Pensiamo, per esempio, al mondo degli zingari. Possiamo domandarci
come vengono regolate, nel mondo degli zingari, le vicende successive
alla morte di un determinato soggetto. Pensiamo, ancora, agli
stranieri ed, in particolare, a coloro che provengono dall’Africa. Nella
sostanza, pensiamo a tutti quei soggetti che vivono, al giorno d’oggi,
16all’interno, anche, dell’ordinamento italiano. Attualmente, nell’ambito
del nostro ordinamento, vivono una pluralità di soggetti e, quindi,
bisogna chiedersi, quando ci si pone nella logica del controllo
giuridico di un singolo atto testamentario, quale sia la valutazione che
deve essere fatta.
Un atto testamentario, praticamente, opera all’interno di un
determinato ordinamento; e l’ordinamento italiano è uno degli
ordinamenti, è uno dei profili, di carattere giuridico, tecnicamente
esistenti in senso giuridico.
È opportuno, quindi, chiedersi quale tipo di valutazione debba essere
effettuata in ordine all’espressione del potere testamentario.
In sostanza, non sappiamo se, per esempio, gli zingari fanno un
testamento, però, quando ci poniamo nell’ottica della valutazione di
un atto posto in essere dal privato, come è appunto il testamento, per
ragionare in senso tecnicamente corretto, si deve far riferimento
all’ordinamento all’interno del quale quel determinato atto è
destinato a valere.
Il discorso appena fatto ci porta a riaffermare un principio La relatività dei
valori giuridici
fondamentale che è quello della relatività dei valori giuridici. Valore
giuridico significa, evidentemente, collocare una specifica situazione
all’interno di criteri di valutazione espressi nell’ambito di singoli
ordinamenti. Da un punto di vista giuridico, il concetto che viene
prima non è il concetto di legge, ma è il concetto di ordinamento.
Quelle sopra esposte sono valutazioni reali, non sono giuochi di
parole. Quando ci poniamo nella logica della valutazione di un
determinato atto, ci si deve, anche, chiedere all’interno di quale sfera
di ordinamento è destinato a valere quell’atto. Dal momento che i
valori giuridici sono espressi, certo, dai singoli Stati, ma anche da
17comunità sovranazionali e in riferimento a settori specifici, è evidente
la relatività dei valori giuridici medesimi.
Questa premessa iniziale serve per evitare di sopravvalutare il
rapporto fra testamento e legge: certo, nell’ambito del nostro
ordinamento giuridico, è così, però, non è detto che questo tipo di
impostazione sia destinato ad esaurire la valenza di carattere
giuridico, in ordine al rapporto fra atto del privato e sfera giuridica.
Sempre da un punto di vista generale ed introduttivo, se pensiamo,
per esempio, ad una coda questo cosa significa. Quando siamo in coda
passa prima quello che è arrivato prima: l’ordinamento giuridico della
coda prevede una precedenza con riguardo al momento di arrivo.
Nella sostanza, è l’idea giuridica che regola il fenomeno della coda.
Se questo è il fenomeno giuridico, quando si parla di testamento e
legge ha una valenza la precisazione del fenomeno che consiste nel
verificare all’interno di quale struttura si colloca il problema della
valutazione, in termini giuridici, dell’atto testamentario.
A questa prima precisazione occorre aggiungerne un’altra. Il La libertà
testamentaria e il
fenomeno della libertà testamentaria necessita, infatti, di ulteriori concetto di
proprietà
considerazioni.
Quando si fa riferimento al testamento e lo si prende per buono, l’idea
giuridica di testamento è un’idea basilare o consequenziale?
In sostanza, è il testamento la base del fenomeno, oppure lo stesso è la
conseguenza di un’altra valutazione? La libertà testamentaria precede
la valutazione del fenomeno, oppure consegue ad una diversa
valutazione dello stesso?
Si ritiene che il testamento sia una conseguenza e non una premessa.
Innanzitutto, bisogna ammettere una valenza giuridica del
testamento. Il fatto che siamo distintamente proprietari di certi beni è
la premessa da cui scaturisce, in ambito giuridico, il testamento. In
18altri termini, il diritto di proprietà, di disponibilità di certi beni è la
premessa da cui scaturisce il testamento: il diritto di proprietà di un
certo bene, di un certo rapporto è ciò su cui si fonda l’esercizio della
libertà testamentaria.
La proprietà, infatti, è indubbiamente inerente alla vita di una certa
persona, ma, nella concezione generale del diritto di proprietà, si
ingloba anche il potere di disporre del bene oltre la morte del
soggetto proprietario.
In quest’ottica, il testamento non è la premessa del discorso, ma è il
frutto di una valutazione, in forza della quale si ritiene che nel
concetto di libertà e disponibilità di certi beni si debba anche
collocare la manifestazione di volontà inerente ai rapporti giuridici
successivi alla morte del titolare del diritto di proprietà.
Questo modo di intendere il rapporto fra libertà testamentaria e
diritto di proprietà porta con sé una valutazione che caratterizza la
disponibilità dei poteri dei privati. Ciò significa che, probabilmente, si
è ritenuto opportuno andare a favore del concetto della disponibilità
dei beni attribuiti a titolo di proprietà dell’individuo, nel momento in
cui si attribuisce a quell’individuo non soltanto la possibilità di
godere, nel suo interesse, di quei beni, ma addirittura di determinarne
le sorti per un momento successivo alla sua morte.
Questo è il motivo per cui si ritiene che il testamento non è la
premessa, ma è la conseguenza dei poteri che spettano al titolare del
diritto di proprietà.
192. Considerazioni generali su testamento e legge.
Dopo aver fatto le valutazioni preliminari di cui sopra, veniamo a
considerare la relazione fra testamento e legge, intesa come
manifestazione del potere che spetta allo Stato italiano.
Per iniziare, in maniera completa, il discorso bisogna, innanzitutto, Articolo 587 c.c.
prendere in esame il contenuto dell’articolo 587 c.c. – “Testamento”.
All’interno del nostro codice civile si hanno, infatti, una serie di
articoli, i quali sono destinati a disciplinare l’esercizio della libertà
testamentaria.
Nello specifico, l’articolo 587 c.c. è la massima espressione di quanto
sopra detto, in quanto, in esso, è contenuta, nella sostanza, la
definizione e l’immagine del concetto di testamento, nell’ambito
dell’ordinamento giuridico italiano.
Al primo comma dell’articolo in commento si legge: “Il testamento è
un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà
cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse”.
Questo primo comma, innanzitutto, stabilisce che il testamento è,
innanzitutto, una manifestazione di volontà del soggetto che è autore
del testamento medesimo che, come tale, è un atto privato.
Sulla base di ciò che risulta dalla norma in commento, il testamento è,
anche, un atto revocabile. In questo senso, a livello legislativo, si
effettua una valutazione in termini di sottoposizione del testamento
alla eventualità di un revoca dello stesso. In altri termini, nell’ambito
della definizione di testamento si inserisce anche il concetto di revoca,
per cui, il testamento è un qualcosa che caratterizza una certa
manifestazione di volontà del soggetto privato che è rimessa ad un
apprezzamento da parte dell’autore del testamento stesso.
Il testamento, dopo essere stato formalizzato all’esterno, costituisce
una manifestazione di volontà testamentaria che, però, potrebbe
20anche cambiare nell’ambito della mente dell’autore. Se, però, il
testatore si dimentica, prima del suo decesso, di formalizzare,
attraverso la revoca, tale mutamento di volontà, la regolamentazione
del rapporto successorio sarà, comunque, affidata al testamento nella
suo formulazione originaria.
In questo senso, è necessario valutare il rapporto fra manifestazione
di volontà e forma con un certo realismo: nella valutazione legislativa,
non si attribuisce preminenza alla manifestazione di volontà, ma si
attribuisce valore decisivo alla formalizzazione sia di ciò che appare
come testamento, sia di un’eventuale revoca.
Nel primo comma dell’articolo 587 c.c. si dice, anche, che la libertà
testamentaria può essere esercitata con riferimento a “tutte le proprie
sostanze o di parte di esse”. Pertanto, è possibile avere un esercizio
della libertà testamentaria, nel momento in cui il soggetto dispone di
tutto il proprio patrimonio; oppure, si può avere esercizio della
libertà testamentaria quando, in forma di testamento, si fa
riferimento ad una parte del patrimonio del de cuius.2
Al secondo comma dell’articolo 587 c.c. si aggiunge: “Le disposizioni di
carattere non patrimoniale, che la legge consente siano contenute in un
testamento, hanno efficacia, se contenute in un atto che ha la forma del
testamento, anche se manchino disposizioni di carattere patrimoniale”.
La norma di cui sopra, per essere meglio compresa, come vedremo,
implica la necessità di fare riferimento ad ulteriori disposizioni da cui
scaturisce l’attribuzione dell’esercizio della libertà testamentaria del
testatore, in ordine a specifiche materie di carattere non patrimoniale.
2Vedremo, in seguito, che, anche nell’eventualità in cui non si sia disposto nulla circa la titolarità di
certi beni, si possa, comunque, avere esercizio della libertà testamentaria.
21Queste disposizioni hanno efficacia se contenute, come risulta
dall’articolo 587/2 c.c., in un atto “che ha la forma del testamento,
anche se manchino disposizioni di carattere patrimoniale”.
Dal secondo comma dell’articolo 587 c.c. scaturisce, quindi, una
visione della libertà testamentaria in un senso non illimitato, ma,
comunque, in un senso ulteriore, rispetto alla disposizione di
carattere esclusivamente patrimoniale. Si può avere esercizio della
libertà testamentaria, anche, con riferimento ad alcune situazioni di
carattere non patrimoniale, laddove sussista un comando legislativo
che lo consenta. In un caso di questo genere, il testamento avrà valore
anche se mancano disposizioni di carattere patrimoniale.
Nell’ambito della suddetta valutazione, il testamento costituisce uno
strumento, attraverso il quale si manifesta una libertà di disposizione
per un momento successivo alla morte del testatore.
Dopo aver individuato il concetto di testamento che discende dal Testamento e
contratto
contenuto dell’articolo 587 c.c., soffermiamoci, adesso, sul rapporto
fra testamento e contratto.
Nella sostanza, bisogna cercare di comprendere se il testamento
rappresenta un istituto autonomo, oppure se lo stesso possa essere
assimilato, per analogia, al contratto.
Per rispondere al suddetto interrogativo, occorre, innanzitutto,
soffermarsi sul contenuto dell’articolo 1321 c.c., in virtù del quale il
contratto “è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o
estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”.
Secondo tale disposizione, da cui può scaturire una certa immagine
della situazione contrattuale, il contratto è l’accordo, ossia il frutto di
due manifestazioni di volontà coincidenti, le quali si manifestano in
maniera analoga, in ordine a certi tipi di situazioni.
22Quando si parla di accordo, in certi casi, perché si abbiano dei riflessi
giuridici nella sfera di un determinato soggetto, in omaggio alla tutela
della sua libertà, si rimette il prodursi dell’effetto giuridico alla sua
volontà di accettare una situazione da altri espressa.
Sia nel contratto che nel testamento, quindi, si ha una duplicità di
manifestazioni del volere, però, contratto e testamento sono due cose
diverse.
Innanzitutto, per aversi contratto è necessario il riferimento alla
materia patrimoniale.
Il ragionamento in ordine al rapporto fra contratto e testamento deve
essere ampliato facendo riferimento ad altre norme.
In primo luogo, bisogna considerare il contenuto dell’articolo 1324
c.c. – “Norme applicabili agli atti unilaterali” – nel quale si dice che la
disciplina del contratto può estendersi, se compatibile, anche agli atti
unilaterali.
Soprattutto, però, occorre fare riferimento a ciò che risulta previsto
dagli articoli 1343 – 1345 c.c., in materia di causa del contratto.
Nello specifico, all’articolo 1343 c.c. si disciplinano le cosiddette
ipotesi di causa illecita. Secondo tale norma la causa è illecita quando
è contraria “a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon
costume”.
Ciò significa che si può avere un contratto inammissibile quando lo
stesso è contrario a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon
costume. Questo è, nella sostanza, il limite che opera nella materia
contrattuale: si può avere esercizio della libertà contrattuale, purché
si rimanga all’interno della valutazione in termini di ammissibilità che
scaturisce da quanto espresso dall’articolo 1343 codice civile.
Questo stesso limite, come vedremo, vale anche per il testamento.
23Il medesimo discorso vale anche per l’articolo 1344 c.c. – “Contratto in
frode alla legge” – secondo cui: “Si reputa altresì illecita la causa
quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di
una norma imperativa”.3
Infine, le stesse valutazioni possono essere fatte, anche, per l’articolo
1345 c.c. – “Motivo illecito”.
Dall’analisi delle suddette norme si evince una considerazione della
materia contrattuale in termini restrittivi. La medesima logica di
valutazione restrittiva vale anche per il testamento.
Consideriamo, a questo punto, alcune ipotesi di esercizio della libertà Ipotesi di esercizio
della libertà
testamentaria. testamentaria
Innanzitutto, facciamo riferimento all’articolo 2821 – “Concessione
d’ipoteca” – che al secondo comma stabilisce che l’ipoteca volontaria
non può essere concessa per testamento.4
Nella norma, dopo aver affermato che l’ipoteca volontaria può essere
concessa per atto pubblico o per scrittura privata, si chiarisce che la
stessa non può essere concessa per testamento. In questo caso,
quindi, si limita il riferimento alla forma costitutiva dell’ipoteca
volontaria, nel senso di ritenere che, fra i diversi tipi di manifestazioni
del volere, non può essere ricompresa la manifestazione in forma di
carattere testamentario.
Con riferimento alla possibilità di disposizioni testamentarie a
carattere non patrimoniale (articolo 587/2 c.c.), si devono
considerare alcune ipotesi di esercizio della libertà testamentaria.
3 Il contratto in frode alla legge richiama alla mente il concetto di abuso del diritto perché, nella
sostanza, esso rappresenta uno strumento per cercare di eludere l’applicazione di una norma
imperativa. Si tratta, in altri termini, di un’ipotesi di abuso dell’esercizio della situazione giuridica.
4 L’articolo 2821 c.c. così recita: “L'ipoteca può essere concessa anche mediante dichiarazione
unilaterale. La concessione deve farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità.
Non può essere concessa per testamento”.
24In primo luogo, il contenuto dell’articolo 254 c.c. – “Forma del
riconoscimento” – così statuisce: “Il riconoscimento del figlio nato fuori
dal matrimonio è fatto nell'atto di nascita, oppure con un’apposita
dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un
ufficiale dello stato civile o in un atto pubblico o in un testamento,
qualunque sia la forma di questo”.
Pertanto, il riconoscimento del figlio può essere manifestato anche
all’interno di un atto di carattere testamentario. Si tratta di una
disposizione di carattere non patrimoniale che può essere
riconosciuta e ammessa anche nell’ambito di un testamento.
All’articolo 256 c.c. – “Irrevocabilità del riconoscimento” – si legge: “Il
riconoscimento è irrevocabile. Quando è contenuto in un testamento ha
effetto dal giorno della morte del testatore, anche se il testamento è
stato revocato”.
Pertanto, il riconoscimento può essere contenuto all’interno del
testamento, ma il medesimo riconoscimento, nell’ambito di questa
ipotesi, non consegue al modo con cui si manifesta l’esercizio del
potere di revoca. Ciò perché il potere di revoca del testamento non fa
cadere la manifestazione di volontà da cui scaturisce il
riconoscimento.
Il ragionamento, quindi, si complica: c’è una disciplina della libertà
testamentaria che prevede la revoca, ma, con riferimento alla
modalità attraverso la quale si ha il riconoscimento, questa ipotesi
non ricade all’interno del potere di revoca.
Pertanto, in tali casi, prevale, in sede di apprezzamento legislativo, il
riconoscimento e la manifestazione di volontà da cui esso scaturisce
ha un valore, per così dire, eccezionale.
25D’altra parte, il legislatore sceglie di attribuire efficacia al
riconoscimento, non dal momento della revoca, ma dal giorno della
morte del testatore.
La normativa in questione è, chiaramente, il frutto di una scelta
legislativa che dà origine ad una disciplina estremamente composita
che, di fronte a scelte diverse, poteva anche sostanziarsi in modo
diverso.
Altra ipotesi è quella prevista all’articolo 348 c.c. – “Scelta del tutore”
– il quale, al primo comma, così recita: “Il giudice tutelare nomina
tutore la persona designata dal genitore che ha esercitato per ultimo
la responsabilità genitoriale. La designazione può essere fatta per
testamento, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata”.
Ed, ancora, l’articolo 424 c.c. – “Tutela dell’interdetto e curatela
dell’inabilitato” – che al terzo comma prevede: “Nella scelta del tutore
dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato il giudice tutelare
individua di preferenza la persona più idonea all'incarico tra i soggetti,
e con i criteri, indicati nell'articolo 408”. Anche questa è un’altra
ipotesi che potrebbe essere ricondotta all’interno delle disposizioni di
carattere non patrimoniale che possono essere inserite all’interno
della scheda testamentaria.
Infine, occorre porsi una specifica domanda. Poniamo il caso di un
testamento che contiene una confessione. La confessione si impone
rispetto all’eventuale revoca del testamento? Ed ancora, quali sono gli
effetti di una confessione di un illecito penale o civile, al momento
della morte del testatore?
A tal proposito, una valutazione potrebbe essere fatta con riferimento
al contenuto dell’articolo 2735 c.c. – “Confessione stragiudiziale” – nel
quale si legge: “La confessione stragiudiziale fatta alla parte o a chi la
rappresenta ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale. Se è
26fatta a un terzo o se è contenuta in un testamento, è liberamente
apprezzata dal giudice.
La confessione stragiudiziale non può provarsi per testimoni, se verte su
un oggetto per il quale la prova testimoniale non è ammessa dalla
legge”.
Nella sostanza, in virtù della norma in commento, si riconosce un
valore alla confessione contenuta in un testamento. Si tratta, però, di
un valore non definitivo, in quanto il tutto è rimesso al libero
apprezzamento del giudice. In sostanza, la confessione contenuta in
un testamento non determina, in maniera irreversibile, l’ascrizione a
carico del soggetto della responsabilità relativa al compimento di un
certo fatto illecito.
5. Ipotesi specifiche di rapporto fra testamento e legge.
Nel paragrafo precedente abbiamo considerato il rapporto fra
testamento e legge in termini generali. A questo punto, analizziamo
alcune ipotesi specifiche di rilevanza del fenomeno del testamento e
della legge.
In particolare, cinque sono le ipotesi che verranno prese in
considerazione.
Una prima ipotesi è quella che scaturisce dal divieto dei patti Il divieto dei patti
successori
successori di cui all’articolo 458 del codice civile.
La situazione del testamento e della legge, naturalmente, implica la
necessità di considerare anche l’ipotesi prevista dall’articolo 458 c.c.,
il quale, come abbiamo visto nella parte introduttiva, esclude
l’ammissibilità dei patti successori.
27Ci siamo già interrogati sul significato effettivo di tale norma e,
soprattutto, sui dubbi che scaturiscono dall’utilizzazione del termine
patto successorio.
Bisogna, comunque, considerare che, negli ultimi tempi, sia da un
punto di vista dottrinale che da un punto di vista giurisprudenziale,
tende ad affermarsi una valutazione in termini restrittivi del divieto
dei patti successori. Si tende, cioè, a circoscrivere le ipotesi di patti
successori, ammettendo la possibilità di avere manifestazioni di
volontà concordata anche in ambito successorio. Si registra, quindi,
un’interpretazione restrittiva dell’articolo 458 c.c. e, in questo
contesto, può inserirsi anche il contenuto degli articoli 768 bis, e
seguenti, c.c., in materia di patto di famiglia, il quale, come abbiamo
già detto viene considerato, probabilmente in maniera non
totalmente esatta, un patto successorio ammesso.
La seconda ipotesi specifica di rilevanza del fenomeno del testamento Testamento,
successione
e della legge riguarda i rapporti fra testamento, successione legittima legittima e tutela
dei legittimari
e tutela dei legittimari.
Come abbiamo già avuto modo di dire, la prima modalità di
regolamentazione del rapporto successorio è rappresentato dalla
successione testamentaria, in cui, in ossequio alla libertà
testamentaria, il testamento rappresenta la fonte del rapporto
successorio medesimo. Accanto a questa modalità di
regolamentazione della successione esiste la possibilità di far
riferimento alla legge: in questi casi, la disciplina del rapporto
successorio non scaturisce dal testamento, ma dalla legge
(successione legittima).
Pertanto, nella logica complessiva dell’ordinamento, prevale la
necessità di determinare forme di successione. Da un lato, ci si
rimette alla volontà del testatore – successione testamentaria.
28Dall’altro lato, laddove non sussista il testamento, interviene la legge
– successione legittima.
In questo contesto, nell’ipotesi in cui si abbia il testamento, si deve,
comunque, tener presente la necessaria tutela dei legittimari.
A tal proposito, bisogna considerare il contenuto dell’articolo 42,
comma 4, della Costituzione. Tale norma, come è noto, affronta,
nell’ambito della Carta costituzionale, il problema della proprietà e, al
quarto comma, si occupa delle questioni relative alla
regolamentazione del rapporto successorio.
Nello specifico, l’articolo 42/4 Cost. così recita: “La legge stabilisce le
norme e i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti
dello Stato sulle eredità”.
La norma in commento, quindi, ammette una considerazione delle
forme di successione, ma, per quanto riguarda la disciplina delle
stesse, rinvia alla legge ordinaria. L’articolo 42/4 Cost., ad avviso di
chi scrive, non implica l’obbligo di considerare esclusivamente la
successione legittima e quella testamentaria.
29Puoi anche leggere