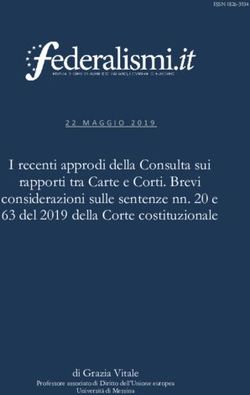Giacomo Leopardi, poeta della gioia - GABRIELLA SICA
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
GABRIELLA SICA
Giacomo Leopardi, poeta della gioia
Giacomo Leopardi è il poeta sempre caro della mia adolescenza, come è il
poeta dell’adolescenza di tutti noi italiani. In quel «buon tempo», il dolore di
Leopardi con la sua solennità e il suo ardore giovanile mi dava stranamente
gioia e i versi, così tristi e pieni di malinconia, mi lasciavano un’eco dolce e
tenera che mi costringeva alla partecipazione e all’affetto, quasi potessi conso-
larne un po’ l’autore. Mi incantava quella musica del verso che sapeva d’aria
primaverile e di canto popolare e dove si sentiva, come per risonanze sonore,
l’affezione e l’avventura di un’anima, l’apprendimento della vita, la libertà e la
luce della giovinezza. E intanto mi rassicurava, con il suo cantare l’«età fiorita»
come una festa, dello «stato soave» e della stagione lieta che ancora mi aspetta-
vano, fino a «il limitare di gioventù».
Quella mia adolescenza sapeva ancora molto di un’infanzia vissuta tra la
campagna e un piccolo borgo dell’Italia centrale piantato tra i Monti Cimini non
troppo lontano dal mare. Nelle poesie di Leopardi mi pareva di ritrovare la stes-
sa geografia e un calendario spirituale molto simile, «con le vie dorate e gli
orti» e le stagioni legate alla maturazione dei frutti, che erano gli stessi dei molti
italiani degli anni Cinquanta ancora legati alla terra. Ritrovavo, nella mia vita di
campagna, il contadino dalla faccia rugosa e la vanga sulle spalle, il «garzoncel-
lo scherzoso», il trascorrere del tempo nell’ozio della campagna, il cielo sereno,
e ancora «del faticoso agricoltore il canto», le schiarite dopo il temporale, il far
festa degli uomini e degli uccelli, il canto di un passero solitario, il lieto rumore
dei fanciulli intenti al gioco, e poi le piante e i fiori della campagna, il farsi sera
e la luna quieta sopra i tetti e nel buio il «fiammeggiar le stelle» e, ancora, le
«vaghe stelle dell’Orsa», «in purissimo azzurro» dei notturni estivi. Quella
«vecchierella» che appare con un fascio di stecchi sulla testa o siede con le vici-
ne sulla scala e racconta il bel tempo aveva proprio i tratti delle vecchiette che
vedevo intorno.
La poesia, con i suoi ritmi e ripetizioni, mi appariva proprio come il suono
della natura che mi circondava, il cinguettare di un uccello, della rondinella o
145Gabriella Sica
del passero o il mormorare dell’acqua o lo stormire delle foglie. E di quelle cose
vere che mi circondavano come appartenenti a una vita nuova e fresca, Leopardi
mi dava la certezza di una radice lontana nei secoli fin dove arrivavano i raccon-
ti biblici sui patriarchi e le origini del mondo.
Tutto, leggendo Leopardi sui banchi di scuola, aveva il sapore della sorpresa
e del miracolo dell’essere, e ci vedevo l’espressione felice di una primavera
della spiritualità, una chiara ingenuità. Le piante e gli uccelli erano quelli della
creazione, le meditazioni leopardiane sulle sorti dell’uomo e dell’universo mi
arrivavano dal Qohélet che meglio conoscevo come Ecclesiaste. E mi parevano
allora improntate a una dolce malinconia.
Un poggetto, una torre, qualche stradetta di campagna: lì si concentrava ai
miei occhi «tutto il bello e il piacevole delle cose», come per quel poeta solo e
infelice. «Ed erra l’armonia per questa valle»: tutto mi pareva splendidamente
detto, in quei versi fluidi senza una misura propria, fitti di interrogativi e dubbi,
con candore e semplicità, nella ricerca evidente di parole familiari e chiare e di
quelle più eleganti e peregrine della civiltà antica. Ci sentivo il cammino verso
la parola «naturale» avendo come guida «l’uso e la familiarità con gli antichi».
Era proprio grande poesia quella capacità di parlare sinceramente di se stessi, di
ricreare una natura dove le cose sorridono, oltre la poesia stessa, poiché «lingua
mortal non dice / quel ch’io sentiva in seno». E di donarmi, per la prima volta,
una memoria che mi era allora del tutto sconosciuta. Intuivo, e non ero lontana
dalla verità, che Leopardi fosse il nostro primo poeta a essere antico e, nello
stesso tempo, moderno.
Leopardi è ancora, per me, il poeta della gioia e della letizia quando «apre i
balconi, apre terrazze e logge la famiglia», «il sole sorride per li poggi e le
ville» e «si rallegra ogni core». Il Leopardi pessimista è uno straordinario datore
di vita e di gioia. La natura matrigna con gli uccelli nell’aria e i muggiti d’ar-
menti è in verità continuamente esaltata.
Dice un vangelo: «la vostra gioia, nessuno ve la toglierà». Anche Leopardi
riuscirà ad avere la sua miracolosa gioia. Tuttavia la letizia leopardiana non è
quella congiunta alla luce di Dante o al sapere di Petrarca. Quella lingua di luce
è invasa dalle tenebre, minacciata dal lutto incombente.
Leopardi è sempre il poeta della «contentezza di se stessi» quando avviene il
riconoscimento di un bene, della felicità che si prova di fronte a una creatura e
alla sua innocenza, davanti alle piante, ai fanciulli che giocano o gli uccelli che
volano, è il poeta dell’ammirazione anche senza ringraziamento. Il modo d’es-
sere dei bambini, diceva Leopardi che era molto un bambino, è lo stesso degli
antichi e degli uccelli che sono «le più liete creature del mondo», con quella
vispezza e mobilità propria dei bambini. Ed è il bambino soltanto che sa, che
«sa talvolta più del filosofo», che conosce la lingua della poesia.
E mi pare, per parafrasare Leopardi, di sentire un moto del cuore nel rilegge-
re ancora una volta quei suoi versi, i versi scritti «veramente all’antica, e con
146Giacomo Leopardi, poeta della gioia
quel mio cuore d’una volta», e nel ritrovare in ogni sillaba e in ogni parola
incredibilmente familiare il suono e il profumo della mia adolescenza poiché le
ricordanze di quel tempo, come lui stesso ci insegna, sono più vive di quelle di
qualunque altra età.
Potrà essere Giacomo Leopardi il poeta della nostra maturità e oltre, potrà
accompagnarci alla soglia estrema della nostra vita, insegnarci la via per la
nuova era che sta per nascere con il nuovo secolo? Siamo forse più portati in
questi tempi a pensare con uno spirito millenario, e Leopardi, che è un maestro
indiscusso di quest’arte particolare che è la meditazione sul tempo, saprà offrirci
la lezione giusta per noi uomini stanchi di modernità e alle soglie di un nuovo
millennio?
Tra il tempo e l’eternità, Leopardi aveva scelto il tempo e il tempo l’aveva
inchiodato al dolore costringendolo ad abbandonare la gioia. La certezza di un
tempo che resta non è un sentimento che gli appartenga. «Dell’eterne idee» pla-
toniche su cui l’Antichità si era fondata, Leopardi non trova tracce sensibili nel
mondo. E intanto John Keats diceva che una gioia è «una gioia per sempre» e
una cosa bella è per sempre, nella certezza dell’immortalità dell’urna e dell’usi-
gnolo, oltre il nostro vivere di uomini. E il pettirosso di Emily Dickinson «indi-
ca la Casa / e certezza e santità».
Leopardi è l’ultimo classico e il primo moderno della nostra poesia. Lo fa
essere assolutamente classico l’attaccamento e la venerazione per la lingua poe-
tica del canone, sia greco che latino, sia ebraico che italiano. Leopardi resuscita
con voracità e straordinaria raffinatezza tutta la tradizione classica, da Omero a
Virgilio e Orazio, dal Salterio ai poeti italiani. Petrarca è naturalmente il princi-
pio e Leopardi è anche l’ultimo grande petrarchista. E poi tutta la tradizione ita-
liana, elaborata in una propria Crestomazia, viene riletta, passando attraverso i
petrarchisti del Cinquecento e Tasso, fino all’Alfieri e Foscolo e poi al Monti,
imitata e ricreata in una contaminazione personalissima di grande originalità
che è già un annuncio molto chiaro della moderna decadenza. Gli antichi
Leopardi li imita tutti, come avevano fatto i suoi predecessori, ma, senza dare
un nuovo significato alla tradizione, li riassume in una contraffazione ardita in
cui è detto tutto e anche il contrario di tutto. Quella straordinaria e spesso mera-
vigliosa selva di pensieri e pagine che è lo Zibaldone è anche un vero labirinto
costruito con grande abilità illusionistica per chi voglia addentrarcisi. Chi ten-
tasse l’impresa di capire come stanno le cose faticherebbe a trovare un filo di
Arianna e non ne verrebbe mai fuori.
Da qui i tanti Leopardi di cui si può discorrere, a cominciare dal Leopardi
risorgimentale di Francesco De Sanctis che è il suo primo vero critico.
Solo la grande poesia leopardiana, inaspettatamente fiorita tra gli Appennini,
può riscattare un pensiero che non è mai sistematico e non cerca mai l’unione
dei contrari come in Petrarca. Leopardi, con un sottile lavoro di appropriazione
e cancellazione, riconverte romanticamente la tradizione a se stesso e alla
147Gabriella Sica
modernità di cui è maestro indiscusso. «Sforzati al cielo», diceva Petrarca.
Leopardi invece trascina tutto verso il buio del nulla e quando dice «veggo» è il
nulla che vede, cioè non vede se non ombre. «E gli uomini vollero piuttosto le
tenebre che la luce», scrive nell’epigrafe alla Ginestra invertendo il senso di un
versetto di Giovanni. Come la fiamma del Vesuvio che nasce nel cratere, quella
è una luce di morte. Come nel mito platonico della caverna le tenebre sono la
sventura. Ma Leopardi non cerca la luce chiara e piena o non sa vederla, gli
piace rimanere nella «notte oscura» dello spirito.
Certo che «l’età superba» in cui è vissuto deve essere stata ben povera. E
certamente misera l’Italia reduce dalla delusione napoleonica. Spaventosi i
rivolgimenti e la confusione dell’epoca che in Italia comincia con Leopardi e
dura fino a oggi, alla fine del secolo. La sua contemporaneità escludeva e mette-
va in esilio la poesia, come del resto continua a fare la modernità a cui lui per
primo si è affacciato.
Perché Leopardi ha certamente annunciato il tempo arido e il deserto del
tempo moderno. Il suo cuore anestetizzato dal dolore, morto alla percezione
estetica del mondo (dal greco aisthesis), aveva per primo, davanti al male e al
brutto del mondo, riportato tutto all’unità e all’uniformità del nulla. Il nulla e
solo il nulla è origine e fine del mondo. E il nulla fa ammalare l’anima, la ucci-
de. La ragione soltanto, per il Leopardi illuminista e sensista, non si illude e sa
guardare la verità terribile delle cose, l’arido vero. Dimentica Leopardi che la
ragione vede solo il visibile. E solo dal visibile, dalla materia, voleva del resto
estrarre il suo vero. E tuttavia anche la ragione è un’illusione, anche il presunto
paradiso della scienza e della tecnica è un’illusione, dirà profeta eccellente dei
tempi a venire.
Tutti i «cari inganni», tra cui la natura antica, sono illusioni e finzioni dispe-
rate dell’anima che vanno sradicate anche se in esse consiste la gran parte della
vita. Tra i verbi più leopardiani compare non a caso il verbo «fingere», indicati-
vo del suo rappresentarsi nella mente qualcosa che non esiste nella realtà, del
suo simulare. E lui si «finge» il mondo come un teatro orrendo e malefico di
apparenze già destinate alla morte, come, da piccolo, allestiva insieme ai fratelli
il teatro delle passioni. «Amaro e noia / la vita, altro mai nulla; e fango è il
mondo», dice in A se stesso.
È un nuovo modo di pensare quello leopardiano che annienta per la prima
volta alle radici la sapienza antica e apre la via al pensiero nichilistico. Mai, nel
pensiero d’Occidente, si era visto prima qualcosa di simile, mai qualcuno aveva
avuto tanta forza da rivolgere gli occhi soltanto sul nulla. Per i greci e per gli
ebrei, come per i cristiani e per gli uomini del Rinascimento, le cose del mondo
sono nulla senza il pensiero del divino. Perfino, sia pure al contrario, per gli
gnostici. Per Leopardi, il primo poeta vero teologo del Dio morto, si spalanca
l’abisso del vuoto più terribile che è la morte vanificatrice di ogni forma di vita,
il silenzio del nulla che è l’unica verità, senza l’eterno. Ma il nulla ha un confine
148Giacomo Leopardi, poeta della gioia
e un limite, è privo di lingua e, a volte, anche il verso si perde. Egli non vede
più immagini nel cielo, la luna come una sfinge non può dare risposte che non
possiede e la notte ha soltanto la lingua del silenzio e del buio.
«Tutto è male» nella più totale insensatezza, senza colpa né redenzione. Al
terribile dio persiano delle tenebre, Arimane, divinità preislamica e più negativa
di Zarathustra, Leopardi rivolge uno dei suoi ultimi incompiuti canti dichiaran-
dosi apostolo della sua religione. L’Occidente non conosceva tanto estremismo.
Solo sulle rive del Gange, tra uomini atterriti e prostrati sotto il peso del dolore
universale, cui non si affacciava neppure il pensiero della divinità, era cresciuta
una dottrina altrettanto pessimista. A originare il buddismo era stato il desiderio
del bene e della felicità impossibili, la certezza del male e dell’infelicità. E il
Budda morente aveva percorso i quattro gradi della liberazione: conoscere la
natura e la vanità delle cose, abolire il giudizio in sé, giungere all’indifferenza,
allo svanire di ogni cosa. Nel nirvana, una specie di infinito leopardiano, nello
svanire di ogni piacere, di ogni memoria e coscienza, non esistono né idee né
assenza d’idee, nemmeno esiste l’idea del niente, e tutto è niente. Ma Leopardi
non conosceva il sanscrito. Conosceva però un po’ d’ebraico e soprattutto si era
quasi fisicamente sconciato nel maneggiare enormi in-folio dei santi padri e i
pesanti volumi della Bibbia che prendeva dalla biblioteca paterna. E del pessi-
mismo ebraico, dell’idea ebraica del tempo si era nutrito, se perfino nel Sabato
del villaggio corre una festosa vena ebraica quando celebra il più bel giorno dei
sette, «pien di speme e di gioia», «un giorno d’allegrezza pieno». Anche
Salomone aveva detto: è migliore il giorno della morte che il giorno della nasci-
ta, ma solo perché l’ultimo è quello della mietitura. Né, per quanto Leopardi
abbia cercato di trovare precursori nei greci, ci fu mai nel mondo pagano e anti-
co, più incline al gusto della vita e alla ricerca della serenità, tanto pessimismo.
Nessuno aveva mai cantato lo spirito del Male. Gli abbozzi di inni sacri al
Redentore, a Maria o agli apostoli, i ragionamenti sulla passione di Cristo pro-
nunciati da Leopardi adolescente nella chiesetta di San Vito sono ben lontani.
Come era lontano da quegli urli di dolore che spingevano Leopardi a farsi cre-
dente del male il Goethe che scrive: «il vero poeta è chiamato ad accogliere in
se stesso tutto lo splendore del mondo e sarà quindi sempre più incline a lodare
che a rimproverare».
Come un santo del deserto o uno dei padri martiri di cui conosceva bene le
storie, Leopardi si era avventurato solitario, prima degli uomini e dei poeti del
Novecento, nel nostro secolo confuso e arrogante, senza trovare un calmante
alla fame e alla sete che lo bruciava. La poesia non aveva portato la quiete al
suo cuore in affanno.
Ungaretti legge Leopardi come «un cristiano ai cui occhi s’era oscurato il
mistero della Redenzione». E tuttavia il nulla leopardiano non diventa mai atte-
sa e pazienza, colloquio con il divino, compassione buddista per la miseria
umana né amore cristiano. Quel nulla è impotenza e privazione, chiusura nell’e-
149Gabriella Sica
gotismo di un io romantico soffocante. Il ritmo incantatorio dei versi che trasci-
nano nel vuoto, le opere, i giorni e gli affanni hanno le cadenze del Qohélet
senza la capacità di trovarne l’invocazione e la preghiera. Le ultime parole di A
se stesso, «l’infinita vanità del tutto», sono soltanto le prime del Qohélet.
Lo studio degli antichi non riesce a salvarlo, a trasformare l’erudizione in
poesia, il sapere in pietà. I tanti antenati spirituali che si è scelto non riescono a
trasformarsi in persone vive, mentori interiori e guida nella miseria dei tempi, a
indicargli la via della misericordia. Egli non riesce o non sa più vedere, se non
in orme di mancanza, in frammenti di lutto, la bellezza né la virtù che la bellez-
za comprende, come fa Keats.
Non è Leopardi il poeta dell’amore: i baci sono un avvenimento del sogno e
i colloqui amorosi li intrattiene con donne scomparse. Non simili a Laura che,
morta, è più viva che mai. Non riesce a trovare l’amore, a riconoscere in una
donna la bellezza e anche la salvezza morale, come aveva fatto Petrarca che
aveva trasformato un evento del cuore, l’incontro con Laura, in uno straordina-
rio rilancio dell’umanesimo d’Occidente. È troppo psicologico Leopardi per riu-
scire a porre le fondamenta per un nuovo Rinascimento, troppo moderno e indi-
vidualmente frammentato, diviso tra l’estetico e l’etico, già troppo immerso nel
vuoto del moderno.
Le parole non gli offrono più immagini e forme per sostenere la sua vita e
dare un senso alla morte, non riescono ad essere interamente persone, esseri
compiuti, non solo letterari, a raccogliere e rifondare la fiducia degli antichi
padri. Le stesse figure che compaiono nella sua poesia, anche quelle straordina-
rie come Silvia e Nerina così legate al tempo in cui «beltà splendea», sono più
ombre che persone vere, nomi che ricordano altre figure letterarie, come la
Silvia tassesca o la Nerina virgiliana. Non sappiamo niente di Silvia o del pasto-
re orientale, né della donna, «cara beltà», che gli ispira un canto.
Le stesse piante e uccelli non hanno mai la proprietà del nome o una deter-
minazione reale, come osservano Pascoli e, meno critico, Montale. Anche la
natura è sempre molto vaga e indefinita. I fiori non hanno la proprietà del nome
ed è tutto «vasto ospitale», elegia del paesaggio. Paesaggio che seduce dissol-
vendo ogni georgica, giardino dove l’io romantico non sa riconoscere la verità e
sfuggire al falso e all’inganno, che non sa dimenticare se stesso ed entrare in
una comunità di uomini. Questa non è la natura intellettiva di Dante né la natura
umana e il cuore di Petrarca, non è più Dio. C’è già l’annuncio pieno della con-
fusione novecentesca.
Anche il fiore del deserto parla a se stesso, non esce dall’io. La ginestra non
aspira ad altro, è contenta del deserto, gioisce di ciò che l’annienterà. Si nasce
alla morte, si vive nella mote. Il sentimento della morte è tale che si riceve vita
da esso. Nasce solitaria ed estrema sulla vetta infuocata del Vesuvio dove non
c’è vegetazione né ha memoria di quei luoghi dov’erano un tempo ville, orti e
giardini: è il fiore del male che si erge dalla cima dell’Ottocento. Volti fuggitivi,
150Giacomo Leopardi, poeta della gioia
parvenze, «vaga fantasia», ombre d’infinito, «stupende larve» sono gli straordi-
nari frammenti poetici dell’essere moderno e non più classico, oltre le aggrovi-
gliate e luttuose affabulazioni cosmogoniche e teologiche delle Operette morali
e il loro operare «morale», cioè dire crudamente della nullità delle cose senza
«nulla al ver detraendo».
L’adolescente Europa di Petrarca è invecchiata e non sa come rinascere,
senza Dio né gli antichi. Anche la lingua è vecchia, fatta di poche parole, e per
ringiovanirla Leopardi ne scontorna le parole, le rende vaghe e indefinite nel
tempo e nello spazio, strette tra oblio e rimembranza, tra un finito sconosciuto e
un infinito altrettanto sconosciuto. Ma il suo naufragare è anche una perdita del
pensiero e della lingua, di una lingua vera, non immaginata o finta, dove la gioia
sia dantescamente congiunta a quella luce che trascende ogni dolore. Ma
Leopardi non inventa una nuova lingua perché già molto ha trovato in Petrarca.
Così il grande dolore diventa alla fine la privazione della lingua, la minaccia
che incombe sulle parole.
Da quel nulla, Leopardi si finge l’illusione ultima ed estrema che è la poesia.
Quando tutto è morto e arido, quando le illusioni più belle della vita, come l’a-
more, muoiono, rimane la poesia, poiesis, che è proprio un fare e un creare,
forza che porta fuori dal niente e consente all’essere di vivere, di ritrovare la
parola per parlare. Perché l’esperienza stessa del nulla non è umanamente possi-
bile e la creazione, la poesia, è la lingua di questa impossibilità, in nessun poeta
così tanto come in Leopardi. La poesia è la sua unica vera madre, consolazione
e rimedio estremo.
Se Leopardi non fosse un altissimo poeta, sarebbero davvero bui e senza
luce i suoi pensieri, e si potrebbe soltanto pregare e diventare pii, non nutrire
brutti pensieri, come già diceva Pascoli, su un uomo che ha cantato la gioia tro-
vandosi poi tra le mani la sabbia e la cenere del mondo e intorno il vento del
nulla, fino a diventare il poeta quasi mistico della glaciazione moderna
dell’Occidente.
La poesia non placa il suo cuore inquieto. Non meraviglia che gli rimanga
estraneo il fiorentinismo foscoliano dei luoghi sacri, che non riesca a essere fio-
rentino e neppure romano. Non riesce a trovare mai un po’ di pace né la voglia
di vedere Roma per ritrovare nelle sue ville, nelle piazze e nelle chiese, dopo la
Roma dei Cesari, quella dei papi, dopo la Roma antica quella barocca. Invece si
sente isolato negli spazi ampi della città eterna, tanto l’eterno, come anche il
contingente, lo angustiano. Certo, non può non detestare il misero traffico di
gloria che vede a Roma, lui che è per di più suddito dello stato pontificio, ma il
suo pensiero non sfonda il muro dell’egocentrismo. Non riesce a pensare a
Roma come centro di spiritualità né tanto meno lo sfiora il desiderio petrarche-
sco di resuscitarne la grandezza.
È quasi imbarazzante il suo radicale rifiuto di Roma, nonostante fosse un
ammiratore degli antichi, di Virgilio e Orazio, che egli stesso aveva invitato a
151Gabriella Sica
onorare. Non si commuove mai a Roma, se non sulla tomba del Tasso in
Sant’Onofrio al Gianicolo dove arriva a piangere. Non c’è niente in lui del desi-
derio di Ortis di recarsi a Roma per «prostrarsi sulle reliquie della nostra gran-
dezza», né dell’eccitazione di Goethe nell’avvicinarsi a Roma, né della scelta
del Borromini o di frate Angelico di morire proprio in questa città universale.
Più che uomo del mondo, Leopardi è un uomo che si sente soffocato dal
mondo, senza la capacità di trovare il suo punto fermo d’equilibrio. Nomade
spirituale ed errante italiano, lascia la terra originaria, la sua vera fonte di poe-
sia, nel misero tentativo di trovare una nuova terra promessa più feconda. Solo
Pisa, la più simile a Recanati, gli darà un breve piacere.
Non ama le città d’Italia, neppure Firenze, non ama gli uomini, tranne
Ranieri, non ama le donne. «Soccomberò io solo»: ma il verso eroico suona
falso ed è enfatico, come quando da piccolo faceva il teatrino con i fratelli.
Finirà per morire nella detestata Napoli di cui neppure lontanamente capirà la
grecità, ma si fermerà, in quella città «semibarbara e semiafricana», alle pendici
del Vesuvio, monte sterminatore di ogni memoria georgica, infernale bocca
d’Averno e di modernità poggiata su cenere e lava. Eppure aveva scritto: «l’an-
tichità [...] è una specie di meridionalità nel tempo» e la civiltà moderna è come
un «furore di settentrionalità nel tempo».
Bisognerà aspettare un secolo quasi perché la lezione di Leopardi, scaval-
cando l’Ottocento, diventi attiva. Perché il suo secolo non gli dimostrò molta
generosità. Lui, che si era mostrato così nemico al proprio tempo, dal suo tempo
fu ripudiato, senza riceverne né amore né gloria. Non videro in lui un maestro
né Carducci o D’Annunzio, e neppure Pascoli, che tuttavia, tra i tre, è certamen-
te il più leopardiano, anticipando anche il grande interesse novecentesco per
Leopardi. Non piaceva a Pascoli quella sua vaghezza che nasceva dalla confu-
sione del reale, come quella, famosa, tra le viole di marzo e le rose di maggio.
Scrive Pascoli: «Che difficoltà nell’esprimere il calpestio dei cavalli col trap
trap trap e il suono dei campanelli col tin tin tin?». C’è già, in questo appunto
sull’imprecisione nominale delle cose e sulla loro risonanza onomatopeica, il
Leopardi fatto interamente pascoliano, i cui Canti recanatesi diventeranno i
Canti di Castelvecchio e dove Silvia «all’opre femminili intenta» rivivrà nella
tessitrice che «muta la spola passa e ripassa». Un Leopardi, quello di Pascoli,
interamente fanciullino, che sa stupirsi davanti allo spettacolo della natura come
pochi altri poiché «il poeta deve essere sempre il primo a dire una cosa in un
dato modo». E Leopardi sa ascoltare gli infiniti mormorii della natura, delle
rane e delle lucciole, del vento e, addirittura, delle galline e sa ricrearli in piena
concretezza. E sa vedere la grandezza degli astri dalla piccola terra, sa mirar le
stelle e la luna come un pianeta morto, come solo i bambini sanno fare o i poeti
nati nella campagna, come già Virgilio. Pascoli vi ritrova quella «familiarità
straordinaria e divina che tanto i bambini, quanto i poeti, hanno con gli esseri
del gran cosmo». E però non può Pascoli non sottolineare anche come, «prima
152Giacomo Leopardi, poeta della gioia
che la ginestra fosse il fiore del deserto, il fiore della negazione, era quello che
in più gran copia mietevamo, noi fanciulli, per i greppi d’Urbino, nelle feste
religiose dell’estate».
Esattamente cento anni fa, nell’aula magna del Collegio Romano, Pascoli
teneva una memorabile conferenza sulla Ginestra, in cui riconosceva nell’esule
«il poeta del dolore della nuova letteratura italica» e, in una successiva sul
Sabato, il poeta della «religione dell’avvenire» nell’«Era nuova».
Per riscoprirlo davvero, bisognerà aspettare, dopo Un Leopardi mal noto di
Clemente Rebora, la rilettura della «Ronda» del 1921 e Ungaretti che nel 1926
gli dedicò il primo di molti scritti e delle molte lezioni leopardiane tenute pro-
prio all’Università «La Sapienza» di Roma.
Allora Leopardi sarà classico o ermetico e anche anticipatore delle poetiche
dell’avanguardia. Il cuore del Novecento sarà infatti interamente leopardiano:
dalla musica per frammenti lirici di Clemente Rebora al passero di Pascoli e di
Montale, dalla «speranza nell’opera» di Vincenzo Cardarelli all’«allegria» di
Ungaretti, ai canti e alle risse degli uccelli colorati di Saba.
Il dolore leopardiano rinasce nella «serena disperazione» sabiana: «l’uma-
na via è oscura e dolorosa / e non è ferma in lei nessuna cosa». Per Saba, come
per Leopardi, il nascere è di per sé un errore e il principio stesso del male.
Saba sa che «la vita è un male / che la vita è il peccato originale»: dietro il suo
male di vivere tuttavia non c’è il nulla, ma il Dio di sua madre e del Vecchio
Testamento, il Dio del castigo: «Dentro una nube muove / il Dio che castiga».
Saba scrive divertito in un racconto di avere in sogno invitato Leopardi a cola-
zione, insieme alla Lina e alla Noretta, e di avergli preparato le polpette al
pomodoro, con le migliore triglie e il migliore dolce al gelato di Trieste per
procurare quei piaceri tanto cari al poeta di Recanati. È il congedo ironico e
divertito da un amore finito. Fu Leopardi, dice Saba, l’«idolo malinconico
della mia giovinezza malinconica», ma, alla fine, conclude: «Ho rimesso il
libro in tasca (si tratta dei Canti, naturalmente) e credo veramente che non vi
leggerò più».
Ma trapiantata nella senilità di Saba c’è la centralità della poesia nonostante
tutto, della «contentezza di se stessi» leopardiana, della capacità di parlare sin-
ceramente di se stessi, di una via diversa da quella battuta con clamore dalle
avanguardie. Anche se le avanguardie novecentesche e l’ermetismo nascono dal
Leopardi contemplatore della sventura senza pietas e che, alla fine, finisce per
essere stritolato dalla sventura stessa.
La ginestra «contenta dei deserti» annuncia già l’agave sullo scoglio monta-
liano; e quella siepe e quei deserti della terra e del cielo così tanto leopardiani
sono la memoria del «rovente muro d’orto» e della «muraglia / che ha in cima
cocci aguzzi di bottiglia» di Montale che è forse, con il suo male di vivere scrit-
to su una natura desertica, il vero erede di Leopardi. I paesaggi di Caproni, teo-
logo scrupoloso del Dio morto, hanno la stessa povertà del deserto che circonda
153Gabriella Sica
la ginestra e il franco cacciatore somiglia al pastore errante. Così come il «con-
fuso sogno» di Penna, in cui il pensiero sembra naufragare nell’indistinto, sa
molto di leopardiano. E da Perugia il giovane Penna si sentiva soffocare come
l’amato Leopardi nella vicina Recanati e guardava con la stessa intensità la
luna.
Eredi Leopardi ne trovò molti anche tra i prosatori, primo tra tutti il Moravia
scrittore senza dolcezze del tedio e della noia, e forse qualche altro furioso
distruttore. Per arrivare alla vitalba di Zanzotto che cresce nel degrado edilizio,
ultima erede naturale della ginestra.
Come l’amante che era Petrarca o il fanciullino di Pascoli, così l’adolescente
pieno di giovinezza, più che l’uomo moderno e solo che era Leopardi, è entrato
in noi e lo abbiamo riconosciuto come nostro.
E tuttavia la forza del canone novecentesco ci incalza e ci chiede risposte.
Ogni nuova generazione porta la sua testimonianza e il suo tributo ai grandi del
passato. E io non credo che la mia generazione abbia proposto una nuova fortu-
na di Leopardi, oltre la memoria di quel suo memorabile cantare l’«età fiorita»,
quando il candore e la semplicità riescono a liberarsi di ogni fardello, e oltre
l’occasione del centenario che ha certamente obbligato poeti e critici a una rilet-
tura. Non si può dire che in questi anni Leopardi sia stato con noi, con noi nella
maturità e non solo nella giovinezza.
Forse Leopardi, spirito moderno ed europeo, che così tanto ci ha lasciato in
eredità, non può darci per gli anni a venire ancora insegnamenti. Ci appartiene
ormai quella chiarezza e agevolezza tutta italiana, quasi che un lembo di suolo
toscano si fosse spinto, attraversando l’Umbria settentrionale, fino alle Marche
dove ha formato uno dei miracoli della poesia italiana.
Il romanticismo, e dunque il moderno, è ormai alle nostre spalle, finito nel
naufragio di un tempo mostruosamente scettico e arido. O almeno così io spero.
E davvero non so se il nuovo secolo possa avere impresso sul suo volto i linea-
menti di Giacomo Leopardi.
Nota
Discorso scritto in occasione delle manifestazioni per il bicentenario della
nascita di Giacomo Leopardi promosse dal Comune di Roma e dall’Università
degli Studi «La Sapienza» e solo parzialmente letto il 4 maggio del 1998 nella
Sala della Promoteca in Campidoglio nel corso di una giornata dal titolo «Nel
nome di Leopardi: riflessioni di poeti italiani e stranieri».
154Puoi anche leggere