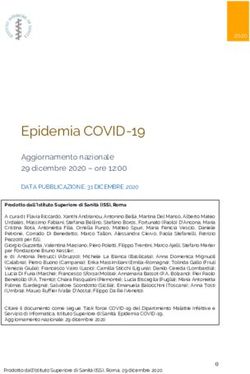Forza, Italia Bill Emmott - (Rizzoli, 2010)
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Bill Emmott Forza, Italia (Rizzoli, 2010) CAPITOLO 1
PERCHÉ? All’inizio la cosa mi aveva colto di sorpresa. In seguito, però, ogni volta che andavo in Italia la conversazione prendeva sempre la stessa piega: «Perché diavolo stai scrivendo un libro sull’Italia?» «Bè, perché no? Non pensi che il tuo sia un Paese interessante?» « In realtà, no. L’Italia non interessa a nessuno. E, comunque, non c’è speranza. I politici sono tutti corrotti. Non c’è niente da fare. A nessuno importa. Sa com’è, siamo un Paese di individualisti, non siamo capaci di fare squadra. La nostra industria è stata annientata dalla Cina e dall’India. Le nostre università sono inutili. Il nostro sistema giudiziario è malato. Stiamo diventando vecchi e nessuno fa più figli. Lascerei perdere, se fossi in te. Tieni, beviti un’altra grappa.» «Ma state per celebrare il centocinquantesimo anniversario della vostra Unità. Che cosa penserebbero Cavour, Mazzini e Garibaldi ti sentissero parlare così? Non sei orgoglioso di essere italiano?» «Sì, sì, ma anche se siamo un Paese da centocinquant’anni non siamo mai stati una nazione. L’unica cosa che ci unisce è il calcio, e a volte neanche quello. Comunque, come ti dicevo, non c'e niente che si possa fare, e nessuno che voglia provarci.» «Ma che mi dici a proposito di... » [e qui cominciavo a fare l’elenco dei cambiamenti in corso in cui mi ero imbattuto in Italia, città
trasformate, imprese che hanno conquistato i mercati mondiali ecc.] «Certo che il Paese può essere cambiato. O sono solo uno straniero ingenuo sedotto dal suo fascino e incapace di rendermi conto di come stanno veramente le cose?» Di solito, i miei interlocutori italiani erano troppo educati per rispondermi. È bizzarro, però. Ho scritto un sacco di libri sul Giappone e nessun giapponese mi ha mai chiesto perché lo stavo facendo. Dubito che un francese chiederebbe a uno straniero perché si prende la briga di scrivere un libro sulla Francia, anche se sicuramente metterebbe in chiaro che non leggerà le fesserie che questi, proprio in quanto straniero, è destinato a produrre. E un inglese? Be’, è probabile che sorriderebbe benevolmente, offrirebbe la sua assistenza, dichiarerebbe che l’attenzione di uno straniero verso il suo umile Paese gli provoca un leggero imbarazzo e si allontanerebbe in fretta per evitare la remota possibilità di dover fare qualcosa al riguardo. Ma tutti darebbero per scontato che gli altri vogliano e debbano essere interessati. L’Italia no. A dire il vero, i miei interlocutori aggiungevano un’altra sfumatura problematica. Va bene scrivere dell’Italia, mi facevano osservare in molti, ma certo avevo notato che non esiste una sola Italia, bensì due, il Nord e il Sud (o tre o quattro, secondo alcuni). In pratica, erano due Paesi differenti. Se m’interessavano i dati, e per un noioso economista come me era di certo così, dovevo capire che il concetto di “media” in Italia non ha senso. È come dire che una persona con la
testa dentro il forno e i piedi nel frigorifero si trova mediamente a proprio agio. Le due metà sono talmente diverse che le statistiche generali sono fuorvianti. È un’affermazione esatta, anche se spesso esagerata. Ma ci dice realmente qualcosa? La gente può essere più ricca al nord, ma anche lì i problemi non mancano. I politici corrotti non si trovano solo al Sud e nemmeno i mafiosi, purtroppo, e se consideriamo altre preoccupazioni diffuse nel Paese, come per esempio le università di bassa qualità, le tensioni sull’immigrazione o il calo della competitività, è chiaro che si tratta di questioni nazionali, non certo regionali. La domanda che ho cominciato a pormi mentre giravo l’Italia, invece, è un’altra: questa distinzione è davvero la più importante? Sì, sì, il Sud e il Nord sono molto diversi tra loro come, se è per questo, il Piemonte e le Marche, la Liguria e il Friuli. Ma contemplando le cose da lontano, da osservatore imparziale, mi chiedevo se non fosse più utile pensare a un’altra divisione dell’Italia. Forse, mi dicevo, la linea di divisione più importante del Paese, lungo il corso dei secoli, non era di natura geografica bensì morale o magari filosofica. Intendo la divisione tra Mala Italia e Buona Italia. La Mala Italia è di certo italiana, ma non è l’Italia nel suo complesso, perché è interamente una questione di egoismo. Si tratta in primo luogo di corruzione e criminalità, chiaro, ma anche e più specificamente dell’impulso a cercare di ottenere il potere per abusarne nel proprio interesse, ad accumularne sempre di più per
ricompensare amici, famiglia, portaborse o partner sessuali, senza tener conto di meriti o capacità. Costruendo in questo modo clan e reti di relazioni basati sul debito nei confronti dei loro benefattori, che vivono arricchendosi a spese degli altri, chiudendo porte invece di aprirne, escludendo invece di includere. Tutti siamo egoisti, e i biologi ci spiegano con soddisfazione che perfino i nostri atti d’amore o di generosità possono derivare da motivazioni egoistiche. Conosco il tema dell’ambivalenza radicata in ogni italiano, la convinzione che le leggi debbano essere fatte rispettare e obbedite, che le tasse vadano pagate: dagli altri. Ma la Mala Italia va oltre. Il suo tipo di egoismo implica un disinteresse distruttivo particolare e perfino intenzionale verso qualsiasi tipo di comunità allargata o, soprattutto, di interessi, istituzioni, leggi e valori nazionali. Questa Mala Italia può essere paragonata a un parassita o, peggio, a un cancro. Non un cancro che si diffonde e uccide rapidamente, ma uno di quelli che crescono un po’ alla volta, che attaccano l’organismo pezzo per pezzo, indebolendolo gradualmente. Di certo, quel cancro è andato diffondendosi in anni recenti, infrangendo la speranza condivisa da molti, dentro e fuori il Paese, che dopo Tangentopoli sarebbe regredito. Dapprima lo ha fatto ma poi, agevolato e ispirato dai più alti livelli del governo, ha ripreso a diffondersi. Nessuno che tenga gli occhi aperti può sostenere con onestà il contrario. Ma questo non significa che non ci sia più speranza.
Per quanti bicchierini di grappa abbia bevuto (e ne ho bevuti parecchi), non riesco ad accettare l’idea che la Mala Italia abbia trionfato o che inevitabilmente lo farà. Ci sono troppe prove del contrario. Se è la Mala Italia a prevalere, com’è possibile che un italiano sia stato il più giovane chef di tutti i tempi, a ventisette anni, a ricevere le tre stelle Michelin o che il Paese abbia tanti imprenditori nonostante la proverbiale difficoltà ad avviare un’attività? Come può essere che nel 2009 l’Italia sia stata il quinto più grande Paese produttore al mondo (dopo, nell’ordine, gli Stati Uniti, la Cina, il Giappone e la Germania, secondo un’indagine condotta dall’istituto di ricerca IHS Global Insight),1se la concorrenza cinese la sta distruggendo? Come può essere che i treni Eurostar a bordo dei quali ho viaggiato in lungo e in largo per il Paese, siano più comodi e puntuali dei loro corrispondenti inglesi (anche se non sono, in realtà, più veloci)? 1 Us crown slips, «Financial Times», 21 giugno 2010. Se non c’è più nessuna speranza, com’è possibile che mi sia imbattuto in aziende leader mondiali nella vendita di attrezzature per il fitness, occhiali da sole, abbigliamento in cachemire, aeromobili leggere e molto altro, o in nuovi movimenti antimafia, o in città che hanno ritrovato una nuova vita postindustriale o sconfitto la delinquenza, o elaborato straordinari piani, come quello per il controllo dell’acqua alta di Venezia? Come mai ho incontrato giornalisti capaci di dire la verità su quello che sta succedendo e
disposti a farlo? È evidente che si tratta di una lotta non facile, e non sempre vincente. Ma la Buona Italia c’è. E combatte. Non sto cercando i pochi raggi di luce nelle tenebre, come far notare che Saddam Hussein in fondo era un buon padre di famiglia e che nella Corea del Nord s’intravede qualche scintilla di creatività. La Buona Italia è più di questo. Molto di più. Alcune caratteristiche della Buona Italia e della Mala Italia si sovrappongono, a onor del vero: le reti personali, l’importanza degli obblighi reciproci, per esempio. Ma le differenze stanno nella motivazione e in una sostanziale apertura. Perché la Buona Italia è meno in balia dell’egoismo, sebbene riconosca anch’io, insieme ai biologi e al nostro grande economista scozzese Adam Smith, che l’interesse personale gioca un ruolo inevitabile e positivo, che la mano invisibile ci guida verso la prosperità, come quest’ultimo ha scritto nella Ricchezza delle nazioni, la sua opera fondamentale del 1776. Come lui, tuttavia, credo che i «sentimenti morali», la solidarietà, l’impulso alla cooperazione, la creatività al servizio di obiettivi comuni, il senso dell’interesse e dell’impegno collettivi siano importanti e rappresentino ingredienti essenziali per il successo del capitalismo e della società. Lo so, lo so, sembrano le parole di un socialista: per questo ho chiamato in causa il discorso di Adam Smith, il portabandiera del capitalismo e del libero mercato. Perfino Wen Jiabao, il primo ministro cinese, nel mezzo della crisi finanziaria globale ha preso in giro gli occidentali dicendo che gli piace portarsi appresso il libro meno
conosciuto di Adam Smith, La teoria dei sentimenti morali, per sottolineare che ne sapeva più di noi sulla presunta morale occidentale e su quanto essa sia fondamentale nelle società capitalistiche. Non avrei mai pensato di parlare come un premier cinese, ma suppongo che dovrò farci l’abitudine. La Buona Italia, infatti, ha proprio qui il suo fondamento: nei sentimenti morali, nella solidarietà, ma anche nello spirito di apertura, nel desiderio di progresso e di modernità: della «ricchezza delle nazioni» per dirla ancora con Adam Smith, non solo di quella dei singoli individui o gruppi. A me sembra che questa Buona Italia, nel corso dei secoli, si sia battuta a più riprese contro il cancro della Mala Italia, cercando di sventare i tentativi di quest’ultimo di erodere l’eccellenza, la qualità, il merito, la giustizia, l’equità, la verità stessa. Se avesse fallito, l’Italia non esisterebbe. Così ho deciso di mettermi alla ricerca della Buona Italia e di vedere che cosa si poteva fare per rafforzarla. La mia fiducia nel successo dell’impresa è aumentata sempre di più, man mano che incontravo i giovani e parlavo con loro. Ho scoperto che hanno una mentalità aperta, un atteggiamento positivo, che sono aperti al mondo e impegnati a cambiare le cose in meglio. Un certo numero di queste persone e di questi modelli positivi compariranno in questo libro, compresi Addiopizzo e Ammazzateci Tutti, due eccellenti organizzazioni antimafia fondate dai giovani, rispettivamente a Palermo e a Reggio Calabria. Ci sono poi gruppi d’imprenditori, think tank, e diversi gruppi formati da giovani parlamentari. Ma sopra tutti
quelli che ho incontrato, e che hanno ispirato la mia fiducia in controtendenza, si stagliano i giovani organizzatori e membri di RENA, la Rete per l’eccellenza nazionale, attivi a Roma, Torino, Bari, Padova... di fatto in tutto il Paese. RENA è una associazione assolutamente moderna, fatta di persone collegate tra loro in pratica attraverso internet e i convegni, ma concettualmente da un obiettivo condiviso e da una serie di valori comuni. La rete, nata da poco, è composta da più di cento giovani professionisti. Per «giovani», va detto per inciso, intendo persone tra i venticinque e i quarantacinque anni, tipi brillanti e pieni di energia capaci di far sentire questo cinquantaquattrenne un po’ vecchio e posato. Lavorano nelle aziende, nelle università, nel governo, nei think tank o in proprio; la maggior parte in Italia, ma alcuni anche all’estero. Il loro obiettivo comune è semplice: rendere l’Italia migliore, diffondendo le cosiddette best practice, le «migliori pratiche», in diversi campi. I valori che condividono sono la meritocrazia, l’opportunità e la democrazia. Ma quello più importante, dal mio punto di vista, è l’entusiasmo, ed è contagioso. Il loro è un piccolo gruppo, con risorse limitate. Ma a Palermo alla «Fiera Addiopizzo» che sono andato a visitare, c’era uno striscione che diceva: L’UOMO CHE SPOSTA LE MONTAGNE, INIZIA DAI SASSOLINI. Con mia grande gioia i membri di RENA mi hanno adottato come uno dei loro «sassolini». Con rapidità e grinta hanno
messo insieme una task force per aiutarmi a trovare esempi positivi, di persone, aziende, università, amministrazioni comunali e altre organizzazioni che poteva essermi utile incontrare. E poi, attraverso la loro rete di associati in tutta Italia, mi hanno aiutato a farlo. A volte mi hanno perfino scortato, guidando per centinaia di chilometri, nutrendomi con ottimo cibo, ottimo vino e ottime idee, e contagiandomi ancora di più con il loro entusiasmo. Spesso si osserva che l’Italia è una creatura economica e politica in teoria incapace di volare, ma che, infrangendo ogni legge dell’aerodinamica, alla fine ci riesce. Un po’ come un bombo. E poi ci si arrovella a cercare di capire come fa. Penso che l’analogia non sia corretta. Riflette l’errata opinione che esista un modello standard per il successo dell’economia e della società, una formula che tutti devono seguire. Ma basta un breve sguardo al mondo per capire che in realtà non è così o lo è molto poco: Francia e America, Giappone e Gran Bretagna, Italia e Cina sono Paesi molto diversi tra loro, eppure, nonostante le differenze, sono riusciti tutti a raggiungere un livello elevato di progresso. È proprio il Giappone il Paese che per primo mi ha orientato a pensare alle economie e alle società nei termini di una lotta tra il bene e il male. Quando il Giappone era in pieno boom, negli anni Ottanta, e attirava su di sé il tipo di attenzione adulatoria che oggi si riversa sulla Cina, erano in molti a ipotizzare che, dato che per quel Paese tutto andava così bene, ogni cosa che faceva doveva essere per forza buona, anche se sfuggiva a ogni spiegazione razionale. Si
diceva che comportarsi in modo inspiegabile era parte dell’eterno mistero dell’Oriente, dell’imperscrutabile natura del Giappone. Poi, quando con gli anni Novanta giunsero il crollo finanziario e la stagnazione, questo ragionamento cominciò a vacillare trasformandosi nell’opinione ampiamente diffusa che in Giappone doveva essere diventato tutto cattivo, tutto negativo. Eppure il Paese non si era trasformato dall’oggi al domani. In realtà, era cambiato l’equilibrio, il rapporto tra buono e cattivo, tra positivo e negativo. Il potere degli interessi acquisiti, il peso della corruzione, il fardello della politica, l’importanza delle industrie protette e non competitive erano aumentati, facendo pendere l’ago della bilancia a sfavore delle forze positive che prima avevano avuto la meglio. Il compito era riportare l’ago della bilancia nella posizione precedente, non cambiare il Paese da capo a piedi. Lo stesso succede in Italia. Questo Paese è diventato uno dei più ricchi del mondo, uno dei più grandi del mondo, grazie al successo della Buona Italia sul peso morto, sul fardello della Mala Italia, specialmente negli anni Cinquanta, Sessanta e Settanta. Il motivo per cui l’Italia vola, e non si schianta tragicamente al suolo, è che la sua parte buona le impedisce di farlo, reagendo a quella cattiva, ricacciandola indietro. Talvolta, in effetti, appena in tempo. Potrebbe farlo ancora. Se lo si vuole abbastanza.
Puoi anche leggere