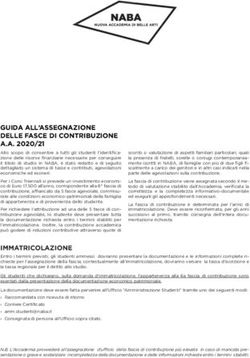Eclissi della famiglia: nuovi modelli
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
da: “The Lion ” n. 2 – 1986 pag. 12
Osvaldo de Tullio
Eclissi della famiglia: nuovi modelli
Per capirci bene occorre delimitare il campo della nostra indagine e
chiarire che cosa intendiamo per “famiglia” in questa nostra chiacchierata.
Questo perché, come tutti sanno, per famiglia può intendersi sia la coppia,
sia il gruppo coniugale ristretto (padre, madre, figlio), sia la comunità
familiare tradizionale comprendente ascendenti e discendenti ed anche
subordinati conviventi, e tante altre cose, anche al di fuori della convivenza,
fino al “lignaggio”, al clan, etc. E’ evidente il nostro riferimento al gruppo
coniugale ristretto, inteso come luogo privilegiato in cui si trovano riuniti
procreazione, sessualità ed amore, in cui il rapporto uomo-donna e adulto-
fanciullo è istituzionalizzato, in cui i ruoli di ciascuno sono definiti dal
costume sociale e dall’ordinamento.
Questo tipo di famiglia è anche il luogo che privilegia le importanti
funzioni di socializzazione dei figli, di unità economica, di trasmissione
delle tradizioni, di riproduzione della società, di reciproca assistenza morale
e materiale, di educazione dei giovani e, se si vuole, contiene il primo
nucleo del principio di coerenza e di autorità. Sarà a tutti evidente la
differenza che intercorre - da sempre, non da oggi - fra il modello
istituzionale della famiglia che assegna posizioni, compiti e funzioni ai suoi
membri e che questi immagina e definisce come attori vivi del rapporto
procreazione, sessualità ed amore e la realtà vera dei rapporti vissuti
nell’ambito familiare nella sua quotidianità.
Molto spesso lo spaccato familiare non ci offre, nella realtà,
procreazione, sessualità e amore o ci offre soltanto qualcosa o a volte nulla
di tutto questo.
Ma penso che non a queste famiglie si riferisca il tema che i Lions
italiani hanno posto durante quest’anno alla attenzione della opinione
pubblica, coscienti della importanza non delle eccezioni alla regola ma del
fatto che le regole potrebbero stare per cambiare.
347In tal caso occorre chiedersi se è bene che cambino e se veramente
debbano cambiare ed occorre scrutare le ragioni del cambiamento.
E questo - cioè accertare che cosa sia veramente e definitivamente
cambiato e sottolineo “definitivamente” - è molto importante anche per non
confondere fenomeni transeunti o mode con asseriti mutamenti della natura
umana che, poi, sarebbe molto poco natura se cambiasse così facilmente.
Occorre poi guardarsi dalle mistificazioni e dalle strumentalizzazioni
che, talora anche in buona fede, vengono operate da certe ideologie secondo
le quali ordine è sinonimo di oppressione, autorità di autoritarismo o di
dittatura, e che hanno la responsabilità di una illogica, ingiusta ed
improduttiva esasperazione del principio di uguaglianza, fatto coincidere
tout court con la negatività dell’egalitarismo.
Il che non significa che mutamenti seri ed effettive cadute di valori non
si siano verificate, che certi falsi miti (tutte le civiltà li hanno) non siano
stati infranti, che alcuni idoli siano andati distrutti (ma quanti ne abbiamo
ancora? Comunque non sostituiamo idolo con idolo).
Ecco, è qui, di fronte a questi valori distrutti ed ai nuovi equilibri
emergenti, che bisogna fermarsi a meditare e predisporre, meglio, direi,
disciplinare il fervido magma della realtà sociale che, abbandonato al
disordinato prorompersi degli istinti, potrebbe produrre danni e che ha
invece bisogno dell’intervento razionalizzante dell’uomo per essere
condotto a feconde conclusioni ed a nuovi utili assetti.
Ebbene quali sono questi nuovi elementi caratteristici dell’attuale stadio
di civiltà che possono indurci a previsioni per il medio periodo?
L’istituto della famiglia nucleare (padre, madre e figlio) sta oggi
subendo l’attacco di alcuni fattori innovativi che hanno fortemente incrinato
la monoliticità (teorica, naturalmente!).
Credo si possa dire senza tema di falsi orgogli che noi lions siamo
particolarmente idonei agli interventi razionalizzanti necessari per percepire
il fenomeno della (asserita) crisi della famiglia (vedremo dopo perché parlo
di crisi asserita) per indicare le linee di una risposta di questo istituto di cui
veramente non vedo come la società possa fare a meno (almeno per quanto è
dato ritenere ad uomini della nostra civiltà e col nostro bagaglio culturale).
348Perché particolarmente idonei, direte voi! Non ci sono altre ideologie,
culture, filosofie, politiche, sociologie atte a risolvere questo tipo di
problemi? Certo che ci sono! Ma lo risolverebbero, mi sia consentito dire, di
certo - e non potrebbe essere diversamente - sulla base di pregiudiziali di
principio che impedirebbero una soluzione serena che tenga conto di tutti i
valori ma a nessuno dia prevalenza oltre il consentito. Ad esempio, una
soluzione di tipo marxista certamente privilegerebbe certi contenuti a danno
di altri. Così una visione oltranzista cattolica potrebbe rischiare di
disconoscere - o non riconoscere sufficientemente - alcuni valori emergenti
nella società di oggi. Noi lions non abbiamo alcuna pretesa ma possediamo
il privilegio di non essere una “ideologia”. Abbiamo le nostre idee che,
combinate insieme ed applicate al vivere sociale, possono costituire una
“ideologia”; ma il nostro modo di essere è ancorato alla realtà dei problemi
quotidiani dei quali prospettiamo soluzioni giuste e possibili, giuste nella
loro effettività e non in teoria soltanto.
Il terreno comune è costituito dal pragmatismo di certe soluzioni e di
certe indicazioni: una giustizia giusta, sollecita ed eseguibile, uno Stato
ordinato, la salvaguardia della personalità umana, la correttezza dei
rapporti intersoggettivi, la lealtà, l’amore per il proprio simile ed il ripudio
della forza e della violenza non hanno bisogno di aggettivazioni. Sono valori
esterni e possono - dovrebbero - essere comuni a tutti.
Vediamo allora quali novità ci hanno portato gli anni che andiamo
vivendo e quali ripercussioni essi hanno avuto sull’istituto della famiglia.
Fortemente caratteristico della nostra epoca è quel tipo di civiltà che
ellitticamente viene definito civiltà dei consumi. Voi sapete tutti di che cosa
si tratta, sapete anche che, del tutto anacronisticamente, essa viene anche
definita civiltà del benessere, laddove per benessere si intende solo quello
fisico (e nemmeno, visti i grandi danni che al nostro corpo produce: da
stress, da inquinamento, etc.). E’ quella civiltà che ci riempie di macchine
oltre ogni dire, fino al punto di rischiare di diventare macchine noi stessi.
Effetto (o presupposto) di questa civiltà è l’amore sconfinato per il
danaro (o per il potere; sono due aspetti di un fenomeno unico che
sostituisce ogni altro sentimento).
349Al servizio di questo, un vivere quotidiano colmo di egoismo e di
violenza! Cioè l’esatto contrario di quanto avviene nell’istituto familiare
che, sotto ogni latitudine ed in ogni tempo, credo sia stato caratterizzato dai
principi dell’amore e dell’altruismo.
Io non voglio astrarmi nella pura teoria né penso che sempre e
veramente nelle famiglie abbia prevalso l’amore e l’altruismo. So bene che
l’egoismo e la violenza, per quanto condannati e messi al bando, albergano
da sempre nell’animo umano e che il modello dell’uomo buono è rimasto un
modello teorico, salvo poche eccezioni.
Ma, detto questo, (e sarebbe ora che la Chiesa ci dicesse qualcosa di più
consolante su questa forbice costituita dal divario fra lo schema teorico
dell’uomo e la realtà da sempre divergente, mai venuta meno; ma ce lo dica
in termini umani, non facendo appello alla fede che non può convincere chi
non l’ha) detto questo, dicevo, bisogna pur riconoscere che il fenomeno ha
assunto oggi dimensioni allarmanti, proprio perché esso è andato a colpire
in nuce anche l’istituto familiare dove un tempo l’individuo, cattivo in
società, si ritrovava più buono, a coltivare certi sentimenti che l’ambiente
esterno non gli consentiva facilmente. Questo deterioramento dovuto alla
civiltà dei benessere, conseguenza dello incattivirsi dell’uomo e dei rapporti
sociali, non so come possa essere rimediato. Esso assume dimensioni
veramente planetarie e non è agevole scorgere quando e come le cose
avranno a migliorare. Che miglioreranno è certo, ma questo è solo un atto di
fiducia nell’Umanità che non si è perduta nel corso di tanti secoli e che ha in
sé i germi di tutte le reazioni.
Un secondo dato negativo per l’istituzione familiare è costituito dallo
scossone che il principio di autorità ha subito nel corso di questi anni. Il
feticcio del capo, l’autorità del padre, l’imperatività delle sue soluzioni
nell’ambito familiare non potevano non essere sommerse dall’ondata di
egalitarismo che si abbatteva sulla intera società.
E come sulla società l’eccesso contestativo produceva grandi danni,
altrettanti ne arrecava nell’ambito familiare. Consentitemi di dire a questo
punto che questi danni, se non fossero stati eccessivi, sarebbero stati i
benvenuti, in quanto non mi par dubbio che la società familiare fosse prima
d’oggi caratterizzata da un eccessivo dogmatismo delle soluzioni sempre
350autoritativamente imposte al di fuori di ogni ricerca di consenso. In sostanza
la contestazione dell’autorità del “pater familias” mi è sembrata soprattutto
una forma di non infondata reazione agli eccessi precedenti.
E penso che questa ventata di egalitarismo e di apertura abbattutasi
sull’istituto familiare avrà presto, ridotta alle accettabili dimensioni che
mossero la protesta, effetti non negativi, se depurati dalle eccessività del
momento strettamente contestativo. In definitiva penso che nell’ambiente
familiare si potrà realizzare la migliore espressione del rapporto di
uguaglianza-autorità o libertà-autorità, che tanta difficoltà di definizione
incontra nella vita pubblica.
E veniamo ora alle note più dolenti. Parlo della emancipazione, della
nuova dignità, della uguaglianza - come talora viene chiamato il fenomeno -
della donna.
Più rettamente io direi dell’affrancamento della donna, laddove con
questa espressione si vuole evidenziare la liberazione della donna da un
peso ingiusto che la gravava da tempo immemorabile.
Che la donna avesse diritto a questo affrancamento, che esso sia stato
oltre misura ritardato, che la donna sia perfettamente pari (e non uguale,
direi) all’uomo e che non possano essere contestati quei diritti che sono
espressione dell’essere una creatura umana così come l’altro sesso, questo
non può essere messo in dubbio.
E nemmeno può dubitarsi che le riforme legislative non bastano;
occorre infatti che esse penetrino nel costume sociale, divengano patrimonio
di tutti e vengano realizzate nella quotidianità delle vicende.
Se, perciò, noi evidenziamo alcune conseguenze che questo processo di
affrancamento ha prodotto nell’ambito familiare è perché dobbiamo
prendere atto di certe realtà ed identificare tutte le cause dei problemi perché
la loro conoscenza giova alle soluzioni.
L’inserimento della donna nel mondo del lavoro, della politica, etc.
diciamo nel mondo esterno alla famiglia, non ha prodotto conseguenze
consistenti solo in un numero minore di ore a questa dedicate. La nuova
realtà significa soprattutto un notevole cambiamento nella mentalità della
donna ed una interversione nelle sue abitudini di vita; e, quindi, direi anche
più frequenti occasioni di incitamento di quei sentimenti e comportamenti
351che sono alla base della vita familiare tradizionale: l’amore, la dedizione, la
procreazione, la sessualità verso il proprio coniuge, l’educazione dei figli.
Non intendo esprimere un giudizio su tutto ciò. So bene che c’è chi
pensa, ed io fra questi, che certe cose non potevano rimanere ancora
retaggio del solo uomo, e che nella divisione dei compiti occorreva
maggiore equilibrio fra le parti (come è brutto dire “parti” a proposito dei
coniugi!). Una disamina completa ed obiettiva della situazione comporta la
necessità di registrare questi mutamenti e noi li registriamo.
Il panorama non sarebbe completo se dimenticassimo la più grande
novità legislativa intervenuta in materia in Italia in questi ultimi anni
(insieme all’aborto): il divorzio.
E’ pacifico che questo rappresenta un attacco alla famiglia-istituzione
in quanto elimina la indissolubilità. Ma non mi sentirei di affermare che
esso abbia arrecato gran danno alla famiglia intesa come comunità di affetti
e di interessi. In molti casi la forma istituzionale copriva una comunità di
vita da tempo in frantumi. Il divorzio è comunque un segno della diversa
considerazione in cui, sotto la spinta degli eventi, queste cose sono viste
dalla società d’oggi.
E’ significativo in proposito l’atteggiamento a suo tempo assunto dal
partito che rappresenta il maggior numero di cattolici italiani.
Conclusioni? Difficile trarne! E poi, le conclusioni in ordine alle vie
nuove da intraprendere sono praticamente nelle critiche fatte!
In ogni caso vorrei qui sinteticamente dire alcune proposizioni che mi
sembrano fondamentali.
In primo luogo non abuserei del termine crisi, che talora si va formando
dalla attuale situazione della famiglia. Più esattamente il nostro tema parla
di eclissi.
Troppo facilmente si scambiano per crisi quelle fisiologiche e
necessarie trasformazioni che avvengono negli uomini, nelle società, nelle
istituzioni. Importante è che queste trasformazioni costituiscano evoluzione
e non regresso, progresso e non involuzione.
In una materia così delicata come quella dell’istituzione familiare
occorre, più che in altre, andar cauti con la proposizione di nuovi modelli,
specie in sede legislativa. Le innovazioni si producono in genere molto
352lentamente, maturando e filtrandosi attraverso la sensibilità della gente.
Sono le esigenze quotidiane ad imporre adattamenti ed innovazioni. Quel
che è facile prevedere è che la nuova coppia vivrà secondo un modello
sostanzialmente paritario, dove compiti e responsabilità saranno suddivisi
nella struttura familiare con criteri nuovi, sfruttando, occorre augurarsi, le
vocazioni attitudinali dei partners: in linea generale l’uomo vivrà di più
dentro la famiglia, la donna di più fuori della famiglia. E’ proprio un gran
male, questo? Visto oggi con gli occhi della nostra millenaria tradizione,
certo. Ma non può escludersi la possibilità di nuovi equilibri
sufficientemente stabili e giusti.
Questo non vuol dire che non ci sia un limite alla ricerca degli asseriti
nuovi modelli. L’istituto familiare deve assolvere le sue insopprimibili
funzioni di educazione e socializzazione dei figli, di riproduzione della
società, di reciproco amore ed assistenza morale e materiale.
Se questo venisse a mancare, non di nuovo modello della famiglia si
tratterebbe, ma di altre forme di convivenza, di comune o altro, che nulla
hanno a che fare con la prima.
Io penso che l’istituzione familiare sia destinata a sopravvivere senza
grosse novità che ne alterino profondamente la natura.
Di certo la struttura interna subirà modifiche: irreversibili (in quel
tempo medio per cui è consentito a noi fare previsioni) quelle connesse
all’affrancamento della donna, più revocabili quelle conseguenti alla
cosiddetta civiltà del benessere ed al nuovo rapporto uguaglianza-autorità.
Un aspetto particolare è costituito dalle convivenze non formalizzate
che certo famiglie non sono e che possono al massimo considerarsi para-
famiglie, quando in esse si riscontrano quasi tutti gli elementi sostanziali
della famiglia, salvo il riconoscimento formale.
Non siamo in possesso di dati sufficienti per esprimere un giudizio sulle
conseguenze future di tali convivenze. Certo esse contribuiranno, al pari del
divorzio, alla diffusione del fenomeno della famiglia monogenitore.
Comunque non sono oggi molte: l’1,3% di tutte le coppie.
Conclusivamente direi che il pericolo vero che corre la istituzione
familiare è nella dispersione di quei valori di cui essa è sempre stata riflesso
istituzionalizzato, custode e depositario.
353Pertanto non mi spiegherei una crociata a favore della famiglia che non
sia contemporaneamente, anzi soprattutto e prima di ogni altra cosa, una
crociata a favore del miglioramento della qualità della vita dei singoli
soggetti che nella famiglia confluiscono e convivono. Le possibilità di
sopravvivenza sarebbero scarse in un mondo che fosse dominato dagli istinti
più bassi, dalla sopraffazione, dal danaro e dalla ambizione del potere ed in
cui non si riconoscesse la primazia dell’amore, del rispetto della dignità
umana, della giustizia, del pacifico componimento delle controversie. Questi
valori vanno ad ogni costo salvati. Solo a queste condizioni il nostro istituto
familiare, quello che sentiamo dentro di noi anche se riusciamo male a
spiegarlo e che ancora vogliamo, riuscirà a sopravvivere purché
modernizzato nelle sue strutture interne ed adeguate ai tempi.
354Puoi anche leggere