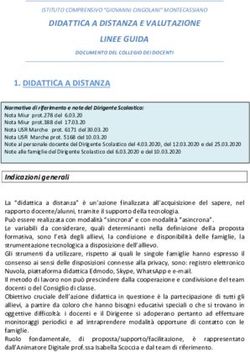Facebook e la strategia del pusher
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Facebook e la strategia del pusher Nell’autunno 2015, improvvisamente, le principali testate online scoprirono che Facebook le aveva abbandonate: da gennaio a ottobre, il traffico proveniente dal social network era crollato del 32%; percentuale che saliva fino al 42% nel caso dei dieci siti più importanti e che poteva raggiungere anche punte del 60% (come ha scoperto, suo malgrado, l’Huffington Post). Non era un incidente di percorso: la situazione ha continuato a peggiorare per tutto il 2016. Un colpo tremendo per l’editoria online, che tra mille difficoltà si sostenta principalmente a colpi di click (conquistati in larghissima parte su Google e Facebook) e che si era abituata a fare affidamento sul traffico costante garantito dal social network, per assicurarsi il quale, al limite, era sufficiente un investimento iniziale più o meno oneroso per conquistare una massa critica di like attraverso la promozione della pagina. Il resto sarebbe venuto da sé. Forse non era la soluzione a tutti i problemi, ma di sicuro era uno dei più grandi aiuti che potessero venire: Facebook consentiva di scovare con estrema facilità i propri lettori e di conquistare un numero di click sufficienti a sostenere la macchina editoriale (o quantomeno ad arginare le perdite). Un modello che, come noto, ha causato anche la nascita di numerose testate (spesso, ma non necessariamente, di bassa qualità e con la missione di diffondere pezzi “virali a tutti i costi”) che seguivano la strada Facebook-only. Chi, nel frattempo, osservava da lontano e con soddisfazione questa dinamica era Mark Zuckerberg, i cui piani, come si sarebbe appunto scoperto nel corso del 2015, erano chiari: rendere il mondo dell’editoria dipendente da Facebook per poi costringerlo a pagare, attraverso gli articoli “sponsorizzati”, per ottenere quel traffico che prima si poteva avere gratis (o quasi). Volendo, la si potrebbe definire la “strategia del pusher”. Con il senno di poi, non sarebbe stato difficile capire che qualcosa non quadrava: perché mai Facebook avrebbe dovuto dare così tanta visibilità a contenuti che portavano l’utente fuori dai recinti del social network? In effetti, la prima àncora di salvezza – lanciata nel maggio 2015 a editori in preda al panico – mirava
proprio a impedire che gli utenti lasciassero Facebook per visitare altri siti: Instant Articles, uno strumento che permette di leggere gli articoli direttamente all’interno della piattaforma mobile di Facebook. In questo modo, il social network si assicurava che nessuno uscisse dal suo “walled garden”, offrendo in cambio una velocità di caricamento istantanea e una visibilità maggiore rispetto agli articoli “non Instant” (Facebook ha però sempre negato di favorire la reach degli Instant Articles, spiegando che questa era semmai causata dalla maggiore predisposizione degli utenti a cliccarli e condividerli). Poteva sembrare un buon compromesso: certo, le testate rischiavano di trasformarsi in semplici produttori di contenuti, distribuiti e gestiti da Facebook, e avrebbero visto sempre meno persone uscire dal social network per scoprire il loro sito internet, ma in cambio le tanto agognate visualizzazioni – e i conseguenti introiti pubblicitari – sarebbero state garantite. Oppure no? In verità, pochi mesi dopo il lancio di Instant Articles divenne non solo sempre più chiaro il tributo da pagare alla nuova tecnologia di Facebook (minori visite al sito e, di conseguenza, minore fidelizzazione dei lettori), ma anche che le enormi speranze in essa riposte erano in larga parte vane: le ultime modifiche dell’algoritmo (risalenti ormai a più di sei mesi fa) avrebbero infatti ulteriormente penalizzato tutti gli articoli pubblicati su Facebook, “Instant” compresi. Ma ogni volta che qualcosa va storto, Facebook si premura di offrire nuove speranze di salvezza agli editori. Così, ecco che una nuova esca iniziò a farsi largo: i video. Per il social network era talmente importante che le principali testate lo seguissero in questa nuova terra promessa, che Mark Zuckerberg si decise a pagare le riviste online affinché producessero video da pubblicare su Facebook. I contratti annuali, siglati a gennaio 2016, vedevano in prima linea testate come BuzzFeed (3,1 milioni di euro come incentivo), il New York Times (3 milioni), la CNN (2,5 milioni), l’Huffington Post (1,6) e via via tutti gli altri. I più importanti siti al mondo hanno quindi ricevuto parecchi soldi (l’investimento complessivo di Facebook è stato superiore ai 50 milioni di euro) per creare video che garantivano inoltre un’immensa visibilità: il sogno era divenuto di nuovo realtà. Ovviamente, il risveglio fu di quelli bruschi: prima scoppiò la polemica (nel settembre 2016) su quanto i dati forniti da Facebook fossero gonfiati (bastava guardare un video per tre secondi per far risultare una visualizzazione, suscitando l’ira dei pubblicitari che avevano investito nei video sponsorizzati); poi venne fuori che – a parità di numero di video pubblicati – le visualizzazioni si erano dimezzate nel giro di sei mesi, e infine l’amara scoperta che Zuckerberg non avrebbe rinnovato i contratti con gli editori attraverso i quali pagava BuzzFeed e gli altri per la produzione di video (invitandoli però a produrne di più lunghi, in modo da approfittare della nuova speranza offerta: la pubblicità che compare nel bel mezzo dei video). Quindi, tirando le somme: conquistare traffico da Facebook attraverso link che portano al proprio sito è ormai speranza vana anche per pagine da centinaia di migliaia di like; Instant Articles porta qualche vantaggio (a caro prezzo) ma non cambia lo scenario complessivo; i video dovrebbero essere l’ultima frontiera, ma le visualizzazioni stanno già crollando prima ancora che gli editori abbiano capito davvero come guadagnarci. Ma dal momento che, col passare degli anni, la dipendenza da Facebook è diventata così forte che nessuno è in grado di farne a meno (e spesso, per ragioni oscure, si snobbano le enormi potenzialità offerte da Google), una sola strada è rimasta aperta per conquistare il tanto agognato traffico: arrendersi a Zuckerberg e pagare moneta sonante. Ogni volta che vedete un articolo su Facebook in cima al quale compare la dicitura “sponsorizzato”,
significa che l’editore ha pagato per far sì che quel pezzo riuscisse ad avere un po’ di visibilità. Le strategie, in questo, possono variare: a parità di budget, c’è chi sponsorizza ogni contenuto che pubblica, chi decide di privilegiare i contenuti più forti o più viralizzabili, chi utilizza questo strumento solo per un periodo di lancio allo scopo di raggiungere una massa critica di like (opzione sempre meno remunerativa, proprio per le modifiche di cui abbiamo parlato). Ma è sufficiente sponsorizzare un post per conquistare un buon numero di visite? “Ovviamente no, sarebbe come pensare che, se scrivo un libro, far vedere la copertina a un ampio numero di persone basti a farlo diventare un best-seller”, spiega Alberto Puliafito, autore di DCM – Dal giornalismo al digital content management e direttore di Slow News. “Ci vogliono contenuti che interessino realmente il pubblico di riferimento e che facciano interagire le persone; senza, non si va da nessuna parte. Serve poi un piano editoriale che sia in grado di sfruttare al meglio i contenuti prodotti per il proprio sito e che li declini in maniera ‘social’, in modo che si possano sfruttare le opportunità concesse dall’algoritmo di Facebook, che però varia in continuazione”. Inoltre, ci si dovrebbe sempre chiedere a cosa servono queste visualizzazioni conquistate a caro prezzo: “È importante definire con chiarezza gli obiettivi. Una campagna su Facebook condotta al solo scopo di avere qualche click in più rischia di essere una visione di brevissimo periodo ed è una delle concause del peggioramento dell’ecosistema dell’editoria italiana. Le sponsorizzazioni su Facebook dovrebbero sempre essere parte di una strategia integrata”. E poi, c’è la questione dei soldi. Quanto costa ogni singolo click che si conquista? La risposta, ovviamente, non è univoca: perché le modalità di promozione sono numerose e le incognite parecchie. Secondo alcune stime, comunque, per conquistare 1000 visualizzazioni servono dai 70 ai 170 euro; alcuni numeri che ho avuto recentemente modo di visionare erano decisamente migliori: per ottenere mille visualizzazioni l’investimento andava dai 50 agli 80 euro. Ma l’investimento non deve per forza essere valutato da un punto di vista quantitativo: “In alcuni casi si possono spendere anche decine di euro per ogni singolo click, ma se sono contatti molto qualificati e preziosi non significa necessariamente che quei soldi siano stati spesi male”, prosegue Puliafito. Sul versante opposto – quella della quantità a tutti i costi – ci sarebbe da soffermarsi sul paradosso di testate giornalistiche che spendono in pubblicità su Facebook al solo scopo di vendere altra pubblicità (quella presente sul loro sito) a un prezzo leggermente superiore; senza peraltro avere nessuna garanzia che questo modello di business (sempre che così lo si possa chiamare) resista nel tempo. “La storia dimostra che le condizioni, quando dipendono dalla fantasia del momento delle cosiddette Over the Top (di cui Facebook fa parte) possono cambiare in qualsiasi istante e senza preavviso”, prosegue Puliafito. “Quindi, meglio non fare affidamento su un solo vettore di traffico o monetizzazione o promozione. Facebook non regala nulla, è uno strumento da usare fra tanti. E mentre lo si usa è bene anche pianificare l’exit strategy”. C’è un modo allora per resistere a questa dinamica e conquistare visibilità su Facebook senza essere costretti a pagare? E quali sono le strade per uscire dalla gabbia non più dorata del social network e trovare qualche alternativa (peraltro a prova di click-bait, fake news e quant’altro), magari anche più sostenibile? Al di là della necessità di coinvolgere sempre di più i profili social dei redattori della testata al fine di promuovere un contenuto, è evidente che – come spiegato su Medium da Gabriel Stein – un ruolo sempre più importante lo giocheranno le pagine pubbliche dei giornalisti o delle personalità più note. La ragione è semplice: nel tentativo di sottrarre a Twitter i VIP (che continuano a prediligere il social network dei 140 caratteri), Facebook garantisce a queste fanpage un’ottima reach,
rendendole potenzialmente delle grosse fonti di traffico. Per questa ragione, quando un articolo viene scritto da una firma nota, quando viene intervistata una celebrità, quando in un articolo vengono citati personaggi famosi, spesso e volentieri ci si affida proprio a loro per la diffusione del pezzo. Il problema, però, è che solo una piccolissima parte dei giornalisti ha una notorietà tale da poter veicolare in maniera efficace gli articoli. E questo anche a causa delle strategie social, che spesso e volentieri non contemplano la promozione dei giornalisti stessi, impedendo così loro di diventare un significativo veicolo di diffusione dei contenuti. E pensare che gli strumenti per promuovere i giornalisti e instaurare un circolo virtuoso non solo esistono, ma vivono proprio su Facebook e non necessitano nemmeno di nessuno sforzo per venire implementati. Il riferimento, per fare un esempio, è all’Author Tag: un plug-in che fa comparire nel lancio del pezzo su Facebook il link al profilo dell’autore dell’articolo. Da lì, si può decidere di seguirlo, cliccando il tasto follow, o di visitarne il profilo, garantendo al giornalista una maggiore visibilità che lui potrà sfruttare, a sua volta, per diventare un veicolo sempre più importante di diffusione dei contenuti. Tutte queste strategie, più o meno funzionali, fanno però riferimento a un mondo dell’informazione che vive solo all’interno di Facebook e che, di conseguenza, dipende eccessivamente dall’umore con cui Zuckerberg si alza dal letto. È possibile, allora, uscire da Facebook o almeno renderlo solo uno dei tanti strumenti necessari a conquistare l’attenzione dei lettori? Per restare ai casi più noti, i concetti chiave sono tre: newsletter, verticalità e personalizzazione. Per quanto riguarda le newsletter, è da tempo ormai che si sottolinea quanto queste possano essere uno strumento decisivo per conquistare l’attenzione di un certo tipo di pubblico e fidelizzare lettori che apprezzano una selezione personalizzata di notizie, recapitata nella casella email, piuttosto che essere costretti a navigare alla cieca nel marasma di Facebook. Che questo strumento stia attraendo sempre più attenzione, tra l’altro, lo dimostrano anche i numerosi casi italiani di successo, che vanno dalla newsletter “americana” di Francesco Costa (vicedirettore de Il Post), al già citato caso indipendente di Slow News, fino all’ultima nata in casa Corriere della Sera: Futura. Uscendo dai nostri confini, è noto come le 62 newsletter tematiche che ogni giorno il Washington Post spedisce per coprire anche gli interessi più di nicchia abbiano avuto un ruolo fondamentale nel ritrovato successo (anche economico) del quotidiano di Jeff Bezos. Il Washington Post sta così dimostrando che un sito generalista non è altro – o non dovrebbe essere altro – che un conglomerato di siti di nicchia. Lo dimostra, per restare agli esempi statunitensi, anche il New York Times, che attraverso il suo team NYT’s Beta sta trasformando alcune sezioni del giornale in veri e propri siti a parte. Si tratta in particolare di tre verticali: NYT Well (salute), NYT Cooking (cucina) e NYT Watching (spettacolo). Ampiamente autonomi, ognuno dotato della sua newsletter, diversi anche graficamente. Con un chiaro obiettivo: rendere la lettura online un’esperienza sempre più intima e personalizzata; riscoprendo un rapporto diretto con il lettore laddove troppo spesso, oggi, è Facebook a giocare la parte del leone (“L’ho letto su Facebook” è il nuovo “l’ha detto la TV”). Le possibili alternative non si esauriscono qui e nemmeno si sono affrontati i temi fondamentali del native advertising, del branded content o degli abbonamenti. Ma una cosa è evidente, nel momento in cui si smetterà di inseguire a tutti i costi una massa enorme di click con una bassissima resa in termini di introiti, per puntare a un numero di utenti inferiore, ma che, attraverso la personalizzazione e il coinvolgimento, dà in cambio una resa economica maggiore (anche solo perché le pubblicità targettizzate con attenzione rendono di più), il giornalismo ritroverà la ragione
stessa per tornare a puntare sulla qualità. E magari assisteremo anche – dopo la sbornia social che ha drogato e in buona parte rovinato il panorama giornalistico – al ritorno della homepage; intesa come l’abitudine, quasi da edicola, di selezionare e visitare con regolarità le proprie testate di riferimento; senza che siano i social network a dirci non solo cosa dobbiamo leggere o vedere, ma anche in quale formato e con quale frequenza. Immagine di copertina Mr. Thoms – Like a Vision
Puoi anche leggere