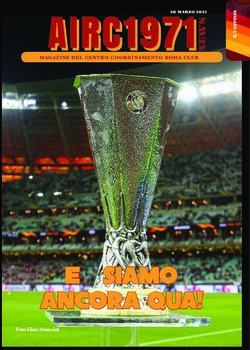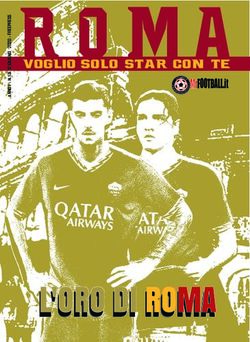Educare nel tempo della post-modernità - Giuseppe Savagnone
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Giuseppe Savagnone
Educare
nel tempo della
post-modernitàCollana LA SFIDA EDUCATIVA Giuseppe Savagnone - Alfio Briguglia, Il coraggio di educare Sandro Ferraroli, Educare si può Giuseppe Belotti - Salvatore Palazzo, Genitori, la sfida educativa Autori vari, Educare ai tempi di Internet Roberto Pasolini (a cura di Luigi Meani), Emergenza educazione Marianna Pacucci, Educare in famiglia Luciano Tallarico, Educare alla responsabilità Zbigniew Formella - Alessandro Ricci, Educare insieme Domenico Cravero, Organizzare la speranza Vito Orlando - Marianna Pacucci, La paura di volare Giuseppe Savagnone, Educare oggi alle virtù Alessandro Ricci, Famiglia tra risorse ed emergenza Marisa Musaio (cur.), Dentro la relazione educativa Guido Crocetti, I bambini vogliono la coppia Sandro Ferraroli, Educare si deve Giuseppe Savagnone, Educare nel tempo della post-modernità © 2013 Editrice ELLEDICI - 10142 Torino E-mail: mail@elledici.org ISBN 978-88-01-05370-8
Introduzione
Qualcuno la chiama «iper-moderna», qualcun altro «tardo-
moderna», altri ancora «post-moderna»: ma su una cosa quasi
tutti convergono, ed è che la cultura della nostra epoca presenta
alcune caratteristiche che non sono riducibili a quella di un pas-
sato, anche recente, che si soleva chiamare «moderna». E poiché
l’essere umano è un animale storico e culturale, identificato dai
suoi universi simbolici – entro cui acquistano significato, per lui,
le sue scelte e il suo stesso esistere –, tenere conto di questa tra-
sformazione è fondamentale per intercettarne i problemi, le rea-
zioni, gli interessi.
Questo è vero anche – e forse soprattutto – quando si affronta
il problema educativo. Non si può pensare di accompagnare i gio-
vani nel loro percorso di crescita se non se ne comprendono la
mentalità e l’approccio alla realtà. Eppure, proprio su questo pia-
no, si registrano oggi dei gravi ritardi da parte delle tradizionali
comunità educative – la famiglia, la scuola, la Chiesa. La cosid-
detta «emergenza educativa» non è tanto determinata da uno
scarso investimento di risorse materiali e umane, quanto dal fat-
to che queste risorse finiscono spesso per indirizzarsi a interlocu-
tori inesistenti, a ragazzi e ragazze che non «abitano più» là dove
ci si illude di raggiungerli. Così, molti dei «predicozzi» di genito-
ri, insegnanti, parroci o catechisti cadono nel vuoto, perché riflet-
tono un linguaggio, una sensibilità, dei modelli etici, che oggi so-
no assolutamente estranei ai loro destinatari.
Ai limiti degli educatori si aggiunge l’influenza di nuove agen-
zie comunicative – Tv, cellulari, Internet – che, a differenza di
quelle istituzionali, non sono comunitarie, o lo sono solo in senso
virtuale (gli «amici» di Facebook), ma che hanno, grazie alle nuove
tecnologie, una capacità di penetrazione immensamente supe-
riore. E questi nuovi strumenti di comunicazione non sono neu-
trali, come qualcuno crede, ma veicolano stili di pensiero e di
3comportamento che contribuiscono in modo decisivo alla tra-
sformazione culturale in atto. Non per nulla, per definire i ragaz-
zi di oggi, si parla di «nativi digitali»!
Educare nella post-modernità significa prendere atto di questa
situazione e affrontarla creativamente, invece di arroccarsi sulla
difensiva. La scelta è tra ignorare i nuovi codici simbolici, oppu-
re entrare fino in fondo in essi, cercando di capirli, per valutarli e
aiutare i propri figli, alunni, parrocchiani a utilizzarli corretta-
mente.
Questo libro è nato dalla convinzione che non abbia senso
chiudersi al nuovo, sottovalutandolo o, peggio ancora, demoniz-
zandolo. Credenti e non credenti possono trovarsi d’accordo con
i vescovi italiani quando, negli Orientamenti pastorali per il 2010-
2020, scrivono che si deve «prendere coscienza, insieme a tutti gli
educatori, di alcuni aspetti problematici della cultura contempo-
ranea (...) cercando di riconoscere anche in essi le domande ine-
spresse e le potenzialità nascoste, e di far leva sulle risorse offer-
te dalla cultura stessa» (Educare alla vita buona del Vangelo, n. 7).
Perciò, in queste pagine, si è preferita, alla categoria dell’«emer-
genza», che ha una connotazione prevalentemente negativa, quel-
la della «sfida», che indica una difficoltà da affrontare ma, al tem-
po stesso, un’opportunità da cogliere.
Ciò però suppone uno sforzo di pensiero che la grande mag-
gioranza degli educatori elude, anche perché li costringerebbe a
prendere coscienza delle loro stesse contraddizioni. Figli o nipo-
ti del Sessantotto, essi si trovano oggi a riproporre ai loro ragazzi
«punti fermi» che, da giovani, avevano contestato e di cui ora per-
cepiscono confusamente l’irrinunciabilità, senza però saperli giu-
stificare ed esserne fino in fondo convinti.
Ne viene fuori una perversa oscillazione tra il rigorismo di cer-
ti comportamenti repressivi e la sottile complicità di chi in fondo
resta legato a logiche sessantottine. Ne è un perfetto esempio, in
un film di successo – La notte prima degli esami (del 2006, anche se
ambientato nel 1989), di Fausto Brizzi – l’arcigno professor Mar-
tinelli (Giorgi Faletti), soprannominato dai propri alunni «la ca-
rogna», per la sua spietata rigidezza come docente.
Un suo alunno, Luca (Nicola Vaporidis), che lo detesta come
tutti i suoi compagni, si trova però quasi costretto a frequentarlo,
4prima per ricevere le ultime ripetizioni in vista degli esami di ma-
turità, poi perché è il padre della ragazza di cui è innamorato. Con
immenso stupore scoprirà che l’inflessibile, anziano insegnante
è in realtà un nostalgico delle trasgressioni più estreme del Ses-
santotto. Sarà lo stesso professor Martinelli che, dismessa la co-
razza dietro cui si nasconde, rievoca con patetico entusiasmo se-
nile le proprie esperienze di droga e di sesso selvaggi, spingen-
dosi fino a domandare a Luca di procurargli uno spinello, per
riassaporare il gusto degli antichi stili di vita «alternativi». Met-
tendo in imbarazzo lo studente, perché, come dice la sua voce
fuori campo, lui lo spinello lo aveva provato solo una volta in vi-
ta sua e si era pure sentito male!
La perplessità di Luca è quella di tanti ragazzi e ragazze che
percepiscono l’inconsistenza di messaggi educativi sclerotici (a
cui non credono, in fondo, neppure coloro che li proclamano), ma
che non si trovano a proprio agio neppure nel nulla etico che og-
gi sembra costituirne, di fatto, l’inevitabile alternativa.
Per un educatore fare i conti con la post-modernità significa
andare oltre questa perversa oscillazione, prendendo coscienza
delle trasformazioni in atto, valorizzandone le istanze positive e
al tempo stesso evidenziandone gli aspetti problematici e con-
traddittori, per elaborare un nuovo progetto educativo che inclu-
da le prime, purificandole però da quanto presentano di unilate-
rale. Perciò in ogni capitolo, dopo un paragrafo dedicato a trat-
teggiare i cambiamenti culturali in corso, ce ne sarà uno volto a
mostrare l’arricchimento che essi comportano rispetto al passato
(e questo è forse il passaggio più originale della riflessione!), se-
guito da un altro che, viceversa, insisterà sulle ombre e da uno
conclusivo che, infine, abbozzerà delle prospettive di sintesi in
chiave educativa.1
È appena il caso di dire che il nostro discorso non pretende di
essere esaustivo. Abbiamo solo cercato di individuare alcuni temi
– che peraltro si richiamano a vicenda, a volte sovrapponendosi –
1 Per un tentativo analogo nell’ambito dell’evangelizzazione, cf G. SAVA-
GNONE, Evangelizzare nella postmodernità. Istruzioni brevi per una navigazione a vista,
Elledici, Torino (Leumann) 1996 (seconda ristampa 2003).
5particolarmente significativi per evidenziare il passaggio dalla
cultura moderna a quella post-moderna. Ma sono aspetti di una
realtà più ampia e complessa, che altri potranno continuare ad
esplorare per conto proprio, magari, se lo vorranno, utilizzando il
metodo qui prospettato.
Soprattutto, però, va precisato subito che questo libro non è
un elenco di risposte da consultare per risolvere questa o quella
difficoltà pratica a cui si può andare incontro nel proprio ruolo di
educatori. Chi si aspetta delle «ricette» farà meglio a non perdere
il proprio tempo leggendolo. Ciò che abbiamo voluto offrire è una
panoramica dei problemi nuovi che si pongono nell’attuale con-
testo culturale e di cui spesso non si è chiaramente consapevoli,
additando alcune prospettive di fondo, alternative alla prassi
educativa vigente, per cercare di affrontarli adeguatamente. Non
ci proponevamo – né saremmo stati in grado di farlo – di dare so-
luzioni, ma solo di aiutare a cercarle.
Un’ultima considerazione riguarda un altro limite di questo
libro – che poi è proprio di ogni libro e, più in generale, di ogni
tentativo di trasmissione del proprio pensiero. Rivolto ai suoi di-
scepoli, il Profeta di Gibran diceva: «Nessuno può insegnarvi nul-
la, se non ciò che in dormiveglia giace nell’erba della vostra co-
noscenza (...). E se egli è saggio non vi invita a entrare nella casa
della sua scienza, ma vi conduce alla soglia della vostra mente»
(Gibran 1983, p. 97). Negli anni, dopo tanti messaggi lanciati per-
ché perforassero le corazze dell’indifferenza, ci si rende conto che
a poter veramente colpire l’interlocutore sono solo quelli che
oscuramente già premevano nella sua anima per vedere la luce e
che, nelle parole dell’altro, trovano finalmente una forma. Chi non
è in alcun modo aperto a quanto si cerca di esprimere in queste
pagine, le troverà astratte e noiose. Chi le accosterà senza nulla
cercare, non vi troverà nulla. Chi, invece, le metterà in relazione
con le proprie esperienze e le utilizzerà per capire meglio ciò che
oscuramente già intuiva, sappia che il frutto che ne trae scaturisce
dalla sua ricerca, più che dai modesti spunti che qui abbiamo cer-
cato di offrire.
6La sfida della frammentazione dell’io
Da Piero della Francesca a Picasso
C’era una volta l’io. Questa parola, breve quanto carica di si-
gnificato, veniva pronunziata con fiera sicurezza. Di tutto si po-
teva dubitare, tranne che del proprio essere se stessi. La cultura
moderna, a partire dal Rinascimento, si è costruita su questa cer-
tezza. I filosofi hanno esaltato il soggetto, ponendolo al centro
della realtà e facendone la misura di tutte le cose. I pittori ne han-
no raffigurato il volto facendone sprigionare la personalità. I poe-
ti l’hanno posto come protagonista delle loro liriche e dei loro ro-
manzi. I musicisti ne hanno espresso in note gli stati d’animo.
L’immagine che ne emergeva era quella di una realtà unitaria,
consapevole di sé, artefice, o comunque protagonista del proprio
destino.
Poi è venuto Nietzsche, che già sul finire dell’Ottocento di-
chiarava che l’io è soltanto «una favola, una finzione, un gioco di
parole» (Nietzsche 1975, p. 72), dietro cui si nasconde un flusso
caotico di cieche pulsioni e di percezioni frammentarie. Un mes-
saggio che ha trovato immediato riscontro negli studi, di poco po-
steriori, di Sigmund Freud sulla psiche umana. Là dove l’età mo-
derna vedeva, come caratteri peculiari del soggetto, l’autoco-
scienza e la libertà, il medico austriaco smascherava l’oscura pre-
senza di un inconscio, a cui non si addice il nome di «Ich» («Io»),
bensì quello di «Es» («Esso»), terza persona neutra, perché del
tutto inconsapevole e soggetto a meccanismi incontrollabili. La
coscienza, tanto esaltata fino ad allora dai filosofi e dai letterati, al-
tro non è, per Freud, che una sottile crosta superficiale, impegna-
ta a reprimere e ricacciare nel buio i mostri emergenti dall’incon-
scio, sotto il controllo spietato di un tirannico Super-Io a sua vol-
ta frutto di processi inesorabili. L’antica immagine monolitica e
auto-trasparente del soggetto si disgregava, così, in una molte-
7plicità conflittuale, in perenne squilibrio, le cui contorte dinami-
che si possono parzialmente portare alla luce solo sottoponendo-
si a un lungo e faticoso lavoro di analisi.
Uno sconvolgimento inquietante, motivato dalla volontà di
vedere più a fondo, senza retorica, la verità dell’essere umano. Si
potrebbe trovare una efficace parabola di questo passaggio nella
descrizione della città di Eudossia, fatta da Italo Calvino ne Le cit-
tà invisibili: «A Eudossia, che si estende in alto e in basso, con vi-
coli tortuosi, scale, angiporti, catapecchie, si conserva un tappeto
in cui puoi contemplare la vera forma della città. A prima vista
nulla sembra assomigliare meno a Eudossia che il disegno del
tappeto, ordinato in figure simmetriche che ripetono i loro moti-
vi lungo linee rette e circolari, intessuto di gugliate dai colori
splendenti, l’alternarsi delle cui trame puoi seguire lungo tutto
l’ordito. Ma se ti fermi a osservarlo con attenzione, ti persuadi
che a ogni luogo del tappeto corrisponde un luogo della città e
che tutte le cose contenute nella città sono comprese nel disegno,
disposte secondo i loro veri rapporti, quali sfuggono al tuo oc-
chio distratto dall’andirivieni dal brulichio dal pigia-pigia. Tutta
la confusione di Eudossia, i ragli dei muli, le macchie di nerofu-
mo, l’odore di pesce, è quanto appare nella prospettiva parziale
che tu cogli; ma il tappeto prova che c’è un punto dal quale la cit-
tà mostra le sue vere proporzioni, lo schema geometrico implica-
to in ogni suo minimo dettaglio (...). Sul rapporto misterioso di
due oggetti così diversi come il tappeto e la città fu interrogato
un oracolo. Uno dei due oggetti, – fu il responso, – ha la forma
che gli dei diedero al cielo stellato e alle orbite su cui ruotano i
mondi; l’altro ne è un approssimativo riflesso, come ogni opera
umana (...). Ma allo stesso modo tu puoi trarne la conclusione op-
posta: che la vera mappa dell’universo sia la città d’Eudossia co-
si com’è, una macchia che dilaga senza forma, con vie tutte a zig-
zag, case che franano una sull’altra nel polverone, incendi, urla
nel buio» (Calvino 1977, pp. 103-104).
Così, da un’età moderna che aveva tracciato con sicurezza la
fisionomia ideale dell’io, la post-modernità contrappone la sua
effettiva realtà, piena di anfratti oscuri e di contraddizioni. Al di-
segno geometrico della sua unità si è sostituita la mappa incerta
della sua complessità. Dove complessità non vuol dire solo mol-
8teplicità di aspetti, ma impossibilità di ricondurli a un ordine sta-
bile e armonico.
Quelle di Nietzsche e di Freud non erano posizioni isolate.
Dalla fine dell’Ottocento, lungo tutto il corso del Novecento, fino
ad oggi, la vicenda dell’io è una storia di progressiva dissoluzio-
ne. Certo, come in ogni passaggio epocale, non si può fissare uni-
vocamente una data in cui alla visione moderna è subentrata
quella post-moderna. Ma basta confrontare la trama lineare dei
romanzi ottocenteschi, costruiti su una coerente, articolata psico-
logia del protagonista, con l’Ulisse di Joyce, attraversato da un
ininterrotto e frammentario flusso di coscienza, oppure le melo-
die romantiche con la musica dodecafonica, per cogliere la di-
stanza tra due universi culturali.
Ancora più emblematica la differenza tra un ritratto di Piero
della Francesca o di Tiziano e un dipinto di Picasso che raffigura il
volto umano. Nel primo si trova una prospettiva armoniosa, uni-
ficante, una descrizione coerente e fedele a ciò che lo sguardo uma-
no vede. Guardiamo ora il quadro di Picasso. Anch’esso vuole rap-
presentare i lineamenti di una persona. A prima vista, se ne po-
trebbe dubitare. Poi, cercando bene, si scopre che gli elementi del
viso – occhi, naso, bocca – ci sono tutti. Ma è come se ognuno fos-
se riprodotto all’interno di una prospettiva diversa e contraddit-
toria rispetto agli altri elementi. L’io che sta dietro quel volto ap-
pare disgregato, irriconoscibile agli altri e forse anche a se stesso.
Siamo davanti a un processo che non riguarda solo l’arte e la
filosofia, ma coinvolge la vita di ogni giorno. Guardiamo la sfera
relazionale. Prima le persone si muovevano all’interno di am-
bienti rigorosamente circoscritti che ne definivano in modo uni-
voco la fisionomia e il ruolo. In primo piano – e per le donne in
modo quasi esclusivo – c’era la famiglia. Per gli uomini contava
molto anche il mondo del lavoro. Più deboli, altri tipi di relazioni:
con la parrocchia (soprattutto per le donne), con il circolo o il par-
tito (soprattutto per gli uomini). In tutti questi ambiti, la cerchia
era limitata sia dal punto di vista quantitativo che da quello qua-
litativo. Si procedeva su binari precostituiti, che favorivano l’iden-
tificazione dei singoli con modelli altrettanto precostituiti.
Oggi la personalità degli individui di entrambi i generi è sol-
lecitata da una miriade di scambi con colleghi, conoscenti e «ami-
9ci» di vario livello e continuamente mutevoli. Le famiglie hanno
perso la loro compattezza centripeta e ognuno dei due coniugi è
al centro di una rete relazionale estremamente variegata. Non so-
lo anche le donne ormai lavorano, ma la profonda trasformazio-
ne del modo di lavorare comporta per tutti – e forse per loro, più
ancora che per gli uomini – la compresenza in ambienti diversi, a
ciascuno dei quali bisogna adeguarsi. «Esiste un nesso tra la di-
sgregazione del lavoro e la frammentazione della vita delle per-
sone (Salmieri 2006, p. 77).
Per non parlare della pressione dei mezzi di comunicazione
– prima limitata a quella dei giornali e della radio –, che inva-
dono da ogni parte gli spazi personali con immagini, slogan, sug-
gestioni di ogni genere, sollecitando la psiche degli individui
e condizionando la loro vita emotiva a partire alla più tenera
età. Anche sotto questo profilo, l’io è sottoposto alla pressione di
una piena a cui non è in grado di far fronte con un’adeguata ope-
ra di sintesi e che suscita in lui stati d’animo incontrollati e con-
trastanti.
Non c’è bisogno di essere degli specialisti per rendersi conto
che un’educazione incapace di tener conto di questa nuova real-
tà è destinata in partenza all’insuccesso.
Oltre la maschera
Certo, il quadro che abbiamo delineato mette in crisi i model-
li monolitici che la tradizione moderna ci ha consegnato e che da-
vano comunque sicurezza. Ma possiamo davvero essere così cer-
ti che dietro quelle costruzioni culturali ci fosse la realtà del sog-
getto in carne ed ossa, e non un fantasma? Pirandello ha bollato
questi volti precostituiti, perfettamente coerenti, socialmente ga-
rantiti, come maschere. Aveva del tutto torto?
Perché, dobbiamo pur dirlo, anche nel passato l’univocità e la
solidità dei modelli spesso soffocava la ricchezza e l’autenticità
dei volti. L’io era compatto, ma solo al prezzo di una pesante re-
pressione di tanti suoi aspetti, di tante sue potenzialità, di tanti
suoi desideri. L’alternativa a questo punto si poneva tra un con-
formismo soffocante e una trasgressione il cui prezzo era il ripu-
dio da parte del proprio ambiente sociale.
10Commentando la tendenza della letteratura post-moderna a
valorizzare la molteplicità rispetto all’unità, Italo Calvino con-
cludeva: «Qualcuno potrà obiettare che più l’opera tende alla
moltiplicazione dei possibili più s’allontana da quell’unicum che
è il self di chi scrive, la sincerità interiore, la scoperta della pro-
pria verità. Al contrario, rispondo, chi siamo noi, chi è ciascuno di
noi se non una combinazione d’esperienze, d’informazioni, di let-
ture, d’immaginazioni?» (Calvino 1988, p. 120).
Si può discutere il fondamento filosofico di questa afferma-
zione. Ma è riconoscibile anche una parte di verità, quando l’au-
tore insiste sull’importanza delle diverse modalità di approccio
alla realtà per la realizzazione della persona. Da questo punto di
vista bisogna dare atto alla post-modernità di avere aperto nuove
prospettive. Particolarmente evidente è stato il fenomeno nel
mondo femminile. Qui i modelli in cui identificarsi erano parti-
colarmente rigidi. Si poteva essere «angelo del focolare», oppure
amante segreta, o addirittura sgualdrina. Tranne che nel caso di
una vocazione monastica, che sottraeva a questa gamma di de-
stini per aprirne uno diverso, ma anch’esso rigorosamente codi-
ficato.
L’educazione indirizzava a uno di questi percorsi. La potenza
della cultura è di modellare le persone senza bisogno di ricorre-
re alla violenza. La scarsa presenza di nomi femminili negli elen-
chi di filosofi, poeti, letterati, pittori, scienziati, musicisti, esplo-
ratori, la dice lunga sotto questo profilo. Non che le donne non
abbiano avuto un’influenza importante sulla storia: ma quasi
sempre passando attraverso le forche caudine di uno dei cliché
appena elencati.
Non c’è da stupirsi che il femminismo abbia fatto saltare, con
una specie di rabbiosa reazione, questi modelli, sganciando dra-
sticamente la donna dalla nicchia troppo stretta in cui era stata
collocata e, in particolare, da una dipendenza dall’uomo che la
rendeva funzionale e complementare al suo ruolo dominante.
Non è questa la sede per ripercorrere le tappe del movimento
femminista, le sue conquiste e i suoi errori. Ma quante donne,
oggi, pur soffrendo della complessità e della disgregazione deri-
vanti dalle loro molteplici identità – di moglie, di madre, ma an-
che di professionista o funzionaria o imprenditrice, sempre di
11corsa, sempre in debito con uno di questi ruoli –, vorrebbero tor-
nare a specchiarsi nell’immagine univoca, semplice, compatta
del passato?
Anche gli uomini, sia pure meno vistosamente, hanno pagato il
prezzo di questa costrizione. Quante vocazioni artistiche, filosofi-
che, religiose soffocate da famiglie e ambienti sociali che non le ri-
tenevano compatibili con i loro modelli! Ritorna alla mente l’anti-
co mito greco di Procuste, un crudele brigante che attendeva al
varco i viandanti e, dopo averli catturati, li costringeva a stender-
si su un letto e ad assumerne le dimensioni, stirandone le membra
se troppo bassi e corti, amputandole se troppo alti e lunghi.
Oggi non si vuole più essere sottoposti a questo trattamento. È
significativo il rigetto verso tutte le divise, dall’abito talare dei
preti a quello, tradizionalmente sobrio e compassato, di magi-
strati e insegnanti.
Dobbiamo riconoscere che, al di là delle forme che assume,
questa reazione alla logica repressiva di tante esperienze del pas-
sato è in perfetta linea con una idea essenziale della tradizione
cristiana, un’idea mai del tutto dimenticata, anche se a lungo
oscurata: la persona umana, immagine di Dio, partecipa di qual-
cosa dell’Infinito e non può essere imprigionata in nessuno sche-
ma. L’educazione, che spesso era utilizzata per vietare e costrin-
gere, per delimitare e comprimere, oggi deve imparare a tener
conto di questa apertura sconfinata, a rispettarla, a promuoverla.
Per questo essa, in una società in cui si parla tanto di «crisi
dei valori», deve tener conto di un valore che per i giovani rap-
presenta un punto di riferimento fondamentale, quello dell’au-
tenticità, in cui si esprime la fedeltà di ciascuno, nel suo essere
unico e irripetibile, al proprio volto, alla propria verità, al proprio
mistero.
Un posto importante, nella prospettiva dell’autenticità, han-
no, con la loro indefinita varietà e perfino con la loro contraddit-
torietà, le emozioni, tante volte represse, misconosciute, masche-
rate (perciò l’autenticità viene spesso identificata con la sincerità!)
in nome di una ragione tirannica, che Freud ha denunziato come
espressione del Super-Io.
Costituisce una specie di manifesto di questa visione della per-
sona e della vita una famosa canzone di Lucio Battisti intitolata,
12appunto, Emozioni: «Domandarsi perché, quando cade la tristez-
za/ in fondo al cuore,/ come la neve, non fa rumore;/ e guidare
come un pazzo a fari spenti nella notte/ per vedere/ se poi è tan-
to difficile morire;/ e stringere le mani per fermare/ qualcosa
che/ è dentro me,/ ma nella mente tua non c’è:/ capire tu non
puoi,/ tu chiamale, se vuoi,/ emozioni./ Uscir nella brughiera di
mattina/ dove non si vede ad un passo/ per ritrovar se stesso;/
parlar del più e del meno con un pescatore/ per ore ed ore,/ per
non sentir che dentro qualcosa muore;/ (...) e prendere a pugni un
uomo solo/ perché è stato un po’ scortese,/ sapendo che quel che
brucia non son le offese;/ e chiudere gli occhi per fermare/ qual-
cosa che/ è dentro me,/ ma nella mente tua non c’è:/ capire tu
non puoi,/ tu chiamale, se vuoi,/ emozioni».
Non è una posizione isolata. «Il mio pensiero, per lo più de-
bole, è sempre stato oscurato dalla forza dei sentimenti»: sono le
parole conclusive dell’esergo posto da Fabrizio De André – un
altro cantautore di cui non si deve sottovalutare l’influsso sul-
la nostra cultura e su quella giovanile in particolare – al volu-
me dove sono raccolti i testi di tutte le sue canzoni (De André
2006, p. 11).
E anche su questo punto bisogna riconoscere che gli stili edu-
cativi tradizionali devono essere rimessi in discussione. Troppo
spesso il perbenismo borghese si è impadronito della razionalità
per piegarla alle logiche di un mediocre utilitarismo o di un an-
gusto moralismo. Da questo punto di vista il richiamo alla com-
plessità dell’io, che include a pieno titolo la sfera emotiva e la po-
ne in primo piano, è un contributo importante che la post-mo-
dernità dà all’educazione.
Il gioco dello zapping
Non si può minimizzare, tuttavia, ciò che di unilaterale e di
distruttivo vi è in tutto questo. La valorizzazione della ricchezza
della personalità assume oggi la forma di una disgregazione che
le rende impossibile, in molti casi, avere un centro interiore. Se
l’io concepisce se stesso – e diventa effettivamente, per il peso che
la cultura ha nella costruzione della soggettività umana – quello
che qualcuno ha definito «una società per azioni a maggioranza
13variabile», non riesce più a sapere chi veramente è e che cosa vuo-
le dalla vita. In realtà oggi questo accade spesso (almeno in Occi-
dente) anche agli adulti che, nel venir meno di strutture sociali
forti a cui affidare l’elaborazione della propria fisionomia inte-
riore, stentano a costruirsene una. Ovviamente tra i giovani – im-
pegnati in un delicato processo di costruzione dell’identità – que-
sta difficoltà è resa ancora maggiore proprio dalla mancanza di
punti di riferimento convincenti.
È impressionante che questo sia l’esito della scoperta di un va-
lore come l’autenticità, che dovrebbe garantire una maggiore ca-
pacità di essere se stessi. Il punto è che questo concetto viene spes-
so ridotto unilateralmente all’abbandono incondizionato ai propri
stati d’animo e alle proprie pulsioni immediate, sganciandoli da
ogni forma di riflessione.
Soprattutto nel mondo giovanile si constata, secondo un luci-
do osservatore come Galimberti, «un’emotività molto più incon-
trollata e uno spazio di riflessione molto più modesto». Ma que-
sto, invece di potenziare la ricchezza dei sentimenti del soggetto,
ha spesso l’effetto paradossale di indebolirli e anestetizzarli:
«L’eccesso emozionale e la mancanza del raffreddamento rifles-
sivo» producono infatti, secondo l’autore, «1) lo stordimento del-
l’apparato emotivo attraverso quelle pratiche rituali che sono le not-
ti in discoteca o i percorsi della droga; 2) il disinteresse per tutto,
messo in atto per assopire le emozioni attraverso i percorsi del-
l’ignavia e della non partecipazione (...); 3) il gesto violento, quan-
do non omicida, per scaricare le emozioni e per ottenere un’over-
dose che superi il livello di assuefazione come nella droga» (Ga-
limberti 2007, pp. 41-42).
Si può cercare di andare più a fondo. Il fatto è che una solleci-
tazione unilaterale della sfera pulsionale degli individui li spinge
ad abolire la distanza tra l’impulso dell’attrazione e la sua realiz-
zazione, impedendo al soggetto di identificarsi di fronte agli og-
getti e portandolo piuttosto a proiettarsi ciecamente su di essi. Un
meccanismo che viene esaltato dalla logica consumistica oggi im-
perante. Lo evidenzia un noto esponente della psicoanalisi laca-
niana, Massimo Recalcati, quando osserva che la cultura del con-
sumismo «rigetta il limite, la mancanza, il desiderio (...). Il godi-
mento deborda senza argine, senza freni, non si aggancia al desi-
14derio, sospinge verso la consumazione dissipativa della vita». In-
fatti, spiega l’autore utilizzando il linguaggio freudiano, «se non
c’è distanza da questo godimento assoluto (....) non si dà possibi-
lità alcuna che vi sia desiderio. È necessaria una perdita origina-
ria, una differenziazione, un limite, una lontananza dalla Cosa
materna perché vi sia desiderio». Così, le dinamiche largamente
dominanti impediscono «di umanizzare il desiderio», favorendo
una «pulsione che conduce la vita verso un godimento tanto illi-
mitato quanto distruttivo», che perciò diventa «pulsione di mor-
te» (Recalcati 2011, pp. 47 e 55).
Non c’è bisogno di condividere le premesse teoriche di queste
riflessioni per essere d’accordo sulla loro sostanza. Del resto, la
caduta della tensione delle passioni nella nostra società è sotto i
nostri occhi. Nel 44° Rapporto Censis, del 2010, troviamo, da que-
sto punto di vista, una diagnosi spietata della situazione: «Sembra
avvenire ogni giorno di più che il desiderio diventi esangue, sen-
za forza, indebolito da una realtà socioeconomica che da un lato
ha appagato la maggior parte delle psicologie individuali attra-
verso una lunga cavalcata di soddisfazione dei desideri (...) e che
dall’altro è basata sul primato dell’offerta che garantisce il godi-
mento di oggetti e di relazioni mai desiderati, o almeno non ab-
bastanza desiderati» (n. 13).
Siamo davanti al paradosso di una cultura che ha posto in pri-
mo piano la liberazione del desiderio, anzi dei desideri, e che al-
la fine si ritrova a constatare il fallimento proprio della capacità di
desiderare.
Tutto ciò ha una ricaduta devastante sul modo di vivere la pro-
pria complessità da parte del soggetto. La ricchezza delle poten-
zialità dell’io scade in una caotica proliferazione di pulsioni su-
perficiali. Le passioni non riescono neppure a mettere radici e a
svilupparsi, e si riducono a banali preferenze consumistiche. Nul-
la di grande, nulla di profondo.1
Si spiega così anche la crisi di quella che un tempo si chiama-
va «vocazione». Spesso si denuncia la diminuzione di quelle al
1 Un ampio sviluppo del tema delle passioni e del loro ruolo nella vita mo-
rale si trova nel mio Educare oggi alle virtù, Elledici, Torino (Leumann) 2011 (pri-
ma ristampa 2012).
15sacerdozio o alla vita religiosa. Ma le statistiche dicono che sono
in crisi anche quelle al matrimonio. Il motivo è lo stesso: un indi-
viduo che si considera una società per azioni a maggioranza va-
riabile non può fare scelte irreversibili o comunque a lunga sca-
denza.
Così viene colpita al cuore proprio quella libertà che, agli occhi
dell’individuo post-moderno, costituisce, insieme all’autenticità, il
bene supremo. Una società dove «le persone (...) cercano sempre di
mantenere aperte tutte le opzioni possibili», tanto da far definire
questi nostri come «gli anni del possibile» (David Brooks, La gene-
razione «self». Pochi vincoli, libertà e la porta sempre aperta, New York
Times – la Repubblica, in «la Repubblica» del 29 novembre 2012, p.
35), assume come modello ispiratore delle esistenze individuali il
gioco dello zapping, il cui esito è spesso, dopo aver trascorso la se-
rata a vagare da un canale all’altro, senza essere capaci di decider-
si per uno, di ritrovarsi alla fine a non aver visto nulla.
In passato era la necessità monolitica dei destini che talora li
spingeva alla disperazione. Oggi si registra l’estremo opposto.
Nessuno meglio di Kierkegaard ha descritto, profeticamente, que-
sta oscillazione: «Ora, se la possibilità va tant’oltre da rovesciare
la necessità, l’io fugge via da se stesso nelle possibilità, senza aver
più nulla di necessario a cui poter ritornare: questa è la dispera-
zione della possibilità. Quest’io diventa una possibilità astratta, si
dimena fino alla stanchezza nella possibilità, ma non si muove
dal posto e non arriva in alcun posto (...). La possibilità sembra co-
sì all’io sempre più grande, sempre più diventa possibile, perché
niente diventa reale. Alla fine è come se tutto fosse possibile, ma
è proprio questo il momento in cui l’abisso ha ingoiato l’io. In un
momento qualcosa si presenta come possibile, poi si presenta una
nuova possibilità e alla fine queste fantasmagorie si susseguono
così rapidamente che tutto sembra possibile; e questo è l’ultimo
momento in cui l’individuo tutto intero è diventato esso stesso
un miraggio» (Kierkegaard 1965, pp. 243-244).
Siamo davanti a uno snodo fondamentale dell’attuale crisi
educativa: «Come vi può essere educazione – e dunque forma-
zione – se l’imperativo che orienta il discorso sociale s’intona per-
versamente come un “Perché no?”» che rende insensata ogni espe-
rienza del limite? (...) Se tutto tende a sospingere verso l’apologia
16cinica del consumo e dell’appagamento senza differimenti?» (Re-
calcati 2011, p. 104). Educare oggi è possibile solo se si prende co-
scienza del problema rappresentato da questo dissolversi del cen-
tro interiore nel gioco illimitato delle pulsioni e nella fantasma-
goria delle possibili esperienze.
Educare all’unità interiore
In questo contesto la risposta più urgente che l’educazione de-
ve dare alla sfida della post-modernità consiste nell’aiutare i gio-
vani a trovare la propria unità, passando attraverso la liberazione
dei loro desideri (che non si riducono alle pulsioni!) e la riscoper-
ta della loro capacità di fare delle scelte.
Oggi molti genitori si preoccupano di dotare i figli di tutte le
abilità e le opportunità che potranno aiutarli ad affermarsi pro-
fessionalmente e socialmente: la conoscenza delle lingue, un fisi-
co sportivo, una scuola e una facoltà universitaria qualificate. Ra-
ramente badano alla cosa più importante, che ha a che fare non
con ciò che il loro ragazzo o la loro ragazza possono «avere» e «fa-
re», ma con ciò che devono cercare di «essere».
Si spiega così lo strano paradosso di una gioventù assai più at-
trezzata da tutti i punti di vista rispetto a quella di altre epoche,
ma al tempo stesso immensamente più fragile e incapace di af-
frontare la vita.
Abbiamo visto che la perdita di unità interiore e la conse-
guente paralisi del soggetto derivano da una specie di corto-cir-
cuito tra la pulsione e il suo appagamento, per cui viene aggirata
l’esperienza del limite che circoscrive l’identità dell’io e ne ali-
menta la tensione vitale. Se è verissimo che «le emozioni dise-
gnano il paesaggio della nostra vita spirituale e sociale» (Nus-
sbaum 2004, p. 17), è altrettanto vero, però, che esse devono esse-
re condotte «per mano» a trasformarsi da mere pulsioni in desi-
deri umani. Altrimenti diventano una minaccia con cui al massi-
mo si può stringere un «patto di non aggressione» come quello di
cui parla Vasco Rossi in una sua canzone: «Ho fatto un patto sai
con le mie emozioni./ Le lascio vivere e loro non mi fanno fuori»
(Manifesto futurista della nuova umanità).
Per andare oltre questo traguardo, già significativo, ma certo
17non soddisfacente, esse devono passare dallo stato di schegge im-
pazzite, proiettate, in un devastante moto centrifugo, verso la
«consumazione dissipativa della vita» e una inconscia «pulsione
di morte», per usare le parole di Recalcati, a quello di espressioni
diverse dell’ identità profonda dell’io, che soltanto attraverso la
loro varietà (talora anche conflittuale) può diventare pienamente
se stesso.
Ad accompagnare il giovane in questo percorso di unità attra-
verso la molteplicità può essere solo «la parola del padre» (Recal-
cati 2011, p. 69), che può ben essere anche quella del «maestro» e,
in generale, dell’educatore. Si potrebbe identificare questa «paro-
la» con quel logos che, nel suo significato originario, è molto di
più che l’emissione di un suono e si identifica con la razionalità.
L’umanizzazione delle pulsioni comporta, allora, la loro circola-
rità con la ragione, non intesa come raziocinio, vale a dire come
pura e semplice argomentazione logica, ma come sguardo intelli-
gente che coglie il senso e la verità delle cose. Perciò correttamente
il Profeta di Gibran ammonisce i suoi discepoli: «La ragione e la
passione sono il timone e la vela di quel navigante che è l’anima
vostra. Se il timone o la vela si spezzano, sbandati, andrete alla de-
riva e resterete fermi in mezzo al mare» (Gibran 1983, p. 87).
Già su questa linea si muoveva Aristotele, ripreso oggi con
grande forza da una pensatrice americana contemporanea: «Una
tipica emozione aristotelica è composta da un sentimento di pia-
cere o dolore e da una particolare convinzione sul mondo (...). La
convinzione è il fondamento del sentimento» (Nussbaum 1996,
p. 687).
Questo significa che, mentre le pulsioni sono immediate e non
modificabili, i desideri e i sentimenti sono il frutto di un processo
di maturazione che vede al tempo stesso protagoniste la sfera
emotiva e quella razionale. È dunque possibile che i nostri senti-
menti siano gradualmente modificati attraverso la riflessione con-
sapevole. «Ciò significa che la nostra emotività può essere educata
e, se vogliamo una società migliore, deve essere educata» (Galim-
berti 2007, p. 44). Dove però è evidente che è vero anche il reci-
proco: e cioè che la ragione può essere, a sua volta, influenzata ed
educata dalle emozioni. Infatti, «la passione non è fuori o contro
la ragione, ma dentro, la ragione è per sua natura (anche) passio-
18nale» (Ventimiglia 2012, p. 10). È l’abisso che separa la razionali-
tà delle intelligenze artificiali da quella umana. «Per reagire cor-
rettamente ad un caso pratico (...) che ci stia davanti, è necessaria
non soltanto la valutazione dell’intelletto, ma anche un’appro-
priata risposta emozionale» (Nussbaum 1996, pp. 160-161).
Nella nostra prospettiva, acquista un singolare significato il
fatto che il termine logos possa significare, in greco, anche l’unio-
ne di elementi diversi che, senza fondersi, si articolano tra di loro.
Il pensare unifica. Unifica il mondo, perché non si riduce alla co-
noscenza dei particolari, ma mira a collegarli scoprendo i loro se-
greti rapporti, così da individuarne il senso complessivo. Soprat-
tutto, però, unifica il soggetto, perché gli consente di andare oltre
le singole, frammentarie reazioni emotive alle diverse situazioni
e gli consente di guardarsi come centro unitario e responsabile
delle sue diverse esperienze. È il prezzo che bisogna pagare per
essere un «io». E, conseguentemente, per essere liberi.
A questo deve mirare, perciò, l’educazione in famiglia, a scuo-
la, nella Chiesa, se vuole seriamente fare i conti con la sfida della
molteplicità. Per riconciliare unità e molteplicità dell’io, si tratta di
riattivare il dialogo spesso atrofizzato tra sensibilità e intelligen-
za, di liberare l’autenticità dalla pretesa di essere irresponsabile, la
spontaneità umana (che include la riflessione e la convinzione)
dallo spontaneismo animalesco, la pulsione dal facile appaga-
mento che la rende incapace di misurarsi col limite e di diventa-
re desiderio.
Il lavoro dell’educatore, oggi, non può dunque prescindere
dalla varietà delle esperienze dei giovani, con la loro carica emo-
tiva, tanto meno deve mirare a un estrinseco «controllo» su di
esse. Ciò che egli deve riuscire a trasmettere è, piuttosto, che le
stesse esperienze ed emozioni perdono il loro significato senza
una adeguata capacità di «raccoglimento» – nel senso letterale
del termine – con cui l’io possa gradualmente unificarsi, attra-
verso preziosi momenti di silenziosa e solitaria riflessione che
bisogna imparare a conquistarsi nella frenetica corsa di ogni
giorno.
Ciò suppone, però, la scoperta del proprio centro interiore da
parte dell’educatore. Questi «può non essere capace di destare,
incontrare e riconoscere la persona dell’educando; e ciò probabil-
19mente in ragione del fatto che lui stesso non si è destato a sé come
presenza personale viva e interessante» (Bellingreri 2010, p. 76).
Se si vuole sperare di vincere la sfida della frammentazione del-
l’io, accompagnando i più giovani nell’arduo impegno di riunifi-
carsi, bisogna cominciare dal prendersi cura innanzitutto del pro-
prio.2
2 Sul ruolo decisivo dell’educatore e sulle condizioni per la sua rivalutazio-
ne cf G. SAVAGNONE - A. BRIGUGLIA, Il coraggio di educare. Costruire il dialogo edu-
cativo con le nuove generazioni, Elledici, Torino (Leumann) 2009 (terza ristampa
2010).
20Puoi anche leggere