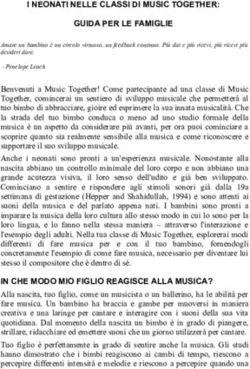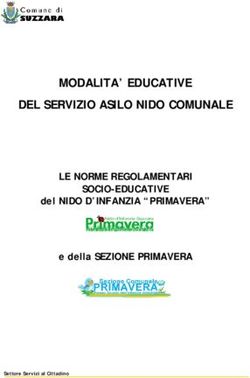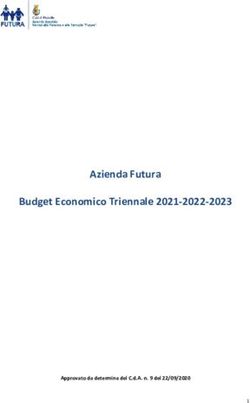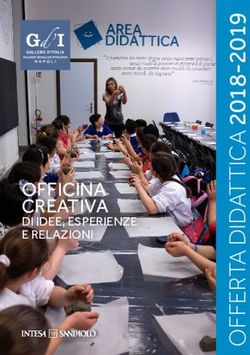Educare nei nidi d'infanzia: dagli spazi creativi e di gioco agli apprendimenti
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Educare.it - SCUOLA
Educare nei nidi d’infanzia:
dagli spazi creativi e di
gioco agli apprendimenti
Maria Buccolo
Dottore di ricerca in Progettazione e Valutazione dei processi formativi, è docente a contratto di Didattica Generale e
DSA presso la Facoltà di Scienze della Formazione Primaria dell’Università La sapienza di Roma, già docente di
discipline pedagogiche presso il Dipartimento di scienze della formazione dell’Università degli Studi di Roma Tre.
Coordina le attività didattiche al Master di “Servizi Educativi per la prima infanzia” presso l’Istituto Nazionale di
Pedagogia Familiare di Roma. È formatore e consulente all’interno di diverse organizzazioni sia pubbliche che private e
tiene corsi di forma-zione e aggiornamento per docenti di ogni ordine e grado di scuola sul tema della gestione delle
emozioni. Tra le sue pubblicazioni: L’educatore emozionale. L’alfabetizzazione emotiva per tutta la vita, Franco Angeli
2019; Formar-si alle professioni educative e formative. Università, Lavoro e Sviluppo dei Talenti, Franco Angeli 2015.
L’articolo focalizza l’importanza dell’educazione nel bambino, sin dai primi
mesi di vita, ed approfondisce la valenza pedagogica e culturale del nido
come primo luogo di apprendimento. I vari aspetti che caratterizzano tale
servizio educativo vengono affrontati in modo organico, sia dal punto di
vista della ricerca pedagogica che dalle recenti normative che ne potenzia-
no l’identità e la preziosa valenza educativa.
Introduzione tari rivolti all'infanzia, gli asili nido, favori-
scono la continuità educativa con la fami-
Il nido è il servizio educativo progettato glia, l'ambiente sociale e gli altri servizi esi-
per sostenere il bambino in una fase della stenti. Ogni asilo nido è organizzato in spazi
sua crescita particolarmente preziosa per lo differenziati per rispondere ai bisogni delle
sviluppo psico-fisico. E’ anche un servizio di diverse età, ai ritmi di vita dei singoli bam-
interesse pubblico che accoglie senza alcuna bini, alla percezione infantile dello spazio,
distinzione di sesso, cultura, etnia e religio- alla necessità di riferimenti stabili, alle atti-
ne. Lo scopo è di offrire ai bambini un luogo vità (Gilardini, 2012).
di socializzazione e di stimolo delle loro po- Nel nostro paese, le istituzioni pubbliche
tenzialità cognitive, affettive e sociali nella per la prima infanzia, a gestione comunale,
prospettiva del loro benessere e del loro ar- sono nate con la legge 6.12.1971, n. 1044 che
monico sviluppo (Buccolo, 2019). detta le disposizioni generali e stabilisce i
Nell'ambito della massima integrazione principi fondamentali entro i quali le Regio-
con gli altri servizi educativi, sociali e sani- ni possono emanare le loro norme e delega-
© Educare.it (rivista on line - ISSN: 2039-943X) - Vol. 20, n. 4 – Aprile 2020
61URL: https://www.educare.it/j/temi/scuola/scuola-e-dintorni/3957
re ai Comuni - quali enti locali più vicini ai identifica con il diritto alla conoscenza e alla
bisogni della comunità - la gestione ed il creatività; il nido offre al bambino occasioni
controllo degli asili nido. di socializzazione e di apprendimento
La classificazione dei servizi rivolti ai (Dewey, 2009).
bambini di età compresa tra i 3 mesi ed i 6 L’idea è quella di nido aperto alle colla-
anni esistenti in Italia identifica i diversi tipi borazioni con il territorio, ma anche tra se-
di risposta per fascia d’età (3 mesi-3 anni, 3- zioni e tra gli educatori, dove far trasparire
6 anni) e intensità di cura. una programmazione rivolta al piano istitu-
Oggi la realtà dei servizi educativi per zionale (degli enti locali) e al piano pedago-
l’infanzia 0- 6 anni è in via di sviluppo in gico (dei servizi per l’infanzia). Per Frabboni
seguito al D.Lgs n. 65/2017 “Decreto sul si- lavorare come educatori al nido, significa
stema integrato di istruzione ed educazione essere dei professionisti che assumono un
da 0-6 anni”. determinato modello di intervento chiaro e
Concettualmente il nido diventa uno spa- definito, nella piena consapevolezza di dove
zio speciale, ritagliato a misura di bambino, e perché si sta intervenendo.
il quale abbandona la visione “assistenziale” Anche Susanna Mantovani (1990, p. 44)
di un tempo, per mettere al centro insiste sull’importanza della programma-
dell’obiettivo lo sviluppo psicologico, fisico zione al nido, ponendola come esigenza di
e sociale. qualunque intervento educativo al di là di
quelle che sono le pretese cognitive. L’idea è
La pedagogia del nido quella di una programmazione “dinamica”,
quindi un’azione educativa basata su teorie
Nel secolo scorso, diversi autori contri-
e conoscenze continuamente adattate alla
buirono ad arricchire il dibattito pedagogico
realtà, dove l’educatore diventa un ricerca-
sulla programmazione del nido e sulla fun-
tore in azione in base alle esigenze che si
zione educativa della struttura della prima
propongono. Egli, infatti, dovrebbe essere in
infanzia. Frabboni (1990) sostiene la necessi-
possesso di strumenti che consentono di co-
tà di pensare a modalità di lavoro che per-
struire e interpretare informazioni e dati, a
mettano ai bambini di “poter scrivere e leg-
partire da conoscenze teoriche precise che
gere i propri linguaggi” e quindi il proprio
gli consentano una programmazione dina-
mondo esistenziale, sociale e culturale. Sulla
mica, seppur rigorosa e pensata (Frabboni,
base di ciò, il bambino non dovrebbe essere
1990).
asservito allo stile di vita “consumistico”,
La programmazione al nido è stata for-
imposto dal modello culturale dominante,
temente sostenuta da Catarsi, facendo rife-
ed inserito entro modelli di vita lontani dalle
rimento ad un’idea libera da rigidità e
esperienze della prima infanzia. Frabboni
schematismi, evolutiva, in grado di svilup-
considera il nido d’infanzia come il luogo
parsi secondo continui aggiornamenti, veri-
che garantisce tale diritto, in quanto lo rico-
fiche e ridefinizioni (Catarsi, Fortunati,
nosce “soggetto di conoscenza e creatività
1989). Incidere sul futuro e promuovere il
fin dalla nascita” (Frabboni, 1990, p. 12).
cambiamento delle persone è una delle fun-
L’autore riprende il programma pedago-
zioni dell’educatore della prima infanzia.
gico di Dewey, secondo cui l’infanzia si
© Educare.it (rivista on line - ISSN: 2039-943X) - Vol. 20, n. 4 – Aprile 2020
62URL: https://www.educare.it/j/temi/scuola/scuola-e-dintorni/3957
Al nido si impara attraverso Un nido a misura di bambino
l’esplorazione e la scoperta, che costituisco-
L'evolvere della vita psichica dell'infanzia
no le basi della pedagogia attiva. Il bambino
è una dimensione difficile da individuare e
viene curato in ogni aspetto della sua vita: i
da esplorare: conoscenze, affetti, percezioni,
bisogni fisiologici, il gioco e le relazioni. Il
emozioni del mondo infantile, rappresenta-
bambino scopre che il nido è un luogo di re-
no un pianeta sconosciuto dove le categorie
lazioni, dove si incontrano i coetanei e anche
di spazio, di tempo, la memoria e l'attesa
adulti che hanno una funzione simile a quel-
hanno connotati difficilmente comprensibili
la dei genitori (cura, accudimento, protezio-
dagli adulti.
ne, affetto), ma con mansioni e ruoli diffe-
Tutto questo contribuisce allo sviluppo
renti, con specifica valenza sociale, cogniti-
dell’identità del bambino, che costituisce
va, affettiva e relazionale. Il contesto del ni-
uno degli elementi principali del progetto
do d’infanzia deve essere accogliente, deve
pedagogico del nido: si promuove
prestare attenzione ad alcuni momenti signi-
l’autoconsapevolezza attraverso il processo
ficativi come ad esempio le routine quotidia-
di separazione/distinzione fra il sé ed il fuori
ne, attraverso le quali si trasmettono cono-
di sé mediante la relazione educativa.
scenze, valori, consuetudini e modelli ad-
Il nido rappresenta, pertanto, uno spazio
dottati sia dalla famiglia che dal contesto so-
ricco di relazioni diversificate fra adulti e
ciale di appartenenza. Oltre
bambini e fra coetanei, ha delle caratteristi-
all’interiorizzazione delle routine giornaliere,
che peculiari difficilmente rinvenibili in altre
l’inserimento al nido rappresenta un mo-
esperienze di relazione e socializzazione del
mento complesso, delicato e fondamentale
bambino. Il nido, configurandosi come espe-
basato sugli stili di attaccamento dei bambi-
rienza quotidiana, consente la possibilità di
ni, come aveva chiarito lo studio di Bowlby
stabilire e sperimentare rapporti "regolari" e
(1979).
"abituali" che, in quanto tali, sono prevedibi-
Si tratta di agire con gradualità, evitando
li da parte del bambino. Routine, azioni, ge-
il distacco improvviso del bambino dalla
sti, parole, ritmi nel loro alternarsi e ripetersi
madre ed adottando delle strategie persona-
scandiscono l'esperienza al nido. Tale pre-
lizzate al fine di rendere questa esperienza
vedibilità, in quanto realizzazione di un'a-
positiva. Il distacco affettivo e la cura hanno
spettativa, agisce positivamente sulla co-
forti implicazioni psicologiche e riguardano
struzione del sé.
la soddisfazione dei bisogni primari come
Tenere conto delle modalità attraverso le
l’alimentazione, la prevenzione delle malat-
quali si forma, si struttura e si elabora la co-
tie, oppure bisogni direttamente fisici come
scienza e l'esperienza del sé, nel bambino da
la pulizia del corpo. Oggi gli educatori sono
zero a tre anni, non significa accostarsi ad
molto più esperti nell’attenzione ai problemi
un problema teorico solo in termini conosci-
relativi alla crescita e allo sviluppo grazie ai
tivi o puramente astratti, ma analizzare con
contributi che si sono avuti dagli studi sulla
quali modalità, nel nido, i bambini svilup-
prima infanzia.
pano la rappresentazione del sé. Essa costi-
tuisce una costellazione di fattori interdi-
pendenti, che prende fisionomia e si orga-
© Educare.it (rivista on line - ISSN: 2039-943X) - Vol. 20, n. 3 – Marzo 2020
63
63URL: https://www.educare.it/j/temi/scuola/scuola-e-dintorni/3957
nizza correlando, in maniera organica, i Un progetto ed una programmazione
propri linguaggi interni a quelli dell'ambien- educativa legati al concetto di strutturazione
te. dell'identità, -quindi alla consapevolezza di
Tale analisi deve essere tenuta presente e un intervento che abbia presente la globalità
comportare una chiarezza di impostazione dell'esperienza infantile e l'unicità del bam-
nella programmazione educativa, dove si bino- deve mirare ad offrirgli occasioni che
individuano gli obiettivi pedagogici, si ela- lo aiutino ad elaborare l'immaginario, a co-
borano metodologie di intervento, si metto- struire oltre la soglia del reale.
no in atto strategie organizzative, si struttu-
rano spazi, ritmi e routine di vita confluenti Il gioco al nido
agli obiettivi fissati.
Nel mosaico del patrimonio pedagogico
La programmazione educativa deve tene-
del nido e all'interno della programmazione
re conto della necessità di agevolare, nel
educativa, grande rilevanza ha l'esperienza
processo di sviluppo del bambino, una
di vita collettiva. I bambini sperimentano
"conversazione" intesa come scambio, atto
un'articolata rete di relazioni, con adulti di-
circolare, processo sociale dove le risposte
versi da quelli che incontrano in famiglia e
dell'ambiente aiutano a definire sé stesso, a
con coetanei. Il gruppo dei coetanei diventa
strutturare la propria permanenza nel corso
occasione di socialità, di gioco che si arric-
dell'evoluzione temporale, nonostante i suoi
chisce e complessifica nelle relazioni.
mutamenti di carattere fisico, motorio, intel-
Alcune ricerche condotte all’interno del
lettuale e sociale.
nido rilevano che, durante l'interazione di
La consapevolezza della propria perma-
gioco, che si svolge attraverso lunghe se-
nenza significa sperimentare il sentimento
quenze, i bambini sembrano non solo con-
di identità all'interno di due contesti diversi,
dividere un'attività con il coetaneo, ma ad-
quello familiare e quello del nido, che non
dirittura comprendere di svolgerla in comu-
vanno né confusi né percepiti come separati,
ne (Macinai, 2011). Le modalità di scambio
ma vissuti con il senso della continuità, af-
fra bambini hanno inoltre un’enorme in-
finché il bambino organizzi la sua mappa af-
fluenza sullo sviluppo socio-affettivo e
fettiva e cognitiva in maniera non disgrega-
quindi esiste una stretta correlazione fra in-
ta. Avere presente l'obiettivo della struttura-
terazioni reciproche, imitazione e sviluppo
zione dell'identità significa, per gli educatori
cognitivo.
del nido, dare al bambino il senso della pro-
Nel gioco collettivo l'attività dell'uno è
pria efficacia, cioè percepirsi come capace di
determinata dall'azione degli altri. Queste
autonomia, centro di iniziativa che produce
indicazioni definite "organizzatrici" nascono
effetti sulla realtà che lo circonda e sugli al-
dalla conservazione della realizzazione fatta
tri. Se gli atteggiamenti degli educatori sono
dal compagno. Tale osservazione amplifica
di continua disconferma, o contraddittori,
progressivamente l'azione iniziale del bam-
possono non solo provocare incertezza e
bino che risulterà essere la rielaborazione
confusione, ma determinare nel bambino la
della propria attività confrontata ed elabora-
percezione di una propria incapacità di su-
ta, utilizzando l'esperienza dell'altro.
scitare atteggiamenti positivi.
© Educare.it (rivista on line - ISSN: 2039-943X) - Vol. 20, n. 4 – Aprile 2020
64URL: https://www.educare.it/j/temi/scuola/scuola-e-dintorni/3957
Nel gioco con l'altro, come nella conver- di restare soli con sé stessi e pensare, consi-
sazione e in qualunque attività o esperienza derare, rielaborare, fantasticare. A tale scopo
condivisa, il bambino del nido acquisisce la concorrono luoghi personali come cassetti in
nozione di "contingenza interpersonale", cui riporre oggetti familiari, come il ciuccio,
cioè sviluppa la capacità di tenere conto il bavaglino etc.
dell'altra persona e può far dipendere e mo- Quanto detto ci fornisce le indicazioni
dificare i propri comportamenti da quelli fondamentali per l'organizzazione degli
degli altri, realizzando non solo il supera- spazi al nido e soprattutto per la loro conno-
mento del proprio egocentrismo, ma una tazione. Gli spazi non possono essere indif-
competenza comunicativa determinata ferenziati perché non sarebbero distinguibili
dall'educazione al rapporto che è uno degli dal bambino; non possono essere neutri ma
obiettivi principali del nido (Cera, 2009). significativi; non possono essere, infine, pur
nella loro flessibilità, non strutturati. Ogni
Il nido d’infanzia come spazio di ap- ambiente, da quello igienico a quello dedica-
prendimento inter-attivo to al riposo o alle attività, deve essere con-
notato con gli elementi che consentono al
Il nido d’infanzia rappresenta uno spazio
bambino di riconoscerne la specificità. Tale
materiale dove un insieme di elementi inte-
specificità, se da una parte deve rispondere
ragiscono fra di loro come la forma, gli arre-
all'impianto pedagogico adottato dagli edu-
di, gli oggetti, la luce, gli angoli strutturati e
catori e ai criteri di funzionalità del nido, ha
non. E’ presente anche una componente
soprattutto il valore di costituire un ambien-
immateriale ed è determinata dal modo in
te differenziato che favorisce un funziona-
cui gli educatori e i bambini vivono quel
mento psicologico e comportamentale più
contesto educativo in termini di gioco ed at-
articolato.
tività quotidiane.
In definitiva, al nido la strutturazione del-
L'importanza dell'organizzazione dello
lo spazio ha una marcata funzione educati-
spazio nei nidi d’infanzia nasce dal fatto che
va, a partire dalla sua configurazione archi-
per i bambini rappresenta l'immagine del
tettonica e dall'ambiente in cui è inserito
mondo esterno che essi hanno rispetto
(Borghi, Guerra, 2006).
all'ambiente familiare. Nella progettazione
Non è ininfluente strutturare il nido in un
degli spazi del nido si deve garantire ai
unico ambiente grande ed indifferenziato o
bambini luoghi in cui possano sentirsi pro-
suddividere lo spazio in sezioni; creare un
tetti, spazi come gli angoli "morbidi" con
sistema di illuminazione piuttosto che un al-
tappeti e cuscini, pupazzi e bambole, oggetti
tro; operare una previsione della percorribi-
affettivamente rassicuranti.
lità interna o lasciarla al caso; prevedere l'in-
Parallelamente si deve creare opportunità
sonorizzazione o meno degli ambienti, stu-
affinché i bambini imparino a dominare lo
diare la razionalità dei tragitti per gli adulti
spazio e a non subire costrizioni ed impe-
e il rapporto tra esterno ed interno.
dimenti da esso (Restiglian, 2012).
La stessa articolazione in sezioni, relative
Inoltre, è importante consentire al bambi-
a gruppi di bambini scelti per età omogenea,
no di passare da momenti di socializzazione
dovrebbe essere fatta attorno ad un punto
a tempi e spazi nei quali è possibile scegliere
nodale di incontro, che può essere rappre-
© Educare.it (rivista on line - ISSN: 2039-943X) - Vol. 20, n. 3 – Marzo 2020
65
65URL: https://www.educare.it/j/temi/scuola/scuola-e-dintorni/3957
sentato da un ambiente comune che offra Ulteriori opportunità possono essere of-
possibilità di incontro libero tra bambini di ferte ai bambini articolando spazi non strut-
età diversa. turati per il gioco libero e di avventura.
Se si analizzano gli spazi esterni al nido,
spesso si presentano privi di attenzione pe- Considerazioni conclusive
dagogica, come se i bambini fossero destina-
Il senso più profondo di questa riflessione
ti a vivere solo all'interno del nido, quando
sul nido d’infanzia è insito nel suo essere
invece dovrebbero consentire molteplici
“luogo” di relazioni ed apprendimento ludi-
esperienze. Per questo motivo la loro strut-
co. Al centro c’è l’intervento educativo che
turazione deve orientarsi a creare zone pro-
pone lo sviluppo di relazioni significative
tette ed organizzate, come quelle chiamate
tra adulti e bambino e tra i bambini.
“ponte” che collegano l'interno con l'esterno,
La pedagogia dell’ascolto, degli affetti,
accessibili con autonome uscite dalle varie
delle relazioni e dell’organizzazione degli
sezioni. In queste zone si possono ricreare,
spazi di apprendimento viene così a fondare
in spazi protetti con opportunità di giochi
un segmento fondamentale delle scienze
tranquilli, di attenzione, letture di libri e so-
dell’educazione che devono oggi sempre più
prattutto anche occasioni di relax come dife-
dialogare con le istituzioni per aiutare il
sa della propria identità e del bisogno di evi-
bambino a “vivere una vita buona” (Mon-
tare intrusioni degli altri che possono spez-
tessori) sin dalla più tenera età.
zare i magici momenti di irrealtà fantastica.
Riferimenti bibliografici
Borghi B. Q., Guerra L., Star bene al Nido d’Infanzia. Strumenti per la gestione organizzativa ed educativa dell’asilo nido,
Junior, Bergamo, 2006.
Bowlby J., Attaccamento e Perdita, Bollati Boringhieri, Torino, 1979.
Buccolo M., L’educatore emozionale, percorsi di alfabetizzazione emotiva per tutta la vita, Franco Angeli, Milano, 2019.
Catarsi E., Fortunati A. (a cura di), La programmazione-progettazione nell’asilo nido, La Nuova Italia, Firenze, 1989.
Cera R., Pedagogia del gioco e dell'apprendimento. Riflessioni teoriche sulla dimensione educativa del gioco, Franco Angeli,
Milano, 2009.
Dewey J., Dewey e l’educazione progressiva, Carocci, Roma, 2009.
Frabboni F. (a cura di), Programmare al nido. I problemi, le procedure, gli strumenti, La Nuova Italia, Firenze, 1990.
Galardini A.L. (a cura di), Crescere al Nido, Gli spazi, i tempi, le attività, le relazioni, Carocci, Roma, 2012.
Macinai E., Nido dei bambini e delle bambine. Formazione e professionalità per l'infanzia, ETS, Pisa, 2011.
Mantovani S., “La programmazione al nido” nella prospettiva interattivo-costruzionista, in F. Frabboni (a cura di),
Programmare al nido. I problemi, le procedure, gli strumenti, La Nuova Italia, Firenze, 1990.
Restiglian E., Progettare al nido. Teorie e pratiche educative, Carocci Faber, Roma, 2012.
© Educare.it (rivista on line - ISSN: 2039-943X) - Vol. 20, n. 4 – Aprile 2020
66Puoi anche leggere