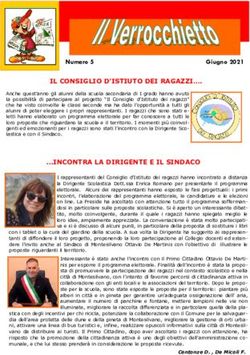ANIMAL studies Fenomenologia e animalità II - Rivista italiana di antispecismo - Novalogos
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
ANIMAL studies
Rivista italiana di antispecismo
trimestrale
anno vi numero 19
Fenomenologia e animalità IIANIMAL STUDIES Rivista italiana di antispecismo trimestrale 19 – Fenomenologia e animalità II numero a cura di Luca Vanzago e Lucia Zaietta Direttore responsabile ed editoriale Roberto Marchesini Comitato scientifico Ralph R. Acampora (Hofstra University) Carol Adams (Southern Methodist University) Matthew Calarco (California State University Fullerton) Felice Cimatti (Università della Calabria) Enrico Giannetto (Università degli studi di Bergamo) Oscar Horta (Universidade de Santiago de Compostela) Andrew Linzey (University of Oxford) Peter Singer (Princeton University) Tzachi Zamir (The Hebrew University of Jerusalem) Redazione Eleonora Adorni, Matteo Andreozzi, Laura De Grazia, Alessandro Lanfranchi, Manuela Macelloni, Valentina Mota, Roberta Papale, Lucia Zaietta, Nicola Zengiaro. ISSN 2281-2288 ISBN 978-88-97339-76-2 Reg. Trib. Roma n. 232 del 27/7/2012 © 2017 NOVALOGOS/Ortica editrice soc. coop. via Aldo Moro, 43/D - 04011 Aprilia www.novalogos.it • info@novalogos.it finito di stampare nel mese di settembre 2017 presso la tipografia ristampa s.r.l., cittaducale (ri)
Sommario
5 Editoriale
Di Luca Vanzago, Lucia Zaietta
Articoli
9 Prendersi cura del mondo. L’ecologia dell’essere in-relazione
Di Roberto Marchesini
25 Guardando dal di dentro, pensando dal di fuori
Di Matthew Calarco
37 Biodiversità e diacritica della vita
Di Ted Toadvine
56 Esodo ed esilio
Di Renaud Barbaras
71 Il versante animale
Di Jean-Christophe BaillyEDITORIALE
Di Luca Vanzago e Lucia Zaietta
Si arricchisce di nuovi sviluppi la riflessione che abbiamo avviato nel numero
16/2016 e si conclude, con queste pagine, la nostra inchiesta sui rapporti tra
fenomenologia e animalità. Fenomenologia, innanzitutto. Sono stati infatti il me-
todo e la storia della fenomenologia a farci da cornice in questo progetto, a par-
tire dalla traduzione del testo del 1934 Il mondo e noi. Mondo-ambiente umano e
animale, Appendice X (XV volume della Husserliana) – pubblicata per la prima
volta in lingua italiana nel numero di Animal Studies Fenomenologia e animalità
I – in cui Edmund Husserl si interroga sulla soggettività animale, e su come la
nostra soggettività umana la possa cogliere e comprendere. Su questa scia, si sono
succeduti i contributi di Florence Burgat, Carmine Di Martino, Brett Buchanan
e Renato Boccali, grazie ai quali è emersa la ricchezza e la profondità delle decli-
nazioni fenomenologiche intorno alla questione dell’animalità e della differenza
antropologica. Che cosa hanno da dire, oggi, le pagine di Heidegger, di Sartre e
di Merleau-Ponty intorno al tema dell’animale? Che cosa ci insegna la tradizione
fenomenologica, attraverso la sua inchiesta sullo statuto della correlazione tra-
scendentale, intorno all’abitare animale? Come comprendere l’essere-al-mondo
animale, nella sua povertà e insieme ricchezza di mondo? Erano queste le doman-
de che hanno accompagnato i contributi della nostra prima riflessione.
Anche nel numero che qui presentiamo, la fenomenologia resta lo sfondo
privilegiato, ma in un senso più esteso e con un respiro più ampio. Voci cen-
trali e autorevoli nel panorama fenomenologico contemporaneo, come quelle
di Renaud Barbaras e di Ted Toadvine, si alternano a grandi studiosi di confine
5animal studies 19
e del confine, quali Roberto Marchesini, Matthew Calarco e Jean-Christophe
Bailly, le cui riflessioni, e contaminazioni, creano incroci inediti tra filosofia,
etica, etologia e persino letteratura. Accanto alla fenomenologia, intesa in que-
ste pagine nel suo significato più originario e fecondo, resta la domanda sulla
specificità dell’animale, degli animali. Sono ancora loro, nella loro pluralità, i
protagonisti dei contributi che andiamo a presentare.
Animali di cui prendersi innanzitutto cura, come ci invita a fare la riflessione
che apre il nostro numero, firmata da Roberto Marchesini. Direttore del Cen-
tro Studi Filosofia Postumanista, della Scuola di Interazione Uomo-Animale
(SIUA) e Direttore Editoriale della rivista Animal Studies, Roberto Marchesini
propone un originale approfondimento sulla cura, un tema che si trova al cen-
tro della fenomenologia (basti pensare a Husserl stesso, Heidegger, Lévinas) e,
ovviamente, al centro della riflessione sulla relazione uomo-animale. È proprio
la propensione epimeletica, infatti, a sospendere il pensiero proiettivo alla base
dell’antropocentrismo e ad aprire uno spazio di incontro, di relazione e di ac-
cudimento, da esplorare con un approccio interdisciplinare.
Anche l’intervento di Matthew Calarco – Guardando dal di dentro, pensando
dal di fuori – mette in opera un decentramento radicale. Professore di Filosofia
continentale e ambientale presso la California State University, autore di Zo-
ografie (Mimesis, 2012) e voce di rilievo negli Animal Studies, Calarco prende
spunto dall’esperienza e dalla riflessione della filosofa australiana Val Plumwo-
od per ripensare la soggettività – e l’alterità – animale. L’attacco da parte di
un coccodrillo subito da Plumwood, evento che è al centro della sua stessa
filosofia, fa da cornice a una fenomenologia dell’impresentabile: comprendere
l’Altro non solo nella sua esteriorità, e dunque estraneità, ma anche nel suo
‘dentro’, nella sua interiorità, permetterà forse di reinstallare l’alterità al nostro
fianco, riconsiderando la sua soggettività e il nostro stile di vita.
Si tratta di un’alterità, come abbiamo accennato prima e come ci ha defi-
nitivamente insegnato Derrida, da pensare al plurale, nella sua specificità e,
allo stesso tempo, nella sua molteplicità. È questo il compito prefissato dalla
preservazione della “biodiversità”, una parola e un concetto ormai onnipre-
sente nell’ecologia contemporanea, che Ted Toadvine – professore di Filosofia
e Environmental Studies alla Oregon University e punto di riferimento negli
studi tra fenomenologia ed ecologia – mette sotto inchiesta nell’articolo che
6editoriale
qui propone, Biodiversità e diacritica della vita. Le differenze nelle e delle forme
di vita sono al centro di ogni pensiero rivolto all’animalità, ma come compren-
dere queste differenze? La nozione di biodiversità rende davvero giustizia alla
variabilità delle forme di vita? Sulla scia della fenomenologia di Merleau-Ponty
e dell’ermeneutica diacritica di Richard Kearney, Toadvine ci sottopone una
stimolante e profonda alternativa al ‘dogma’ della biodiversità, un’alternativa
che prende il nome di biodiacritica. Comprendere la polisemia delle forme di
vita all’interno di un sistema diacritico, composto e retto esso stesso da livelli
e scarti, può infatti condurci a un’ermeneutica carnale, estesa al di là dei limiti
umani «fino a letture diacritiche dei differenti tipi di Altri – umani, animali e
divini. Tutti in carne e ossa» (Kearney 2011).
All’interno del panorama della fenomenologia contemporanea, la proposta
di Renaud Barbaras è ineludibile e rappresenta uno dei contributi più pro-
fondi. La sua fenomenologia dinamica, incentrata sulla nozione di desiderio,
investe ogni aspetto del pensiero sul vivente, e sulla vita stessa. Professore di
Filosofia contemporanea all’Université Panthéon Sorbonne di Parigi, membro
dell’Istituto Universitario di Francia e autore di studi critici fondamentali per
approfondire la filosofia di Husserl, Merleau-Ponty, Patočka, nonché di pro-
poste originali tra le quali citiamo Introduzione a una fenomenologia della vita
(Mimesis 2014) e Dinamica della manifestazione (Lythos 2017), Renaud Bar-
baras interviene nel nostro numero con una riflessione sulle modalità di abitare
il mondo proprie dell’animale e dell’uomo. Senza adottare un continuismo
biologico, che non renderebbe giustizia alle specificità di entrambi, ma senza
d’altra parte marcare una separazione netta e ormai ingiustificabile, Barbaras
caratterizza la modalità dell’essere al mondo animale e umano rispettivamente
come esodo e come esilio: prossimità e distanza, dentro e fuori, sono così ricom-
presi all’interno di una fenomenologia dinamica che riconosce una separazione
originaria e, dunque, l’emergenza di un desiderio che è la modalità prima della
soggettività e terreno comune tra uomo e animale.
Conclude infine questo numero, e così il nostro percorso tra fenomenologia
e animalità, Jean-Christophe Bailly. Scrittore, poeta, drammaturgo e filosofo,
Bailly si è recentemente interessato alla questione animale pubblicando Le versant
animal (Bayard, 2007) e Le parti pris des animaux (Seuil, 2013; tradotto in Italia
da Nottetempo, 2015). La proposta di Bailly non si configura come uno studio
7animal studies 19
sistematico sull’animalità (nozione dalla quale Bailly prende esplicitamente le di-
stanze), ma si presenta anzi come un invito a guardare ai modi di abitare animali,
alle tracce, alle piste e alle reti inestricabili di segni che gli animali lasciano con
il loro passaggio fugace. Assimilabile per certi versi all’appello di von Uexküll, il
richiamo di Bailly evoca la dimensione dell’Aperto di Rilke, quell’infinita gram-
matica di segni e fraseggi attraverso cui si dispiega l’inesauribile manifestazione
di senso dei mondi animali. A conclusione del nostro percorso, abbiamo dunque
scelto di riportare, per la prima volta in traduzione italiana, alcune tra le pagine
più dense e suggestive del libro Le versant animal (capp. 19-23).
8PRENDERSI CURA DEL MONDO.
L’ECOLOGIA DELL’ESSERE IN-RELAZIONE
Di Roberto Marchesini
La dimensione della cura, nelle sue diverse scansioni – dall’esercizio me-
todologico in Husserl alla liberazione dell’autentico nell’altro in Heidegger,
dalla presa in carico della solitudine dell’alterità in Lévinas al pudore che lo
sguardo dell’altro suscita in Derrida – ci parla di un “essere nella relazione”
come fondamentale dell’umano. Nel seminario della cura, un flusso ricorsivo
sul Sé che eccentra, gratifica, coniuga e poi amplifica la propensione a venire,
l’atto epimeletico – dal greco epimeleomai = mi prendo cura – trascende l’a-
spetto meramente prassico dell’atto tutorale, per divenire attribuzione di senso,
ragione di presenza che consente al Sé di sfuggire dalla gravitazione egoica. La
cura ritorna sempre su chi ne fa professione di fede quale fattore ontopoietico
capace di mescolare l’empito proiettivo del vissuto con l’attribuzione di senso.
Nel flusso epimeletico la presenza diventa vita-attiva, sguardo sospensivo e ri-
ordinativo sul divenire fenomenico.
La cura è sempre coniugata all’empito di proiezione oltre il qui-e-ora, pur
inverandosi nell’istantaneità e nella corposità della presenza, giacché è indirizzo
di crescita, ricerca di un ordine capace di sfidare l’entropia, preoccupazione
attiva orientata a un obiettivo, attesa di una rivelazione nel flusso di dettagli
da setacciare. L’evento epimeletico rende la presa in carico dell’Erlebnis quale
inevitabile “momento di ritorno”, successiva consapevolezza di una copula già
avvenuta, cosicché il Sé è sempre partecipe di predicati di espressione che non
sono mai fedeli al retaggio pregresso ma frutti a posteriori del flusso ibridativo.
In tal senso la cura precede il vissuto. L’epimelesi è eccentramento nell’alteri-
tà e, per contro, ricorsiva emergenza ontopoietica, poiché inaugura il rinno-
vamento del Sé attraverso la protezione dell’altro, poiché avvolge, condivide,
9animal studies 19
crea partecipazione: nel dedicarsi e nel darsi s’accentua il significato relazionale
dell’essere e la sua solidità nell’essere.
L’essere preoccupato precede e sostanzia l’essere occupato, coniuga il filoge-
netico mammale con l’ontopoietico decentrativo e dubitativo, proprio nell’a-
limentare il prendere distanza dal Sé per realizzarne una presenza reale e non
occasionale. Questo è forse il tratto più affascinante dell’atto epimeletico, che
non disgiunge o distanzia le diverse scansioni dell’essere ma le coniuga in un
millepiani dimensionale, in una coerenza che non è mai staticità, regressione
nel retaggio. Nella cura si svolge, come un germoglio foliare, la nostra natura
di mammiferi, le risonanze remote del nostro essere primati, l’avvolgente calore
amniotico del primo mondo, l’orbitare intorno alla base sicura del processo di
attaccamento, la crescita prossimale del dialogo materno, l’espansione adole-
scenziale dello scacco relazionale fino alla problematica e affascinante ricerca di
un senso capace non di cancellare il fenomeno ma di farlo giungere infine alla
stazione dell’epifania.
La cura non è mai espressione tal quale di una competenza pregressa, messa
in atto quasi per emanazione di una dotazione acquisita, tale per cui si possa
dire che nella donazione il retaggio esprime le sue doti in purezza, giacché è
sempre evento emergenziale, esito della congiunzione, potremmo dire “crea-
tivo”, nel senso di innovare-inventare un piano di realtà, sempre che si tenga
in certezza la natura dialogica e non solipsistica del creare. L’essere umano che
apre a ventaglio il gesto nella semina, che adotta un cucciolo d’altra specie,
che trasforma la coreografia motoria del proprio corpo, che confeziona uno
zufolo per riprendere-rispondere alla sinfonia del mondo o che misura con lo
sguardo gli spazi dell’infinito, proprio nella contraddizione interna di queste
proiezioni, crea un nuovo piano di realtà, perché non precedente, e fa emergere
il senso come risultato dell’atto dialogico-relazionale. Il senso non è mai perciò
qualcosa di nascosto da scoprire, bensì una possibilità da far emergere nel mare
magno del virtuale attraverso un concepimento: tale è in effetti la cura.
La cura rende l’essere umano copula mundi, ma non nel significato antropo-
plastico, cui ci ha abituato la pretesa antropocentrica dell’età moderna, bensì in
quello ibridativo, nel far emergere i predicati dell’umano non attraverso il pri-
sma emanativo o essenzialistico, ma nel loro tratto di sopravvenienza, nell’es-
sere cioè frutti relazionali. Prendersi cura del mondo allora non ci riporta a un
atto paternalistico, di chi ponendosi al di sopra impone, anche nella luce della
generosità, la propria mano benevolente, né ricade nella demiurgica attribu-
zione di senso o nominazione del mondo, ma nel saper coniugarsi, nell’umiltà
10prendersi cura del mondo. l’ecologia dell’essere in-relazione
dell’accoglienza e della contaminazione. La cura pertanto non è mai limitata
alla sua espressione prassica, non è mai solo un’azione e non può essere confi-
nata o ricondotta al mero valore produttivo. L’epimelesi è una condizione del
soggetto che, sospendendo l’angustia del pensiero proiettivo, la gravitazione
del narcisismo ma altresì l’eziologia riflessiva dell’inanizione, si apre non solo
alla relazione, ma alla trasformazione del Sé.
La cura come epifania
Se ci è negato l’atto riflessivo sui predicati, ovvero se la via cartesiana del
cogito è fuorviante perché il suo risultato è ancor più aleatorio del nostro os-
servatorio sul mondo, giacché siamo sempre coscienti di un ex post copulativo,
diviene conseguente il riflettere sul fenomeno, che difficilmente può rimanere
di fronte a noi, ossia disgiunto e a sé, perché sempre il flusso epimeletico lo
trasforma in qualcosa che ci riguarda, nel senso di rivelare matrici dimensionali
disponibili al divenire ontopoietico. Non è meramente una fruizione e tuttavia
anche la contemplazione è sempre una partecipazione immersiva, ovvero che
mi riguarda, nel panorama, un contaminarsi con esso e trasformarsi attraverso
esso. La distanza o, meglio, la disgiunzione è solo apparente, così come appa-
rente è la sua dimensione di fondale per lo sguardo o di spazio contenitivo. La
partecipazione, innescata dal flusso epimeletico, ossia dall’inevitabile tendenza
a guardare il mondo cercando di far emergere un ordine che ci riguarda, o di
sottrarlo all’algore dell’entropia, trasforma il fenomeno in epifania.
Quando parlo di una prospezione epimeletica, inevitabile nell’essere uma-
no perché attinente a ciò che più di profondo e autentico c’è nella condizio-
ne umana, intendo rimarcare il fatto che non siamo in grado di sottrarci da
questo flusso di ospitalità che sta alla base della nostra ontologia. L’ospitalità
è un modo d’intendere il rapporto con il mondo, accogliendolo e cercando
accoglienza in esso. E mi rendo conto che, valutando la storia dell’umanità, le
guerre e i genocidi, o la crisi ecologica in atto, questa mia professione di fede
nell’umano sembra peccare di ottimismo o comunque essere assai controintui-
tiva. Tuttavia non credo che la dimensione umana, nelle sue diverse espressioni
culturali, nella scienza come nella poesia, possa/debba essere ricondotta al solo
empito autoaffermativo, a una generica volontà di potenza. C’è un continuo
spaccio di cura nell’agire umano, un desiderio materno di preservare, mettere
in ordine, sostenere e tutorare, un empito amniotico verso il mondo che rende
11animal studies 19
l’umano non già tensionale nella verticalizzazione disgiuntiva – quale ci sotto-
linea Peter Sloterdijk in You must change your life – ma nell’orizzontalizzazione
coniugativa.
Il flusso epimeletico, proprio nel suo archetipo protettivo, trasforma il
nostro rapporto con il mondo sul modello relazionale che s’instaura tra una
madre e il proprio cucciolo. In questo senso ribadisco il mio credo in una
prevalente declinazione femminile della condizione umana e nel significato
maternale dell’antropo-poiesi. Possiamo allora dire che la cura trasforma l’in-
tersezione al fenomeno in un atto evolutivo a doppio senso: i) da una parte ciò
che appare non è mai solo un’estrazione parziale riferibile alla umwelt umana,
ma è sempre un’ibridazione, esito cioè della proiezione del Sé nel mondo; ii)
dall’altra il soggetto non si trova mai di fronte al fenomeno ma dentro di esso,
disperso in esso e posseduto da esso, cosicché si riconosce non nel retaggio ma
nell’oltrepassarsi. Chiamo questo doppio flusso predicativo, ossia di emergenza
creativa di predicati, con il termine di “epifania”.
La cura, in altri termini, apre la strada a quell’evento epifanico che rimarca
la necessità di riconoscere l’essere non nel retaggio ma nella trasformazione di
questo, nella capacità cioè dell’essere di oltrepassarsi, nel rivelare una propria
presenza nella violazione del dato, nell’infedeltà al consolidato, nella meta-
morfosi. A questo aggiungasi – ma, a ben vedere, non è altro che una seconda
prospettiva dello stesso concetto – che la cura mostra il significato relazionale
dell’ontologia, che non può essere raggiunta attraverso operazioni enucleative,
giacché l’essere costruisce i propri predicati nell’ibridazione e non per emana-
zione. Se è vero che esiste una propensione epimeletica dell’essere umano, che
possiamo indagare con diverse ottiche disciplinari ed epistemologiche, è altret-
tanto vero che la cura non è mai adesione al pregresso bensì utilizzo dell’acqui-
sito per operarne un superamento.
Il soggetto che si prende cura, dal momento che nell’epimelesi si proietta
nell’altro e si coniuga a lui, non può ritrovare o pretendere di mantenere un
proprio, quasi fosse un carattere essenziale da preservare, ma deve accettare
la condizione di rivelatore di predicati ibridi. Ora, il mio ragionamento può
essere equivocato in due modi: i) il ritenere che in questa prospettiva venga
totalmente annichilito il retaggio, rendendo di fatto il Sé a tal punto elusivo
che qualunque discorso su di lui assuma il valore dell’arbitrarietà; ii) il conside-
rare, viceversa, il retaggio così rilevante da trasformare l’evento epimeletico in
nient’altro che un atto surrogatorio della propensione parentale, con il rischio
di un riduzionismo. Voglio subito sgombrare il campo da questi equivoci. Dal
12prendersi cura del mondo. l’ecologia dell’essere in-relazione
mio punto di vista parlare di un evento dialogico-ibridativo, vale a dire di una
prevalenza dell’epifania sul fenomeno, non significa negare una presenza e una
costituzione dei dialoganti. Sostenere l’importanza della natura umana, per
converso, non significa far discendere i predicati in modo diretto dal retaggio.
Quando parlo di estrazione matriciale dalla virtualità del reale, al fine di
costruire un piano di realtà, non intendo sostenere la nullità del reale, ma il
suo carattere virtuale, vale a dire il presentare dei vincoli di resistenza ma, al
contempo, dei campi di possibilità organizzative, tali per cui l’intersezione di
risulta non è altro che il modo attraverso cui il Sé, rispettando i vincoli, realizza
in modo singolare un proprio piano organizzativo di realtà. Per tale motivo
l’epifania non può prescindere dal retaggio e dal fenomeno, ma altresì non
dev’essere appiattita in essi. L’epimelesi è una tendenza profonda, precedente
per alcuni aspetti all’emergenza della nostra specie, e tuttavia l’espressione epi-
meletica – il modo attraverso cui la cura si realizza e i frutti che produce – non
può essere ricondotta esclusivamente a detta tendenza. Ogni espressione di
cura è sempre un atto creativo, un parto capace di portare singolarità sotto la
volta del mondo, non un ripetersi ciclico.
Pertanto, se è pur vero che la propensione epimeletica ci riporta a qualcosa
di profondo, che trascende la nostra individualità e precede il nostro essere get-
tati nel mondo, risonanza di età lontanissime e rivelazione di condivisioni che
vanno oltre la dimensione umana, non possiamo dimenticare altresì che la cura
è come lo sviluppo della chioma di un albero, si appella alla luce e alla spinta
vitale dell’essere-un-corpo che nella singolarità del vissuto – inteso husserliana-
mente non come participio passato – trova il suo palpito: è cioè il frutto di un
esercizio alla relazione dedita e all’accudimento. Questo esercizio richiede una
palestra che nell’essere umano trova la maggior soddisfazione nella dedicazio-
ne alla crescita del vivente. Si usa la predicazione del coltivare per significare
una crescita tolta alla casualità e all’occasionalità perché tutorata, sostenuta,
indirizzata, e la rivolgiamo agli interessi, alle passioni, alla ricerca, allo studio,
all’amicizia e all’amore.
La costruzione del paesaggio è un esempio della lettura epifanica dell’am-
biente, che risente di un millepiani ibridativo che, come sottolineato da Edward
Wilson nel saggio Biofilia, risente di risonanze remote, come la tendenza a
privilegiare un panorama fatto di alberi distanziati tra loro da prati erbosi in
un’estetica che risente di prototipicità filogenetiche che l’autore attribuisce al
desiderio di riproporre un orizzonte a savana ove si è svolta gran parte del
cammino speciativo del nostro lignaggio. Potremmo allora ipotizzare che la
13animal studies 19
rivoluzione agricola abbia avuto come primo movens non già un bisogno di re-
perimento di risorse alimentari, che sarebbero divenute un ex post facto ovvero
una disponibilità, bensì un significato primariamente epimeletico. Le attività
di coltivazione rappresentano infatti non solo la radice antica di un flusso cul-
turale che ha trasformato l’umano, luogo di relazione privilegiata tra l’essere
umano e la terra, ma andrebbero considerate quale cartina al tornasole di una
tendenza più complessiva: atelier evolutivo dell’antropopoiesi stessa.
La cura sembra essere perciò una delle caratteristiche che maggiormente
definiscono la dimensione umana nelle sue svariate espressioni, non solo come
attività di estrazione di un ordine nella realtà circostante o come modalità di
controllo sui fenomeni naturali – alla cura può infatti essere ricondotta sia la
tensione epistemico-tassonomica sia la facilitazione dei processi naturali utili
al sostentamento, sviluppati in specie con la rivoluzione neolitica – ma altresì
come ricerca di senso, quale tendenza a trasformare l’intersezione ai fenomeni
in epifanie ovvero a trasfigurazioni dell’evento in ibridazioni con l’alterità. In
particolare, per comprendere tale bisogno di superamento del fenomeno in sé
attraverso lo speculum della rivelazione – nel significato di cosa l’evento che mi
sta di fronte può annunciare che mi riguardi in modo diretto, ossia interna-
mente – è necessario soffermarsi sulla trasformazione dell’alterità da altro-da-sé
ad altro-in-sé, ovvero da fenomeno a epifania. L’alterità fenomenica dismette il
suo essere di fronte, vale a dire il suo carattere di estraneità, per quanto coinvol-
gente sotto il profilo emotigeno, rappresentazionale o elicitativo, nel momento
in cui rende disponibile o disvela un significato condizionale o dimensionale
che mi riguarda.
È in quel preciso momento che il volo di un uccello non è più qualcosa da
ammirare o da decrittare nei suoi caratteri previsionali o, ancora, da conoscere
come datità oggettiva, per assumere il significato rivelatore o epifanico, capace
cioè di modificare la mia dimensione esistenziale mostrandomi una condizione
possibile che mi riguarda. Il volo, nell’ibridazione epifanica che la rende dispo-
nibile all’essere umano, rivela o fa emergere una nuova prospettiva predicativa,
un nuovo senso alla mia presenza, grazie alla proiezione coniugativa che l’es-
sere-con rende possibile, investigabile, immaginabile. La cura entra in modo
diretto e profondo in tale emergenza metamorfica, consentendo una proiezio-
ne empatica sull’alterità, un con-sentire, che non è più simpatia, riflessione
egoica nell’altro, ma eccentramento nell’alterità. L’afflato epimeletico è un farsi
carico della prospettiva altrui che insiste-su, ovvero non può prescindere-da,
quelle risorse espressive che hanno reso praticabile l’ibridazione, in virtù di una
14prendersi cura del mondo. l’ecologia dell’essere in-relazione
sospensione sull’estraneità del fenomeno. Il volo è pertanto una creazione di
senso portata a mettere in discussione tanto l’estraneità del volo di un uccello
quanto il mio retaggio di creatura non dotata di volo.
La cura supera quella distanza tra me e l’altro che porterebbe a limitare
l’incontro all’interazione disgiunta, definendo la relazione nei termini tradi-
zionali del: i) polemos, ove l’alterità è il luogo del confronto e dell’opposizione
per oscillazione di sfondo, mantenendo la disgiunzione; ii) taxon, ove l’alterità
qualifica attraverso il tipo-gradiente di rapporto, sia esso omologico, analo-
gico o di referenza, definendo e quindi fondando la distanza; iii) proiettivo,
ove l’alterità diviene un contenitore o uno specchio che consente la riflessione
egoica senza apportare alcun contributo perché non riconosciuto; iv) infusivo,
ove l’alterità annichilisce o diluisce il retaggio, come se non ci fosse dialogo ma
semplice invasione-iscrizione. L’epifania definisce, al contrario, una soglia di
meticciamento capace di far emergere nuovi predicati in cui il soggetto si rico-
nosce proprio perché non aderente a una precedenza. Il senso pertanto non è
mai una costruzione arbitraria sul fenomeno, bensì un mettere in luce attraver-
so l’eccentramento quello che è sepolto all’interno dell’apparenza fenomenica.
L’epimelesi proprio per il suo carattere copulativo e quindi ibridativo rende
possibile quell’eccentramento che non è mai annichilimento del retaggio e del
fenomeno ma trasformazione del retaggio nel fenomeno e viceversa. L’errore
che potremmo fare può essere duplice: i) nell’appiattimento sulla disgiunzio-
ne e sulla stabilità ontica del retaggio e del fenomeno, come entità separate e
impermeabili che nell’incontro confermano i loro predicati precedenti; ii) nel
non riconoscere o nel pretendere una trascendenza assoluta dal retaggio e dal
fenomeno, tale per cui il primo non ha alcuna voce in capitolo nella ricerca
di senso e il secondo diventa una totale costruzione della proiezione del Sé.
La cura ci chiede di andare oltre l’immagine solipsistica della ricerca di sen-
so, per riportarla al millepiani dell’Erlebnis, che non guarda al passato, pur
appoggiandosi sulle molteplici risonanze ontopoietiche che nel loro insieme
portano a vivere l’esperienza, ma all’atto emergenziale di predicati che s’invera
nell’incontro con l’alterità. Non è possibile pertanto limitarsi a scavare all’in-
terno del flusso fenomenico, setacciando, accantonando, sospendendo, bensì
occorre attualizzare il molteplice, giacché l’esperienza non si pone mai su un
unico piano di vissuto.
A questo punto è perciò indispensabile comprendere che la propensione
alla cura ha una base remota nell’essere umano, risonanza di storie che talvolta
precedono il biografico o si perdono nella dimensione amnesica dell’infanzia.
15animal studies 19
La cura è un patrimonio che abbiamo ereditato dai nostri progenitori e da
un frattale dialogico che ci ha fatto emergere infine come entità individuata.
D’altro canto, i frutti predicativi che la dimensione epimeletica determina van-
no inquadrati, quasi per paradosso, nel senso di un superamento del retaggio
stesso, perché portati all’eccentramento rispetto alla condizione precedente e
perché in grado di operare una sospensione sull’apparizione fenomenica ovvero
sull’intersezione prima facie dell’evento. A mio avviso, pertanto, non è possibile
fare un ragionamento sul comportamento di cura senza prendere in conside-
razione alcune propensioni naturali dell’essere umano, pur facendo salve tutte
le articolazioni antropopoietiche, in primis culturali, che intervengono nella
definizione del prospetto della cura. Vorrei tuttavia chiarire il fatto che non
ritengo l’epifania o l’attribuzione di senso una mera discendenza diretta o ema-
nativa dei caratteri impliciti dell’essere umano, bensì il risultato emergenziale e
dialettico che tali caratteri rendono possibile. In tal senso i connotati dell’essere
umano vanno considerati come volani e non come generativi delle risultanze
epifaniche: non si può prescindere da loro, ma non li si può considerare esau-
stivi nell’esplicazione.
La dimensione epimeletica dell’essere umano
La tendenza a “prendersi cura di” – da cui la natura intenzionale dell’epi-
melesi – riguarda diversi aspetti nell’essere umano e parallelamente si riflette
su un orizzonte ampio di prospettive, come l’epistemologia, l’etica, l’estetica,
solo per citarne alcune. Tuttavia, per comprendere la base comportamentale di
questa attitudine, è necessario riferirsi al significato evoluzionistico o adattati-
vo di tale dimensione espressiva. Come ho detto, non ritengo che i predicati
umani vadano ritenuti espressioni dirette o discendenze emanative del retaggio
filogenetico ma, a mio avviso, sbaglia chi pretende di prescindere totalmente
da quella che rimane pur sempre la risonanza di retaggio più importante, ciò
che possiamo definire “natura umana”. L’essere umano è infatti il frutto di un
processo evoluzionistico che ha arricchito la nostra tavolozza cromatica non
solo di precise conformazioni anatomico-funzionali, ma altresì di propensio-
ni e sensibilità espressive, dotandoci di connotati che talvolta sono unici nel
nostro lignaggio, altre volte sono condivisi per omologia o analogia con altre
specie, in particolare con quelle più vicine da un punto di vista tassonomico o
che hanno subito analoghe pressioni selettive. Si tratta di un patrimonio im-
16prendersi cura del mondo. l’ecologia dell’essere in-relazione
portante, sovente sminuito per paura di una sorta di determinismo biologico,
ma si tratta di un errore grossolano perché il retaggio filogenetico non è mai
deterministico sull’ontogenesi, ma semplicemente definisce il range evolutivo
possibile e gli strumenti ontopoietici disponibili.
Da un punto di vista meramente etologico, ritroviamo comportamenti di
cura in tutti quegli animali che presentano una struttura parentale in onto-
genesi. Le cure parentali rappresentano un’innovazione importante negli stili
riproduttivi presenti nel mondo animale, avvento riconducibile al periodo Per-
miano, quando dall’alveo dei rettili presero avvio numerose linee filetiche, oggi
rappresentate dalla classe dei mammiferi e degli uccelli, ove le cure parentali
sono sempre presenti. Se è vero che le cure parentali si manifestano a macchia
di leopardo nel mondo animale, è nei mammiferi e negli uccelli che divengono
una dimensione consolidata. La strategia riproduttiva intrapresa è presto detta:
fare pochi piccoli ma affiancarli nel difficile periodo della crescita, quando è
più consistente la mortalità. Le cure parentali prevedono una serie di attività
genitoriali, come la nutrizione, la protezione, l’accudimento, l’educazione: tut-
ti gli animali che hanno cure parentali devono dedicare parte della loro esisten-
za ai bisogni di un’alterità rappresentata dal cucciolo o dal nidiaceo.
L’espressione epimeletica in natura si basa su una componente motivazio-
nale, vale a dire su una propensione innata a esprimere certe azioni e a essere
sensibili verso particolari richiami rispondendo con precisi pattern comporta-
mentali. Quando si analizza una fonte motivazionale occorre non solo prende-
re in considerazione il significato funzionale e adattativo che ha stabilizzato il
carattere in quella specie, ma altresì il significato edonico che l’espressione di
detto connotato determina sul soggetto. La presenza di una certa motivazione
definisce un’area di orientamento e consumazione, una sorta di languore, che
se trova rispondenza espressiva produce gratificazione e appagamento, mentre
se non ha agibilità causa frustrazione e depressione. Questo è il motivo per cui
un animale rinchiuso in uno zoo, per quanto sottoposto a pratiche di welfare
animale, tende a cadere all’interno di compulsioni di ordini sostitutivo o a stati
depressivi. Ribadire questo concetto è molto importante perché ci fa compren-
dere che, negli animali dotati di motivazione epimeletica, l’atto di cura non è
soltanto una donazione, ma un completamento del proprio essere, un’urgenza
di pienezza e rispondenza alla propria natura.
La componente motivazionale è importante, direi indispensabile nella defi-
nizione etografica di una specie, perché è il menù motivazionale – la specificità
intrinseca dell’essere desiderante – che definisce i verbi-desideri che un sogget-
17animal studies 19
to presenta. Ma l’espressione epimeletica per realizzarsi – ossia per trasformarsi
da propensione in azione – deve appoggiarsi ad altre componenti come: i) la
competenza nel riconoscere il bisogno, ossia nel partecipare alla condizione
carenziale dell’alterità; ii) le dotazioni espressive nelle attività di cura, come le
conoscenze di accudimento o l’esperienza nella gestione di cucciolata; iii) l’o-
rientamento sociale e la complessità sociale, in termini di regole da impartire;
iv) la componente emozionale e, in particolare, la sicurezza implicitata in fase
ontogenetica, come dimostra ampiamente la teoria dell’attaccamento di John
Bowlby. Quindi non si tratta solo di un desiderio espressivo, ma altresì di una
competenza-disponibilità, in tutto paragonabile ad altre attività: come il pro-
cacciamento di cibo, la capacità mimetica, la migrazione. Da un punto di vista
filogenetico possiamo dire che la robustezza del comportamento epimeletico
risente: i) del gradiente di bisogno di cura che manifesta il cucciolo per poter
raggiungere in pienezza la maturità sociale; ii) della complessità del gruppo
sociale, anche solo in termini di numerosità del gruppo, di complessità delle
dinamiche sociali, dell’indice di negoziazione delle istanze e della collaborativi-
tà richiesta nell’esaudimento dei bisogni.
Per quanto concerne le componenti filogenetiche voglio rimarcare la mia
posizione sul ritenere l’essere umano tutt’altro che carente nel retaggio filo-
genetico. La potenzialità di assumere più profili ontopoietici (educativi e cul-
turali) non nasce, a mio avviso, da una carenza – come più volte riportato
dalla tradizione umanistica – ma da una virtualità attribuibile a ridondanza
del retaggio che consente di assumere più declinazioni. La carenza di fatto
limiterebbe il portato declinativo ontopoietico. Per tornare all’epimelesi, è evi-
dente che l’essere umano, sia in termini motivazionali sia in termini di com-
petenza espressiva, ha sviluppato una dimensione epimeletica estremamente
consistente. Quando parliamo di una propensione epimeletica nell’essere uma-
no, ci riferiamo ad alcune caratteristiche che, seppur presenti anche in altre
specie, hanno una solidità e una rilevanza nell’uomo incomparabile. Il perché
è afferibile da un punto di vista filogenetico ai bisogni di cure parentali che il
cucciolo umano presenta alla nascita, per una serie di motivi: i) l’immaturità
al parto o neonatale, riconducibile alla difficoltà di transito nel bacino rispetto
alla grandezza del neurocranio; ii) la lunghezza dell’età evolutiva rispetto alla
vita media.
Si tratta di uno stato di totale abbandono alle cure parentali, che non ha
riscontri, prendendo in considerazione la linea filetica da cui l’essere umano
discende, vale a dire tra i mammiferi e i primati, peraltro già specialisti nel
18prendersi cura del mondo. l’ecologia dell’essere in-relazione
comportamento parentale. Il cucciolo d’uomo non è in grado non solo di ag-
grapparsi, come fanno le altre antropomorfe, ma nemmeno di tener su la testa,
mostrando a tutti gli effetti la sua condizione fetale. Anche i carnivori presen-
tano una considerevole immaturità neonatale, ma raggiungono l’indipendenza
nel giro di due settimane e hanno poi un periodo evolutivo molto più con-
tratto in relazione alla vita media. Immaturità neonatale e lunghezza dell’età
evolutiva si traducono in spiccati bisogni di cura da parte del bambino, ragion
per cui la nostra specie ha dovuto controlateralmente sviluppare una forte di-
sponibilità epimeletica e parimenti una notevole sensibilità verso la richiesta
di cura e una robusta capacità di riconoscere i bisogni dell’altro. In generale
possiamo dire che l’evoluzione dei caratteri in filogenesi è sempre correlativa,
non solo nel senso di adattamento tradizionale all’ambiente e allo stile di vita,
ma anche in senso di coerenza interna dei caratteri: non è possibile un incre-
mento di bisogni di cure parentali nel cucciolo senza parimenti sviluppare una
maggiore propensione alla cura da parte del genitore.
Siamo cioè degli specialisti dell’epimelesi, lo siamo già nella nostra natura
ovvero in quelle predisposizioni che ci vengono dalla storia filogenetica di Homo
sapiens. Lo siamo come specie, lo siamo come appartenenza alle antropomorfe,
lo siamo in quanto primati, lo siamo in quanto mammiferi. Cosa significa?
Riprendendo quanto detto sulla motivazione, significa: i) che siamo propensi
a mettere in atto comportamenti di cura; ii) che il farlo corrisponde a un desi-
derio espressivo e che quindi produce soddisfazione e appagamento; iii) che ci
muoviamo nel mondo con una forte attenzione a tutto ciò che ha bisogno del
nostro intervento; iv) che siamo molto sensibili verso le richieste di aiuto che
ci provengono dall’esterno e verso le forme giovanili; v) che costruiamo spazi
di agibilità su prassi che favoriscono la crescita come il coltivare, l’allevare, il
catalogare, il mettere ordine. Ritengo che la propensione epimeletica dell’essere
umano sia fortemente influenzata dalla nostra natura, dalla particolare traiet-
toria filogenetica che la nostra specie ha intrapreso. Può sembrare che questo
riconduca l’epimelesi a una sorta di determinismo innato e di riduzionismo
biologico, ma non è così. Se leggiamo il retaggio motivazionale non come una
struttura comportamentale già definita ma come una copula — un progetto
verso il mondo — l’espressione epimeletica non è prefissata.
La motivazione è una progettualità, incardinata sì su un verbo – desiderio,
che tuttavia chiede una specificazione ontopoietica, vale a dire che si rende di-
sponibile a evolvere e ad assumere specificazioni espressive assai libere e spesso
impredittibili. L’orientamento motivazionale definisce la coordinata predicati-
19Puoi anche leggere