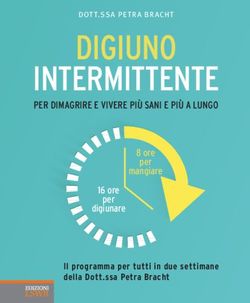ACTINIDIA E GELATE: METODI DI PREVISIONE E MEZZI DI DIFESA
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
ACTINIDIA E GELATE: METODI DI PREVISIONE E MEZZI DI DIFESA
Andrea Cicogna – Centro Servizi Agrometeorologici –ERSA
Mariangela Sandra – Università di Udine
PREMESSA
Le gelate, pur non rappresentando un’avversità molto frequente nel Friuli Venezia Giulia, sono
ugualmente un pericolo non trascurabile, che va contrastato con mezzi efficaci per non subire
danni ingenti alle colture frutticole.
Per gelata s’intende un fenomeno meteorologico caratterizzato da un forte abbassamento della
temperatura dell’aria che, a partire da valori positivi, raggiunge valori inferiori allo zero. In modo
particolare l’actinidia è una specie molto sensibile ai ritorni di freddo primaverili e agli anticipi di
freddo autunnali.
CLASSIFICAZIONE DELLE GELATE
E’ intuitivo che gli effetti della gelata dipendono fortemente dalla specie, dalla varietà considerata
e dallo stadio fenologico della pianta e in questo senso una classificazione basata sul danno
arrecato è sempre difficile.
Comunque, a prescindere dal danno, esistono diverse classificazioni.
La prima di queste si basa sull’epoca in cui si verificano le gelate; si distinguono:
• gelate invernali;
• gelate primaverili (o tardive);
• gelate autunnali (o precoci).
Le gelate più temute sono quelle che si verificano quando le piante sono in vegetazione e, in
particolare per il Friuli Venezia Giulia, quelle primaverili tardive, che colpiscono le piante in
fioritura, allegazione (pomacee e drupacee) e/o in germogliamento (actinidia) . Per l’actinidia
anche le gelate autunnali sono molto pericolose.
Dal punto di vista dell’origine meteorologica si possono distinguere tre tipi di gelata:
o per irraggiamento notturno: l’aria vicina al suolo è più fredda di quella che si trova a due
o dieci metri d’altezza. Questo fenomeno è detto inversione termica notturna ed è tanto
maggiore quanto più l’aria è limpida e tersa, non vi sono nuvole o foschie, l’umidità
dell’aria è bassa e non vi è vento. In queste condizioni, quando la temperatura massima
del giorno è di 11-13 °C, o al tramonto di 5-6 °C, la temperatura durante la notte può
scendere sotto i zero gradi e si verifica quindi la gelata per irraggiamento (Fig. 1);
o per avvezione: dovuta all’arrivo di una massa d’aria che ha una temperatura inferiore allo
zero;
o per evaporazione: non è molto comune. Si verifica in condizioni particolari, ossia
quando i tessuti della pianta sono bagnati da un velo d’acqua, l’umidità dell’aria è molto
bassa e la temperatura dell’aria è prossima allo zero. In queste condizioni e in presenza di
forte vento, l’evaporazione dell’acqua dalle superfici della pianta sottrae una grande
quantità di energia ai tessuti vegetali, raffreddandoli. Per pochi minuti la temperatura
delle piante risulta inferiore allo zero, mentre quella dell’aria rimane superiore. Questo
effetto può verificarsi all’inizio dell’irrigazione contro la gelate specie se effettuata
soprachioma. (vedi seguito)
o per gelate miste (irraggiamento + avvezione): spesso i fenomeni di irraggiamento e
avvezione tendono a sovrapporsi, così che la gelata si verifica quando, a seguito di una
irruzione di aria fredda e secca e che ha portato la temperatura dell’aria a valori bassi ma
comunque sopra lo zero, segue una notte serena e senza vento in cui l’irraggiamento è
molto elevato.
Infine, in base agli effetti visivi si possono distinguere due tipi di gelate:
con deposito di ghiaccio (brinata): si verifica quando l’umidità dell’aria è elevata (80-
90%). La brina si forma in seguito all’abbassamento della temperatura del vapore
1acqueo, per cui esso condensa e contemporaneamente o di seguito ghiaccia,
depositandosi su fiori, foglie, rami ed erba;
senza deposito di ghiaccio: quando l’umidità dell’aria è molto bassa (40-60% o meno), la
temperatura scende senza che il vapore contenuto nell’aria condensi e ghiacci. Questo
tipo di gelata è senz’altro più temibile della brinata perché la temperatura scende di più;
inoltre, vista l’umidità bassa, le piante tendono ad appassire diminuendo così la propria
resistenza al gelo.
PREVISIONE DELLE GELATE
Raccogliere per molti anni (almeno trenta) la temperatura minima e massima di diverse località,
per poi analizzarle e capire con che frequenza determinati fenomeni vi verificano è uno dei
compiti della climatologia. La climatologia quindi può essere un valido aiuto nell’individuazione
del rischio che in una determinata zona si verifichi un abbassamento termico pericoloso per le
colture. (Fig. 1). Non bisogna comunque confondere il rischio climatologico di gelata con la
previsione che questa si verifichi e ciò soprattutto perché le previsioni hanno comunque una
validità temporale limitata.
Si possono infatti avere previsioni:
1. a medio termine: le gelate vengono previste con alcuni giorni di anticipo, attraverso
l’ausilio di modelli matematici;
2. a breve termine: le gelate vengono previste con alcune ore di anticipo. Esistono più
metodi di previsione in questo ambito (empirici, semi-empirici e meccanicistici).
Vi sono molti modi, anche “fatti in casa”, per produrre delle previsioni. In linea di massima,
però, ove presenti , è bene affidarsi ai servizi meteorologici locali.
In Friuli Venezia Giulia per avere informazioni su possibili gelate con almeno uno o due giorni di
anticipo, si può ricorrere alle previsioni che l’ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente) emette durante i periodi più a rischio di gelo.
Inoltre il CSA (Centro Servizi Agrometeorologici) in collaborazione con l’ARPA fornisce anche
le previsioni a breve termine delle temperature minime notturne. Al tramonto, durante i periodi a
rischio, vengono emesse delle previsioni sull’andamento della temperatura nel corso della notte
su diverse località della regione dove sono situate le stazioni meteorologiche della rete osservativa
ERSA-CSA. Queste previsioni sono rielaborate ogni ora fino all’alba e trasmesse sul teletext di
Telefriuli.
LA “DIFFICILE ARTE” DI MISURARE LA TEMPERATURA
Premessa
Misurare correttamente la temperatura durante una notte a rischio di gelata, è un esigenza
cruciale per l’agricoltore. Lo studio della variabilità termica all’interno dell’area da proteggere dal
gelo e il monitoraggio delle temperature nel corso degli interventi di difesa permettono da una
parte di scegliere la tecnica di difesa più appropriata e dall’altra di verificarne l’efficacia durante gli
interventi. Ma un’operazione che sembra così semplice presenta delle insidie.
La variabilità termica nel frutteto
Innanzi tutto bisogna sottolineare come durante le gelate, specie per quelle dovute ad
irraggiamento, tipiche nella nostra regione, la temperatura non è mai costante in tutto il frutteto.
In primo luogo la temperatura dell’aria varia con l’altezza dal suolo: è più bassa vicino a terra ed è
maggiore a 2-3 metri di altezza.
Se esistono delle zone infossate, degli avvallamenti all’interno del frutteto, l’aria più fredda vicino
a terra tenderà a scivolare lungo il terreno per accumularsi proprio nelle zone più basse e
avvallate. In collina, contrariamente a quanto verrebbe spontaneo pensare, sarà il fondo valle ad
essere più freddo rispetto alle cime o ai versanti.
Nel corso della notte la temperatura più bassa si raggiunge in prossimità del suolo subito prima
del sorgere del sole; successivamente, grazie al riscaldamento, la temperatura aumenta vicino al
suolo e quindi il calore si propaga verso l’alto (Fig.2).
2Tipi di strumenti
Per la misura della temperatura all’interno del frutteto si ricorre all’utilizzo di termometri. Diverse
sono le tipologie di termometri reperibili sul mercato, da quelli a mercurio classici a quelli
elettronici più sofisticati.
Indipendentemente dal tipo di termometro scelto, è necessaria una verifica costante del buon
funzionamento dello strumento. Bisogna innanzitutto operare una corretta taratura dei
termometri. Questa va effettuata con anticipo rispetto al momento in cui si verifica la gelata e
con condizioni meteorologiche che siano il più possibile simili a quelle di intervento (ad esempio
nel periodo freddo invernale), ponendo i termometri nelle stesse condizioni meteorologiche.
Ricordiamo che una bacinella contenete acqua distilla e ghiaccio (ottime le sbrinature del
frigorifero) ha esattamente 0 °C… basta immergerci i termometri per capire se sono tarati!
Sarebbe opportuno avere un termometro a mercurio “di precisione” da utilizzare come elemento
di riferimento per l’analisi degli errori commessi dai termometri a confronto. E’ consigliabile
sostituire tutti quei termometri che presentano errori significativi rispetto a quello di riferimento.
Esistono poi particolari tipologie di termometri definiti “a bulbo umido”, indispensabili nella
difesa dal gelo con impianti di irrigazione soprachioma. Il termometro a bulbo umido
rappresenta in modo più adeguato la situazione termica a cui è sottoposto un organo vegetale su
cui ci sia deposito di acqua che successivamente evapora.
Il termometro a bulbo bagnato rientra nella costituzione di un altro strumento, lo psicrometro
(Fig. 3). Questo è uno strumento formato da due termometri. Il primo misura la temperatura di
bulbo asciutto (termometro tradizionale) e il secondo misura la temperatura del bulbo bagnato.
In questo secondo termometro il bulbo è ricoperta da una garza bagnata; l’acqua evaporando
dalla garza raffredda il bulbo (il bulbo bagnato quindi si trova ad una temperatura inferiore
rispetto al termometro tradizionale). La differenza di temperatura tra i due termometri dipende
dall’umidità dell’aria: maggiore è la differenza e minore l’umidità. Nelle notti di primavera con
gelate da irraggiamento, l’aria è generalmente calma e l’umidità è bassa e la differenza tra i due
termometri può oscillare tra 0.5 e 2.5°C.
Posizionamento degli strumenti
Per effettuare un accurato monitoraggio delle temperature all’interno del frutteto, specie nei
periodi più a rischio di gelata, è necessario posizionare correttamente più termometri in diversi
punti dell’azienda.. Sarebbe auspicabile misurare la temperatura almeno a due quote, ad esempio
a 50 e a 150 cm dal suolo. Inoltre sono sicuramente da privilegiare, nel posizionamento di
termometri, gli avvallamenti dove l’aria fredda si accumula e dove, quindi, è maggiore il rischio di
gelo.
La scelta del posizionamento dei termometri va effettuata anche in relazione alle metodologie di
difesa antigelo applicate al frutteto, in particolar modo all’ irrigazione antigelo sopra e sotto
chioma. In entrambi i casi, per determinare l’inizio degli interventi, ci si riferisce ad un
termometro posizionato esternamente ai filari di coltura in prossimità del suolo (30-50 cm dalla
superficie). Ciò che cambia nelle due metodologie d’intervento è il tipo di termometro a cui ci si
riferisce per l’avvio delle irrigazioni: a bulbo bagnato per l’irrigazione soprachioma e un
termometro tradizionale per l’intervento sottochioma.
Per determinare la temperatura di fine irrigazione, è consigliabile piazzare un ulteriore
termometro fuori dal frutteto, lontano dagli irrigatori, in modo che la temperatura misurata non
risenta dell’irrigazione.
DIFESA DALLE GELATE
Una volta prevista la gelata, bisogna procedere con i mezzi di difesa. E’ bene ricordare che per
l’actinidia, come per le altre colture arboree, i danni sono più o meno ingenti a seconda
dell’epoca in cui avviene la gelata e, quindi, in relazione allo stadio fenologico della pianta. In
linea di massima tanto più è avanzato lo sviluppo fenologico tanto meno la pianta può resistere al
gelo (Tab.1). Nell’actinidia, che tra le colture arboree coltivate in regione è la più sensibile ai
ritorni di freddo, già temperature di -1/ -2°C possono determinare gravi danni nella fase in cui i
bottoni fiorali sono visibili. Vari studi (Testolin et al., 1995) dimostrano inoltre che danni molto
3gravi si possono avere quando la temperatura del frutto scende al di sotto dei –3.5 °C, visto che il
frutto stesso congela e non può più essere commercializzato.
La difesa contro le gelate tardive può essere effettuata per l’actinidia impiegando tecniche diverse
il cui scopo fondamentale è ridurre al massimo i danni.
A seconda del momento in cui viene attuato l’intervento di difesa si distingue tra:
1. difesa passiva. Si tratta di interventi diversi effettuati con anticipo per ridurre l’effetto
delle gelate:
una corretta gestione del territorio evitando ad esempio di posizionare gli
impianti in zone di fondo valle ad alto rischio di gelate tardive e comunque
scartare situazioni in cui viene favorita la precocità della ripresa vegetativa
(l’actinidia ha una ripresa vegetativa post invernale alquanto precoce, intorno ai
primi giorni di marzo, quando il rischio di gelate è ancora molto elevato);
una corretta gestione del frutteto attraverso, ad esempio, concimazioni mirate
(quelle azotate rendono le piante più sensibili alla formazione del ghiaccio,
mentre quelle fosfate o potassiche danno maggiore resistenza al gelo);
2. difesa attiva: si attua tramite interventi di difesa effettuati nel corso della gelata. Esistono
diversi metodi ma nelle nostre condizioni per le colture arboree l’irrigazione antibrina è
sicuramente il mezzo di difesa attiva più efficace. L’acqua, congelandosi, cede energia
all'ambiente (calore latente di congelamento 80 cal/grammo di acqua) impedendo
l’ulteriore diminuzione della temperatura.
L’irrigazione antibrina può essere effettuata sopra e sottochioma a seconda dell’intensità
della gelata e della coltura interessata. Per gelate molto intense solo l’irrigazione
soprachioma risulta completamente affidabile, mentre è meno efficace in presenza di
forte vento.
L’avvio dell’impianto d’irrigazione soprachioma viene effettuato riferendosi alla misura
della temperatura a bulbo bagnato. Infatti, appena avviato l’impianto di irrigazione, a
causa dell’evaporazione dell’acqua, la temperatura dell’aria può scendere appunto fino a
quella misurata dal termometro a bulbo bagnato.
E’ inoltre importante conoscere la temperatura critica della coltura in relazione alla fase
fenologica in cui si trova. L’impianto viene avviato quando il termometro a bulbo
bagnato misura 0.5/1°C sopra tale soglia, ma, in via previdenziale, per evitare eventuali
congelamenti all’impianto, si inizia ad irrigare a temperature già di 0°C. L’irrigazione non
può essere bloccata fino a che non si raggiungono temperature di bulbo asciutto di
2/3°C con un innalzamento progressivo di almeno 2°C per ora. Il termometro a bulbo
asciutto va posizionato all’esterno dell’area da proteggere.
Con intensità di irrigazione di 1-1,5 mm/ora si può avere un incremento di temperatura
di 4,5 °C, con intensità di 3-3.5 mm/ora si può arrivare ad un incremento di 6°C.
Con l’irrigazione soprachioma si possono limitare i danni sia delle gelate dovute
all’irraggiamento notturno sia di quelle per avvezione..
L’irrigazione soprachioma non è molto indicata per l’ actinidia. Questa è una
specie che, viste le sue caratteristiche biologiche e strutturali, resiste ben poco al
peso del gelo. In particolar modo durante le gelate autunnali l’impiego
dell’irrigazione antibrina soprachioma può essere ostacolata dalla presenza di
una gran quantità di massa vegetativa e produttiva che porta a problemi di
sovraccarico sulle strutture di sostegno. Ma anche in primavera i germogli della
pianta sopportano male il peso del ghiaccio.
Per l’actinidia è quindi applicabile la microirrigazione sottochioma. Tale tecnica è
particolarmente efficace nelle gelate dovute a irraggiamento notturno non
eccessivamente intense. L’incremento termico è più limitato rispetto all’irrigazione
soprachioma, specie nella parte alta del frutteto: a terra, dove l’acqua congela, la
temperatura va a 0°C, a 150 cm da terra si ha un incremento termico che può arrivare a
1,5°C. Per tale tecnica si può utilizzare l’impianto presente se dotato di microjet (non
irrigatori a goccia) che devono bagnare tutto il terreno con una nebulizzazione non
eccessiva.
4Sarebbe auspicabile l’ inerbimento (meglio se l’erba è alta), per aumentare la superficie su
cui l’acqua di irrigazione gela in tal modo il calore liberato per unità di superficie risulta
maggiore.
Con questa tecnica è possibile suddividere l’azienda in settori e bagnare ogni settore per
2-3 minuti con una sosta di 5-6 minuti. Così facendo vi è un risparmio di acqua ( 2-4
m³/ha ora ) e di energia utilizzata rispetto invece all’irrigazione soprachioma (da 15 a 35
m³/ha ora) .
Per decidere l’inizio dell’intervento di irrigazione antibrina sottochioma, è possibile
impiegare un termometro tradizionale posto in prossimità del suolo (20/50 cm dalla
superficie), ma esternamente ai filari della coltura, facendo attenzione alle zone
dell’appezzamento più basse e in conca, dove l’aria fredda ristagna e dove la gelata inizia
prima (in questo caso è indicato misurare l’inizio gelata proprio nella zona più
svantaggiata). L’avvio va programmato in corrispondenza della misura di 0-0.5 °C. Per
determinare la temperatura di fine irrigazione, è consigliabile piazzare un ulteriore
termometro fuori dal frutteto, lontano dagli irrigatori, in modo che la temperatura
misurata non risenta dell’irrigazione L’irrigazione può essere sospesa quando la
temperatura torna a valori superiori a 0.5-1 °C.
3. difesa in prossimità della gelata: nel caso in cui non sia possibile utilizzare l'impianto con
le modalità sopra citate, si consigliano due ulteriori metodi che sfruttano lo stato di
idratazione del terreno. La caratteristica principale di questo tipo di difesa dalle gelate è
che non si esegue durante la gelata, ma si attua un'azione di prevenzione (qualche ora o
un giorno prima), irrigando il terreno per aumentarne lo stato di idratazione, quindi
bisogna consultare attentamente le previsioni del tempo per prepararsi adeguatamente.
Un terreno secco in superficie ha una bassissima conducibilità termica e quindi anche se
il suolo in profondità è caldo, tale calore non può essere ceduto all'aria. Invece una
migliore difesa preventiva dalle gelate viene ottenuta con terreni ben idratati, compatti e
senza cotica erbosa.
Infatti con l'aumentare dell'umidità del terreno si ha anche un aumento della
conducibilità termica del terreno stesso, con il trasferimento del calore latente sotto
superficiale verso la superficie, si ha il riscaldamento dell'aria sopra superficiale per
irraggiamento.
I tipi di irrigazione che possono essere utilizzati per questo metodo di difesa sono
l'irrigazione per scorrimento o per aspersione. Con l'irrigazione a scorrimento sono
necessari elevati volumi irrigui da 300 m3/ha per terreni argillosi a 700-800 m3/ha per
terreni sciolti. Per l'attuazione di questo tipo di irrigazione è spesso necessaria
un'adeguata sistemazione del terreno e per questo motivo tale tecnica potrebbe non
essere praticabile. Con l'irrigazione per aspersione, si utilizzano volumi irrigui non
elevati: 10-20 m3/ha per intervento, quantitativo sufficiente a idratare i primi 2-5 cm del
terreno, spessore sufficiente per ottenere l'effetto desiderato per 3-5 giorni nel periodo
marzo-aprile.
Con sistemi di irrigazione per aspersione è fondamentale umettare tutta la superficie del
campo e non solo i filari. Solo con una superficie uniformemente irrigata si riesce a
ottenere un riscaldamento dell'aria uniforme ed efficace.
Particolare molto importante da sottolineare, è che la vegetazione deve essere asciutta
durante le ore della gelata, si consiglia di eseguire l'eventuale irrigazione varie ore prima
del tramonto o nella giornata precedente, per permettere alle parti bagnate delle piante di
asciugarsi ed evitare danni da ghiaccio.
CONCLUSIONI
Le gelate rappresentano un problema non trascurabile per il Friuli Venezia Giulia e possono
essere affrontate con metodologie diverse in relazione alle caratteristiche colturali, al terreno e
alle disponibilità aziendali.
L’irrigazione antibrina è sicuramente il metodo più efficace nella difesa dalle gelate, ma richiede
una predisposizione dell’impianto di irrigazione fin dalla sua progettazione. Nei frutteti già dotati
di un impianto d’irrigazione è bene preparare l’attrezzatura per irrigare entro la metà di marzo e
per gli actinidieti è bene mantenere l’efficienza degli impianti fino a novembre.
5Molto importanti, infine, nella difesa dalle gelate sono i sistemi di previsione messi a disposizione
dall’ARPA e dal CSA, che possono rappresentare un valido aiuto per gli agricoltori.
6Tab 1- Sensibilità dell’actinidia a basse temperature in funzione dello sviluppo.
Fase fenologica Soglie critiche
Gemma d’inverno -15°C
Rottura gemme -2°C
Germogliamento -1°C
Inizio accrescimento germogli -0.5°C
Bottoni fiorali visibili -0.5°C
Inizio apertura fiori 0°C
Frutti -3.5 °C
Fig. 1 – Stazione di Udine: frequenza con cui almeno in un giorno per pentade si sono raggiunte
temperature uguali o inferiori ai 0, -1,-2,-3,-4 °C, misurati a 180 cm da terra, nel trentennio 1961-
1990.
40
35 0°C
30
-2°C 0°C
25
frequenza (%)
-1°C
20
-3°C
15 -4°C -1°C
10
-2°C
5 -3°C
-4°C
0
1-5/3
6-10/3
11-15/3
16-20/3
21-25/3
26-31/3
1-5/4
6-10/4
11-15/4
16-20/4
21-25/4
26-30/4
16-20/10
21-25/10
26-31/10
1-5/11
6-10/11
11-15/11
pentadi
7Fig. 2 - Nella gelata per
irraggiamento l’aria è più fredda
vicino al suolo e più calda a 2
metri d’altezza. La gelata è tanto
più intensa quanto più l’aria è
limpida e tersa, non vi sono
nuvole o foschie, l’umidità dell’aria
è bassa e non vi è vento.
8Fig. 3 – Foto psicrometro
9Puoi anche leggere