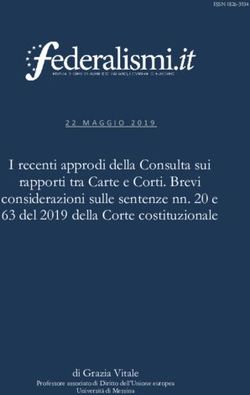Aborto negli USA: un discorso che si riapre - Filodiritto
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752
Direttore responsabile: Antonio Zama
Aborto negli USA: un discorso che si riapre
Ripercorriamo alla luce della giurisprudenza il dibattito sull’aborto negli USA.
10 Maggio 2022
Luigi Maria Misasi
Indice:
1. Il dibattito tra antiabortisti e abortisti
2. Griswold v. Connecticut (1965) e il diritto alla privacy
3. L’aborto negli USA prima di Roe v. Wade
4. La battaglia legale di Jane Roe. Il processo di primo grado
5. La sentenza Roe v. Wade (1973)
6. Le critiche a Roe v. Wade
7. Planned Parenthood v. Casey (1992)
8. Conclusioni
Abstract: Negli Stati Uniti, il diritto all’aborto non si rinviene in Costituzione, ma è stato frutto
dell’elaborazione giurisprudenziale della Corte Suprema, riconosciuto per la prima volta con la sentenza
Roe w. Wade, del 1973. È notizia degli ultimi giorni, tramite la diffusione della notizia da parte di Politico
, che la Corte sarebbe in procinto di votare un documento, redatto dal giudice Samuel Alito, con cui
rinnega in toto Roe v. Wade: «Roe si è clamorosamente sbagliano fin dall’inizio. Il suo ragionamento era
eccezionalmente debole, e la decisione ha avuto conseguenze dannose. Roe e Casey hanno infiammato il
dibattito e approfondito una divisione». In seguito alle proteste che stanno infiammando il Paese,
conseguenti alla diffusione della bozza, la Corte Suprema, con una propria nota, ha comunicato che,
sebbene il documento sia vero, esso non rappresenterà il punto di arrivo della questione. Il dibattito è
aperto.
1. Il dibattito tra antiabortisti e abortisti
Nel mondo anglosassone la discussione sull’aborto gravita più su un piano morale che giuridico, avendo –
in più occasioni – interessato maggiormente i filosofi e i sociologi rispetto ai giuristi.In estrema sintesi, gli argomenti solitamente adottati dagli antiabortisti ruotano intorno all’affermazione che l’embrione è un essere umano e, perciò, una persona, almeno allo stato potenziale. Il loro punto di forza consta del fatto che non è possibile individuare, se non in modo arbitrario, il momento della gestazione in cui il prodotto del concepimento diviene persona. Tale impossibilità, che dipende dal fatto che lo sviluppo del feto è un processo di accrescimento lento ma continuo, porterebbe a concludere che i diritti della personalità devono essere attribuiti all’embrione fin dal momento del concepimento, essendo in quel momento già in atto il processo formativo. Ne consegue che l’interesse del feto non potrebbe essere subordinato a quello della madre, in particolare quando le ragioni per interrompere la gravidanza non sono di natura strettamente sanitaria. Gli argomenti degli abortisti, invece, fanno perno sul diritto della donna all’autodeterminazione , che comporta l’esclusivo potere di controllo sul proprio corpo (right to control our own body in order to control our own lives, recitava un noto slogan di un comitato femminile abortista). Sarebbe, perciò, un’esigenza di libertà, ossia la libertà di decidere il corso della propria vita e, quindi, il diritto di non subire gravidanze indesiderate che, proprio perché non volute, ne condizionerebbero negativamente l’esistenza prima e dopo il parto. Tale esigenza consentirebbe, quindi, il prevalere dell’interesse della donna di prevalere su quello del feto. Quest’ultimo, se anche può considerarsi un essere umano (accettando che dal punto di vista biologico la vita inizi con il concepimento) non potrebbe per ciò solo ritenersi una persona, ossia destinatario della stessa considerazione morale di cui godono i nati e, quindi, d’identica protezione giuridica. Nel conflitto tra una persona (la donna) e un essere umano che non è ancora persona (il feto) dovrebbe prevalere, pertanto, più o meno incondizionatamente, la prima. Si afferma, poi, che la decisione di non portare a termine la gravidanza è essenzialmente una decisione morale, la quale, in una società democratica, dev’essere lasciata all’individuo, e non può quindi essere imposta dal legislatore: se lo Stato adottasse una particolare idea religiosa o etica, e intendesse sostenerla modellando su di essa le proprie leggi, finirebbe per violare il principio pluralistico e con ciò la libertà dei cittadini. Anche negli Stati Uniti, gli abortisti si rifanno – infine – a un argomento di carattere sociale che è stato tenuto in considerazione dalla stessa Corte Suprema, il quale si fonda sulla necessità di scongiurare un ritorno alle tragiche situazioni del passato, il cui l’aborto era comunque praticato clandestinamente, in condizioni sanitarie che ponevano seri pericoli per la vita delle donne, soprattutto se di condizioni economicamente disagiate. 2. Griswold v. Connecticut (1965) e il diritto alla privacy Per poter meglio comprendere il ragionamento dei giudici della Corte Suprema in Roe v. Wade conviene fare un salto indietro di qualche anno ed affrontare il tema del riconoscimento del diritto alla privacy. Una legge dello Stato del Connecticut, risalente al 1879, proibiva penalmente l’utilizzo di qualsiasi anticoncezionale. Nel 1961 Estelle Griswold, medico e direttrice di Planned Parenthood League del Connecticut, venne accusata di fornire, ai propri pazienti, informazioni su come prevenire il concepimento, in particolare consigliando alle donne l’utilizzo di particolari strumenti anticoncezionali.
La Corte Suprema ritenne che la legge fosse incostituzionale, poiché violava il diritto alla privacy dei coniugi. Il divieto, quindi, comportava un’illecita intromissione dello Stato nella vita coniugale, ostacolando scelte che dovevano essere rimesse all’esclusiva volontà dei coniugi. La Corte, per la prima volta, affermava in modo esplicito che il right of privacy, sebbene non espressamente menzionato («unenumerated») nel Bill of Rights (nonché nei successivi Emendamenti alla Costituzione), aveva piena rilevanza costituzionale. La fonte di tale diritto doveva rintracciarsi nelle garanzie sancite dal I, dal III, dal Ve dal IX Emendamento, in quanto tali disposizioni presupponevano l’esistenza di penumbras, ossia «zones of privacy» dalle quali poteva ricavarsi l’esistenza di un più generale diritto alla privacy. Per alcuni giudici della Corte, tra cui il Presidente Warren, il diritto di libertà -il cui contenuto non poteva considerarsi limitato dalle espressioni utilizzate nel Bill of Rights- offriva protezione ai diritti della personalità riconosciuti come fondamentali. In altri termini, il diritto alla privacy discendeva come «implied right» dai principi di libertà formulati dalla Costituzione e trovava, perciò, tutela nel XIV Emendamento, il quale garantisce la libertà personale nei confronti dell’azione dello Stato. I due giudici dissenzienti, Black e Stewart, contestarono il valore costituzionale del diritto in parola e, più in generale, l’affermazione dell’esistenza di «implied rights», accusando la Corte di sostituirsi al legislatore costituzionale (federale o statale) nella scelta di quei valori proteggere: la teoria degli «unenumerated» o «implied rights» avrebbe concesso alla Corte Suprema eccessiva discrezionalità e, quindi, un potere politico che non le spettava. Malgrado le critiche, Griswold v. Connecticut inaugurò una serie di pronunce di carattere liberale, avendo seguito anche in altri paesi di common law: in Irlanda, ad esempio, fu espressamente richiamata dalla Irish Supreme Court nella causa McGee v. Attorney General (1974), la quale dichiarò l’illegittimità costituzionale della legge che proibiva l’importazione e la vendita di contraccettivi, poiché violava il diritto alla privacy delle persone sposate. 3. L’aborto negli USA prima di Roe v. Wade Preliminarmente, prima di affrontare il contenuto della sentenza oggetto del presente lavoro, è utile fare cenno alla storia dell’aborto nei paesi anglosassoni, anche perché ad essa si richiamò, con il chiaro intento di motivare alcune scelte compiute dalla Corte, lo stesso giudice Blackmun nel redigere l’opinione di maggioranza. Le norme che proibivano l’aborto non hanno origine nel common law, ma derivano da Statutes introdotti negli Stati Uniti nella seconda metà dell’Ottocento. Per il common law, l’aborto eseguito precedentemente ai primi movimenti avvertibili del feto nell’utero materno (cd. quickening) non costituiva un crimine: nell’antico diritto inglese si era affermata, in un primo tempo, l’opinione che il feto dovesse ritenersi formato (e quindi «recognizably human» ovvero «infused with a soul or animated») dopo un periodo approssimativo, dal momento del concepimento, di 40 giorni per il maschio e di 80 giorni per la femmina. Successivamente, probabilmente per soddisfare un’esigenza di certezza, si fece largo l’idea (di origine ecclesiastica) che si dovesse far riferimento ai primi movimenti del feto. Quando questi non erano ancora avvertibili, l’embrione veniva considerato inanimato, cioè privo di anima, e perciò una parte materiale della madre, la cui distruzione non era considerabile come omicidio. L’aborto di un “quick fetus” veniva, invece, giudicato come reato (minore), che poteva essere commesso sia dalla donna, sia da terze persone.
Analogamente alla legislazione inglese, negli Stati Uniti scomparve dalle legislazioni statali, nel XIX
secolo, la distinzione tra aborto ante e post quickening: le pene furono (generalmente) inasprire e, alla
fine degli anni ’50 del secolo scorso, quasi tutti gli Stati proibivano l’aborto con pene severissime, a meno
che fosse praticato per salvare la vita della madre. Ad esempio, l’Alabama e il District of Columbia lo
consentivano anche a “tutela della salute” della madre, mentre la Pennsylvania e il Massachussets
demandavano al giudice la valutazione della sussistenza di una valida giustificazione per abortire.
Il movimento a favore dell’aborto, sostenuto dai medici e dalle loro organizzazioni, nonché dalle
associazioni femministe, tra il 1967 e il 1973 condusse alcuni Stati ad adottare leggi più permissive,
seguendo le indicazioni fornite dall’American Law Institute nel 1962, le quali suggerivano che l’aborto
fosse consentito quando due medici avessero attestato che la gravidanza avrebbe potuto gravemente
pregiudicare la salute fisica o psichica della donna, oppure quando il bambino sarebbe potuto nascere con
seri danni fisici o mentali, e anche quando la gravidanza era stata conseguenza di una violenza o di un
incesto.
Nel 1970, gli Stati di New York, Washington, Hawaii e Alaska, giunsero sostanzialmente a liberalizzare
l’aborto nel primo trimestre di gravidanza.
4. La battaglia legale di Jane Roe. Il processo di primo grado
Gli articoli 1191-1194 e 1196 dello State’s Penal Code del Texas sanzionavano come crimine la condotta
di chi procurasse l’aborto ad una donna, sebbene con il consenso di quest’ultima, con una sola eccezione,
ossia quando risultasse necessario per salvare la vita della madre. Con formulazioni sostanzialmente
equivalenti, il divieto era presente nello Stato sin dal 1854.
Norma Leah McCorvey, meglio conosciuta con lo pseudonimo legale di “Jane Roe” (scelto a fini
processuali per tutelarne la privacy) era una giovane donna 21enne residente nella contea di Dallas, la
quale, una volta scoperto di esser rimasta incinta del suo terzo figlio, decideva di voler interrompere la
gravidanza, promuovendo un’azione giudiziaria nei confronti del District Attorney avanti la Corte Federale
del Distretto. La donna affermò che desiderava che l’aborto fosse eseguito da un medico competente in un
contesto sanitario sicuro e ciò in Texas non le era consentito, poiché la gravidanza non poneva a rischio la
sua vita e non le era neppure possibile recarsi in un altro Stato, che le consentisse «a legal abortion under
safe conditions», per ragioni economiche.
Jane Roe concludeva, allora, che la legge penale statale era incostituzionale e pregiudicava il suo diritto
alla «personal privacy» protetta dal I, IV, V, IX e XIV Emendamento.
La District Court accolse la domanda dell’attrice, dichiarando l’incostituzionalità delle norme della
legislazione penale texana, in quanto violava i diritti della donna garantiti dal IX e XIV Emendamento.
Tuttavia, la Corte si astenne dal concedere l’injunction richiesta e, anziché proporre appello alla Court of
Appeals, fece direttamente ricorso alla Corte Suprema.
5. La sentenza Roe v. Wade (1973)
Secondo la Corte Suprema erano tre le ragioni storicamente adottate per giustificare l’esistenza di leggi
proibitive dell’aborto:
1.la prima, ritenuta ormai sorpassata dai tempi, in quanto prodotto della società vittoriana (e neppure utilizzata dalla difesa del Texas), consisteva nell’intendere le norme antiabortiste uno strumento per scoraggiare condotte sessuali illecite, ossia le relazioni extraconiugali. Sotto questo profilo, ha osservato la Corte, la legislazione texana risultava essere eccessivamente generica, giacché non distingueva tra donne sposate e donne nubili; 2. la seconda doveva rintracciarsi nella tutela della salute della donna, in un tempo (il XIX secolo) in cui la mortalità per l’aborto era ancora altissima, non venendo impiegate adeguate pratiche antisettiche e non essendo ancora in uso gli antibiotici. Negli ultimi decenni, anche grazie l’utilizzo di tecniche moderne, la situazione era radicalmente cambiata, tanto da potersi affermare che un aborto praticato all’inizio della gravidanza, in situazioni sanitarie adeguate, era meno pericolo del parto. Con il proseguire della gravidanza, però, l’aborto diveniva progressivamente più rischioso. Sul punto, la Corte Suprema sostenne che il Texas, nel proteggere la salute e la vita della donna, conservava ancora interesse a disciplinare e limitare la possibilità di abortire, quando la gravidanza si trovava in uno stadio avanzato; 3. la terza, infine, era rappresentata dal dovere dello Stato di proteggere la vita prenatale. Per il Texas, solo se si fosse trovata a rischio la vita della madre, l’interesse di quest’ultima ad interrompere la gravidanza avrebbe potuto prevalere su quella del feto. A questo punto, viene sviluppato un rilevante argomento, che parte dal presupposto dell’oggettiva incertezza circa il momento in cui incomincia la vita. Non essendoci accordo sul punto in questione, tra gli scienziati, i filosofi e i teologi delle varie confessioni religiose, la Corte ha ritenuto che si dovesse quantomeno evitare di adottare rigidamente una delle opposte teorie. Non era sostenibile, pertanto, l’assunto secondo il quale la vita inizierebbe già al momento del concepimento. Del resto, il rigetto di questa soluzione si fondava su quella tradizione di common law che, come anzidetto, aveva elaborato la nozione di quickening, la quale segnava il tempo in cui il feto poteva considerarsi “animato” e, quindi, l’aborto non era più praticabile. Prima di questo momento, il feto era già considerato una cosa inanimata e, conseguentemente, l’aborto poteva essere consentito. La Corte Suprema riprese la nozione di diritto comune, e le attribuì – ai fini di certezza del diritto – un preciso significato temporale, individuando i primi tre mesi della gravidanza come il periodo in cui, non potendosi ancora parlare (relativamente all’embrione) di essere umano, il diritto della madre di interrompere la gravidanza non poteva essere in alcun modo limitato dallo Stato. Come s’è detto, la Costituzione non menziona il right of privacy, ma la Corte Suprema – già nel 1965 con il caso Griswold – era giunta al pieno riconoscimento costituzionale della sua esistenza. Da alcune pronunce si poteva evincere la riconducibilità di alcuni diritti fondamentali della persona ad un più generale e unitario concetto di personal privacy, al quale il V e il XIV Emendamento offrivano garanzia costituzionale, avverso l’azione del Governo Federale e degli Stati. La Corte, in sostanza, utilizzava il right of privacy come una sorta di clausola generale, che poteva apprestare tutela a libertà individuali di diversa manifestazione, relative al matrimonio, alla procreazione, alla contraccezione, alle relazioni familiari e all’educazione dei figli. In questo modo, la privacy aveva consentito ai giudici di fornire copertura costituzionale a diritti non espressamente menzionati in Costituzione, tramite il doppio passaggio della loro inclusione nel right of privacy e del riconoscimento che, la privacy stessa, rappresentava un diritto fondamentale protetto dalla Carta fondamentale, anche se da essa non espressamente menzionato (caso Griswold).
Nel 1973 la Corte Suprema era consapevole del ruolo che ormai aveva assunto tale diritto e del fatto che esso, ormai, rappresentava un concetto di sintesi, che racchiudeva -nel suo ambito- libertà di diverso contenuto. Nel caso in esame, la Corte affermò che il contenuto della privacy era sufficientemente ampio da includere la libertà della donna di decidere la sorte della propria gravidanza. Ribadì, quindi, che la privacy doveva essere garantita dal XIV Emendamento che, come già detto, limita il potere di azione degli Stati a salvaguardia delle libertà degli individui. Era, in definitiva, la due process clause a garantire, sul terreno costituzionale, la libertà della donna di abortire. Aggiunse, infine, per giustificare il riconoscimento del diritto d’interrompere la gravidanza, che una maternità non voluta poteva essere causa di pregiudizio fisico o psichico e, comunque, alterava -contro la volontà della donna- le sue condizioni materiali e psicologiche di vita. Il diritto all’aborto, però, non era assoluto, così come non lo è ancora oggi. Se è vero che esso trova fondamento nel right of privacy, è altresì vero che dev’essere contemperato dai legittimi interessi di cui lo Stato è titolare. Tali interessi, con il proseguire della gravidanza e dello sviluppo del feto, possono giungere a prevalere sul diritto della donna, giustificando la proibizione ad abortire. Per tale ragione, la Corte rigettò l’argomento della cd. ownership, secondo cui la donna, con il proprio corpo, potrebbe fare ciò che più le aggrada, ed affermò che il diritto alla privacy non garantisce alla donna un potere illimitato sul suo corto e, quindi sul feto. Inoltre, intorno alla 24° settimana, il feto diventa viable, cioè potenzialmente capace di vivere all’esterno dell’utero (sebbene con cure intensive): da questo momento, trovandosi di fronte ad un essere umano già formato, lo Stato ben avrebbe potuto proibire l’aborto, salvo che si rendesse necessario per salvare la madre da un serio pericolo di vita. Ma è opportuno rilevare che la Corte non ha affermato che il feto, una volta raggiunta la viability , diviene “persona”: essa si è solo limitata ad affermare che, da quel momento, trovandosi di fronte ad un essere un essere umano già formato anche se ancora non nato, lo Stato aveva un legittimo interesse a tutelarne la vita, vietando l’aborto. Riassumendo: per la Corte Suprema il diritto alla privacy, sebbene non menzionato dalla Costituzione, trova protezione nella due process clause del XIV Emendamento, e ricomprende – nel suo contenuto – il diritto di aborto, che viene così considerato fondamentale. Prima della fine del primo trimestre, la decisione di abortire dev’essere lasciata al giudizio del medico della donna e lo Stato non può interferire nella decisione assunta dal medico con la propria paziente. Proseguendo la gravidanza (e, quindi, lo sviluppo del feto) l’aborto diviene più rischioso del parto e, quindi, prende corpo l’interesse dello Stato alla protezione della salute della donna. Pertanto, dopo il primo trimestre, lo Stato può disciplinare (ma non proibire) l’aborto, imponendo limitazioni finalizzate (esclusivamente) alla tutela della salute della donna. Successivamente alla raggiunta viability del feto, ossia negli ultimi tre mesi di gravidanza, viene in considerazione anche il diverso interesse dello stesso alla potenziale vita umana che il feto rappresenta. Conseguentemente, l’aborto può essere vietato, purché non si renda necessario per salvaguardare la vita (o la salute) della madre. 6. Le critiche a Roe v. Wade
Alla base del favore che la sentenza ha ricevuto da parte dei sostenitori del diritto all’aborto, in un certo senso, vi è un fraintendimento, giacché, se è vero che la libertà di abortire si afferma essere costituzionalmente garantito dal right of privacy, è altrettanto vero che la decisione di abortire viene rimessa dalla Corte al prudente giudizio di un medico: «the abortion decision in all its aspects is inherently, and primarily, a medical decision, and basic responsability for it must rest with the physician». Questo significherebbe, a dirla tutta, che la donna non è pienamente libera di abortire, bensì di trovare un medico più o meno accondiscendente, disposto ad avallare la sua decisione, giustificandola dal punto di vista medico. Ma nei fatti, così come anche in Italia, la pratica medica ha seguito altre direzioni, non opponendosi alla volontà della donna e limitando il compito del medico alla verifica della serietà delle intenzioni della gestante. In diritto, la maggior critica mossa a Roe v. Wade è che la Corte Suprema, nel tentativo di operare una scelta di compromesso, non ha affrontato la vera questione su cui gravita il problema dell’aborto, ossia il riconoscimento (o meno), in capo al feto, della titolarità di diritti costituzionalmente garantiti e, quindi, l’individuazione dei reciproci limiti operativi tra tali diritti e la libertà di autodeterminazione della madre. Diverso è il percorso seguito da parte della dottrina, che (più o meno) coscientemente, comprende che non sono gli interessi dello Stato ad assumere diretta rilevanza giuridica, ma i diritti del feto . Quello che dovrebbe compiersi è, quindi, un bilanciamento tra la libertà della madre e l’interesse del feto. Evidentemente, ciò presupporrebbe un riconoscimento, almeno implicito, della rilevanza costituzione dei diritti del feto. Se tale riconoscimento non venisse effettuato, la libertà della madre, in quanto garantita dalla Costituzione, finirebbe sempre e incondizionatamente per prevalere sull’interesse del feto a nascere. Non è poi mancata neppure la contestazione della suddivisione, in tre periodi distinti, della gestazione, in considerazione del fatto che la Corte dovrebbe interpretare la Costituzione e salvaguardarne i valori, ma non sostituirsi al legislatore statale: spetterebbe solo al singolo Stato disciplinare la materia e, quindi, stabilire fino a quale mese sia consentito l’aborto da parte della madre. La Corte Suprema, invalidando le norme texane ritenute illegittime avrebbe quindi dovuto porre dei limiti all’azione del potere legislativo, lasciando però libero di scegliere, nel rispetto di tali limiti, come regolare l’aborto. Ma la questione giuridica sulla quale si manifesta il maggior dissenso, anche da parte di alcuni giudici della Corte, riguarda il riconoscimento costituzionale del diritto all’aborto operato, come s’è detto, tramite la sua inclusione nel diritto alla privacy. La critica si dirige verso entrambi i passaggi tramite i quali si è giunti al riconoscimento del diritto della donna di abortire: si contesta, quindi, quanto statuito dalla sentenza Griswold del 1965, cioè che la privacy sia un diritto costituzionale, giacché esso non è espressamente contemplato dalla Costituzione e, comunque, si nega che la problematica dell’aborto coinvolga la privacy della donna.
La dottrina, quand’anche afferma la riconducibilità del diritto all’aborto all’ambito del right to privacy, si trova in difficoltà nel ricostruire un concetto unitario del diritto, così come effettuato dalla Corte Suprema nel 1965 e nel 1973. La tendenza è, quindi, di tenere distinte la privacy, che offre protezione per mezzo del V e del XIV Emendamento, avverso l’ingerenza dei pubblici poteri nelle scelte personali di vita, dalla privacy a tutela della riservatezza dei singoli, di cui si occupa -in particolare- il IV Emendamento e il tort law, a seconda che la violazione sia commessa dal Governo oppure da altri cittadini. Per Rubenfeld, il diritto alla privacy – di cui parla la Corte – non va confuso con l’omonimo diritto che regola i rapporti tra privati: il primo protegge la libertà d’azione dell’individuo nei confronti dello Stato, mentre il secondo disciplina la raccolta, l’utilizzo e la diffusione di informazioni riguardanti la persona. Più precisamente, il right of privacy protetto dal XIV Emendamento impedisce che la vita dei cittadini sia diretta dallo Stato, tramite l’imposizione di comportamenti che influiscono pesantemente sulla loro esistenza. Imporre alla donna di avere un figlio, portando a termine una gravidanza non voluta, significa condizionarne la vita: la privacy, di conseguenza, può essere definita come il «right not to have the course of one’s life dictated by state», ossia come la garanzia delle libertà individuali contro le tendenze totalitarie dello Stato. Significativo è anche il pensiero di Gavison, il quale non mette in dubbio che la privacy (intesa come “diritto alla riservatezza”) sia un legal right, e accetta anche un’accezione ampia del diritto. Secondo l’autore la privacy consiste nella «limitation of others’ access to an individual» sotto un triplice profilo: inaccessibilità delle informazioni, anonimato e conservazione della distanza fisica dagli altri (secrecy, anonymity and solitude). Il diritto all’aborto non sarebbe riconducibile a nessuno dei tre enunciati, sì che il suo fondamento non dovrebbe rintracciarsi nella privacy, ma nella liberty of action, cioè nella libertà della donna ad autodeterminarsi. 7. Planned Parenthood v. Casey (1992). Dalla bozza della relazione redatta da Alito sembra che anche un’ulteriore pronuncia della Corte sia stata “presa di mira”: Planned Parenthood v. Casey, del 1992, la più rilevante pronuncia in tema di aborto dopo Roe v. Wade. Con questa pronuncia, la Corte Suprema, pur non compiendo un esplicito overrule di Roe, respinse alcuni dei principi in essa affermanti, confermandone però l’essential holding: sostenne, infatti, che la legge che limiti il ricorso all’aborto prima della vialibility deve essere sottoposta non più ad uno strict scrutinity , ma ad una valutazione della misura in cui essa incida sulla capacità di scelta della donna (undue burden test). Secondo la Corte, quindi, solo quelle previsioni che hanno il proposito o realizzano l’effetto di porre un ostacolo sostanziale per la donna che voglia compiere l’aborto di un feto ancora non vitale sono da ritenersi incostituzionali. Nel tentativo di chiarire quale limite potesse integrare gli estremi di un undue burden , e richiamando parte delle distinzioni enunciate in Roe, la Corte aggiunse che sono da ritenersi legittime le sole previsioni aventi lo scopo di tutelare la sicurezza e la salute della madre prima della viability. Al contrario, da questo momento, lo Stato può persino vietare certe tecniche di aborto a condizione che esse non siano necessarie per proteggere la salute e la vita della madre.
Il principio espresso in Casey ebbe conseguenze di notevole rilievo: il ricorso a un test meno stringente dello strict scrutinity di Roe implicò la qualificazione del diritto all’aborto non più come diritto fondamentale, ma come un interesse meritevole di particolare tutela costituzionale e venne altresì respinta la distinzione tra i tre trimestri della gravidanza, quale parte non essenziale dello holding di Roe. Mentre dopo Roe una legge statale che limitasse l’esercizio del diritto all’aborto prima del sesto mese difficilmente sarebbe stata giudicata costituzionale, Casey rese -di fatto- più semplice per gli Stati regolare l’aborto. Ciò, insieme alla minor rigidità dell’undue burden test, ha spinto nell’ultimo decennio i movimenti pro-life ad abbandonare l’obiettivo di una completa abolizione dell’aborto per indirizzarsi verso la condanna di determinate tecniche abortive, tra cui i partial-birth abortions e quelli a gravidanza avanzata. Almeno fino ad oggi. 8. Conclusioni Quando ci si addentra nell’esame delle opinioni espresse dai giudici favorevoli all’aborto, si rileva che il riconoscimento del diritto dipende, in ultima istanza, dalla sentita necessità di garantire la libertà della donna di decidere di un fatto (la gravidanza) che è, intimamente e biologicamente, connesso alla propria persona. È la libertà individuale, valore fondante (anche a scapito di altri) della società americana, il vero substrato del diritto all’aborto. Perciò la privacy potrebbe essere definita come l’involucro protettivo di questa manifestazione della libertà personale, come lo strumento scelto (in un particolare contesto politico-sociale) per tutelare il diritto della donna di autodeterminare il corso della propria esistenza. Il right of privacy garantisce il singolo dalle eccessive limitazioni che la libertà personale può subire dall’azione dello Stato o del Governo federale. La privacy, quindi, va intesa come conservazione di un proprio spazio individuale di libertà, non solo avverso le illecite intromissioni dei propri consociati, ma anche verso quelle operare dai poteri pubblici. Convive, perciò, nel diritto alla privacy, una dimensione propriamente privatistica accanto a quella pubblicistica. Come si è osservato, la Corte Suprema ha impostato il problema dell’aborto in termini di conflitto tra libertà della donna e interessi dello Stato. Si comprende, allora, la necessità di limitare i poteri di quest’ultimo al fine di preservare l’autonomia della prima. Lo Stato non può intromettersi nella vita privata della donna, sostituendosi ad essa nel compimento di scelte che attengono al suo corpo e alla sua esistenza, presente e futura, senza che sussistano ragionevoli giustificazioni di pari rilevanza costituzionale. Se, al contrario, il problema fosse stato inteso come bilanciamento della libertà della donna con l’interesse (o, se preferite, il diritto) del feto alla vita, allora evidentemente non si sarebbe trattato d’individuare i limiti dell’intromissione dell’autorità statale nella sfera privata di autonomia della donna, ma di stabilire i rapporti tra la libertà di quest’ultima e l’interesse di un altro soggetto privato (il feto). Poiché lo Stato liberale non ha un interesse proprio alla vita dell’uomo, essendo la sua funzione al servizio di quest’ultimo e non viceversa, l’azione pubblica dovrebbe essere intesa a tutela sia della libertà della donna di abortire, sia del diritto del feto alla vita, nella misura in cui tali opposti interessi siano stati (in base ad una scelta di valore, cioè politica) riconosciuti e contemperati.
La Corte ha preferito, invece, impostare il problema nel modo in cui la sua tradizione giuridica le suggeriva, cioè come conflitto tra il potere normativo dello Stato e la libertà della persona, utilizzando il collaudato strumento della substantive due process clause of law del XIV Emendamento, al fine di limitare l’intrusione della legislazione statale in scelte individuali. Subito dopo la sentenza Roe v. Wade, gruppi antiabortisti cominciarono un’intensa attività di lobbying affinché il Congresso intervenisse per contrastare gli effetti della sentenza del 1973. Si prospettò, quindi, l’introduzione di un Human Life Bill, che proclamasse che il feto fosse una persona e, come tale, dovesse essere protetto dal XIV Emendamento, il quale – come già detto – vieta agli Stati di togliere la vita alle persone senza la celebrazione di un giusto processo. Ma una legge federale non garantiva alcun risultato, potendo la Corte Suprema, vincolata solo alla Costituzione, mantenere il proprio orientamento: lo Human Life Bill avrebbe rappresentato solo un “invito” alla Corte a riconsiderare la propria decisione. Per questa ragione venne accantonato. L’unico percorso che potesse garantire tale risultato era una modifica costituzionale, ma nessuna delle proposte venne accolta, anche perché, all’interno del Partito Repubblicano, non sono mai mancati senatori pro-choice o, più semplicemente, senatori che non intendevano assumersi, davanti all’opinione pubblica, la responsabilità di essere stati coloro che avevano apertamente delegittimato l’operato della Corte Suprema, esasperando il conflitto sociale e riportando il paese all’“anarchia legislativa” degli anni ’60. L’ultimo tentativo avvenne nell’ormai lontano 1981, per opera di Orrin Hatch, senatore repubblicano dello Utah, il quale propose di introdurre un emendamento che affermasse che il diritto di abortire non è tutelato dalla Costituzione, consentendo agli Stati di regolarsi autonomamente. Da allora le forze antiabortiste presenti nel Congresso hanno abbandonato l’idea della modifica costituzionale, e si sono limitate a contrastare indirettamente gli avversari, tagliando i fondi destinati ad attività federali che agevolassero la scelta della donna di abortire e finanziando attività volte a favorire la decisione della gestante di portare a termine la gravidanza. Sembra, quindi, che solo la Corte Suprema possa rimettere in discussione i principi da essa formulati con la sentenza Roe v. Wade, e demandare agli Stati il compito di decidere se vietare o consentire l’aborto. Per anni, la dottrina (non solo americana) aveva visto di gran lunga improbabile un possibile overrule della sentenza, seppur paventato da alcuni studiosi, ma che non sembrava prossimo per via della maggioranza dei giudici ancora pro-choice. Tale possibilità appariva remota, in quanto il precedente aveva assunto, con il trascorrere degli anni, un’autorevolezza che lo rendeva difficilmente attaccabile e, per molti americani, la libertà della donna di abortire è ormai entrata, a tutti gli effetti, tra i diritti che la Costituzione riconosce e garantisce. Ma ad un attento esame dell’attuale composizione della Corte Suprema, appare che i giudici pro-choice , per la prima volta, siano in minoranza (4 a 5).
Nonostante ciò, ancora oggi, appare improbabile che vi possa essere un generale ripensamento dei
presupposti teorici della decisione, con riferimento alla particolare funzione assegnata dai giudici al
diritto alla privacy e alla considerazione dell’interesse dello Stato (anziché del feto) quale limite alla
libertà della donna. Ciò che invece appare possibile è che vi sia una riconsiderazione di alcune
questioni, di certo non marginali, quale quella, a cui si è accennato, della rigida suddivisione della
gravidanza in trimestri e della collocazione della viability del feto, che segna il momento a partire dal
quale l’aborto può essere proibito dallo Stato, al compimento del sesto mese di gravidanza, con un
adeguamento delle risposte date nel 1973 al progresso della scienza medica, nonché alle legislazioni
europee. In tal caso, è presumibile che si assisterà ad un sensibile arretramento dello spazio occupato
dalla puntigliosa regolamentazione introdotta dalla Corte a favore dell’autonomia normativa degli
Stati dell’Unione.
Dalla bozza della Relazione redatta da Alito, pubblicata da Politico, così si legge: «è tempo di dare ascolto
alla Costituzione e restituire la questione dell’aborto ai rappresentanti del popolo». Al momento, sembra
essere questa la strada. Salvo ripensamenti.
TAG: aborto, USA
Avvertenza
La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di
commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori,
titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi
(Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere
(anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-
ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre
copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente
personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono
parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal
nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità
del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365
cod. pen., in "Filodiritto" (https://www.filodiritto.com), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore
non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso
esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta
la citazione.
Filodiritto(Filodiritto.com) un marchio di InFOROmatica S.r.lPuoi anche leggere