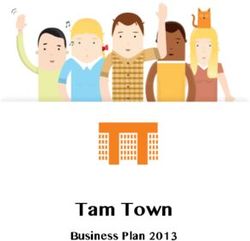SHORT NOTES SERIES Due libri importanti - www.econpubblica.unibocconi.it
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Università Commerciale Luigi Bocconi
Econpubblica
Centre for Research on the Public Sector
SHORT NOTES SERIES
Due libri importanti
Roberto Artoni
Short note n. 10
January 2007
www.econpubblica.unibocconi.itDUE LIBRI IMPORTANTI Negli ultimi anni J.S.Hacker, un politologo dell’Università di Yale, ha pubblicato due libri importanti, di grande interesse per tutti gli scienziati sociali e quindi anche per gli economisti. Il primo, The Divided Welfare State (Cambridge University Press,2002), ripercorre la storia dei meccanismi di protezione sociale operanti negli Stati Uniti, evidenziando similarità e differenze rispetto agli assetti europei. Il secondo, The Great Risk Shift (Oxford University Press, 2006) , uscito negli ultimi mesi dell’anno passato, analizza le conseguenze del progressivo ridimensionamento del sistema di assicurazioni fondate sul rapporto di lavoro, che aveva caratterizzato gli Stati Uniti nel secondo dopoguerra. Anche se il riferimento di questi due libri è alla realtà statunitense, dato lo stato di sudditanza interpretativa in cui versa in particolare il nostro paese, accurate informazioni sui problemi sociali americani sono comunque utili. Il punto di partenza del primo libro di Hacker è essenzialmente empirico. Utilizzando una serie d’indagini elaborate presso l’OECD, di cui in particolare è autore Adema, si sottolinea in primo luogo che la spesa sociale degli Stati Uniti, corretta per i fattori fiscali e integrata con le cosiddette componenti private, è sostanzialmente allineata a quella europea. La differenza sostanziale, più che nella dimensione quantitativa, risiede nel fatto che negli Stati Uniti la componente privata è molto più estesa di quella europea. Ricordando la tripartizione di Titmuss fra welfare pubblico, aziendale e fiscale, negli Stati Uniti il welfare aziendale (in cui l’accesso a pensioni e sanità è associato ad un determinato rapporto di lavoro, là dove l’impresa è in grado ed è disposta a predisporre le condizioni per l’accesso a questi benefici) ha avuto straordinario sviluppo, almeno fino a metà degli anni ’90 del XX secolo. Da allora la contrazione del welfare aziendale è stata compensata dallo sviluppo del welfare fiscale, in cui l’accesso alle più rilevanti forme di protezione sociale è il risultato di scelte individuali, anche se fiscalmente incentivate, eventualmente con il concorso del datore di lavoro. Lo sviluppo del welfare aziendale americano deve essere interpretato in stretta connessione con la storia politica, sociale ed economica degli Stati Uniti. Cogliendo alcuni spunti dall’analisi estremamente dettagliata di Hacker, qui si può ricordare l’impostazione corporativa del sindacato americano, molto attento alle esigenze dei propri iscritti per larga parte collocati presso imprese di grandissime dimensioni, dalle quali era relativamente agevole ottenere la concessione di piani pensionistici e sanitari. Il fatto poi che le minoranze fossero relativamente poco rappresentate nei settori sindacalizzati, spiega perché la divisione del welfare state negli Stati Uniti rifletta anche la composizione etnica della società americana, nel senso i meccanismi di protezione sociale sono relativamente poco diffusi fra le minoranza nere o latino-americane. Hacker dà anche importanza alla natura molto frammentata del sistema politico americano, che rende difficile il raggiungimento del consenso necessario per l’avvio di riforme di portata tendenzialmente universale. In questo senso rimane peculiare il new deal, quando in una situazione di particolari difficoltà economiche fu istituita la social security, senza che peraltro fosse possibile, allora o successivamente, avviare un sistema sanitario riferito all’intera popolazione. Qui interessa tuttavia soffermarsi sulle conseguenze di un sistema di protezione sociale largamente fondato su provvidenze aziendali. In primo luogo, l’erogazione delle prestazioni dipende dall’attività imprenditoriale di operatori privati, legittimamente mossi da motivi di profitto. Ma l’assenza di adeguati stimoli concorrenziali o la concentrazione del mercato, associate alla tipica presenza di un terzo pagante (l’impresa o il settore pubblico) non rende gli operatori privati fornitori dei servizi attenti nel controllo della dinamica dei costi. Qui basti ricordare che il tasso medio di del premio delle assicurazioni private sanitarie è aumentato nell’arco di tempo che va dal 1969 al 2002 del 10% annuo, contro un’inflazione che si è collocata in media fra il 3 e il 4%. Analogamente, là dove la platea dei potenziali assicurati non è vasta, l’accesso alle forme previdenziali private implica costi di gestione e di distribuzione assai elevati, con la conseguente erosione di una parte consistente dei rendimenti finanziari.
Il secondo elemento tipico del sistema americano riguarda il tasso di adesione ai piani previdenziali e sanitari, comunque relativamente circoscritto, sia perché solo una parte delle imprese li offrono, sia perché non tutti i potenziali beneficiari vi aderiscono. Il tasso di partecipazione si è collocato negli ultimi decenni fra il 50 e il 60%, a seconda che si comprendano o meno i dipendenti pubblici. Il terzo punto sottolineato da Hacker fa riferimento alla scarsa visibilità dei costi dei sistemi di protezione sociale fondati sulle agevolazioni fiscali. Infatti le tax expenditures (le perdite di gettito che derivano dalla concessione di agevolazioni fiscali e che concorrono al finanziamento delle prestazioni private) sono difficilmente valutabili, anche se certamente consistenti. Per una loro stima possiamo rinviare ai già ricordati lavori dell’OECD. Su un piano più generale Hacker sottolinea come il legislatore americano sia stato in questi anni ideologicamente contrario all’aumento degli interventi diretti in materia sociale, mentre è stato pronto, forse proprio per la scarsa visibilità del meccanismo o per le sollecitazioni derivanti da tutti gli intermediari coinvolti nel processo di erogazione delle prestazioni private, ad espandere le tax expenditures. La copertura non universale (ma concentrata nei settori sindacalizzati o presso gli alti redditi, con una scarsa presenza dei bassi redditi o del settore dei servizi o delle minoranze etniche), e le modalità di finanziamento fondate sul meccanismo della deducibilità portano ad effetti distributivi molto forti a favore delle classi abbienti (e anche su questo punto l‘analisi di Hacker è illuminante). Credo che le precedenti considerazioni diano ampiamente ragione del titolo del primo libro di Hacker, The Divided Welfare State: il meccanismo di protezione sociale, così come si è venuto formando nel tempo con un forte ruolo delle corporation, copre solo una parte della popolazione, la più abbiente o quello meglio collocata nel mercato del lavoro. La divisione non passa solo attraverso l’accesso alle prestazioni, ma anche attraverso modalità di finanziamento che presentano significativi elementi di regressività. Tutto ciò deve essere paragonato con il modello che in linea generale si è venuto formando in Europa, in termini di assorbimento di risorse, di efficacia sul piano sociale e anche di conseguenze macroeconomiche. Questi temi non sono affrontati da Hacker, anche se qui è opportuno ricordare che in questi anni è uscito un altro importante libro di un economista americano, P.H.Lindert, Growing Public (Cambridge University Press, 2004), in cui si pongono in discussione, e di fatto si demoliscono, alcuni dei temi più cari all’ortodossia economica; in particolare si dimostra che un sistema di sicurezza sociale, consapevolmente organizzato ed attento alle esigenze di coesione sociale, non sembra disincentivare gli individui al risparmio, al lavoro e in genere all’intraprendenza, essendo semmai vero il contrario. Ma questi temi non possono essere affrontati in questa sede. Qualsiasi costruzione sociale è caratterizzata da un processo evolutivo che, dopo periodi d’incubazione più o meno lunghi, produce mutamenti profondi negli assetti preesistenti. Nel secondo libro, The Great Risk Shift, Hacker analizza appunto la portata e gli effetti della trasformazione verificatasi nell’ultimo decennio nel sistema di protezione sociale degli Stati Uniti, dove è stato avviato il passaggio da un welfare caratterizzato da una forte componente aziendale ad uno di tipo fiscale in cui gli incentivi si applicano a scelte in buona misura individuali. All’origine di questa trasformazione si possono individuare molti fattori fra loro interconnessi. In primo luogo è stata dimostrata la scarsa funzionalità di meccanismi assicurativi a base ristretta in cui il rischio è collocato sul datore di lavoro. La decadenza relativa dei settori produttivi tradizionali e la stagnazione o il calo dell’occupazione in questi settori ha reso estremamente arduo per le imprese rispettare i contratti alla base dei meccanismi di welfare aziendale. I piani pensionistici in cui la pensione è legata al salario, con conseguente assunzione del rischio demografico da parte dell’impresa, si sono rivelati eccessivamente onerosi in situazioni economiche e produttive meno favorevoli di quelle originarie: di qui la chiusura a ritmi crescenti dei piani a beneficio definito e la loro sostituzione con piani a contribuzione definita, in cui il rischio di rendimento inadeguato delle contribuzioni o di cattiva gestione dei fondi previdenziali è totalmente a carico dell’individuo. Analogamente, la copertura sanitaria, per l’inadeguato controllo della dinamica dei costi (come abbiamo già osservato) e l’allungamento della vita media, là dove l’assicurazione sanitaria prosegue
sia pure parzialmente nel periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ha posto oneri di fatto insostenibili per le imprese. Si afferma che ogni automobile prodotta dalla General Motors è gravata da 1400 dollari di spese per l’assicurazione sanitaria. L’adozione di meccanismi di copertura meno capienti o, in molti casi, l’annullamento della possibilità di accedere ad assicurazioni sanitarie promosse dal datore di lavoro sono state le tipiche riposte di quest’ultimo decennio. Anche in questo caso, si è assistito ad uno spostamento del rischio dall’impresa all’individuo. Il secondo fattore di trasformazione ha natura ideologica e si risolve nell’affermazione di un principio di responsabilità individuale anche nei confronti dei grandi rischi dell’esistenza, quali sono la perdita delle salute e l’incapacità di guadagno per ragioni di vecchiaia. Per quanto riguarda le pensioni, la mancata costituzione di risorse adeguate per un dignitoso tenore di vita nella fase finale della vita è eventualmente “colpa” dell’individuo che non ha saputo risparmiare in maniera adeguata, prescindendo quindi dalle condizioni famigliari individuali o dalle vicissitudini che possono colpire segmenti più o meno larghi della popolazione per fatti che esulano completamente dalla responsabilità individuale. Il compito della collettività o del governo è semplicemente la predisposizione di veicoli fortemente agevolati sul piano fiscale che consentono la formazione di rendite pensionistiche attraverso l’investimento del risparmio individuale, integrato da un contributo comunque modesto dei datori di lavoro. Com’è noto il progetto di riforma del sistema pensionistico di Bush, al momento impantanato, prevede che, oltre alle componenti private, anche parte dei contributi destinati alla Social Security entrino nell’area del rischio di mercato a carico del l’individuo. E’ evidente che queste agevolazioni fiscali, nella misura in cui sono state utilizzate, hanno beneficiato le classi più abbienti (che hanno orientato il loro risparmio sulla componente previdenziale), mentre chi non era in grado di risparmiare (e l’annullamento del tasso di risparmio personale negli Stati Uniti ne è testimonianza eloquente) non ha potuto beneficiare di questi meccanismi. Nel campo sanitario il punto di attacco è stato individuato nell’azzardo morale, ossia nella propensione dell’individuo, in quanto assicurato, a richiedere più cure mediche di quanto necessario; di qui la creazione dei cosiddetti Health Individual Accounts, che, alimentati dagli accantonamenti individuali e da generose agevolazioni fiscali, dovrebbero spingere la popolazione americana a limitare la domanda di prestazioni sanitarie. Nella copertina del libro di Hacker si fa riferimento a The Assault on American Jobs, Families, Health Care, and Retirement, e sulla base di una documentazione per certi versi aneddotica, ma comunque molto ricca si analizzano le conseguenze che questa diversa distribuzione dei rischi fra individui e imprese, in una quadro di limitate responsabilità dell’autorità pubblica, ha avuto sulla popolazione americana e, in particolare, su quel segmento che si definisce classe media. Lo sviluppo economico di questi anni sembra aver avuto beneficiato solo una fascia ristretta della popolazione. Per larga parte della popolazione, a partire da redditi tipici della classe media, gli incrementi eventualmente ottenuti sono stati assorbiti dall’aumento di spese essenziali, educazione e sanità; il ricorso all’indebitamento è stato in larga misura indirizzato al finanziamento, e al rifinanziamento, di investimenti intrinsecamente rischiosi quali gli acquisti immobiliari o gli studi superiori, se è vero che il numero di diplomati o laureati che finiscono i loro studi indebitati è fortemente cresciuto. Hacker parla da un lato d’insicurezza diffusa, e dall’altro dimostra come lo spostamento del rischio dalle strutture collettive alla dimensione individuale ha creato in molti casi forti situazioni di disagio, che nella sua analisi sono destinate ad ampliarsi in futuro. Al di là dell’analisi e delle prospettive della società americana, i due libri di Hacker sono importanti a mio giudizio perché delineano in maniera precisa il problema fondamentale delle nostre società: come devono essere ripartiti i rischi di natura sociale, per i quali le responsabilità individuali sono comunque circoscritte. I creatori dello stato sociale moderno, lungi dal considerare il welfare state con un meccanismo puramente redistributivo (dai ricchi e gli intraprendenti ai poveri e agli incapaci) hanno ritenuto che malattia, disoccupazione, vecchiaia o impossibilità per ragioni economiche di accesso all’istruzione fossero di competenza collettiva e che elementari principi
assicurativi giustificassero la massima estensione della platea degli assicurati. Come ha chiaramente spiegato Hacker, negli Stati Uniti, al contrario, si è voluto evitare per quanto possibile questa assunzione di responsabilità collettiva (ma Social Security, Medicare e Medicaid sono stati via via introdotti), attribuendo alle imprese una grande responsabilità nella sfera sociale. Il meccanismo del welfare aziendale, per ragioni interne ed esterne, sembra essersi rotto. Al momento la risposta del governo americano sembra essere quella di allargare per quanto possibile la componente individuale. Richiamando quanto abbiamo osservato, si deve aggiungere che dal punto di vista delle dimensioni macroeconomiche l’assorbimento di risorse connesso agli interventi in campo sociale non è sostanzialmente diverso sulle due sponde dell’Atlantico, mentre è molto più sperequata la distribuzione dei benefici negli Stati Uniti. Quali insegnamenti si possono trarre per l’Europa o il nostro paese? Due sono le alternative ragionevolmente configurabili: mantenere intatte le strutture fondamentali dello stato sociale, con tutti gli adattamenti e le correzioni che le specifiche circostanze economiche e sociali imporranno, o inseguire il modello americano nelle sue ultime modulazioni.
Puoi anche leggere