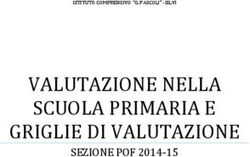PSR 2014-2020 Quadro di sintesi delle principali misure per la conservazione della biodiversità e la sostenibilità ambientale - La mia terra vale
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
PSR 2014-2020 Quadro di sintesi delle principali misure per la conservazione della biodiversità e la sostenibilità ambientale
PROGRAMMI
DI SVILUPPO RURALE
2014-2020
Quadro di sintesi delle principali misure
per la conservazione della biodiversità
e la sostenibilità ambientaleQuesta pubblicazione è stata realizzata nell’ambito del progetto fa.re.na.it. - Fare Rete per Natura 2000 in Italia realizzato da CTS, in collaborazione con Coldiretti, Comunità Ambiente, ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e Regione Lombardia, con il contributo del programma europeo Life+ dell’Unione Europea. Testi e ricerche Danilo Marandola e Silvia Coderoni Hanno collaborato Cinzia Chiodetti, Sara Cirillo Taiani, Stefano Di Marco, Oliviero Spinelli Responsabile Comunicazione Daniela Moretti Creative Director Luigi Pruiti Grafica Arianna Calandriello Fotografie Bigstock Stampa Press Up s.r.l. Per la citazione del presente volume si raccomanda la seguente dizione: Marandola D., Coderoni S., 2015. “PSR 2014-2020 - Quadro di sintesi delle principali misure per la conservazione della biodiversità e la sostenibilità ambientale”.
Î
indice
Introduzione: finalità, metodologia e contenuti della guida 2
Natura 2000: una rete di habitat da conservare nel territorio rurale 3
Natura 2000 in Italia 4
La multifunzionalità dell’agricoltura e i servizi ambientali 4
La politica agricola comune: per un’agricoltura a vantaggio di tutti 5
La PAC 2014-2020: per un’agricoltura più “verde” 6
I PSR 2014-2020: le priorità ambientali e climatiche del II pilastro della PAC 7
Principali misure per il raggiungimento delle priorità ambientali
e climatiche previste dai PSR 2014-2020 9
Istituzioni competenti per sviluppo rurale e Natura 2000 12
Il progetto Fa.re.na.it. - Fare Rete per Natura 2000 in Italia 14
RiferimentiÎ
Introduzione: finalità, metodologia e contenuti della guida
La serie di pubblicazioni che proponiamo ha l’obiettivo di presentare una sintesi dei principali strumenti di so-
stegno e incentivazione previsti dalla politica comunitaria di sviluppo rurale e dai Programmi di Sviluppo Ru-
rale (PSR) 2014-2020 nelle 21 tra Regioni e province autonome italiane. Scopo della pubblicazione è fornire
indicazioni e informazioni utili agli agricoltori, ai selvicoltori, agli allevatori e agli enti pubblici attivi nei terri-
tori rurali interessati ad intraprendere, con il sostegno della PAC, percorsi virtuosi di sostenibilità ambientale
e di protezione di habitat, con particolare riguardo alle aree Natura 2000.
Il materiale pubblicato si compone di due elementi. Un primo fascicolo, il presente, espone una iniziale disa-
mina delle questioni generali connesse a Natura 2000 e alla Politica agricola comune, concentrandosi sulle
finalità ambientali degli interventi in essa previsti o incentivati.
Vi è poi una sezione dedicata alle diverse realtà regionali o provinciali, con dei singoli fascicoli che riportano
un quadro delle principali misure previste dai singoli PSR regionali a favore di ambiente, clima e biodiversità.
In questa sezione vengono inquadrate le principali linee di intervento, i potenziali beneficiari, i contatti regionali
degli uffici preposti e ogni altra informazione utile per i potenziali destinatari delle misure.
Le informazioni riportate sono aggiornate al 31 marzo 2015, ma fanno riferimento a versioni preliminari dei
PSR presentate dalle Regioni e Province autonome tra luglio e ottobre 2014.
Nel momento in cui queste informazioni vengono raccolte, tutti i PSR regionali sono in fase di negoziato con
i Servizi della Commissione Europea, soprattutto su questioni relative ad ammissibilità degli impegni e degli
importi e alle diverse regole di attuazione. La conclusione di questo percorso di negoziato, che porterà a mo-
difiche anche sensibili dei Programmi, e l’ufficializzazione dei diversi PSR è attesa per tutte le regioni entro la
metà del 2015. A tale data sarà sicuramente possibile riscontrare modifiche e aggiornamenti dei programmi
rispetto alle versioni preliminari dei PSR ufficializzate a luglio-ottobre 2014, e sulle basi dei quali gli opuscoli
sono stati costruiti.
Per queste ragioni le informazioni presentate non intendono, né possono fornire un quadro completo ed esau-
stivo di tutti gli strumenti di sostegno e incentivazione previsti dai PSR per la conservazione della biodiversità
o per la tutela ambientale e climatica. Al contrario gli opuscoli intendono rappresentare documenti di orien-
tamento per guidare il lettore, potenziale beneficiario delle misure, a districarsi fra regole, acronimi e funzioni
2
dei pagamenti PSR.
Il lettore è pertanto invitato a consultare i siti tematici indicati in calce alla presente pubblicazione o nelle se-
zioni tematiche per conoscere ogni dettaglio e aggiornamento che sarà disponibile oltre a quanto indicato nella
Guida nel momento in cui saranno definitivamente approvati i diversi PSR.
Buona lettura!Î
Natura 2000: una rete di habitat da conservare nel
territorio rurale
L’Unione Europea (UE) caratterizza la sua politica per un forte impegno nelle tematiche di protezione della bio-
diversità. Natura 2000 è lo strumento che L’UE ha istituito per contrastare il degrado degli habitat naturali e
contenere le diverse minacce che mettono a rischio la sopravvivenza di specie animali e vegetali. Si tratta di
una rete ecologica composta da diversi habitat e diffusa su tutto il territorio dell’Unione, che ha come princi-
pale scopo la conservazione della biodiversità negli Stati membri attraverso la definizione di un quadro co-
mune di regole e pratiche per la corretta gestione di habitat che ospitano piante e animali di interesse
comunitario.
La Rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC) identificati dagli Stati Membri secondo
quanto stabilito dalla Direttiva Habitat (92/43/CEE) e da Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi
della Direttiva 2009/147/CE “Uccelli” per favorire la conservazione degli habitat naturali di uccelli selvatici di
interesse comunitario. Una volta individuato, ogni SIC deve diventare oggetto di un apposito Piano di ge-
stione, uno strumento di pianificazione che prevede una serie di misure di conservazione, ossia regole o azioni
che vanno messe in campo per conservare al meglio habitat e specie minacciati. Con questo passaggio un SIC
diventa Zona Speciale di Conservazione (ZSC). La designazione delle ZSC è un passaggio fondamentale per
la piena attuazione della Rete Natura 2000 perché garantisce l’entrata a pieno regime di misure di conser-
vazione “sito-specifiche” e offre una maggiore sicurezza per la gestione della rete e per il suo ruolo strate-
gico finalizzato al raggiungimento dell’obiettivo di arrestare la perdita di biodiversità in Europa entro il 2020.
Le aree che compongono Natura 2000 non devo essere intese come delle “aree protette”, ossia come riserve
gestite in modo rigido escludendo le attività umane. In particolare la Direttiva Habitat riconosce il valore di
tutte quelle aree nelle quali la secolare presenza dell’uomo e delle sue attività tradizionali hanno permesso il
mantenimento di un equilibrio tra attività antropiche e natura. È questo il caso delle aree agricole pastorali e
forestali alle quali sono legate numerose specie animali e vegetali ormai rare per la cui sopravvivenza è ne-
cessaria la prosecuzione e la valorizzazione delle attività tradizionali come il pascolo estensivo, la gestione fo-
restale sostenibile e l’agricoltura multifunzionale. Nelle Zone Speciali di Conservazione o nelle Zone di
Protezione Speciale, gli Stati membri dell’UE devono adottare tutte le misure necessarie per garantire la con-
servazione degli habitat e per evitarne il loro degrado. La direttiva prevede pertanto la possibilità che la Co-
3
munità Europea cofinanzi con proprie risorse la messa in campo di misure di conservazione attraverso diversi
strumenti.
Considerato che una grande parte degli habitat della Rete Natura 2000 ricade in aree rurali di interesse agri-
colo, forestale e pastorale, e che queste aree sono animate da agricoltori, boscaioli o pastori che possono con-
tribuire a conservare tali habitat, uno degli strumenti prioritari che interviene a finanziare la realizzazione di
idonee azioni di conservazione è la Politica comunitaria di Sviluppo rurale.
La Politica comunitaria di Sviluppo rurale, finanziata dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR),
sostiene la redazione di Programmi di Sviluppo Rurale (PSR), che a loro volta possono prevedere una serie di-
versificata di misure di sostegno per agricoltori, selvicoltori e allevatori che contribuiscono attivamente alla con-
servazione di habitat e specie.Î
Natura 2000 in Italia
In Italia, i SIC, le ZSC e le ZPS coprono complessivamente circa il 19% del territorio terrestre e quasi il 4% di
quello marino. Ad oggi da parte delle Regioni italiane sono stati individuati 2.314 Siti di Importanza Comu-
nitaria (SIC), 367 dei quali sono stati designati quali Zone Speciali di Conservazione, e 610 Zone di Protezione
Speciale (ZPS). Sono 335 i siti di tipo C, ovvero SIC/ZSC istituiti ai sensi della direttiva Habitat e coincidenti
con zone di protezione ZPS individuate ai sensi della direttiva Uccelli. In Italia la Direttiva Habitat protegge
complessivamente 131 habitat, 89 specie di flora e 111 specie di fauna (21 mammiferi, 11 rettili, 16 anfibi,
25 pesci, 38 invertebrati, mentre la Direttiva Uccelli protegge 387 specie di avifauna. Il 3 dicembre 2014 la
Commissione Europea ha approvato l’ultimo (ottavo) elenco aggiornato dei SIC per le tre regioni biogeogra-
fiche che interessano l’Italia (alpina, continentale e mediterranea).
Per saperne di più
Per avere un quadro completo delle aree Natura 2000 in Italia, è possibile visitare il sito internet del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM). Gli elenchi di habitat e specie della direttiva Ha-
bitat sono riportati in apposite liste di riferimento individuate per ogni regione biogeografica.Alla sezione schede
e cartografie dei SIC, ZSC e ZPS si possono visualizzare e scaricare tutti i dati aggiornati dei siti Natura 2000.
www.minambiente.it
Î
La multifunzionalità dell’agricoltura
e i servizi ambientali
Secondo la definizione della Commissione agricoltura dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo
Economico (OCSE), l’agricoltura si definisce multifunzionale quando oltre alla sua funzione primaria di pro-
4 duzione di cibo e fibre, diviene in grado di garantire alla collettività una serie di servizi secondari come il man-
tenimento del paesaggio, la protezione dell’ambiente, del territorio e della biodiversità, la gestione sostenibile
delle risorse naturali, la vitalità socio-economica delle aree rurali e la sicurezza alimentare.
L’agricoltura multifunzionale, dunque, è quell’agricoltura capace di svolgere a vantaggio di tutti, più funzioni
contemporaneamente, oltre alla funzione primaria di produzione di beni alimentari e materie prime. Questa
molteplicità di funzioni può essere ordinata secondo una scala di colori ad ognuno dei quali vengono ormai
tradizionalmente associate le diverse multi-funzioni dell’attività agricola:
FUNZIONE VERDE (gestione del paesaggio, degli habitat, della biodiversità);
FUNZIONE BLU (gestione delle risorse idriche, dell’equilibrio idrogeologico);
FUNZIONE GIALLA (mantenimento della vitalità e dell’identità sociale delle aree rurali, conservazione del-
l’eredità culturale, funzione ricettiva e ricreativa);
FUNZIONE BIANCA (sicurezza e qualità alimentare).
In Italia il concetto di agricoltura multifunzionale è espresso e recepito nel Decreto legislativo n. 228 del 2001
che, in attuazione della cosiddetta “legge di orientamento del settore agricolo”, pone le basi per una nuova
configurazione giuridica e funzionale dell’impresa agricola. Il D.lgs. 228/2001, infatti, ridefinisce la figura del-
l’imprenditore agricolo, modificando anche l’articolo 2135 del codice civile, e sancisce che
“è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, alleva-
mento di animali e attività connesse […]”ove per attività connesse, si intende una serie di attività:
“dirette alla fornitura di beni o servizi […], ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del
patrimonio rurale e forestale”.
Nel contesto normativo nazionale, dunque, le “attività connesse” divengono l’ambiente entro il quale,
sotto regole precise, l’imprenditore agricolo può esercitare la propria multifunzionalità a vantaggio della
collettività.
L’Unione Europea è la culla dei principi dell’agricoltura multifunzionale agricola che vengono promossi a
tutto tondo attraverso gli strumenti di sostegno e incentivazione della Politica agricola comune (PAC) e,
soprattutto, dalle misure di intervento dei Programmi di sviluppo rurale (II pilastro della PAC).
Per saperne di più
www.ec.europa.eu/agriculture
Î
La politica agricola comune:
per un’agricoltura a vantaggio di tutti
L’agricoltura è una componente essenziale dell’economia e della società dell’Unione Europea. Il settore agri-
colo, infatti, oltre ad assolvere alla funzione primaria di produzione di beni alimentari, rappresenta anche una
fonte di servizi preziosi per la collettività come occupazione, presidio del territorio, salvaguardia delle risorse
naturali e ambientali. La Politica Agricola Comune (PAC) sposa a pieno i principi della multifunzionalità del-
l’agricoltura prevedendo due diversi Pilastri di azione destinati a supportare l’agricoltura europea nella dire-
zione non solo della competitività, ma anche dello sviluppo armonico di tutte le sue diverse funzioni. Per il
prossimo settennio di programmazione, la PAC si pone tre macro-obiettivi strategici in linea con quella che
viene definita Strategia Europa 2020: crescita più sostenibile, intelligente ed inclusiva dell’Europa rurale. Nel
dettaglio, gli obiettivi strategici identificati per la PAC 2014-2020 sono:
• Preservare il potenziale di produzione alimentare dell’UE secondo criteri di sostenibilità, al fine di garantire 5
la sicurezza dell’approvvigionamento alimentare a lungo termine per i cittadini europei e contribuire a sod-
disfare la domanda mondiale di prodotti alimentari, stimata in aumento al 2050.
• Sostenere le comunità agricole che forniscono ai cittadini europei una grande varietà di derrate alimentari
di pregio e qualità prodotte in modo sostenibile, nel rispetto degli obiettivi che l’Unione si è data in materia
di ambiente, acque, salute e benessere degli animali e delle piante e salute pubblica.
• Preservare la vitalità delle comunità rurali, per le quali l’agricoltura costituisce un’attività economica im-
portante in grado di creare occupazione locale.Î
La PAC 2014-2020: per un’agricoltura più “verde”
I principi della multifunzionalità, ma soprattutto le funzioni “verdi” dell’agricoltura, hanno avuto un ruolo
molto importante nel dibattito verso la programmazione della Politica Agricola Comune 2014-2020, tanto che
questi temi sono stati affrontati in modo diretto sia nel I che nel II pilastro di intervento della nuova PAC.
Il greening del primo pilastro.
Il primo pilastro della PAC è quello dedicato a erogare pagamenti diretti a tutte le aziende agricole attive sul
territorio che rispettano i criteri base della condizionalità. Per questo pilastro di azione, la programmazione
2014-2020 ha previsto una novità assoluta: le aziende agricole sono meritevoli dell’intero pagamento che
spetterebbe loro solo se prima dimostrano di rispettare delle regole “verdi” di base racchiuse nel cosiddetto
pacchetto “greening”.
Il greening del primo pilastro è lo strumento con cui la PAC persegue l’obiettivo di remunerare la produzione
di beni pubblici assicurati dagli agricoltori come lo stoccaggio di carbonio nel suolo, il mantenimento degli ha-
bitat erbosi presenti nel pascolo permanente, la protezione delle acque e degli habitat attraverso aree di in-
teresse ecologico e il miglioramento della resilienza dei suoli e degli ecosistemi con la diversificazione delle
colture.
Per aver diritto al pagamento aziendale “pieno” (pagamento di base integrato con l’importo previsto per la com-
ponente “verde”), l’agricoltore deve osservare su tutti i suoi ettari ammissibili quanto previsto dal greening, ovvero:
1.Obbligo di diversificazione dei seminativi presenti in azienda
Variabile a seconda della superficie a seminativo
2.Mantenimento prati e pascoli permanenti
Divieto assoluto di convertire in seminativo prati permanenti e pascoli in quanto zone di elevato interesse am-
bientale. Queste zone possono essere ubicate sia all’interno che all’esterno della Rete Natura 2000.
3.Introduzione di Aree di Interesse Ecologico (AIE)
Le aziende con più di 15 ettari di seminativi devono destinare almeno il 5% della superficie a seminativi ad
aree di interesse ecologico (AIE).
Per evitare di penalizzare con il rispetto di questi requisiti tutte le aziende che in qualche misura già adottano
6
sistemi di sostenibilità ambientale, il “greening” prevede un sistema di “equivalenza d’inverdimento”. In base
a questo principio la PAC assume che alcune prassi favorevoli all’ambiente sostituiscano di fatto gli obblighi
di sostenibilità previsti dal greening. Rientrano in questi casi: le aziende che praticano agricoltura biologica
certificata e le aziende ricadenti in un sito della rete Natura 2000 a patto che questo sito sia in possesso di
misure di conservazione, che l’azienda le rispetti e che queste siano coerenti con i principi del greening stesso.Î
I PSR 2014-2020: le priorità ambientali e climatiche del
II pilastro della PAC
Il secondo Pilastro della PAC è per gli attori del mondo rurale, imprese o enti locali che volontariamente in-
tendono intraprendere percorsi di crescita e sviluppo sostenibile. Partendo dagli obiettivi generali di Europa
2020 e della PAC 2020, la politica di Sviluppo Rurale del periodo 2014-2020, alimentata dal Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) si ripropone di perseguire sei priorità strategiche in sinergia con altri
Fondi dell’UE come il Fondo di Sviluppo Regionale (FESR) o il Fondo Sociale Europeo (FSE). Per farlo il FEASR
si avvale di Programmi (i PSR), che in Italia sono costruiti dalle regioni, contenenti le indicazioni strategiche e
soprattutto un set di misure di intervento destinate ai beneficiari finali (Fig. 1)
POLITICA AGRICOLA COMUNE
M M M
Obiettivi Europa 2020 - Crescita intelligente, crescita sostenibile, crescita inclusiva
Obiettivi PAC 2020 [COM(2010) 672-def]
Produzione alimentare efficiente Gestione sostenibile delle risorse Sviluppo territoriale equilibrato
Fondo di coesione
Quadro Strategico
Comune (QSN)1
I PILASTRO II PILASTRO
Sviluppo Rurale Fondo europeo di sviluppo regionale
Pagamenti diretti
M
M
M
M
(FESR)
Fondo Europeo Agricolo
+ Sviluppo Rurale Fondo sociale europeo (FSE)
Misure di mercato (FEASR)
M
Fondo europeo per la pesca (FEAMP)
M
Programmi Sviluppo Rurale (PSR)
1. Promuovere il trasferimento di conoscenze e l’innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali;
2. Potenziare la competitività dell’agricoltura in tutte le sue forme e la redditività delle aziende agricole;
3. Incentivare l’organizzazione della filiera agroalimentare e la gestione dei rischi nel settore agricolo;
4. Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall’agricoltura e dalle foreste;
5. Incoraggiare l’uso efficiente delle risorse e il passaggio a un’economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale;
M
6. Promuovere l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali.
MISURE
7
Fig. 1. La struttura della PAC e dei PSR 2014-2020 (Romano&Marandola, 2012)
Le sei priorità dei PSR 2014-2020 sono:
1.Promuovere il trasferimento di conoscenze e l’innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali
2.Potenziare la competitività dell’agricoltura in tutte le sue forme e la redditività delle aziende agricole
3.Incentivare l’organizzazione della filiera agroalimentare e la gestione dei rischi nel settore agricolo
4.Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall’agricoltura e dalle foreste
5.Incoraggiare l’uso efficiente delle risorse e il passaggio a un’economia a basse emissioni di carbonio e re-
siliente al clima nel settore agroalimentare e forestale
6.Adoperarsi per l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali.
Due di queste sei priorità (la 4 e la 5) sono di stampo strettamente ambientale e prevedono una serie di sotto-
priorità (chiamate “focus areas”) di forte interesse ecologico (Fig. 2).PRIORIT¸ FOCUS AREAS
4) preservare, ripristinare e valorizzare gli a) salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità
ecosistemi connessi all’agricoltura e alla b) migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione
silvicoltura, con particolare riguardo ai se- dei fertilizzanti e dei pesticidi
guenti aspetti:
c) prevenzione dell’erosione dei suoli e migliore gestione degli
stessi
5) Incentivare l’uso efficiente delle risorse a) rendere più efficiente l’uso dell’acqua nell’agricoltura
e il passaggio a un’economia a basse b) rendere più efficiente l’uso dell’energia nell’agricoltura e nel-
emissioni di carbonio e resiliente al clima l’industria alimentare
nel settore agroalimentare e forestale, con
c) favorire l’approvvigionamento e l’utilizzo di fonti di energia
particolare riguardo ai seguenti aspetti: rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre ma-
terie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia;
d) ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca pro-
dotte dall’agricoltura
e) promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel
settore agricolo e forestale
Le priorità “ambientali” e “climatiche” dei PSR 2014-2020 e le relative focus areas
La rilevanza di queste tematiche è notevole, tanto che i regolamenti stabiliscono che almeno il 30% della do-
tazione finanziaria complessiva di ciascun PSR debba essere destinata agli interventi a favore dell’ambiente,
del clima e della biodiversità. Tutte e sei priorità dello sviluppo rurale, inoltre, devono concorrere al raggiun-
gimento di tre obiettivi trasversali: l’azione per il clima, l’ambiente e l’innovazione.
8Î
Principali misure per il raggiungimento delle priorità
ambientali e climatiche previste dai PSR 2014-2020
Come detto la Politica di sviluppo rurale trova attuazione attraverso dei Programmi di azione (che in Italia sono
realizzati su scala regionale). Tali Programmi di Sviluppo Rurale (PSR) prevedono una serie diversificata di mi-
sure di incentivazione e sostegno per beneficiari sia pubblici che privati interessati ad intraprendere volonta-
riamente investimenti e azioni di crescita e sviluppo sostenibile.
Fra i beneficiari privati possono rientrare imprenditori agricoli, selvicoltori, allevatori e proprietari di fondi rustici.
Fra i beneficiari pubblici i Comuni, gli Enti parco, gli enti gestori di siti Natura 2000 o loro associazioni.
La lista delle possibili misure da prevedere in un PSR a vantaggio dei beneficiari, e tutte le regole per farlo, sono
contenute in un regolamento comunitario (Reg. UE 1305/2013) e in tutti i documenti (normativi e non) ad esso
associati. La lista delle misure di intervento che possono essere previste da un PSR è molto lunga e ha lo scopo
di fornire strumenti di azione necessari ad affrontare tutte e sei le priorità strategiche individuate dall’UE. Ogni
misura, in linea generale, può prevedere ulteriori sotto-misure o operazioni allo scopo di focalizzarsi su aspetti
nodali o su comparti particolarmente vulnerabili o importanti.A loro volta sotto-misure e operazioni possono pre-
vedere ulteriori diversificazioni in singole linee di intervento che prevedono specificità per tipologie di impegni e
beneficiari. “Ambiente” e “clima” sono, insieme a “innovazione”, due delle tre priorità trasversali dei PSR, ossia
priorità a cui tutte le misure devono poter contribuire. Ad ogni modo, con riguardo alle priorità 4 e 5 dei PSR, le
misure a disposizione di agricoltori, selvicoltori, allevatori, proprietari privati ed enti pubblici più squisitamente
destinate ad affrontare i temi ambientali e climatici dei PSR possono essere ricondotte a:
Misura 4.4 - Investimenti non-produttivi con finalità climatico-ambientale e di difesa di habitat
Il sostegno nell’ambito della misura è destinato a investimenti materiali e/o immateriali di tipo non-produt-
tivo connessi all’adempimento degli obiettivi agro-climatico- ambientali perseguiti dai PSR, compresa la con-
servazione della biodiversità delle specie e degli habitat, o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità
delle zone Natura 2000 o di altri sistemi ad alto valore naturalistico. Beneficiari della misura sono gli im-
prenditori agricoli o loro associazioni e la quota di finanziamento è fino al 100% delle spese di investimento
realizzate e giudicate ammissibili.
9
Misura 7 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali
Il sostegno nell’ambito della misura riguarda anche la stesura e l’aggiornamento di piani di tutela e di gestione
dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico; la misura finanzia, inoltre, studi e investimenti re-
lativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del pae-
saggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni
di sensibilizzazione in materia di ambiente. Beneficiari di questa misura sono principalmente gli enti locali.
Misura 10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali
Questa misura è finalizzata alla conservazione e alla promozione dei necessari cambiamenti delle pratiche agri-
cole che contribuiscano favorevolmente all’ambiente e al clima. Il suo inserimento nei programmi di sviluppo
rurale è obbligatorio a livello nazionale e/o regionale. Si tratta di pagamenti a superficie destinati ad agricol-
tori, ad associazioni di agricoltori o ad associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio che si im-
pegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni agro-climatico-ambientali.
I pagamenti agro-climatico-ambientali compensano soltanto quegli impegni che vanno volontariamente al di
là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legge. Detti impegni devono essere rispettati per un periodo
compreso tra cinque e sette anni. I pagamenti sono erogati annualmente per compensare, in tutto o in parte,
i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti volontariamente.Misura 11 - Agricoltura Biologica
La misura concede un pagamento, per ettaro di superficie agricola, agli agricoltori o alle associazioni di agri-
coltori che si impegnano volontariamente ad adottare o a mantenere i metodi e le pratiche di produzione bio-
logica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007. Il sostegno è concesso unicamente per impegni che vanno
al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legge. Gli impegni assunti nell’ambito della presente
misura vanno mantenuti per un periodo di tempo compreso tra cinque e sette anni. I pagamenti sono erogati
annualmente e compensano, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli im-
pegni assunti di conversione o mantenimento dell’agricoltura biologica.
Misura 12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull’acqua
Il sostegno previsto dalla presente misura è erogato annualmente, per ettaro di superficie agricola o per ettaro di
foresta, per compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli occasionati dall’applicazione della
direttiva 92/43/CEE (Habitat) e della direttiva 2009/147/CE (Uccelli) e della direttiva quadro sulle acque. Il soste-
gno è concesso agli agricoltori e ai silvicoltori privati nonché alle associazioni di silvicoltori privati. Il sostegno agli
agricoltori in relazione alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE è concesso unicamente per i vincoli derivanti da
requisiti che vanno al di là delle buone condizioni agronomiche e ambientali stabilite dalla legge. Il sostegno può
oscillare da 200 a 500 euro/ha massimi a seconda delle scelte regionali. Per l’attivazione della misura è indispen-
sabile che i siti Natura 2000 siano dotati di piani di gestione e di misure di conservazione che rappresentano le
regole rispetto alle quali vanno commisurate le eventuali indennità.
Misura 15 - Servizi silvo-ambientali e climatici e salvaguardia delle foreste
Il sostegno proposto con la misura è concesso, per ettaro di foresta, a silvicoltori pubblici e privati e altri enti
di diritto privato e pubblici e loro associazioni che si impegnano volontariamente a realizzare interventi con-
sistenti in uno o più impegni silvoambientali e climatici. Nel caso delle foreste demaniali, il sostegno può es-
sere concesso solo se l’organismo di gestione di tali foreste è un ente privato o un comune. Per le aziende
forestali al di sopra di una determinata soglia (che viene determinata dalle singole Regioni), il sostegno è su-
bordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da
uno strumento equivalente che sia conforme ai criteri di gestione forestale sostenibile. I pagamenti riguardano
soltanto quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dal diritto nazionale sulle
10foreste o da altri atti legislativi nazionali applicabili. Gli impegni assunti nell’ambito della misura hanno una
durata compresa tra cinque e sette anni. I pagamenti sono intesi a compensare, in tutto o in parte, i costi ag-
giuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti.
Misura 16 - Cooperazione
Il sostegno nell’ambito della misura è concesso al fine di incentivare ogni forma di cooperazione tra almeno
due soggetti e in particolare azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento
ad essi e approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso, inclusi la gestione efficiente delle ri-
sorse idriche, l’uso di energia rinnovabile e la preservazione dei paesaggi agricoli. Sono sovvenzionabili nel-
l’ambito della misura i seguenti elementi di costo inerenti alle forme di cooperazione: studi di fattibilità, stesura
di piani aziendali, stesura di piani di gestione forestale, costo dell’animazione della zona interessata al fine
di rendere fattibile un progetto territoriale collettivo, i costi di esercizio della cooperazione, costi diretti di spe-
cifici progetti legati all’attuazione di un piano ambientale, di un piano di gestione forestale o di una strate-
gia di sviluppo locale e i costi delle attività promozionali.
Fra tutte le misure, si sottolinea in particolare il potenziale ruolo della cooperazione (misura 16), che vede al-
largarsi il suo campo di applicazione per incentivare i rapporti tra due o più operatori nel settore agricolo e
forestale. Questa più forte enfasi sugli approcci collettivi deriva dal fatto che vengono riconosciuti i molteplici
vantaggi che l’azione collettiva e la cooperazione possono apportare in termini di scambio di conoscenze ed
esperienze, stimolo all’innovazione, sviluppo di nuove relazioni e sfruttamento di opportunità di mercato ba-
sate su interessi condivisi. Da un punto di vista ambientale, inoltre, è evidente che l’azione collettiva porti
vantaggi in termini sia di efficacia del raggiungimento di obiettivi su scala territoriale, che di maggior parte-
cipazione dei beneficiari nella definizione degli interventi.
Per saperne di più sulla PAC e le politiche comunitarie per l’agricoltura
www.politicheagricole.it
www.ec.europa.eu/agriculture
www.europa.eu/pol/agr/
Per saperne di più sulla programmazione PSR 2014-2020
www.ec.europa.eu/agriculture
11Î
Istituzioni competenti per sviluppo rurale e Natura 2000
UNIONE EUROPEA Emilia Romagna
• Commissione Europea - Direzione • PSR 2014-2020
Generale Agricoltura www.agricoltura.regione.emilia-romagna.it
www.ec.europa.eu/agriculture • Natura 2000
• Commissione Europea – Direzione Generale Am- www.ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchi-
biente natura2000
www.ec.europa.eu/dgs/environment Friuli Venezia Giulia
• PSR 2014-2020
ITALIA www.regione.fvg.it/rafvg
• Ministero delle Politiche Agricole Alimentari • Natura 2000
e Forestali www.regione.fvg.it/rafvg
www.politicheagricole.it Lazio
• Ministero dell’Ambiente e della Tutela • PSR 2014-2020
del Territorio e del Mare www.agricoltura.regione.lazio.it/agriweb
www.minambiente.it • Natura 2000
www.regione.lazio.it/rl_ambiente
REGIONI Liguria
Abruzzo • PSR 2014-2020
• PSR 2014-2020 www.agriligurianet.it/it/impresa
www.rica.inea.it/PSR_2014_2020 • Natura 2000
• Natura 2000 www.natura2000liguria.it
www.regione.abruzzo.it/xambiente Lombardia
Basilicata • PSR 2014-2020
• PSR 2014-2020 www.agricoltura.regione.lombardia.it
12 www.basilicatapsr.it/politica-agricola-comune--2014- • Natura 2000
2020 www.cartografia.regione.lombardia.it
• Natura 2000 Marche
www.natura2000basilicata.it • PSR 2014-2020
Calabria www.agricoltura.regione.marche.it
• PSR 2014-2020 • Natura 2000
www.sites.google.com/site/vexapsrcalabria1420 www.ambiente.marche.it/Ambiente
• Natura 2000 Molise
www.regione.calabria.it/ambiente • PSR 2014-2020
Campania www3.regione.molise.it
• PSR 2014-2020 • Natura 2000
www.sito.regione.campania.it/agricoltura www3.regione.molise.it
• Natura 2000 Piemonte
www.web.regione.campania.it • PSR 2014-2020
www.regione.piemonte.it/agri
• Natura 2000
www.regione.piemonte.it/parchiProvincia Autonoma di Bolzano Toscana
• PSR 2014-2020 • PSR 2014-2020
www.provincia.bz.it/agricoltura www.regione.toscana.it/programma-di-sviluppo-
• Natura 2000 rurale
www.provincia.bz.it/natura-territorio • Natura 2000
Provincia Autonoma di Trento www.regione.toscana.it
• PSR 2014-2020 Umbria
www.trentinoagricoltura.it/Trentino-Agricoltura • PSR 2014-2020
• Natura 2000 www.svilupporurale.regione.umbria.it/Mediacenter
www.territorio.provincia.tn.it • Natura 2000
Puglia www.regione.umbria.it/ambiente
• PSR 2014-2020 Valle d’Aosta
www.svilupporurale.regione.puglia.it • PSR 2014-2020
• Natura 2000 www.regione.vda.it/agricoltura
www.sit.puglia.it • Natura 2000
Sardegna www.regione.vda.it/risorsenaturali
• PSR 2014-2020 Veneto
www.regione.sardegna.it/speciali • PSR 2014-2020
• Natura 2000 www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste
www.regione.sardegna.it • Natura 2000
Sicilia www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio
• PSR 2014-2020
www.psrsicilia.it
• Natura 2000
www.sitr.regione.sicilia.it
13Î
Il progetto Fa.re.na.it.
Fare Rete per Natura 2000 in Italia
Il progetto Fa.re.na.it, co-finanziato dal programma LIFE+ dell’Unione Europea, nasce per rilanciare Rete Natura
2000 in Italia, il programma europeo per la protezione degli habitat e delle specie a rischio.
Molti habitat naturali e tanti animali rari e minacciati sopravvivono anche grazie a pratiche agricole tradizionali e
sostenibili. Per questo è importante coinvolgere nella salvaguardia della biodiversità chi vive ed opera in determi-
nate aree agricole.
Nel corso di 3 anni di progetto (dal 2012 al 2015) fa.re.na.it si è posto l’obiettivo di rafforzare l’alleanza tra mondo
rurale e mondo della conservazione della natura, attraverso una serie di azioni di comunicazione realizzate su tutto
il territorio nazionale e rivolte:
• agli agricoltori per aumentare la conoscenza della rete Natura 2000 e le opportunità che essa offre al mondo
rurale;
• agli amministratori pubblici, per accrescere le conoscenze e le competenze sulle tematiche relative alla rete eco-
logica europea;
• alle scuole per rafforzare il rapporto dei giovani con il territorio in cui vivono e per renderli consapevoli dell'im-
portanza della natura e della biodiversità.
Le azioni previste si sono proposte di migliorare la comunicazione fra amministrazioni pubbliche e mondo agricolo,
illustrando i benefici collegati alla rete ecologica europea e restituendo ai territori inclusi nella Rete Natura 2000
il riconoscimento del loro valore per fermare la perdita della biodiversità.
Fa.re.na.it nasce dalla collaborazione tra CTS, ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
- la Regione Lombardia, Coldiretti e Comunità Ambiente.
Il progetto è stato co-finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dal Ministero
delle Politiche Agricole, dalle Regioni Abruzzo, Calabria e Marche e dalla Provincia di Agrigento, dai parchi Nazio-
nali delle Cinque Terre e del Pollino e dal Parco Regionale delle Serre.
Per maggiori informazioni sul progetto: www.lamiaterravale.it - farenait@cts.it
14Î
Riferimenti
Bibliografia
Coderoni S. (2014), Misure per la sostenibilità ambientale: cosa cambia con la riforma della PAC, Agrimar-
cheuropa n. 4, Settembre 2014
Coderoni S. (2014), L’accordo agroambientale d’area della Valdaso, in Vanni F (a cura di). Agricoltura e beni
pubblici. Governance territoriale e politiche. INEA, 2014.
Coderoni S., (2013), Agricoltura e cambiamenti climatici: dalle politiche comunitarie ai Psr, AgriregioniEu-
ropa anno 9 n. 35, Dicembre 2013.
Mantino F., (2013), La riforma della Politica di sviluppo rurale 2014-2020, AgriregioniEuropa anno 9 n. 35,
Dicembre 2013.
Marandola D. (2010), L’evoluzione dei processi di regolamentazione nel contesto italiano, in (a cura di) Ievoli
C., Percorsi multifunzionali in agricoltura: agricoltura e servizi del verde e del territorio, Ed. Sistemi Editoriali.
Marandola D. (2014), Agricoltura e multifunzionalità, in (a cura di) Messina G., Una vita in cooperazione:
un manuale del tempo e del lavoro ritrovato, Ed. La Scuola di Pitagora
Romano R., Marandola D., (2012) Risorse forestali nello Sviluppo Rurale 2014-2020, nuove opportunità e
vecchie esigenze. Sherwood, Foreste e alberi oggi, n. 182, Aprile 2012
Vanni F., (2014), Verso una PAC più verde? AgriregioniEuropa, n.38, Settembre 2014, Associazione Ales-
sandro Bartola, Ancona, ISSN: 1828-5880.
Vanni F., (2013). Il possibile impatto dell’applicazione del greening in Italia, AgriregioniEuropa anno 9 n. 35,
Dicembre 2013.
Van Huylenbroeck, G., Vandermeulen, V., Mettepenningen, E. and Verspecht, A., 2007. Multifunctionality of
Agriculture: A Review of Definitions, Evidence and Instruments. Living Reviews in Landscape Research 1
Sitografia
www.europa.eu/legislation_summaries/environment
www.minambiente.it/pagina/rete-natura-2000
www.minambiente.it/pagina/sic-zsc-e-zps-italia
www.giovanimpresa.coldiretti.it/pubblicazioni
www.ec.europa.eu/agriculture/rurPuoi anche leggere