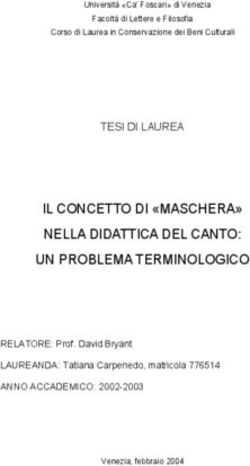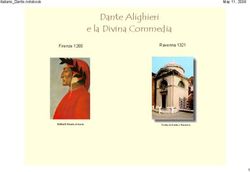PROGRAMMA di ITALIANO - IIS - Eliano Luzzatti
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
PROGRAMMA di ITALIANO
I.I.S. ELIANO-LUZZATTI IV A Classico
ANNO SCOLASTICO 2018-19 CLASSICO
Premessa
Il presente programma è stato integralmente redatto dagli Alunni. A tutti loro il docente esprime
gratitudine e apprezzamento.
Ritorno alle origini
• Guido Cavalcanti:
-Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira;
-Donna me prega, perch’eo voglio dire;
-Voi che per li occhi mi passaste 'l core.
• Guido Guinizzelli:
-Al cor gentil rempaira sempre amore.
• Bonagiunta Orbicciani:
-Voi, ch’avete mutata la mainera;
-Critica a Cavalcanti.
• Dante Alighieri:
-Convivio, allegoria dei poeti e dei teologi;
-La Vita Nova;
-Voi ch’ascoltaste in rime sparse il suono;
-Amor che ne la mente mi ragiona;
-Donne ch’avete intelletto d’amore;
-Oltre la spera che più larga gira;
-Tanto gentile e tanto onesta pare.
R. Luperini, Perché la letteratura:
• Il poema cavalleresco alle corti di Firenze e di Ferrara:
-La tradizione dei cantari e la nascita del poema cavalleresco
• Luigi Pulci, Il Morgante:
-Ciclo carolingio;-Parodia e sproporzioni -Rivisitazione dell’eroismo nell’analisi critica di Cavazzoni; -Edizioni del Morgante; -Parodia della Bibbia e del Purgatorio di Dante. R. Luperini, Perché la letteratura: - Un poeta controcorrente alla corte medicea: Luigi Pulci • Matteo Maria Boiardo: -Confronti con il ciclo carolingio e il ciclo bretone; -Novità dell’Orlando Innamorato; -Ruolo di Angelica nell’Orlando Innamorato; Riferimenti a: -Ironia in Boiardo; -Differenza tra ironia in Ariosto e Boiardo; -Legami tra il contenuto dell’Orlando Furioso e la situazione storica in cui è stato scritto. R. Luperini, Perché la letteratura: -La tradizione cavalleresca a Ferrara: Boiardo e l’Orlando Innamorato R. Luperini, Perché la letteratura: • Il trattato: proposte di stile e codificazioni di modelli: -La centralità del trattato • Il Petrarchismo e Pietro Bembo; R. Luperini, Perché la letteratura: -Pietro Bembo e il dibattito sull’amore e sulla lingua -Bembo e il petrarchismo -La “donna di palazzo” e la “cortigiana”, amor platonico e suo rovesciamento • Antipetrarchismo; • Ciceronianismo;
• Ciceronianesimo; • Approfondimento sul Petrarchismo fino a Leopardi; • Niccolò Machiavelli R. Luperini, Perché la letteratura: -Il trattato politico e la nascita della saggistica moderna: lo scandalo del Principe -La vita e la formazione culturale -Un manifesto politico: il Principe -I fondamenti della teoria politica: i Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio -Il Principe: -La composizione: datazione, titolo e storia del testo -La struttura generale del trattato -La lingua e lo stile del Principe -L’ideologia nel Principe -Etica e politica -Tensione saggistica e rapporto fra realismo e utopia in Machiavelli -La Dedica -Le qualità e le virtù necessarie a un principe nuovo -La fortuna. L’esortazione finale -La nozione di “machiavellismo” e “ragion di stato” -la bestia e l’uomo nella concezione di Machiavelli R. Luperini, Perché la letteratura: • Fra trattatistica e storiografia: Francesco Guicciardini e l’arte della “discrezione” -Machiavelli e Guicciardini rinnovano la storiografia e la trattatistica • Francesco Guicciardini, Ricordi; R. Luperini, Perché la letteratura: -Vita e opere di Francesco Guicciardini -I Ricordi: la “discrezione” e il “particulare” -la Storia d’Italia
Riferimenti: -Tacito, Vivere sotto i tiranni (saggio storiografico di Antonio La Penna); -Figura di Cesare in Lucano e in Dante; -Machiavelli, Il Principe; -Tacito, l’Agricola; -Aristotele e Polibio: teoria dell’anaciclosi; -Critica di Giambattista Vico. R. Luperini, Perché la letteratura: -Machiavelli e Guicciardini: un nuovo senso della storia • Ludovico Ariosto: -Orlando Furioso; -Dall’Innamorato al Furioso; -Il poema dello spazio; -Il poema del movimento: dello spazio in movimento; -Microscopia e macroscopia; -Il suono dei sospiri: dalla lirica all’epica. R. Luperini, Perché la letteratura: -Novità di Ariosto -La vita -L’Orlando Furioso: -La tradizione cavalleresca sino al Furioso in Italia e in Europa -Ideazione e stesura dell’Orlando Furioso -La struttura del poema -La poetica del Furioso: tra epica e romanzo -I temi: la quete, il labirinto, la follia -La voce del narratore: Ariosto demiurgo e Ariosto innamorato -Armonia e ironia: equilibrio rinascimentale e dissoluzione dei valori -Le tre edizioni del Furioso: dal poema cortigiano al poema “nazionale” -L’epicità del Furioso: le posizioni di Croce e Zatti -La pazzia di Orlando -Il labirinto temporale e spaziale dell’Orlando Furioso -Passione e ragione nell’Orlando Furioso
-L’amore-follia dell’Orlando Furioso -La guerra nell’Orlando Furioso • Innovazioni di Ariosto: -Molteplicità degli intrecci; -Introduzione di personaggi con caratteri; -Utilizzo dell’ironia; -Discrimen tra ironia e parodia; -La follia come indice di saggezza. • Aristotele, La Poetica - commento critico di Diego Lanza Riferimenti a: -Aristotele vs Orazio; -Orazio e le cinque parti della tragedia; -Unità di azione, tempo, spazio; -Tasso e Ariosto: l’epoca tra vero, verosimile, storia e meraviglioso; -Questioni filologiche per l’esegesi della poetica; -Unità di azione, tempo, spazio in Tasso; -Unità di azione, tempo, spazio in Ariosto; -Rapporto tra le parti della tragedia; -Epica; -Presenza del divino e del sovrannaturale in un componimento epico; -Importanza assegnata al paesaggio e suo rapporto con l’azione in Virgilio e in Tasso; -Rapporto tra Eros e eroismo in Tasso, Ariosto, Omero e Lucano, Nevio; -I fondamenti dell'aristotelismo critico. R. Luperini, Perché la letteratura: • La parodia del poema cavalleresco e la scrittura dell’eccesso • Teofilo Folengo, Baldus: -Uso del Latino maccheronico; -Parodia R. Luperini, Perché la letteratura: -Vita e opere di Filengo: il Baldus
• Torquato Tasso: -L’Aminta; -Gerusalemme Liberata; -Rapporto tra molteplicità e unità; -Rapporto tra storia e invenzione; -Conflitti nel cosmo; -Oltre il poema eroico; -Il teatro e il meraviglioso; -Uno e molteplice; -Magia e magie; -La guerra. Oltre la guerra; -Parla Amore. R. Luperini, Perché la letteratura: -La vita e la personalità -Le Rime -Aminta -Spazio lirico e spazio mitico nelle Rime e nell’Aminta La Gerusalemme Liberata: -La composizione: argomento, datazione, titolo, storia del poema -La struttura e la trama dell’opera -Le fonti del poema -I personaggi principali -Un’interpretazione psicoanalitica del poema -I temi fondamentali del poema -Amore nella Liberata -La poetica delle Gerusalemme Liberata: fra Aristotele e il Manierismo -Tasso e la crisi del Rinascimento -L’ideologia tassesca: l’amore, la guerra -Lo stile, la lingua, la metrica -Il dibattito sulla Liberata ai tempi di Tasso e il passaggio alla Conquistata -La dimensione spaziale della Gerusalemme Liberata: realtà, simbolo e magia -Il conflitto d’amore nella Gerusalemme Liberata -La guerra nella Gerusalemme Liberata
• Sequenze del Propp applicate all’Elena di Euripide e alle altre opere studiate. • Commedia classica e Commedia dell’Arte; ● La lirica barocca G. Baldi, Il piacere dei testi: - Meraviglia, concettismo e metafora nella lirica barocca; - La rottura del canone classico e petrarchesco; - Il gusto del pubblico come criterio guida del poeta - Il fine della poesia è meravigliare; - La funzione conoscitiva della metafora; - Marino e i marinisti: varietà di temi nella lirica d’amore; - La struttura dei canzonieri e del sonetto; - La poesia classicista. • Giovan Battista Marino: G. Baldi, Il piacere dei testi: - Le modalità operative: la variazione ingegnosa e l’arte di “leggere col rampino”; - Dalla Lira all’Adone; - L’Adone. -L’Adone; -Tema amoroso; -La Gerusalemme Distrutta; -Le sequenze del Propp nell’Adone; -Adone: un poema bifocale. G. Baldi, Il piacere dei testi: ● La dissoluzione del poema tradizionale - La decadenza del poema epico: il valore esemplare della Gerusalemme; - Gli epigoni di Tasso e il definitivo tramonto dell’epica eroica: Tassoni e il Marino.
• Alessandro Tassoni: -La secchia rapita; -La secchia rapita e l’Aristotelismo letterario. • Carlo Goldoni: -Rapporto con l’Illuminismo; -Confronti con la commedia classica: Plauto, Terenzio, Menandro, Aristofane; -Rivoluzione del teatro: introduzione di personaggi con caratteri, abolizione dell’improvvisazione e delle maschere, creazione di un rapporto tra mondo e teatro. G. Baldi, Il piacere dei testi: - Goldoni e la crisi culturale del suo tempo; - Motivi “illuministici” in Goldoni; - La riforma della commedia; - Il declino della Commedia dell’Arte; - “Mondo” e “Teatro”; - Dalla “maschera” al “carattere”; - Il rapporto tra caratteri e ambienti: la commedia borghese; - Il significato del distacco dalla Commedia dell’Arte; - Una riforma graduale; - L’accrescimento delle parti scritte, l’eliminazione delle parti e le opposizioni alla riforma; - La celebrazione del mercante; - Incertezze e soluzioni eclettiche; - I testi più maturi; - La fase parigina; - La lingua; - La Locandiera • Giuseppe Parini: -Il Giorno; -Finalità della poesia: cambiamento sociale; -Tentativo da parte dell’autore di rieducare l’aristocrazia; -Presenza dell’umanitarismo e dell’uguaglianza tra gli uomini; -Il diletto e la pedagogia come fini della poesia;
-Impiego della satira e dell’ironia. G. Baldi, Il piacere dei testi: - La ricerca della “pubblica felicità”; - L’atteggiamento verso l’illuminismo francese; - Le posizioni verso la nobiltà; - I dissensi dall’illuminismo lombardo; - La critica alla letteratura utilitaristica; - L’interesse per le teorie fisiocratiche; - Parini, riformista moderato; - Le odi e la battaglia illuministica; - Le novità formali di ispirazione sensistica; - L’eredità classica; - Il Giorno; - I caratteri del poemetto: il mattino e il mezzogiorno; - Gli strumenti della satira; - La pluralità di piani; - Le “favole”; - L’ambiguità verso il mondo nobiliare; - Le scelte stilistiche; - La delusione storica; - Parini e il neoclassicismo; - Il Vespro e la Notte; - La sfiducia nelle istanze riformistiche; - Gli aspetti neoclassici; Dante Alighieri, Commedia: • Inferno, Canto V; • Inferno, Canto IX; • Inferno Canto X; Riferimenti a: -Ingenium • Inferno, Canto XII
• Purgatorio, Canto I Riferimenti a: -Follia, viaggio folle di Ulisse -Ingenium in Dante e Properzio; -Orazio (III, Carmina): “Vester, Camenae, vester in arduos tollor Sabinos” -Ovidio ( Metamorfosi, v.338-40, IV): mito delle Pieridi -Zaffiro: I lapidari -Figura di Catone in Dante e nella Pharsalia di Lucano; -Realismo figurale, legato all’espressione “oneste piume” v. 42 -Interpretazione del suicidio di Catone da parte di Dante (Monarchia), Agostino (De civitate dei) e San Tommaso. • Critica di Singleton: differenza tra il processo ascendente di Dante e quello discendente di Guinizzelli e Cavalcanti; • Purgatorio, Canto II; Riferimenti a: -Salmo 113: “In exitu Israel de Aegypto”; -Legame tra Dante e gli affetti terreni; -Amor che nella mente mi ragiona; -Dolce Stil Novo. • Purgatorio, Canto III: Odissea, Platone, Eneide in particolare figura di Minosse, Radamanto, Riferimenti a: -Follia; -Riflessione di Virgilio; -Tema della morte e della corporeità; -Differenza tra infinito e perpetuo; -Figura di Manfredi e Radamanto; -Odissea, libro IV, v. 564; -Iliade, libro XVI; -Platone, Gorgia; -Critica di Ettore Paratore. • Purgatorio, Canto IV;
• Purgatorio, Canto V;
• Purgatorio, Canto VI;
• Purgatorio, Canto XXIV;
• Purgatorio, Canto XXVI.
Silloge di quesiti proposti dagli alunni per le verifiche in classe:
- Rifletti, sulla base di quanto studiato, sui numerosi riferimenti
letterari e sui conflitti di interpretazione dell’Aminta di Tasso.
- Spiega come alla base della “Gerusalemme Liberata” di Tasso ci sia
la concezione aristotelica in problematica e complessa
contrapposizione all’“Orlando Furioso” di Ludovico Ariosto.
- La concezione dell’uomo-bestia nell’Aminta del Tasso e nel Principe
di Machiavelli. Si discuta in che modo le creature mitologiche come
satiri e centauri, che incarnano sia la natura umana che la bestialità
dell’uomo, esprimano un contrasto tra due mondi diversi.
- Si spieghi l’espressione “Il labirinto temporale e spaziale
dell’Orlando Furioso” presente nel testo del Luperini, proponendo un
confronto con la Gerusalemme Liberata di Tasso e inserendo
opportuni riferimenti all’aristotelismo.
- Prendendo in considerazione i testi lirici scritti da Tasso e,
successivamente, raggruppati nell'opera che prende il nome di Rime,
evidenzia gli aspetti fondamentali che caratterizzano lo stile del
poeta, analizzando il modo in cui si distacca dal petrarchismo di
Bembo per tendere verso lo stile plurilinguistico dantesco.
- Machiavelli e Guicciardini, oltre alla diversa valutazione degli
esempi del passato come modelli, presentano incongruenze anche
nell'elaborazione del concetto di fortuna. Ricollegandoti a questotema, fai riferimento al ruolo di Eritone e alla funzione della necromanzia, basandoti sui versi del nono canto dell'Inferno: "Ver'è c'altra fïata qua giù fui, congiurato da quella Eritón cruda che richiamava l'ombre a' corpi sui. Di poco era di me la carne nuda, ch'ella mi fece intrar dentr' a quel muro, per trarne un spirito del cerchio di Giuda." - L'idea di fortuna con immagine personificata giunge a Machiavelli da una lunga tradizione letteraria: il concetto di fortuna si differenzia in ambito umanistico-rinascimentale da quello proprio dell'età medievale. In Dante (Inferno VII,vv. 67-96) la fortuna diviene ministra della volontà di Dio, alla quale nessuna ragione umana può resistere. Da Boccaccio ad Alberti si affermerà invece il rapporto virtù-fortuna, assai presente in Machiavelli e Guicciardini. Esponi come in Machiavelli e Guicciardini sia essenziale il ruolo svolto dalla fortuna, intesa come sorte positiva o negativa. - Orbicciani, personaggio storico che riesce a trovare il suo adempimento nella Commedia, critica il modo di scrivere degli altri poeti, soprattutto di Guinizzelli, sostenendo di “traier canson per forsa di scrittura” (ultimo verso della poesia “Voi, ch’avete mutata la mainera”). Spiega il significato di questa espressione e proponi opportuni collegamenti. (16 righe) - Per correr miglior acque alza le vele ormai la navicella del mio ingegno, che lascia dietro a sé mar sì crudele; e canterò di quel secondo regno dove l’umano spirito si purga e di salire al ciel diventa degno. - Soffermandoti sulla parola ingegno, trova tutti i collegamenti che si possono stabilire sia con la figura di Properzio e il suo servitium amoris sia con l’effetto che l’ingegno ha provocato in Cavalcanti e Guinizzelli. - L’'incontro con Casella nel canto secondo del Purgatorio dà modo a Dante di puntualizzare alcuni concetti fondamentali riguardanti il
destino delle anime non dirette all'Inferno, tra cui il fine del viaggio che si accingono ad affrontare. Spiega in che modo e perché il canto di Casella ritarda questo fine, facendo riferimento anche ad altri episodi di comportamenti e situazioni moralmente non accettabili nella Commedia. - Tasso e Ariosto: tra il rigorismo della "Gerusalemme Liberata" e la libertà dell' "Orlando Furioso". - Machiavelli e Guicciardini hanno due diversi modi di concepire la storia. Come è visto il tema del decadimento di uno stato e quali sono le possibili soluzioni proposte dai due autori? - Perché Dante propone Catone, personaggio pagano e suicida, come custode del Purgatorio? Si facciano riferimenti alla visione del suicidio in San Tommaso e Sant'Agostino. - Partendo dalla prima strofa di “Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira” di Guido Cavalcanti, analizza il rapporto tra l’amore immanente e trascendente in Dante, Guinizelli e Cavalcanti. - L’esperienza amorosa vissuta nella dimensione di angoscia rappresenta un tema caro ai poeti sia greci che latini. Esponi le analogie e le differenze tra i poeti classici e Cavalcanti ponendo attenzione sui limiti del poeta e su quelli di suo padre e formulando opportuni riferimenti ad Aristotele e Averroè. - Canto III, Purgatorio, vv. 136-141 “Vero è che quale in contumacia more // di Santa Chiesa, ancor ch’al fin si penta, // star li convien da questa ripa in fore, // per ognun tempo ch’elli è stato, trenta, // in sua presunzion, se tal decreto // più corto per buon prieghi non diventa”. (Purgatorio, Canto III, versi 136-141) Partendo da queste terzine, elabora un testo argomentativo analizzando principalmente la formula del decreto e proponenendo poi riferimenti ad altri brani o autori studiati. Prerequisiti:
Purgatorio, Canto III, verso 110 (incontro con Manfredi) Purgatorio, Canto VI, verso 30 e altri Eneide, caso di Palinuro Platone, la Repubblica (limite per la vita di un uomo) Dino Campagna, “Virgilio non è Dante” Eneide, libro VI, versi 327 e seguenti - Canto IV, Purgatorio, vv.121-126 “Li atti suoi pigri e le corte parole mosser le labbra mie un poco a riso; poi cominciai: «Belacqua, a me non dole di te omai; ma dimmi: perché assiso quiritto se’? attendi tu iscorta, o pur lo modo usato t’ha’ ripriso?».” Metti a confronto questi versi del Canto IV del Purgatorio con l’episodio e la figura di Casella, nel Canto II, soffermandoti sulla nostalgia e sul legame perpetuo di Dante con la vita terrena, manifestato da questi due personaggi amici del poeta. Prerequisiti: Purg. II, (in particolare vv. 106-132) Purg IV (resto del canto) - Canto V, Purgatorio, vv. 103-108 Dante affronta il tema del pentimento e della separazione violenta del corpo dall’anima: come un moderno giornalista, utilizza una congrua varietà di materiali e fonti che conferiscano all’invenzione poetica la funzione di verità storica. Prerequisiti: -La concezione dell’ anima e del corpo in Platone -Tema del pentimento nel Canto XXVII dell’inferno -Tema della separazione violenta nel canto XIII dell’inferno -v. 87 canto V del purgatorio -La corporeità in San Tommaso -Tema del pentimento nella Chanson de Roland
-Letteratura religiosa degli exempla - Canto VI, Purgatorio, vv. 71-78; Nel VI canto del Purgatorio l'incontro con l'anima di Sordello provoca la reazione di Dante che inizia al verso 76 la celebre digressione sulla situazione politica dell'Italia contemporanea. Parla nello specifico di questo episodio con opportuni riferimenti ad altri luoghi della Commedia e/o di altre opere. Prerequisiti: Purgatorio VI, Purgatorio V, Inferno VI, Paradiso VI, Eneide VI, Orlando Furioso. -Canto III (Purgatorio) vv. 34-36 Analizza e commenta i versi del Purgatorio tratti dal canto III, facendo opportuni riferimenti agli altri canti danteschi e soffermandoti sul significato etimologico del verbo "trascorrere" che confligge con il concetto di "infinita via". "Matto è chi spera che nostra ragione possa trascorrer la infinita via che tiene una sustanza in tre persone." Prerequisiti: 1. Canto I Purgatorio v.59 e riferimento alla parola follia. 2. Concetto di perpetuo che si collega al termine "trascorrer". 3. V.122 Purgatorio canto III, dove si trova il termine "bontà infinita", manifestata tramite la figura di Manfredi. 4. La vicenda di Manfredi (il motivo per cui si trova nel Purgatorio). 5. Il concetto del corpo che mette in relazione Virgilio con Manfredi. - Canto IV, Purgatorio, vv. 76-85 Dante pone particolare attenzione nella Commedia alle coordinate astronomiche dandone prolisse spiegazioni. Commenta i versi riportati di seguito e proponi altri esempi all’interno dell’opera. In
seguito analizza l’espressione “ingegno parea manco” e rifletti sul ruolo dell’ingegno all’interno della letteratura stilnovista. “Certo,maestro mio”,diss’io, “ unquanco non vid’io chiaro sì com’io discerno là dove mio ingegno parea manco, che ‘l mezzo cerchio del moto superno, che si chiama Equatore in alcun’ arte, e che sempre riman tra ‘ l sole e ‘l verno, per la ragion che di’, quinci si parte verso settentrïon, quanto li Ebrei vedevan lui verso la calda parte.” (Purgatorio IV, vv 76-84) Prerequisiti: riferimenti astronomici nell’Inferno, nel Purgatorio e nel Paradiso; Cavalcanti e la poesia “chi è questa che ven che ogn’om la mira”. - Canto XXI, Purgatorio, vv. 94-99 Svolgi la parafrasi dei versi 94-99 del canto XXI. In seguito descrivi il rapporto che c'è tra Stazio e Virgilio facendo opportuni riferimenti ad altri canti e opere da te conosciute. Prerequisiti: conoscere il canto I e il canto III del Purgatorio, canto I e V dell'Inferno, Bucoliche IV Ecloga. - Canto V, Purgatorio, vv. 88-93 "Io fui di Montefeltro, io sono Bonconte; Giovanna o altri non ha di me cura; per ch'io vo tra costor con bassa fronte". E io a lui: "Qual forza o qual ventura ti travïò sì fuor di Campaldino, che non si seppe mai tua sepoltura?" Ci troviamo nel V canto, versi 88-93. Dopo aver parafrasato i versi, presenta il tema del corpo che domina questo canto, prendendo in considerazione la vicenda di Bonconte da Montefeltro, il quale fece una fine violenta e sanguinosa: il suo corpo non era stato ritrovato dopo la battaglia a Campaldino. Il tema del corpo è un argomento affrontato e analizzato da Platone, il quale propone una nuova suddivisione dell'aldilà e una diversa modalità di giudicare i morti, con esplicito riferimento proprio alla materia
corporea. Elabora opportuni riferimenti al mito di Minosse, Eaco e
Radamanto. Il canto presenta poi il motivo delle preghiere, come
speranza per un miglioramento della propria condizione. Prendendo
in considerazione questo tema, presenta i personaggi sia della Divina
Commedia (Manfredi, oltre a Bonconte) sia dell'Eneide (Palinuro)
che si sono trovati in questa situazione.
- Canto VI, Purgatorio, vv.28-30
"Io cominciai:per che ‘l lume del sole è fesso. “
Purgatorio III, vv. 94-96
Prerequisiti:
Canto II, v. 67;
Canto V, vv. 25, 46;
Canto II, v. 79;
Canto III, vv. 19-127;
Canto V, vv. 83, 98, 101, 124;
- Canto III, Purgatorio, vv. 121-123
Con riferimento alla seguente terzina contenuta nel III canto del
purgatorio (versi 121-123):
“Orribil furon li peccati miei;
ma la bontà infinita ha sì gran braccia,
che prende ciò che si rivolge a lei.”
analizza criticamente il ruolo che assume l'essere consapevoli dei
propri peccati nel Purgatorio dantesco.
Prerequisiti:
-conoscenza della storia di Manfredi (la scomunica della Chiesa)
-fondamenti teologici del perdono di Dio;
-differenza tra il Giudizio di Dio e quello degli uomini;
-Topos letterario dell’eroe sconfitto: Ettore (Omero, Iliade XXII, vv.
286-330); Manfredi (Dante, Purgatorio III, vv. 104-132); Adelchi (A.
Manzoni, Adelchi, atto V).
- Canto V, Purgatorio, vv. 7-12.
Li occhi rivolsi al suon di questo motto,
e vidile guardar per maraviglia
pur me, pur me, e ‘l lume ch’era rotto. 9
«Perché l’animo tuo tanto s’impiglia»,
disse ‘l maestro, «che l’andare allenti?che ti fa ciò che quivi si pispiglia? 12 L’atteggiamento di Virgilio nel Purgatorio è più esitante rispetto a quello nell’Inferno e mette in evidenza la delicatezza della sua coscienza: il maestro sembra meno sicuro di sé, meno determinato e più fallibile e maldestro. Rifletti sulla figura di Virgilio e sull’atteggiamento che egli assume, a partire dai versi 9-12 del Canto V del Purgatorio, in cui un attimo di distrazione da parte di Dante basta a provocare la reazione di Virgilio. Fai anche riferimento ad altri episodi di questa Cantica, in particolare alla riflessione del maestro nel Canto III e alle motivazioni di tale riflessione. Prerequisiti: - Canto I, Purgatorio; vv. 85-93; - Canto II, Purgatorio; vv. 110-123; - Canto III, Purgatorio; vv. 20-24; - Canto III, Purgatorio; vv. 34-45. - Il ruolo dell’eros. Rifletti sulla figura di Angelica in Ariosto e Boiardo e proponi opportuni riferimenti a figure femminili presenti sia in contesto epico che tragico come Medea, Elena e Didone. - Utilizzando anche le sequenze di Propp, analizza, confronta e discuti le due seguenti affermazioni di Benedetto Croce e di Sergio Zatti riguardo l'epicità del Furioso: “Come mai potrebbe essere, nel Furioso, epicità quando nel suo autore non solo mancavano i sentimenti etici dell’epos, ma quel poco, che si può alquanto sottilmente sostenere che pur ne possedesse in retaggio, veniva, con tutto il resto, disciolto nell’armonia ed ironia?” (B.Croce). “Ariosto mostra di rispettare le regole del gioco nel solo caso in cui può trasformarle in un fattore essenziale per indirizzare il suo racconto verso una conclusione di tipo epico.” (S.Zatti) - “Le lacrime e i sospiri degli amanti, l’inutil tempo che si perde a giuoco, e l’ozio lungo d’uomini ignoranti, vani disegni che non han mai loco,
i vani desideri sono tanti,
che la più parte ingombran di quel loco:
ciò che in somma qua giù perdesti mai,
là su salendo ritrovar potrai.”
Commenta questi versi dell’Orlando Furioso, legati all’episodio di
Astolfo sulla luna, facendo riferimento a tutte le tue conoscenze.
- Le funzioni di Propp: la partenza, il viaggio e il ritorno a casa
dell’eroe.
- Ironia, parodia e “sproporzione” nella letteratura del ‘400-‘500.
- Il verisimile e il diletto nella Gerusalemme Liberata. Illustra la
presenza di questi due elementi nell’opera di Torquato Tasso, con
opportuni riferimenti alla varietà e al “meraviglioso cristiano”.
- In Boiardo, molto importante è il personaggio di Angelica. Illustra le
sue principali caratteristiche e cerca di motivare le sue azioni,
confrontando il personaggio di Angelica e quello di Elena.
- Il concetto di “meraviglioso” e l’unità di azione, spazio e tempo,
nell’Orlando Furioso e nella Gerusalemme Liberata.
- Spiega la funzione che il paesaggio svolge nella Gerusalemme
Liberata di Tasso con opportuni riferimenti al modello classico delle
Bucoliche di Virgilio.
Palestrina, 08 giugno 2019
Gli Alunni Il Docente
Alessia D’Auria Michele Botte
Giorgia Vecchio
Claudia Albanesi
Beatrice GentiliPuoi anche leggere