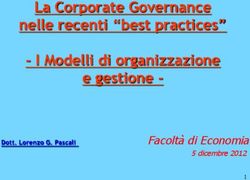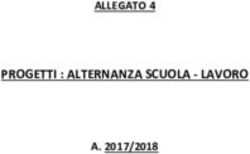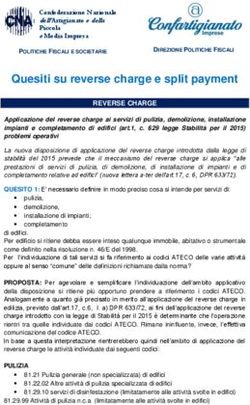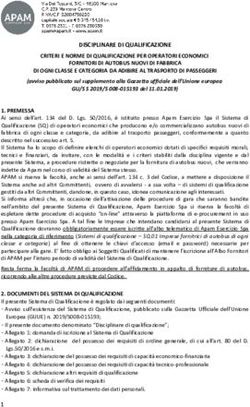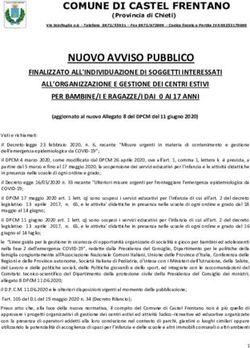Metodi e procedure della psicologia - Il metodo scientifico 2. Comprendere i risultati della ricerca 3. Etica - Lumsa
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Metodi e procedure
della psicologia
1. Il metodo scientifico
2. Comprendere i risultati della ricerca
3. EticaIl metodo scientifico Raccolta attenta delle prove attraverso descrizioni e misurazioni precise, la ricerca di leggi di carattere generale attraverso osservazioni controllate e risultati ripetibili.
Scopo delle scienze comportamentali Descrizione del comportamento Predizione del comportamento Scoprire le cause del comportamento Spiegare il comportamento
Definizione di teoria Un insieme di affermazioni che descrive e spiega fatti noti, che propone relazioni tra variabili e fa nuove previsioni. Un gruppo di asserzioni esplicative sul comportamento che possono essere provate attraverso la ricerca empirica. Una buona teoria è una che genera ipotesi verificabili (comprovate o falsificate)
La teoria Organizza e spiega dati esistenti Porta a nuovi intuizioni che producono nuovi esperimenti Viene convalidata quando nuovi dati sono consistenti con la teoria Deve essere rivista quando nuovi dati rivelano debolezze Deve essere rimpiazzata quando arrivano nuove teorie che spiegano meglio i dati.
Teoria dell’attaccamento
Attaccamento fondamento del modello interno
alla base delle nostre relazioni sociali
Attaccamento influenza lo sviluppo sociale,
emozionale e cognitivo
VIDEO 1: https://youtu.be/LBHdx3XdRtE
(Ainsworth, 1969; Bowlby, 1969)Stili di attaccamento Sicuro – (65%) genitore base sicura; piange alla separazione; cerca contatto al suo ritorno Insicuro evitante– (20%) non reagiscono al genitore; non stressati quando se ne va; tratta estraneo come il genitore; lento a riagganciarsi al suo ritorno Insicuro resistente– (10-15%) cerca contatto, si aggrappa, non esplora; piange ed è arrabbiato alla separazione; resiste quanto torna; non si lascia confortare facilmente disorganizzato/disorientato – (5-10%) confuso, comportamneto contradditorio; postura tesa; piatto emozionalmente; pauroso
Metodo scientifico Lo psicologo cerca di rispondere a quesiti sul comportamento e sulla mente utilizzando il metodo scientifico L’essenza del metodo scientifico è che tutte le proposizioni devono essere supportate da prove empiriche ¡ Un’idea deve essere studiata in condizioni che ne permettano il rigetto o il supporto ¡ La ricerca deve essere effettuata in modo tale da poter essere osservata, valutata e replicata da altri
La psicologia generale studia i processi cognitivi e il comportamento degli esseri umani cercando di spiegarlo tramite il ricorso al metodo scientifico Questo ci garantisce spiegazioni non influenzate da interpretazioni proprie delle psicologia ingenua
Psicologia ingenua Non si fonda su controlli scientifici ma sull’esperienza personale Esempio: un bambino corre per la stanza perlustrando ogni angolo e nascondiglio ¡ Possibileinterpretazione basata sul senso comune: un comportamento di questo tipo (esplorazione) potrebbe essere associato ad un evento (perdita di un oggetto)
Osservando il comportamento del bambino, l’interpretazione ingenua potrebbe essere: CONFERMATA se subito dopo avere scoperto il suo giocattolo preferito, il bambino si ferma e smette di cercare RESPINTA se entra un amico e ci rendiamo conto che stavano facendo un altro tipo di gioco Le spiegazioni che noi diamo spesso degli eventi della vita appartengono alla psicologia ingenua (folk psychology) e possono portare a conclusioni erronee in quanto sono spiegazioni che non si basano sull’oggettività Per garantire tale oggettività si utilizza in psicologia principalmente il metodo sperimentale
Vediamo un altro esempio che ci fa capire meglio come
raggiungere l’oggettività
Secondo il senso comune (ipotesi ingenua) ricordiamo di
più le cose che decidiamo di ricordare (memoria
intenzionale); cioè la memoria intenzionale dovrebbe
sempre essere superiore alla memoria incidentale
Costruiamo un esperimento, che ci permette di
verificare tale ipotesiGRUPPO 1 GRUPPO 2
Leggere e Leggere e
memorizzare una memorizzare una
lista di parole lista di parole
(intenzionale) (intenzionale)
Poi ripetere Poi categorizzare
GRUPPO 3 GRUPPO 4
Leggere una lista di Leggere una lista di
parole (incidentale) parole (incidentale)
Poi ripetere Poi categorizzare L’esperimento, realmente condotto da Mandler (1967), ha dato i
seguenti risultati
Tipo di memoria
Incidentale Intenzionale
Ripeti Prestazione più bassa Prestazione buona
Raggruppa Prestazione buona Prestazione buona
Solo il gruppo che non sapeva di dover ricordare (memoria
incidentale) e che ripeteva le parole della lista aveva una
prestazione inferiore a quella degli altri gruppi
Conclusione: il fattore rilevante non è l'intenzionalità (una teoria
ingenua della memoria è quindi insufficiente) ma l'attivazione di
processi volti a integrare le informazioni in arrivo Il metodo appena utilizzato garantisce l’oggettività in quanto, in qualunque altro momento e in qualunque altro laboratorio scientifico è possibile verificare le stesse ipotesi costruendo un esperimento con altri soggetti. Permettendo di confermare la stessa ipotesi e avanzarne altre, al fine di aumentare la conoscenza nel settore (scienza)
Tre forme di ricerca scientifica ´Osservazioni naturalistiche e cliniche ´Studi correlazionali Ricerche sperimentali
Tre forme di ricerca scientifica Osservazioni naturalistiche e cliniche: ¡ Nel loro ambiente, nel corso di un trattamento o di una diagnosi ¡ Alla base delle scienze biologiche e sociali (Darwin, Broca) Studi correlazionali ¡ Sempre osservativo ma relazione tra misurazioni Ricerche sperimentali ¡ Relazioni causali tra gli eventi
Tre forme di ricerca scientifica
Osservazioni naturalistiche e cliniche
÷ Metodo descrittivo
sperimentali
Non
÷ Metodo clinico
÷ Metodo dell’inchiesta
Studi correlazionali
÷ Metodo correlazionale
Ricerche sperimentaliMetodi di ricerca non sperimentali Metodo descrittivo Metodo clinico Metodo dell’inchiesta Metodo correlazionale
Studi descrittivi Descrivere il comportamento di un singolo individuo o di un gruppo senza analizzare sistematicamente le relazioni tra particolari variabili ¡ E.g. Goodal e gli scimpanze’ ¡ E.g. studio del comportamento sociale del bambino in età prescolare
Metodo clinico: o metodo del caso singolo, in
cui si cerca di aiutare la persona a risolvere i
propri problemi attraverso la raccolta di
informazioni tramite il colloquio clinico e la
somministrazione di test e questionari.
Alcuni dei primi dati sugli
effetti dei danni nelle aree
frontali del cervello si trovano
nello studio dell’incidente
subito da Phineas Gage
(Harlow, 1868): lobotomia
frontale accidentale. Metodo dell’inchiesta: in cui vengono sperimentate tecniche specifiche per creare domande e codificare le risposte (sondaggi attraverso il web) ÷Domande standardizzate
Studi di correlazione Lo sperimentatore non manipola variabili ma misura due o più variabili per scoprire se sono tra loro in relazione Possono individuare relazioni regolari tra variabili ma non rapporti causa-effetto ¡ E.g. Baumrind: stile educativo (autoritario, permissivo, autorevole, indifferente) e sviluppo psicologico. ¡ E.g. relazione tra autostima e voti alti all’Università
¡ Coefficiente di correlazione: indice statistico che può variare da -1,00 a +1,00 e che indica la direzione e il grado di correlazione. ¡ Correlazione positiva: al crescere di una variabile corrisponde l’aumento dei valori dell’altra variabile. ¡ Correlazione negativa: l’aumento di una variabile è associato alla diminuzione dell’altra variabile.
Gli studi correlazionali Correlazione positiva Correlazione negativa Assenza di correlazione
Tre forme di ricerca scientifica in
psicologia
Osservazioni naturalistiche e cliniche:
¡ Nel loro ambiente, nel corso di un
trattamento o di una diagnosi
¡ Alla base delle scienze biologiche e sociali
(Darwin)
Studi correlazionali
¡ Sempre osservativo ma relazione tra
misurazioni
Ricerche sperimentali
÷Relazioni causali tra gli eventiEsperimento
¡ Sperimentale non si identifica con scientifico
÷ La matematica, la filologia e la storia sono discipline che
applicano il metodo scientifico, senza per questo essere
sperimentali.
÷ Si possono d'altra parte fare esperimenti di nessun valore
scientifico, perché per esempio sono viziati da errori
concettuali o strumentali.
÷ Osservazioni, indagini sul campo portano egualmente a
risultati di valore scientifico assoluto, senza che perciò si sia
proceduto ad alcun esperimento.Esperimento
¡ Sperimentale non si identifica con empirico
÷ Il termine empirico denota il ricorso all'esperienza, mentre il
termine sperimentale denota il ricorso ad un particolare tipo
d'esperienza - quella raggiunta con il controllo delle variabili.
÷ Tutte le ricerche sperimentali sono empiriche, ma non tutte le
ricerche empiriche sono sperimentali: l'osservazione e l'indagine
sul campo sono ricerche empiriche (attuate ricorrendo
all'esperienza) che tuttavia non sono sperimentali (attuate con il
controllo delle variabili).
÷ La loro scientificità dipende dalla correttezza del metodo
impiegato e dall'analisi motivata dei risultati, non dal controllo
delle variabili.Studi sperimentali ¡ Per saggiare l’ipotesi di una relazione causa-effetto tra due variabili: indipendente (manipolata dallo sperimentatore) e dipendente (misurata) ¡ L’individuazione di una grandezza controllata (manipolata) dallo sperimentatore, la cosiddetta variabile indipendente (esempio l’istruzione di ripetere e non ripetere) ¡ L’individuazione di una grandezza da misurare, la cosiddetta variabile dipendente, e che varia al variare della variabile indipendente ¡ in questa maniera sarà possibile evidenziare una CAUSALITA’ fra le variabili
Esperimento Il metodo sperimentale ha in psicologia un ambito di applicazione limitato, perché nello studio dei fatti mentali è spesso difficile identificare la variabile dipendente, e d'altro canto risulta impossibile tenere sotto controllo tutte le variabili indipendenti, che sono in numero teoricamente illimitato. Il metodo sperimentale viene per lo + impiegato in psicofisica, nello studio della percezione, dell'apprendimento e del pensiero, l’attenzione, il linguaggio e anche di certi fenomeni d’interazione sociale come percezione della personalità altrui, collaborazione etc..
Gli studi sperimentali
÷ Es.
I maschi sono più bravi delle femmine in compiti
matematici:
¢ SOGGETTI SPERIMENTALI: 50 maschi e 50
femmine
¢ MATERIALE: test composto da varie prove
¢ COMPITO DEL SOGGETTO: eseguire più prove
possibili entro 10 minuti
¢ VARIABILE DIPENDENTE: ACCURATEZZA
¢ VARIABILE INDIPENDENTE: ?????Il metodo scientifico ideale è costituito da sei tappe:
Gli studi sperimentali
IDENTIFICARE IL PROBLEMA E FORMULARE IPOTESI SULLE
RELAZIONI CAUSA-EFFETTO FRA LE VARIABILI
PROGETTARE ESPERIMENTO
÷ MANIPOLAZIONE VARIABILE INDIPENDENTE
÷ DEFINIZIONI OPERAZIONALI
CONDURRE ESPERIMENTO
÷ GRUPPO SPERIMENTALE E DI CONTROLLO
÷ SELEZIONE DEI PARTECIPANTI
RACCOLTA DATI
÷ ANALISI DEI DATI STATISTICI
COMUNICARE I RISULTATI
÷ PUBBLICARE RISULTATI SU RIVISTA SCIENTIFICA (PEER
REVIEW) E/O A CONVEGNI
COSTRUIRE UNA TEORIAGli studi sperimentali
IDENTIFICARE IL PROBLEMA E FORMULARE IPOTESI SULLE
RELAZIONI CAUSA-EFFETTO FRA LE VARIABILI
÷ LA PRESENTAZIONE DI UN AIUTO VISIVO FAVORISCE LA
LETTURA DI UNA PAROLA
PROGETTARE ESPERIMENTO
÷ MANIPOLAZIONE VARIABILE INDIPENDENTE: (aiuto visivo
presente / aiuto visivo assente.
÷ DEFINIZIONI OPERAZIONALI
CONDURRE ESPERIMENTO
÷ GRUPPO SPERIMENTALE E DI CONTROLLO
÷ SELEZIONE DEI PARTECIPANTI
RACCOLTA DATI
÷ ANALISI DEI DATI STATISTICI
COMUNICARE I RISULTATI
÷ PUBBLICARE RISULTATI SU RIVISTA SCIENTIFICA (PEER
REVIEW) E/O A CONVEGNICASA
PAROLA
PAROLA
PAROLA
CASA
CONTESTO: 20 parole. COMPITO: leggere a voce alta.
FACILITAZIONE VISIVA: CASA
VARIABILE INDIPENDENTE: PRESENZA O NO DELL’AIUTO VISIVO
VARIABILE DIPENDENTE: ACCURATEZZA E TEMPI DI REAZIONEPAROLA
PAROLA
PAROLA
CASA
CONTESTO: 20 parole. COMPITO: leggere a voce alta.
FACILITAZIONE VISIVA: NESSUNA
VARIABILE INDIPENDENTE: PRESENZA O NO DELL’AIUTO VISIVO
VARIABILE DIPENDENTE: ACCURATEZZA E TEMPI DI REAZIONEVARIABILE INDIPENDENTE: PRESENZA O NO DELL’AIUTO VISIVO (DISEGNO DELLA CASA vs FIGURA GEOMETRICA CASUALE). VARIABILE DIPENDENTE: Tempi di Reazione/Accuratezza
Variabili dipendente ed indipendente
Var. indipendente Var. dipendente
causa
Presentazione dell’aiuto Lettura più rapida della
visivo parola
causaControllo delle variabili indipendenti
Isolare la variabile indipendente:
¡ HP: il rumore ambientale ha un effetto sulla velocità di
lettura?
¡ Var. indipendente: rumore della televisione accesa
¡ Confusione: rumore / contenuto programma televisivo
Errori:
¡ Presentazione degli stimoli nello stesso ordine (contro
bilanciamento; preferenza volti neonati)Controllo delle variabili indipendenti
Isolare la variabile indipendente:
¡ HP: il rumore ambientale ha un effetto sulla velocità di
lettura?
¡ Var. indipendente: rumore della televisione accesa
¡ Confusione: rumore / contenuto programma televisivo
Errori:
¡ Presentazione degli stimoli nello stesso ordine
(contro bilanciamento; preferenza volti neonati): se
presento sempre le facce il dato sporcato
dall’effetto abituazioneGli studi sperimentali
IDENTIFICARE IL PROBLEMA E FORMULARE IPOTESI SULLE
RELAZIONI CAUSA-EFFETTO FRA LE VARIABILI
÷ LA PRESENTAZIONE DI UN AIUTO VISIVO FAVORISCE LA LETTURA DI UNA
PAROLA
PROGETTARE ESPERIMENTO
÷ MANIPOLAZIONE VARIABILE INDIPENDENTE: (aiuto visivo presente / aiuto visivo
assente.
÷ DEFINIZIONI OPERAZIONALI
CONDURRE ESPERIMENTO
÷ GRUPPO SPERIMENTALE E DI CONTROLLO
÷ SELEZIONE PARTECIPANTI
VALUTARE LE IPOTESI VEDENDO I DATI
÷ ANALISI DEI DATI STATISTICI
COMUNICARE I RISULTATI
÷ PUBBLICARE RISULTATI SU RIVISTA SCIENTIFICA (PEER
REVIEW) E/O A CONVEGNIGruppo sperimentale e gruppo di
controllo
¡ Gruppo sperimentale: soggetti che si trovano in una
situazione sperimentale in cui la variabile scelta dal
ricercatore viene manipolata secondo il progetto
dell'indagine (aiuto visivo presente)
¡ Gruppo di controllo: soggetti in una situazione identica
a quella dei soggetti del gruppo sperimentale, salvo
che per essi non vi è alcuna manipolazione della
variabile indipendente (aiuto visivo assente)Gruppo sperimentale e di
controllo
Velocità ed
Gruppo Aiuto visivo presente accuratezza lettura
Speriment. parola
differenza
Velocità ed
Gruppo accuratezza lettura
Aiuto visivo assente
controllo parola20 soggetti
20 parole
GRUPPO GRUPPO DI
SPERIMENTALE (10 CONTROLLO (10
SOGGETTI) SOGGETTI)
500 MS. 750 MS.20 SOGGETTI
40 parole (20 CON PRESENZA E 20 CON ASSENZA)
PRESENZA AIUTO ASSENZA AIUTO
VISIVO VISIVO
Condizione Condizione di
sperimentale controllo
500 MS. 750 MS.Con Senza Con Senza
indizio indizio ind. ind.
1 grup. 500 - Sogg 1 520 -
sper
1 grup. - 700 Sogg 2 - 700
controllo
Sogg 3 450 -
Sogg 4 - 600
media 485 650Con Senza Con Senza
indizio indizio ind. ind.
1 grup. 500 - Sogg 1 520 -
sper
1 grup. - 700 Sogg 2 - 700
controllo
Sogg 3 450 -
Con Senza Sogg 4 - 600
indizio indizio
Sogg 1 500 620 media 485 650
Sogg 2 480 540
Sogg 3 520 700
media 500 620Metodi per lo studio dei processi cognitivi La psicofisica La cronometria mentale ¡ Il metodo sottrattivo di Donders (1818-1889) ¡ L’effetto stroop
Cronometria mentale
misura delle operazioni mentali o metodo
sottrattivo di Donders
Tempo di reazione di scelta (250 msec)–
Tempo di reazione semplice (200 msec)=
Tempo di decisione (50 msec)Effetto stroop
Rosso verde blu nero
Giallo blu verde rosso incongruente
Nero verde giallo rosso
xxxxx xxxxx xxx xxxx
neutra
xxxxxx xxx xxxxx xxxxx
xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx
Rosso verde blu nero
congruente
verde giallo rosso blu
nero verde giallo rossoEsperimento - controllo
Se i due gruppi danno risultati differenti allora la
manipolazione ha avuto un effetto e la variabile indipendente
è realmente una variabile decisiva del fenomeno allo studio.
Se i due gruppi danno risultati simili allora la manipolazione
non ha avuto effetto perché
¡ (a) la variabile scelta come indipendente non è una variabile
decisiva del fenomeno
¡ (b) l'aspetto del fenomeno scelto come variabile non è una
variabile
¡ (c) l'esperimento contiene un errore, di progettazione o di
esecuzioneGli studi sperimentali
IDENTIFICARE IL PROBLEMA E FORMULARE IPOTESI SULLE
RELAZIONI CAUSA-EFFETTO FRA LE VARIABILI
÷ LA PRESENTAZIONE DI UN AIUTO VISIVO FAVORISCE LA LETTURA DI UNA
PAROLA
PROGETTARE ESPERIMENTO
÷ MANIPOLAZIONE VARIABILE INDIPENDENTE: (aiuto visivo presente / aiuto
visivo assente.
÷ DEFINIZIONI OPERAZIONALI
CONDURRE ESPERIMENTO
÷ GRUPPO SPERIMENTALE E DI CONTROLLO
÷ SELEZIONE PARTECIPANTI
VALUTARE LE IPOTESI VEDENDO I DATI
÷ ANALISI DEI DATI STATISTICI
COMUNICARE I RISULTATI
÷ PUBBLICARE RISULTATI SU RIVISTA SCIENTIFICA (PEER
REVIEW) E/O A CONVEGNISELEZIONE DEI PARTECIPANTI ASSEGNAZIONE CASUALE DEI PARTECIPANTI (es. valutare efficacia del tipo di lezione, A e B, in due gruppi (sperimentale alle 8 del mattino; controllo alle 16.00) ¡ CHE ERRORE POTREI FARE?????
SELEZIONE DEI PARTECIPANTI ASSEGNAZIONE CASUALE DEI PARTECIPANTI (es. valutare efficacia del tipo di lezione, A e B, in due gruppi (sperimentale alle 8 del mattino; controllo alle 16.00) ¡A differenti orari ¡ Le differenze dei partecipanti si annullano
LE VARIABILI INDIPENDENTI VANNO CONTROLLATE PER CAPIRE QUALI SONO I REALI EFFETTI SULLA VARIABILE DIPENDENTE. PER FAR QUESTO, IL LUOGO MIGLIORE PER EFFETTUARE ESPERIMENTI E’ IL LABORATORIO, IN CUI LE CONDIZIONI SONO DIFFERENTI DA QUELLE DELLA VITA QUOTIDIANA, DOVE POSSONO INTERVENIRE INFLUENZE DI VARIO GENERE.
Ma nonostante si usino le considerazione appena descritte per effettuare un esperimento, si possono verificare altri fattori che possono minacciare la validità di un esperimento, e a cui bisogna fare attenzione Questi, spesso, sfuggono anche agli sperimentatori stessi, e vengono chiamati Artefatti, nel senso che i risultati ottenuti sono dovuti a qualcosa di diverso da quel che lo sperimentatore pensava di manipolare con la variabile indipendente
Ad Esempio
Uno psicologo deve controllare l'azione di un farmaco che si
ritiene curi la depressione
Prima della somministrazione del farmaco, la valutazione media
dei soggetti del loro stato d'animo su una scala a 7 punti (dove 1 =
depressione profonda, e 7 = beatitudine) è 4.3
Somministrazione del farmaco
I soggetti valutano ancora il loro stato d'animo sulla scala a 7
punti, la valutazione media è 6.1
É possibile concludere che la somministrazione del farmaco è
efficace? Ipotesi: la somministrazione del farmaco migliora l’umore dei soggetti? ¡ Variabile indipendente: somministrazione del farmaco (si o no) ¡ Variabile dipendente: misura dell’umore
PRIMA CONDIZIONE SECONDA
VALUTAZIONE SPERIMENTALE VALUTAZIONE
UMORE SOMMINISTRAZIONE UMORE ALTO
GRUPPO BASSO DEL FARMACO
A
UMORE BASSO PLACEBO (AMIDO) UMORE ALTO
GRUPPO
B
UMORE MEDIO- NESSUNA UMORE
GRUPPO BASSO SOMMINISTRAZIONE MEDIO
C
ARTEFATTO
GRUPPI DI EFFETTO
CONTROLLO PLACEBO Effetto placebo: se mi si da una pillola e mi si dice che questa migliora il mio umore, per effetto della profezia che si auto-avvera, automaticamente mi pongo nella condizione di soddisfare le aspettative dello sperimentatore (psicologo, medico, ecc.) È il caso, allora, che nessun soggetto sappia a quale gruppo appartiene (cieco) Per evitare altri effetti indesideratisarebbe il caso di condurre un esperimento in doppio cieco
Vizi sistematici Vizi di misurazione ¡ Attendibilità (due osservatori indipendenti che valutano lo scoring di un esperimento) ¡ Validità (come possiamo essere sicuri che abbia visto il disegno della casa o sio semplicemente più bravo nel leggere? Fare altri test di lettura) Vizi prodotti dalle aspettative ¡ Del soggetto (effetto Hawthorne, effetto placebo) ¡ Dello sperimentatore (effetto Rosenthal)
Errori tecnici Effetto Hawthorne (Rimedio: tenere all’oscuro) Effetto placebo (Rimedio: singolo cieco) Effetto Rosenthal (Rimedio: a doppio cieco)
Aspettative del soggetto:
Effetto Hawthorne
I partecipanti di un esperimento sanno di essere osservati e
questo ne influenza il comportamento
Anni ‘30 stabilimento Hawthorne della Western Electric
¡ una migliore illuminazione avrebbe avuto effetti positivi sulla
produttività delle maestranze?
due gruppi di lavoratori
¡ uno sperimentale (illuminazione + elevata)
¡ uno di controllo
La produttività del gruppo sperimentale ebbe un aumento significativo,
ma si ebbe un aumento di produttività anche nel gruppo di controllo.
Anche diminuendo drasticamente l'illuminazione, significativi aumenti di
produttività sia nel gruppo sperimentale che in quello di controllo.
.Aspettative del soggetto:
Effetto Hawthorne
I partecipanti di un esperimento sanno di essere osservati e questo ne
influenza il comportamento
Anni ‘30 stabilimento Hawthorne della Western Electric
¡ una migliore illuminazione avrebbe avuto effetti positivi sulla produttività
delle maestranze?
due gruppi di lavoratori,
¡ uno sperimentale (illuminazione + elevata)
¡ uno di controllo
La produttività del gruppo sperimentale ebbe un aumento significativo, ma si
ebbe un aumento di produttività anche nel gruppo di controllo.
Anche diminuendo drasticamente l'illuminazione, significativi aumenti di
produttività sia nel gruppo sperimentale che in quello di controllo.
La produttività è aumentata perché entrambi i gruppi avevano reagito
positivamente al semplice fatto di aver partecipato ad un esperimento, oppure
alla convinzione che la direzione si occupasse attivamente delle loro condizioni di
lavoro.Aspettative del soggetto: Effetto Hawthorne L'effetto Hawthorne si configura quindi come un’erronea determinazione della variabile indipendente: ¡ gli sperimentatori credevano di manovrare soltanto la variabile dell'illuminazione fisica, mentre in realtà manovravano i contenuti cognitivi delle persone soggette agli esperimenti. Per evitare l'effetto Hawthorne bisognerebbe ¡ tenere i soggetti all'oscuro degli scopi e delle modalità degli esperimenti (ma questo non elimina del tutto errore) ¡ aver cura di mettere entrambi i gruppi – quello sperimentale e quello di controllo - nelle identiche condizioni, siano esse semplicemente fisiche o anche cognitive.
Aspettative del soggetto:
Effetto placeboAspettative del soggetto:
Effetto placebo
Un paziente qualsiasi, dopo aver assunto un farmaco, riferisce
solitamente di aver provato sollievo al suo disturbo
Miglioramento attribuibile al preparato effettivamente assunto,
oppure all'aspettativa del paziente di vedere migliorate le
proprie condizioni?
Per stabilire l'efficacia di un farmaco bisogna mettere i soggetti
di entrambi i gruppi nella stessa situazione psicologica e
somministrare
¡ al gruppo sperimentale il farmaco
¡ al gruppo di controllo un preparato in tutto simile (il placebo)
ma inerte.Aspettative del soggetto:
Effetto placebo
I soggetti spesso rispondono a ciò che essi pensano lo
sperimentatore faccia su di loro, e non necessariamente a ciò
che invece lo sperimentatore pensa di star facendo su di loro.
Essi agiscono in modo da soddisfare quelle che essi pensano
essere le aspettative dello sperimentatore, e spesso si
sbagliano nell’indovinare quelle aspettative.
Inoltre talvolta i soggetti si impegnano a dimostrare la propria
abilità e a "sconfiggere" lo sperimentatore, cercando significati
nascosti nelle consegne ricevute, e agendo in modo da
aggirarle.
Si aggirano questi problemi con l'esperimento a singolo
cieco cieco, in cui i soggetti sono veramente all'oscuro degli
scopi della ricerca.Aspettative dello sperimentatore:
Effetto Rosenthal
Alcuni studenti di psicologia erano incaricati di eseguire degli esperimenti
di laboratorio (prove di apprendimento in labirinto) con dei ratti.
I ratti erano classificati per metà come intelligenti e per metà come
stupidi, e questa caratteristica era specificata per ciascun ratto nella sua
gabbietta.
Gli studenti sapevano che si potevano ottenere ratti intelligenti o stupidi
con appositi incroci ma Rosenthal aveva preso dei ratti qualunque dal
suo stabulario e li aveva distribuiti a caso nelle gabbiette.Effetto dello sperimentatore (effetto Rosenthal)
I risultati ottenuti dagli esperimenti eseguiti dagli studenti
confermarono le false indicazioni contenute sulle gabbiette:
¡ i ratti considerati dagli studenti come intelligenti ottennero
realmente risultati migliori.
I soggetti sperimentali (i ratti) riescano a cogliere
involontariamente manifestazioni comportamentali dello
sperimentatore (lo studente).
¡ Per es lo studente, mentre assiste dall'alto alla prova del
ratto nel labirinto, può anticipare con movimenti del capo la
direzione giusta che il ratto deve prendere quando si trova
ad una biforcazione del labirinto medesimo.
¡ i movimenti involontari dell'osservatore siano + frequenti per
i ratti ritenuti intelligenti, quelli da cui ci si aspetta prestazioni
migliori.Effetto dello sperimentatore
Esiste dunque un'influenza dello sperimentatore sul
soggetto sperimentale, difficilmente evitabile proprio
perchè involontaria e non manifesta
¡ Rimedio: esperimento a doppio cieco
÷ il soggetto non conosce lo scopo della prova
÷ lo sperimentatore non sa quali risultati confermano o
sconfermano l'ipotesi di lavoro
Effetto non solo in situazioni puramente sperimentali
¡ In una classe scolastica i bambini ai quali era stato
attribuito falsamente un alto QI, e che erano stati
raccomandati ai rispettivi insegnanti, dopo otto mesi
ottennero un reale guadagno nelle proprie prestazioni,
di molto superiore a quello di altri bambini formanti il
gruppo di controllo.Gli studi sperimentali
IDENTIFICARE IL PROBLEMA E FORMULARE IPOTESI SULLE
RELAZIONI CAUSA-EFFETTO FRA LE VARIABILI
÷LA PRESENTAZIONE DI UN AIUTO VISIVO FAVORISCE LA LETTURA DI UNA
PAROLA
PROGETTARE ESPERIMENTO
÷ MANIPOLAZIONE VARIABILE INDIPENDENTE: (aiuto visivo presente / aiuto
visivo assente.
÷ DEFINIZIONI OPERAZIONALI
CONDURRE ESPERIMENTO
÷ GRUPPO SPERIMENTALE E DI CONTROLLO: DEFINIZIONI OPERAZIONALI;
SELEZIONE PARTECIPANTI.
VALUTARE LE IPOTESI VEDENDO I DATI
÷ ANALISI DEI DATI STATISTICI
COMUNICARE I RISULTATI
÷ PUBBLICARE RISULTATI SU RIVISTA SCIENTIFICA (PEER
REVIEW) E/O A CONVEGNICome possiamo stabilire se la variabile indipendente influenza la variabile dipendente? metodi statistici Attendibilità (riproducibilità) Validità (appropriatezza della misura)
Metodi statistici
I dati devono essere elaborati ed interpretati per
individuare relazioni significative
¡ Metodi statistici descrittivi
÷ Rappresentazione di insiemi di dati
¡ Metodi d’inferenza statistica
÷ Stabilire il grado di certezza con cui si possono trarre
specifiche inferenzeMetodi descrittivi Se i dati originali consistono in misure numeriche è possibile rappresentarli utilizzando ¡ Misure di tendenza centrale: Media e mediana ¡ Variabilità: deviazione standard Se l’esperimento è di correlazione per stimare forza e direzione della correlazione ¡ Grafico di dispersione ¡ Coefficiente di correlazione
Confronto medie dei gruppi Risultati: media maschi 81; media femmine 78 Tipo di variazioni: tra i gruppi ed entro i gruppi Rapporto critico
Metodi di inferenza statistica
I dati contengono sempre variabilità dovuta al caso
¡ Es. Differenze iniziali nei gruppi
Dobbiamo calcolare la probabilità p che l’ipotesi di
ricerca sia errata: cioè che la VI non influenzi la VD
¡ Più bassa e’ p più alto è il grado di certezza del
ricercatore nel concludere che la sua ipotesi era
valida
¡ Convenzione: i risultati sono statisticamente
significativi se la probabilità che l’ipotesi sia errata è
inferiore al 5%. (.05)Gli studi sperimentali
IDENTIFICARE IL PROBLEMA E FORMULARE IPOTESI SULLE
RELAZIONI CAUSA-EFFETTO FRA LE VARIABILI
÷LA PRESENTAZIONE DI UN AIUTO VISIVO FAVORISCE LA LETTURA DI UNA
PAROLA
PROGETTARE ESPERIMENTO
÷ MANIPOLAZIONE VARIABILE INDIPENDENTE: (aiuto visivo presente / aiuto
visivo assente.
÷ DEFINIZIONI OPERAZIONALI
CONDURRE ESPERIMENTO
÷ GRUPPO SPERIMENTALE E DI CONTROLLO: DEFINIZIONI OPERAZIONALI;
SELEZIONE PARTECIPANTI.
VALUTARE LE IPOTESI VEDENDO I DATI
÷ ANALISI DEI DATI STATISTICI
COMUNICARE I RISULTATI
÷ PUBBLICARE RISULTATI SU RIVISTA SCIENTIFICA (PEER
REVIEW) E/O A CONVEGNIwww.pubmed.com PubMed comprises more than 25 million citations for biomedical literature from MEDLINE, life science journals, and online books. US National Library of Medicine. www.google.scholar.com
Etica della ricerca Tutti noi abbiamo la responsabilità di comportarci eticamente rispetto alle altre persone, ma gli psicologi devono essere consci in particolare di questa responsabilità. La ricerca etica origina dalla chiarezza e da alcune semplici linee guida.
Gli psicologi hanno una responsabilità
particolare
Gli stati mentali sono propriamente privati, eccetto quanto
viene rilasciato il permesso di intervenire.
L’intervento è talvolta necessario nella ricerca
psicologica.
Questi interventi possono creare problemi, quindi bisogna
garantire attenzioni particolari.https://youtu.be/dFR7qHTVsPo L'esperimento di Stanley Milgram di psicologia sociale del 1961 Uno dei più famosi ed importanti esperimenti psicologici per svariati motivi: l'apporto conoscitivo ai meccanismi della autorità, l'originalità dell'esperimento e soprattutto la riflessione etica sulla ricerca psicologica.
L'esperimento della prigione di Stanford del 1971 di Philippe Zimbardo: -deindividuazione
Rapporto rischio/beneficio Chi rischia? ¡ Cos’è un rischio “accettabile”? ¡ Accettabile per chi? I benefici per chi? ¡ Come valutiamo i benefici? ¡ Significatività? ¡ Immediatezza? ¡ Probabilità che il risultato della ricerca sia utile?
Consenso informato
I nostri soggetti sono volontari. SEMPRE.
Due stadi
¡ Informate i vostri soggetti prima di iniziare l’esperimento
÷ Spiegate i diritti.
÷ Siate chiari sui rischi.
÷ Assicuratevi di essere capiti.
¡ Ottenete un consenso genuino
÷ Non mentite su cose che influenzerebbero la decisione di
partecipare
÷ Non offrite vantaggi significativi.Livelli di rischio
Ricerca senza rischio
¡ Studio che utilizza test educativi/cognitivi come test di
intelligenza
¡ Esperimenti di osservazione del comportamento eccetto nei
casi in cui I soggetti possano venire identificati
¡ Ricerche bibliografiche
Ricerca a rischio minimo
¡ Misure psicologiche standard e di registrazione vocale
¡ Studi cognitivi e percettivi che non inducono stress
¡ Consenso informato non e’ necessario
Ricerca ad alto rischio
¡ Studi che inducono stress fisico, stress psicologico,
invasione della privacy, utilizzo di informazioni sensibili con
cui I soggetti possono essere identificatiPuoi anche leggere