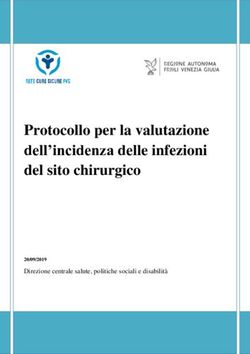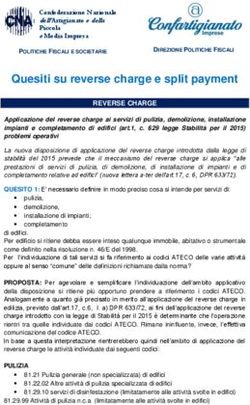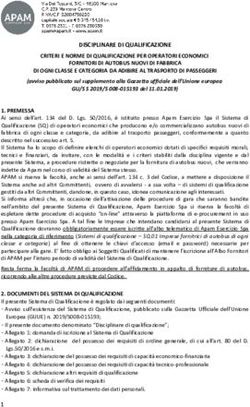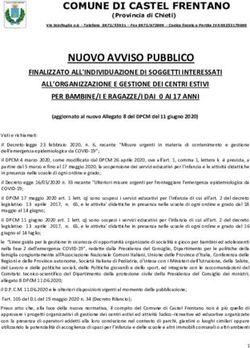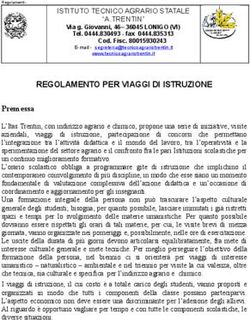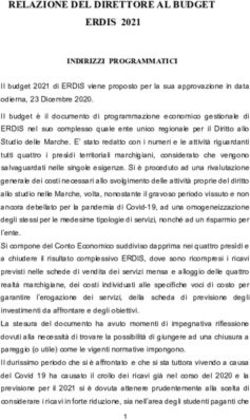Le rappresentazioni sociali relative a soggetti sieropositivi e malati di AIDS: una ricerca su ope-ratori sociali, scolastici e studenti
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Boll. Farmacodip. e Alcoolis., XXIV (2) 2001
Le rappresentazioni sociali relative a soggetti sieropositivi e malati di AIDS: una ricerca su ope-
ratori sociali, scolastici e studenti
Marco Capelli*, Alessandro De Leo**, Federico Lorenzotti*, Giancarlo Piccitto*
Riassunto
Il lavoro si propone di evidenziare alcune caratteristiche delle rappresentazioni sociali relative a persone sieropositive
e/o malate di AIDS in campioni di operatori sociali e scolastici ed in un gruppo di studenti. Nonostante la diffusione di
informazioni scientificamente corrette, le rappresentazioni sociali sembrano ancora condizionate da stereotipi e pregiudizi.
Questo risulta ancora più rilevante nelle persone che, nell’ambito della loro attività lavorativa, possono trovarsi direttamen-
te in contatto con persone sieropositive o malate di AIDS o possono avere una funzione educativa verso i giovani. Nella
progettazione di interventi educativi su questi temi risulta quindi imprescindibile lavorare sui processi mentali che potreb-
bero distorcere o rendere meno efficaci i contenuti trasmessi.
Parole chiave: Rappresentazioni sociali, AIDS, HIV
Abstract
Social attitudes towards HIV and AIDS patients. A research project on health and social workers, teachers and students
The aim of this work was to identify the attitudes of social and school workers, as well as a group of students, with re-
spect to people with HIV or AIDS. Despite the distribution of correct scientific information, the sample still seemed to re-
tain stereotyped and prejudiced attitudes. This is more significant among people that are directly involved with HIV or
AIDS patients or with educational roles. It is therefore essential, when preparing educational projects about AIDS, to work
on the mental processes that may distort the transmitted message or make them less effective.
Keyword: Social representation, AIDS, HIV
Introduzione me quanto più elevata sia la carica affettivo-emotiva relati-
va ad una qualunque tematica, tanto più la corrispondente
Le rappresentazioni sociali possono essere definite co- rappresentazione sociale possa potenzialmente risultare
me “una serie di concetti, asserti e spiegazioni che nascono lontana dalla “realtà”, per quanto questa non sia mai intera-
nella vita di tutti i giorni... sono una maniera di interpretare mente oggettivabile.
la realtà quotidiana, una forma di pensiero sociale” (1). Per quanto concerne più direttamente il problema AIDS
Tutti noi abbiamo rappresentazioni sociali interiorizzate “con rappresentazioni sociali intendiamo l’insieme di
che ci portano a interpretare e/o attribuire significati e ca- informazioni, atteggiamenti, stime di rischio ed intenzioni
ratteristiche specifiche a eventi, persone, situazioni. Queste comportamentali, direttamente od indirettamente legate ad
convinzioni influenzano il modo di operare e di comportar- esso” (2).
si nella vita quotidiana di ciascuno ed anche la modalità ed La valutazione dell’impatto e dell’efficacia delle ormai
il contenuto delle informazioni trasmesse agli altri. numerose campagne informative a scopo preventivo, pro-
Le rappresentazioni che ciascun individuo ha maturato mosse da vari Enti nel corso degli anni in cui si è definita
ad un dato momento su un dato argomento sono la risultan- la malattia e si sono chiariti i meccanismi di trasmissione
te sia di una conoscenza oggettiva dei dati di realtà del pro- ed evoluzione, è piuttosto scoraggiante. La sola informa-
blema, sia, soprattutto, della interpretazione affettivo-emo- zione, per quanto fornita in modo corretto, chiaro, mirato,
tiva che determina in ultima analisi il significato personale sembra non avere determinato gli attesi cambiamenti a li-
attribuito alla situazione stessa. È facilmente intuibile co- vello di atteggiamenti ed abitudini comportamentali (3).
* Psicologo - Ser.T. - ASL 4 Regione Liguria - Salita Levaggi, 16043 Chiavari (GE), tel. 0185/488920-21.
** Educatore Professionale - Ser.T. - ASL 4 Regione Liguria - Chiavari (GE).
96Articoli
Pertanto, nel momento in cui si progettano interventi - un differenziale semantico, graduato secondo intensità
educativi, soprattutto nei confronti delle giovani generazio- da -3 a +3 (molto, abbastanza, un po’) ed un valore centra-
ni, risulta imprescindibile considerare e lavorare anche sui le 0 (né l’uno né l’altro), applicato alle affermazioni: “Il
“processi di significazione” che potrebbero intervenire sui sieropositivo è:” ed “Il malato di AIDS è:”; tale differen-
contenuti trasmessi, piuttosto che centrare l’attenzione ziale veniva ripetuto su 15 aggettivi (Tab. 2);
sull’aspetto meramente informativo. Tra l’altro, questo ter- - una lista di 20 aggettivi, tra i quali gli intervistati do-
reno di studio ed intervento è particolarmente stimolante in vevano scegliere i 5 che meglio qualificavano il proprio
quanto sia la “fonte”, sia il “bersaglio” dell’azione educati- personale “concetto di AIDS” (Tab. 3).
va, si trovano insieme, nello stesso tempo, ad affrontare la La somministrazione dello strumento è stata curata dal
realtà nuova costituita dallo sviluppo dell’infezione da personale del Servizio.
HIV. Non si configura quindi un intervento educativo
“classico”, in cui le nozioni e le relative rappresentazioni
possono essere presentate e trasmesse come qualcosa di Campione
consolidato, bensì un ambito in cui lo stesso formatore/
educatore deve fare i conti con l’acquisizione di dati scien- Lo strumento articolato nel modo sopra descritto è stato
tifici per certi aspetti ancora in via di definizione e con la somministrato a quattro gruppi di soggetti, all’incirca omo-
costruzione delle proprie relative rappresentazioni. Infine, genei per quanto riguarda la percentuale di maschi e fem-
un’altra variabile che influenza la trasmissione ai giovani mine (rispettivamente 30 e 70%), definiti come segue:
dei sistemi di credenze, di valutazione e di interpretazione, - gruppo 1: composto da aspiranti volontari già inseriti
da tenere in considerazione per la progettazione di inter- in uno specifico corso per l’assistenza domiciliare a malati
venti efficaci, è relativa al livello, alla natura, alla qualità di AIDS, prevalentemente infermieri professionali neo-di-
del rapporto comunicativo-affettivo tra giovani e genitori, plomati (N 50);
insegnanti o più in generale “autorità” ed agenti educativi. - gruppo 2: composto da operatori sociali, impiegati nel
settore dell’handicap (N 21);
- gruppo 3: composto da insegnanti di Scuola Superiore
Obiettivi interessati a svolgere attività di prevenzione socio-sanitaria
in ambito scolastico (N 14);
Il lavoro si propone di evidenziare alcune caratteristi- - gruppo 4: composto da studenti iscritti alle classi terza
che delle rappresentazioni sociali relative a persone siero- e quarta di un Istituto Professionale Statale (N 41).
positive e/o malate di AIDS in campioni di soggetti appar- Si suppone che il gruppo 1 sia costituito da persone al-
tenenti a differenti categorie professionali e in un gruppo di tamente motivate alla relazione con soggetti infettati, men-
adolescenti. tre nei gruppi 2 e 3 si presume siano rappresentati soggetti
L’ipotesi che guida la ricerca è che, nonostante oramai comunque sensibili e/o attivamente impegnati in temi so-
da tempo venga diffusa una informazione scientificamente ciali. Il gruppo di studenti è stato costituito come campio-
corretta, le rappresentazioni mentali siano ancora condizio- ne, pur se non realmente rappresentativo, della realtà stu-
nate da stereotipi e pregiudizi. La manifestazione di atteg- dentesca locale che si suppone provenire da fasce sociali in
giamenti di discriminazione e la messa in atto di comporta- cui è maggiormente probabile riscontrare aree di disagio
menti di emarginazione, collegati a tali rappresentazioni sociale.
distorte, risulterebbero ancora più rilevanti in quelle cate-
gorie di persone che, nell’ambito della loro attività lavora-
tiva, possono trovarsi direttamente in contatto con persone Risultati
sieropositive o malate di AIDS o possono avere una fun-
zione educativa verso i giovani. Questionario
In Tabella 4 sono riportate le percentuali di risposta a
Materiali e metodo tutti gli items. Di seguito saranno commentati solo i risul-
tati più significativi.
Strumento di ricerca Gli items 2 e 5 del questionario fanno riferimento ad
aspetti oggettivi del problema, specificatamente alla quan-
Allo scopo di rilevare conoscenze, atteggiamenti ed at- tificazione della diffusione della malattia. Nonostante si
tribuzioni causali è stato appositamente costruito uno stru- tratti di cifre volutamente sovrastimate e decisamente lon-
mento composto da tre parti: tane dalla realtà, è da sottolineare come percentuali molto
- un primo questionario, composto da dieci affermazio- elevate, dal 98% degli studenti al 48% degli operatori so-
ni, tendenti a verificare sia alcune conoscenze oggettive ciali, non sappiano esprimere una valutazione in merito sia
sull’incidenza della malattia e sul suo possibile sviluppo, al numero di persone contagiate, sia alla diffusione nel
sia, soprattutto, atteggiamenti ed attribuzioni causali. Tali prossimo decennio. Tale incertezza risulta particolarmente
affermazioni prevedevano risposte del tipo “Vero”, “Fal- preoccupante nel caso degli insegnanti (65% e 71% rispet-
so”, “Non so” (Tab. 1); tivamente alla domanda 2 e 5). Addirittura il 22% del grup-
Le rappresentazioni sociali relative a soggetti sieropositivi e malati di AIDS 97Boll. Farmacodip. e Alcoolis., XXIV (2) 2001
po dei volontari ed il 14% degli operatori sociali affermano mo ritenuto degni di commento scostamenti prossimi o su-
che in Italia, attualmente, vi sono più di 5 milioni di malati periori al valore 1, che indicano la presenza della caratteri-
di AIDS e previsioni catastrofiche sulla diffusione della stica almeno nella misura di “un po’”.
malattia sono sostenute dal 27% degli studenti. Rispetto all’affermazione “Il sieropositivo è” (Fig. 1) le
La palese enormità delle cifre indicate, sempre rispetti- caratteristiche salienti individuabili dalle risposte di tutti i
vamente alle domande 2 e 5, è individuata solo dal 18 e gruppi risultano essere di una certa emotività (items 12, da
22% degli aspiranti volontari, dal 38 e 24% degli operatori 0.8 a 1.2) e tendenza all’isolamento (items 13, da -0.7 a -
sociali, dal 35 e 24% degli insegnanti, dal 2 e 7% degli stu- 1.1). Altre caratteristiche della rappresentazione sociale del
denti. soggetto HIV+, rilevabili pur se con gradi di intensità infe-
Gli items 3 e 10 erano tesi a porre in rilievo eventuali riori e non omogenei in tutti i gruppi, sono l’eccitabilità,
atteggiamenti di discriminazione ed emerginazione sociale l’impulsività, l’imprevedibilità. Inoltre, nel gruppo di stu-
che sembrano essere propri di circa un terzo degli intervi- denti, che appare mediamente pronunciarsi in maniera più
stati, con elevazioni marcate di questa percentuale nel netta, si rilevano altri aggettivi che superano la soglia del
gruppo degli studenti. +/- 0,8: in particolare il soggetto HIV+ è visto come eccita-
Più in dettaglio il 22% dei volontari, il 29% degli inse- bile (-1), squilibrato (-0.9), intollerante e disonesto (-0,8).
gnanti, il 5% degli operatori sociali e il 30% degli studenti Per tutti i gruppi, tranne gli insegnanti che si collocano me-
ritiene che i sieropositivi non dovrebbero lavorare in locali diamente sul punto neutro, il soggetto è comunque da avvi-
pubblici ove vengano manipolati o serviti cibi. Se a questi cinare (items 15, da 0.7 a 1.3).
si aggiungono coloro che esprimono incertezza si ottengo- Rispetto all’affermazione “Il malato di AIDS è” (Fig.2)
no valori percentuali tra il 30 e il 45%. si conferma sostanzialmente il profilo ottenuto per il sog-
I dati relativi alla necessità di segnalare i soggetti siero- getto sieropositivo, con una maggiore accentuazione di ca-
positivi in ambito lavorativo rivelano che di questo avviso ratteristiche quali l’emotività, lo squilibrio, la tendenza
è il 18% degli aspiranti volontari, il 19% degli operatori all’isolamento. L’avvicinabilità viene confermata pur se
sociali, il 12% degli insegnanti e ben il 65% degli studenti. con un grado di intensità minore. In questo secondo caso
Se a questi si aggiungono coloro che esprimono incertezza, non viene confermata l’estremizzazione dei tratti da parte
ma che non escludono quindi totalmente tale possibilità, del gruppo di studenti, tranne che per l’aggettivo squilibra-
otteniamo percentuali tra il 30 ed il 40% nei primi tre grup- to; sono invece i volontari ad accentuare i tratti di di emoti-
pi ed addirittura dell’88% degli studenti. vità ed isolamento.
La volontà personale di sottoporsi al test nel caso di
dubbio di infezione è negata dal 6% dei volontari e dal 5%
degli studenti (item 7); soprattutto la percentuale rilevata Connotazione dell’AIDS
nel gruppo dei volontari, pur essendo riferibile a pochissi-
me persone, induce ad immaginare una situazione parados- Per quanto riguarda la definizione “L’AIDS è” tramite
sale di disponibilità alla cura di estranei già ammalati ac- la scelta di 5 tra gli aggettivi di una lista, rileviamo una ge-
canto all’indisponibilità di affrontare l’eventuale problema, nerale concordanza nei quattro gruppi, con una netta preva-
per sé e per gli altri. lenza, abbastanza prevedibile, di definizioni come crudele,
Rispetto alla correttezza delle campagne informative e tetro, cattivo (Fig. 3). Degna di riflessione ci appare tutta-
all’utilizzo di fondi pubblici spesi per affrontare il proble- via la non esigua percentuale di scelta, oscillante tra il 12%
ma AIDS (items 6, 9) circa il 70% degli intervistati è con- e il 24%, che ha ricevuto il termine “ribelle”. Ancora più
corde con le politiche adottate sino ad oggi; gli studenti so- marcata risulta la percentuale di scelta dall’aggettivo “ven-
no comprensibilmente più indecisi sulla valutazione di dicativa”: 19% operatori sociali, 29% insegnanti, volontari
questi aspetti. 42%, studenti 59%.
Un ultimo blocco di affermazioni (items 1, 4, 8) fa rife-
rimento, rispetto al rischio di contrazione del virus, ad at-
tribuzioni causali del tutto esterne o al fatto di appartenere Conclusioni
a determinate “categorie”. La quasi totalità degli intervista-
ti di tutti i 4 gruppi sembra avere superato il pregiudizio Dai dati riportati è possibile estrapolare alcune rifles-
che contrarre l’AIDS dipenda dalla sfortuna o riguardi solo sioni utili per la programmazione di interventi di formazio-
alcune categorie di persone. Solo il 5% degli studenti affer- ne e prevenzione rivolti a diversi soggetti sociali.
ma che il rischio è limitato ad omosessuali e tossicodipen- La percezione che l’AIDS sia una malattia non circo-
denti. scrivibile a ristrette e determinate “categorie a rischio”, ma
che la possibilità di contagio riguardi trasversalmente tutta
la popolazione, appare oramai consolidata e condivisa da
Differenziale Semantico soggetti differenti per età, cultura, interessi. Sembra supe-
rata anche una concezione moralistica che nel senso comu-
Le risposte al differenziale semantico date da ciascun ne attribuiva la possibilità di entrare in contatto con il virus
gruppo a ciascun item sono state sintetizzate con il valore prevalentemente a chi “se lo andava a cercare”.
medio di scostamento dall’asse centrale neutro (0). Abbia- Tuttavia, la parte irrazionale, legata ad archetipi di con-
98 Le rappresentazioni sociali relative a soggetti sieropositivi e malati di AIDSArticoli
tagio pestilenziale, affiora nelle valutazioni della diffusione caratteristiche e con un maggior grado di intensità. L’im-
attuale della malattia e del trend di crescita, che vengono magine mentale del soggetto HIV+ risulta ancor più domi-
decisamente sovrastimate da percentuali elevate di soggetti nata dalla sfera emotiva nella gestioni degli impulsi e con-
di tutti i gruppi considerati. notata in senso deviante.
Inoltre, la scelta di non effettuare il test in caso di dub- Tale evidenze ci inducono a riflettere su quanto sia an-
bio di contagio da virus HIV, dato limitato a pochi soggetti cora necessario lavorare nel campo dell’educazione sociale
del gruppo studenti ed insegnanti ma comunque importan- per fornire strumenti critici che permettano valutazioni più
te, rivela un persistente substrato di paura che si potrebbe libere da pregiudizi ed immagini stereotipate, come spesso
concretamente manifestare attraverso comportamenti pale- sono proposte dai media. Come elemento positivo può es-
semente irrazionali e pericolosi per la propria ed altrui sa- sere segnalata una certa spinta ad avvicinare soggetti siero-
lute. positivi presente nei gruppi di volontari ed anche studenti
Questi rilievi ci portano a riflettere sull’opportunità di ed operatori sociali.
prevedere sempre un adeguato spazio negli interventi for- Per quanto riguarda la percezione del malato di AIDS,
mativi e preventivi all’analisi, libera o parzialmente guida- pur se si mantiene all’incirca lo stesso profilo del soggetto
ta, delle paure personali altrimenti inespresse. HIV+, vediamo diminuire in tutti i gruppi l’avvicinabilità e
Dal punto di vista dell’accettazione e dell’integrazione comparire la caratterizzazione di leggero squilibrio.
sociale, è allarmante l’elevata percentuale di insegnanti e Pur considerando che il differenziale semantico forza
di studenti, circa il 30% in entrambi i gruppi, che ritengono necessariamente le possibilità di scelta dei soggetti, ci sem-
che i sieropositivi non dovrebbero lavorare nei bar e risto- bra comunque che la rappresentazione sociale emergente
ranti. Tale similitudine di orientamenti potrebbe anche non sia abbastanza bene definita, orientata come già detto verso
essere del tutto casuale e configurare una sorta di trasmis- il lato emotivo e poco controllato della personalità.
sione, più o meno esplicita e consapevole, di atteggiamenti, Infine, le definizioni dell’AIDS ci rimandano, come
convinzioni, o più in generale di clima culturale, da parte prevedibile, un’immagine di crudeltà e di cattiveria della
di soggetti con funzioni educative verso i loro allievi. malattia stessa. È da rilevare anche la percezione della ma-
Per quanto riguarda la necessità di segnalazione dei lattia come “vendicativa” che compare con frequenza negli
soggetti sieropositivi negli ambienti di lavoro l’elevatissi- studenti (59%) e negli aspiranti volontari (42%). Tale ca-
ma percentuale di studenti (65%) che si dichiara d’accordo, rattere vendicativo della malattia potrebbe indicare l’ipote-
ci induce a ritenere che i contenuti espressi fino ad ora dal- si, trattabile anche nei corsi formativi con adeguata meto-
le varie campagne di sensibilizzazione promosse dai più dologia, che in qualche misura persista in molti soggetti
diversi Enti, non raggiungano efficacemente perlomeno l’attribuzione inconscia di colpe da espiare da parte di chi è
questo target di popolazione. Infatti, un dato così elevato infetto.
sta ad indicare un profondo e diffuso atteggiamento discri-
minatorio e la deformazione o la mancanza di efficacia
dell’informazione data fino ad ora in questo senso.
Bibliografia
Il differenziale semantico mette in luce una visione del
profilo del soggetto HIV+ piuttosto uniforme tra i soggetti 1) Ardone R.G. (1990): Rappresentazioni familiari. Borla, Roma.
adulti intervistati, al di là dell’appartenenza ai diversi grup- 2) Mannetti L. (a cura di) (1992): L’AIDS nell’immaginario col-
pi; tale soggetto è connotato come tendente alla solitudine lettivo. Franco Angeli Editore, Milano.
e dominato dalla parte emotiva. 3) Coletti M. (1994): Prima della droga: come informare e preve-
Gli studenti si differenziano dalle valutazioni fornite nire, p. 137-154. In: L. Onnis, W. Galluzzo. La terapia relazio-
dagli adulti in quanto attribuiscono un maggior numero di nale e i suoi contesti, NIS, Roma.
Tabella 1. Questionario. Alle seguenti affermazioni era possibile rispondere con “Vero”, “Falso”, “Non so”.
1) Contraggono il virus solo quelli che se lo vanno a cercare
2) I malati di AIDS in Italia sono più di 5 milioni
3) I sieropositivi non dovrebbero lavorare nei ristoranti, nei bar e nei negozi di alimentari in genere
4) Solo i tossicodipendenti e gli omosessuali contraggono l’AIDS
5) Continuando con questo trend entro il 2010, il 30% della popolazione italiana sarà sieropositiva
6) L’informazione scientifica sulla diffusione del virus dell’AIDS tende a descrivere la situazione in modo molto più
drammatico di quanto non sia in realtà
7) Se avessi il dubbio di aver contratto l’infezione HIV preferirei continuare a non saperlo e quindi non mi sottoporrei al
test di verifica
8) Rimanere infettati dall’HIV è esclusivamente una questione di fatalità sfortunata
9) Attualmente i fondi pubblici spesi per affrontare il problema AIDS sono eccessivi, bisognerebbe dirottarne una parte
verso altre patologie più gravi
10) In ambito lavorativo qualunque persona sieropositiva dovrebbe essere segnalata a tutti i colleghi
Le rappresentazioni sociali relative a soggetti sieropositivi e malati di AIDS 99Boll. Farmacodip. e Alcoolis., XXIV (2) 2001
Tabella 2. Differenziale semantico. Riferito sia all’affermazione “il sieropositivo è”, sia a “il malato
di AIDS è”. (+ 3 e -3 Molto, +2 e -2 Abbastanza, +1 e -1 Un po’, 0 Né l’uno né l’altro).
Items 1 Cattivo -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 Buono
Items 2 Peccatore Virtuoso
Items 3 Intollerante Tollerante
Items 4 Eccitabile Calmo
Items 5 Violento Moderato
Items 6 Impulsivo Autocontrollato
Items 7 Disonesto Onesto
Items 8 Sleale Leale
Items 9 Infido Fidato
Items 10 Imprevedibile Prevedibile
Items 11 Squilibrato Sano
Items 12 Insensibile Emotivo
Items 13 Solitario Socievole
Items 14 Egoista Altruista
Items 15 Da evitare Da avvicinare
Tabella 3. Lista di aggettivi, tra cui scegliere i 5 che qualificano nel miglior modo il concetto di AIDS.
1) Affascinante 6) Curiosa 11) Piacevole 16) Dà sicurezza
2) Attraente 7) Forte 12) Razionale 17) Socievole
3) Cattiva 8) Fredda 13) Realistica 18) Sognatrice
4) Creativa 9) Odiosa 14) Ribelle 19) Tetra
5) Crudele 10) Originale 15) Rilassata 20) Vendicativa
Tabella 4. Percentuali di risposta fornite dai 4 gruppi ai 10 items del
questionario.
Gruppo 1 (risp.%) Gruppo 2 (risp.%)
Vero Non so Falso Items N. Vero Non so Falso
- - 100 1 - 5 95
22 60 18 2 14 48 38
22 8 70 3 5 24 71
- - 100 4 - - 100
14 64 22 5 24 52 24
10 20 70 6 10 14 76
6 8 86 7 - - 100
2 0 98 8 5 5 91
4 26 70 9 0 29 71
18 14 68 10 19 19 62
Gruppo 3 (risp.%) Gruppo 4 (risp.%)
Vero Non so Falso Items N. Vero Non so Falso
- - 100 1 5 - 95
- 65 35 2 7 91 2
29 12 59 3 30 15 55
- - 100 4 5 15 80
6 71 24 5 27 66 7
6 24 71 6 7 34 59
- 6 94 7 5 12 83
- - 100 8 2 15 83
- 35 65 9 10 28 62
12 18 71 10 65 23 12
100 Le rappresentazioni sociali relative a soggetti sieropositivi e malati di AIDSArticoli
Figura 1. Valore medio di scostamento dall’asse centrale neutro espresso a ciascuno degli items del diffe-
renziale semantico dai 4 gruppi, relativamente all’affermazione “Il sieropositivo è”.
Figura 2. Valore medio di scostamento dall’asse centrale neutro espresso a ciascuno degli items del
differenziale semantico dai 4 gruppi, relativamente all’affermazione “Il malato di AIDS è”.
Le rappresentazioni sociali relative a soggetti sieropositivi e malati di AIDS 101Boll. Farmacodip. e Alcoolis., XXIV (2) 2001
Figura 3. Percentuali di scelta nei 4 gruppi degli aggettivi più frequentemente indicati rispetto all’affer-
mazione “L’AIDS è”.
102 Le rappresentazioni sociali relative a soggetti sieropositivi e malati di AIDSPuoi anche leggere