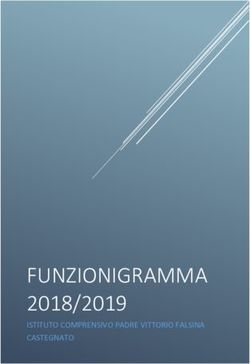La Politica di Coesione 2014 - 2020 Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
La Politica di Coesione 2014 – 2020
Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea
La politica di coesione 2014 – 2020 è il più importante strumento
finanziario dell’UE per l’investimento finalizzato a produrre crescita e
occupazione e a ridurre il divario tra i paesi membri dell’Unione Europea.
Sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea serie L
347 del 20 dicembre 2013 i Regolamenti sui Fondi strutturali e di
investimento europei (SIE) che forniscono le disposizioni in materia di
investimenti della politica di coesione per il nuovo ciclo di
programmazione 2014/2020.
Le nuove nome si strutturano in:
1 Regolamento recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione,
sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
(Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
Base giuridica del 17 dicembre 2013);
5 Regolamenti specifici relativi a ciascun fondo:
Reg. (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo
regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che
abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
Reg. (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che
abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
Reg. (UE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo di coesione che abroga il
regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio;
Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, relativo al Fondo Europeo per gli affari
marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n.
2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n.
1791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio;
2 Regolamenti specifici sulla cooperazione territoriale e sul GECT:
Reg. (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il
sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all’obiettivo di
cooperazione territoriale europea;
Reg. (UE) n. 1302/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 17 dicembre 2013 che modifica il Reg. (CE) n. 1082/2006
relativo a un Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT)
per quanto concerne il chiarimento, la semplificazione e il
miglioramento delle norme in tema di costituzione e
funzionamento di tali gruppi;
Nella GUUE del 20/12/2013, inoltre, è pubblicato anche il Regolamento
(UE, EURATOM) n. 1311/2013, che stabilisce il quadro finanziario
pluriennale per il periodo 2014/2020.
E’ possibile visionare i testi integrali dei regolamenti sopra citati
cliccando su questo link.
Come adottato dal Regolamento (UE, EURATOM) n. 1311/2013 del
Consiglio del 2 dicembre 2013, la Politica di Coesione economica, sociale
e territoriale conta un investimento pari a poco più di 325 miliardi di
euro negli Stati membri e nelle loro regioni e città per realizzare gli
obiettivi su scala unionale in tema di crescita e occupazione nonché per
affrontare le problematiche legate al cambiamento climatico, alla
dipendenza energetica e all’esclusione sociale.
Nel Quadro finanziario pluriennale 2014 – 2020 risulta essere la fonte di
finanziamento pubblico europeo più importante e oltre all’importo
sopra citato, bisogna tenere conto del contributo nazionale degli Stati
membri e dell'effetto di leva degli strumenti finanziari, l'impatto
complessivo dovrebbe superare i 500 miliardi di euro. La riforma della
politica di coesione massimizzerà l'impatto di questi investimenti
Descrizione
adattati ai bisogni individuali delle regioni e città. Gli elementi chiave
della riforma sono:
1. Investire in tutte le regioni dell'UE e adattare il livello di sostegno e
il contributo nazionale (tasso di cofinanziamento) ai loro livelli di
sviluppo:
regioni meno sviluppate (PIL < 75% della media UE-27)
regioni in transizione (PIL dal 75% al 90% della media UE-27)
regioni più sviluppate (PIL > 90% della media UE-27)
2. Indirizzare le risorse sui settori chiave per la crescita: gli
investimenti a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
verranno concentrati su 4 priorità chiave: innovazione e ricerca, agenda
digitale, sostegno alle piccole e medie imprese (PMI) ed economia a
2bassa emissione di carbonio, a seconda della categoria della regione
(meno sviluppata: 50%, in transizione: 60% e più sviluppata: 80%). Circa
100 miliardi di euro saranno consacrati a questi settori, dei quali almeno
23 miliardi di euro serviranno a sostenere il passaggio a un'economia a
bassa emissione di carbonio (efficienza energetica ed energie
rinnovabili). In relazione a ciò le risorse del FESR saranno soggette a
un'opportuna ripartizione (regioni meno sviluppate: 12%, in transizione:
15% e più sviluppate: 20%).
Circa 66 miliardi di euro saranno consacrati alla priorità Reti
transeuropee di trasporto nonché a progetti per l'infrastruttura
ambientale chiave per il tramite del Fondo di coesione.
Grazie al Fondo sociale europeo (FSE) la politica di coesione recherà un
contributo significativo alle priorità unionali nel campo dell'occupazione,
ad esempio mediante azioni di formazione e di apprendimento
permanente, di istruzione e di inclusione sociale (almeno il 20% dell'FSE
sarà stabilito in funzione delle esigenze di ciascuno Stato membro dovrà
essere impiegato per questo obbiettivo). Lo stanziamento minimo per
l'FSE sarà stabilito da ciascuno Stato membro, con un minimo
predefinito, per un totale di almeno 70 miliardi di euro. La nuova
iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, del valore di almeno 6
miliardi di euro, correlata all'FSE, sosterrà l'implementazione della
garanzia per i giovani.
3. Stabilire obiettivi chiari, trasparenti e misurabili e parametri di
responsabilità e di risultato: i paesi e le regioni dovranno annunciare sin
dall'inizio quali obiettivi intendono raggiungere con le risorse disponibili
e identificare esattamente in che modo misureranno i progressi
compiuti in direzione di tali obiettivi. Ciò consentirà il monitoraggio
regolare e la discussione sull'uso delle risorse finanziarie. Ciò significherà
che per i programmi che presentano migliori risultati potranno essere
resi disponibili finanziamenti addizionali (attraverso la cosiddetta
"riserva di efficacia ed efficienza") verso la fine del periodo.
4. Definire di condizioni prima che i finanziamenti vengano
convogliati in modo da assicurare investimenti più efficaci: ad esempio,
le strategie di "specializzazione intelligente" volte a identificare i punti di
forza particolari e le potenzialità, le riforme favorevoli all'imprenditoria,
le strategie dei trasporti, le misure per migliorare i sistemi di appalti
pubblici, il rispetto delle normative ambientali, le strategie di lotta
contro la disoccupazione e contro la dispersione scolastica o quelle a
promozione della parità tra i generi e della non-discriminazione sono
tutte precondizioni irrinunciabili.
5. Definire una strategia comune per assicurare un migliore
coordinamento ed evitare le sovrapposizioni: un quadro strategico
comune costituirà la base per un migliore coordinamento tra i Fondi
3strutturali e di investimento europei (FESR, Fondo di coesione e FSE nella
loro qualità dei tre fondi che partecipano alla politica di coesione nonché
il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e il Fondo per la pesca).
Tale quadro consentirà inoltre di assicurare un migliore collegamento
con altri strumenti unionali come Orizzonte 2020, il meccanismo per
collegare l'Europa e il programma per l'occupazione e l'innovazione
sociale.
6. Ridurre la burocrazia e semplificare l'uso degli investimenti
unionali attraverso un insieme comune di regole per tutti i Fondi
strutturali e di investimento europei nonché regole di contabilità più
semplici, oneri di rendicontazione più mirati e un maggior uso delle
tecnologie digitali ("e-cohesion").
7. Accrescere la dimensione urbana della politica stanziando un
importo minimo delle risorse a valere sul FESR per progetti integrati
nelle città, al di là degli altri tipi di spesa consacrata alle zone urbane.
8. Rafforzare la cooperazione transfrontaliera e agevolare la
costituzione di un maggior numero di progetti transfrontalieri.
Assicurare inoltre che strategie macroregionali come quella danubiana e
del Baltico siano sostenute dai programmi nazionali e regionali.
9. Assicurare che la politica di coesione sia meglio correlata alla più
ampia governance economica dell'UE: i programmi dovranno essere
coerenti con i programmi di riforma nazionali e dovrebbero affrontare le
riforme pertinenti identificate nelle raccomandazioni per paese nel
contesto del semestre europeo. Se del caso la Commissione può
chiedere agli Stati membri, facendo leva sulla cosiddetta clausola di
"condizionalità macroeconomica", di modificare i programmi per
sostenere le principali riforme strutturali. In ultima istanza la
Commissione può sospendere l'erogazione dei finanziamenti se le
raccomandazioni economiche venissero violate ripetutamente e
gravemente.
10. Incoraggiare l'uso degli strumenti finanziari per dare alle PMI
maggiore sostegno e accesso al credito: i prestiti, le garanzie e il capitale
netto/di ventura riceveranno un sostegno dai fondi dell'UE sulla base di
regole comuni, allargando le possibilità del loro uso e erogando incentivi
(ad esempio, tassi di cofinanziamento più elevati). L'accento posto sui
prestiti piuttosto che sulle sovvenzioni dovrebbe migliorare la qualità dei
progetti e scoraggiare la dipendenza dalle sovvenzioni.
Proprio attraverso questo importante strumento d’investimento, che
porta in sé una cospicua dote finanziaria, l’Unione Europea realizzerà gli
obiettivi della strategia Europa 2020 e cioè: crescita e occupazione, lotta
4contro i cambiamenti climatici e riduzione della dipendenza energetica,
della povertà e dell’esclusione sociale. Questi investimenti verranno
incanalati soprattutto verso quattro settori:
Ricerca e innovazione;
Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC);
Potenziamento della competitività delle piccole e medie imprese
(PMI);
Sostegno a favore della transizione verso un’economia a basso
tenore di carbonio.
In virtù di questo allineamento con la Strategia Europa 2020 per una
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tutti i Fondi strutturali e di
investimento europei perseguono 11 obiettivi tematici che sono:
1. Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione;
2. Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, Nonché l'impiego e la qualità delle medesime;
3. Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore
agricolo e il settore della pesca e dell’acquacoltura;
4. Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di
carbonio in tutti i settori;
5. Promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la
prevenzione e la gestione dei rischi;
6. Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse
7. Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le
strozzature nelle principali infrastrutture di rete;
8. Promuovere l’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la
mobilità dei lavoratori;
9. Promuovere l’inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma
di discriminazione;
10. Investire nell’istruzione, formazione e formazione professionale, per
le competenze e l’apprendimento permanente;
11. Rafforzare la capacità delle amministrazioni pubbliche e degli
stakeholders e promuovere un’amministrazione pubblica efficiente,
Assistenza tecnica.
5(milioni di EUR - prezzi 2011)
Fonte: Regolamento (UE, EURATOM) n. 1311/2013, che stabilisce il quadro finanziario
STANZIAMENTI DI IMPEGNO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOT
1. Crescita intelligente ed inclusiva 60.283 61.725 62.771 64.238 65.528 67.214 69.004 450.763
1a: Competitività per la crescita e l'occupazione 15.605 16.321 16.726 17.693 18.490 19.700 21.079 125.614
1b: Coesione economica, sociale e territoriale 44.678 45.404 46.045 46.545 47.038 47.514 47.925 325.149
Quadro finanziario pluriennale (UE-28)
2. Crescita sostenibile: risorse naturali 55.883 55.060 54.261 53.448 52.466 51.503 50.558 373.179
di cui: spese connesse al mercato/pagamenti diretti 41.585 40.989 40.421 39.837 39.079 38.335 37.605 277.851
pluriennale per il periodo 2014/2020
3. Sicurezza e cittadinanza 2.053 2.075 2.154 2.232 2.312 2.391 2.469 15.686
4. Ruolo mondiale dell'Europa 7.854 8.083 8.281 8.375 8.553 8.764 8.794 58.704
5. Amministrazione 8.218 8.385 8.589 8.807 9.007 9.206 9.417 61.629
di cui: spesa amministrativa delle istituzioni 6.649 6.791 6.955 7.110 7.278 7.425 7.590 49.798
6. Compensazioni 27 0 0 0 0 0 0 27
TOTALE STANZIAMENTI DI IMPEGNO 134.318 135.328 136.056 137.100 137.866 139.078 140.242 959.988
in percentuale dell'RNL 1,03% 1,02% 10,,% 1,00% 0,99% 0,98% 0,98% 1,00%
TOTALE STANZIAMENTI DI PAGAMENTO 128.030 131.095 131.046 126.777 129.778 130.893 130.781 908.400
in percentuale dell'RNL 0,98% 0,98% 0,97% 0,92% 0,93% 0,93% 0,93% 0,91%
Margine disponibile 0,25% 0,25% 0,26% 0,31% 0,30% 0,30% 0,32% 0,28%
Massimale delle risorse proprie in percentuale dell'RNL 1,23% 1,23% 1,23% 1,23% 1,23% 1,23% 1,23% 1,23%
6Nuove regole:
Rispetto alla programmazione precedente, il periodo 2014-2020, la politica di
coesione è caratterizzata da due obiettivi:
Investimenti in Favore della Crescita e dell’Occupazione (IFCO), obiettivo
generale che trova applicazione su tutto il territorio dell’Unione, con
un’articolazione differenziata in relazione alle tre categorie di Regioni:
o regioni meno sviluppate (PIL < 75% della media UE-27)
o regioni in transizione (PIL dal 75% al 90% della media UE-27)
o regioni più sviluppate (PIL > 90% della media UE-27)
Come
funziona
Vengono, pertanto, inglobati gli obiettivi della programmazione 2007-2013
Convergenza e Competitività regionale e occupazione.
Cooperazione Territoriale Europea (CTE) rimane confermato e viene e
disposizioni specifiche in merito vengono stabilite dal Regolamento (UE)
1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo
regionale all’obiettivo di cooperazione territoriale europea.
Per facilitare, quindi, il processo di programmazione a livello di Stati membri e di
regioni, la Commissione ha istituito un quadro strategico comune (QSC). Come
definito dall’Allegato I del Regolamento generale, “al fine di massimizzare il
contributo dei fondi SIE alla strategia dell'Unione per la crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva, nonché la missione specifica di ciascun fondo SIE, compresa
7la coesione economica, sociale e territoriale, è necessario garantire che gli impegni
politici assunti nel contesto della strategia dell'Unione per la crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva siano sostenuti da investimenti tramite i fondi SIE e da altri
strumenti dell'Unione. Pertanto, il quadro strategico comune (QSC), a norma
dell'articolo 10 e in linea con le priorità e gli obiettivi definiti nei regolamenti
specifici di ciascun fondo, fornisce orientamenti strategici al fine di conseguire un
approccio di sviluppo integrato utilizzando i fondi SIE in coordinamento con altri
strumenti e politiche dell'Unione, in linea con gli obiettivi strategici e con gli
obiettivi principali della strategia dell'Unione per la crescita intelligente, sostenibile
e inclusiva e, ove appropriato, con le iniziative faro, tenendo conto delle principali
sfide a territoriali e degli specifici contesti nazionali, regionali e locali”.
In base al QSC, ogni Stato membro dovrebbe elaborare un accordo di partenariato
in collaborazione con i partner e in dialogo con la Commissione. L'accordo di
partenariato dovrebbe trasferire gli elementi contenuti nel QSC nel contesto
nazionale e stabilire solidi impegni per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione
attraverso la programmazione dei Fondi SIE. L'accordo di partenariato dovrebbe
definire le modalità per garantire l'allineamento con la strategia dell'Unione per
una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché con le missioni specifiche di
ciascun Fondo, conformemente ai rispettivi obiettivi in virtù del trattato, le
modalità per garantire un'efficace e efficiente attuazione dei Fondi SIE e le
disposizioni relative all'applicazione del principio di partenariato nonché di un
approccio integrato allo sviluppo territoriale.
Per quel che riguarda l’Italia la programmazione dei fondi ha avuto avvio in
dicembre 2012 con la pubblicazione del documento “Metodi e obiettivi per un uso
efficace dei fondi comunitari 2014-2020”, a cui le amministrazioni centrali e
regionali hanno fatto riferimento nella stesura dei rispettivi Programmi Operativi
Nazioanali (PON) e Regionali (POR). Successivamente, in base a tale documento, il
9 dicembre 2013 è stata presentata alla Commissione la prima bozza di accordo di
partenariato che recepisce gli esiti del confronto finalizzato ad individuare risultati
attesi e azioni per ciascun obiettivo tematico. Durante il periodo dicembre 2013 –
aprile 2014 i colloqui informali con la Commissione Europea sono proseguiti (e la
CE stessa ha fornito osservazioni) fino alla presentazione della versione finale
presentata il 22 aprile 2014.
L’Accordo di Partenariato, in linea con le indicazioni e i regolamenti, ha assunto
come obiettivi di riferimento gli 11 obiettivi tematici e, sebbene la salute non abbia
un obiettivo tematico dedicato, il tema salute può rientrare negli obiettivi sotto
descritti:
Ob. 2: il risultato atteso n. 2.2 prevede la digitalizzazione dei processi
amministrativi e la diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili della
PA offerti a cittadini e imprese. Questo risultato riguarda in special modo gli
interventi di innovazione tecnologica in sanità che possano garantire gli
standard di sicurezza e protezione dati anche razionalizzando i Data Center
Pubblici. Tra le azioni indicate vi sono la realizzazione di servizi di e-
Government interoperabili e integrati (joined-up services) e progettati con
cittadini e imprese, soluzioni di e-procurement riguardanti, in particolare, la
8sanità elettronica e la telemedicina.
Ob. 9:
o il risultato atteso 9.3 prevede l’aumento, il consolidamento o la
qualificazione dei servizi di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei
servizi di cura rivolti a persone con limitazione dell’autonomia e il
potenziamento della rete infrastrutturale e dell’offerta di servizi sanitari
e sociosanitari territoriali come implementazione dei buoni servizio,
formazione di assistenti familiari e registri di accreditamento, sostegno
e potenziamento della rete di servizi sociosanitari territoriali non
ospedalieri;
o il risultato atteso 9.5 prevede la riduzione della marginalità estrema e
interventi di inclusione delle persone senza dimora e delle popolazioni
Rom, Sinti e Camminanti, in coerenza con la strategia nazionale di
integrazione dei rom. Questa strategia nazionale di integrazione per
queste popolazioni è quindi una precondizione;
Ob. 11: questo obiettivo intende sostenere azioni che migliorino la qualità dei
servizi offerti dalla pubblica amministrazione, soprattutto per quel che riguarda
i servizi sociali e le politiche sociali e sanitarie.
Opportunità di finanziamento
Il regolamento (UE) 1299/2013 prevede che le risorse vengano ripartite, su tutto il
territorio europeo, come segue:
a) 74,05% (6.626.631.760 €) per la cooperazione transfrontaliera;
b) 20,36% (1.821.627.570 €) per la cooperazione transnazionale;
c) 05,59% (500.000.000 €) per la cooperazione interregionale.
L’obiettivo Cooperazione Territoriale Europea incoraggia i territori di diversi Stati
membri a cooperare mediante la realizzazione di progetti congiunti, lo scambio di
esperienze e la costruzione di reti.
Le componenti della CTE sono tre:
Regioni 1. La cooperazione transfrontaliera
ammissibili Tra i suoi obiettivi la cooperazione transfrontaliera ha quello di promuovere
un’occupazione sostenibile e di qualità, sostenere la mobilità dei lavoratori
mediante l’integrazione dei mercati del lavoro e promuovere l’inclusione sociale e
combattere la povertà.
I Programmi Operativi specifici dedicati in Italia alla cooperazione transfrontaliera
e le relative aree ammissibili sono:
ITALIA – FRANCIA MARITTIMO: Liguria (Genova, Imperia, La Spezia, Savona),
Regione Sardegna (Sassari, Nuoro, Cagliari, Oristano, Olbia-Tempio, Ogliastra,
Medio Campidano, Carbonia-Iglesias), Toscana (Massa-Carrara, Lucca, Livorno,
Grosseto;
ITALIA – FRANCIA ALCOTRA: Piemonte (Torino, Cuneo), Valle d’Aosta, Liguria
(Imperia);
ITALIA – SLOVENIA: Friuli Venezia Giulia (Pordenone, Udine, Gorizia, Trieste),
9Veneto (Venezia);
ITALIA – SVIZZERA: Valle d’Aosta, Lombardia (Verbano-Cusio-Ossola, Varese,
Como, Lecco, Sondrio), Piemonte (Biella, Vercelli, Novara), P. Autonoma di
Bolzano;
ITALIA – AUSTRIA: Provincia Autonoma di Bolzano, Friuli Venezia Giulia
(Pordenone, Udine, Gorizia, Trieste), Veneto (Vicenza, Belluno, Treviso;
ITALIA – CROAZIA: Friuli Venezia Giulia (Pordenone, Udine, Gorizia, Trieste),
Regione Veneto (Venezia, Rovigo, Padova), Emilia Romagna (Ferrara, Ravenna,
Forlì-Cesena, Rimini), Marche (Pesaro e Urbino, Ancona, Macerata, Ascoli
Piceno, Fermo), Abruzzo, (Teramo, Pescara, Chieti) Molise, (Campobasso)
Puglia (Brindisi, Lecce, Foggia, Bari, Barletta-Andria-Trani);
ITALIA – MALTA: Sicilia (Trapani, Palermo, Messina, Agrigento, Caltanissetta,
Enna, Catania, Ragusa, Siracusa);
GRECIA – ITALIA: Puglia (Bari, Brindisi, Lecce, Taranto, Foggia, Barletta Andria
Trani;
Cooperazione Transfrontaliera esterna:
ENI – MED: Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Puglia, Sardegna,
Sicilia, Toscana;
ENI ITALIA – TUNISIA : Sicilia;
IPA ITALIA – ALBANIA – MONTENEGRO: Puglia, Molise
2. La cooperazione transnazionale
La cooperazione transnazionale mira a rafforzare la capacità istituzionale delle
autorità pubbliche e delle parti interessate mediante lo sviluppo e il
coordinamento di strategie macroregionali e concernenti i bacini marittimi.
I Programmi operativi e le aree ammissibili sono:
ALPINE SPACE: Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige,
Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria;
CENTRAL EUROPE: Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Provincia
Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli- Venezia
Giulia, Emilia- Romagna;
MEDITERRANEO: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia- Romagna,
Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Umbria,
Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto, Valle d’Aosta;
ADRIATIC IONIAN: Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di
Trento, Friuli- Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Emilia- Romagna, Marche,
Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.
3. La cooperazione interregionale.
La cooperazione interregionale mira a rafforzare la capacità istituzionale delle
autorità pubbliche e delle parti interessate in ottica di: i) diffondere buone prassi e
competenze; ii) promuovere lo scambio di esperienze al fine di rafforzare
l’efficacia dei programmi di CTE; iii) rafforzare la base di conoscenze per
consolidare l’efficacia della politica di coesione e conseguire gli obiettivi tematici.
I Programmi Operativi che coinvolgeranno tutte le regioni dei 28 Stati Membri
10sono:
URBACT;
ESPON;
INTERACT;
INTERREG EUROPE.
www.europa.eu
http://www.dps.gov.it/it/politiche_e_attivita/programmazione_2014-
Link 2020/Cooperazione_territoriale_europea/Cooperazione_territoriale_europea.html
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_it.cfm
11Puoi anche leggere