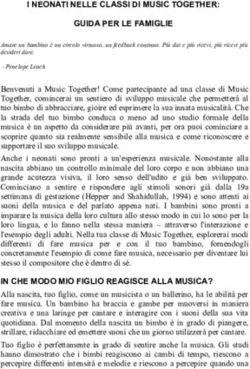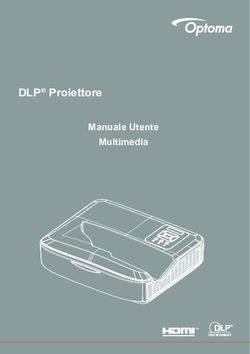La musica greca antica - Di Andrea Cuniolo (1 A Sc "Liceo G. Peano", Tortona)
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
1
La musica greca antica
Di Andrea Cuniolo (1°A Sc “Liceo G. Peano”, Tortona)
Prefazione
Nella storia della cultura occidentale, l'antichità greca ha rappresentato un concreto modello di classicità,
specialmente per l'architettura, la scultura, la filosofia e la letteratura, di cui ci sono rimaste molte
testimonianze. Diverso è stato per la musica, arte altrettanto importante e praticata nel mondo classico, ma
della quale ci sono rimasti solo pochi frammenti e di difficile interpretazione.
L'elemento di continuità tra il mondo della civiltà musicale ellenica e quella dell'Occidente europeo è
costituito principalmente dal sistema teorico greco, che fu assorbito dai romani e da essi fu trasmesso al
Medioevo cristiano. Il sistema diatonico, con le scale di sette suoni e gli intervalli di tono e di semitono, che
sono tuttora alla base del nostro linguaggio musicale e della nostra teoria, è l'erede e il continuatore del
sistema musicale greco. Altri aspetti comuni alla musica greca e ai canti della liturgia cristiana dei primi
secoli dopo Cristo furono il carattere rigorosamente monodico della musica e la sua stretta unione con le
parole del testo (primo contenuto multimediale: “Dies irae”, http://www.youtube.com/watch?
v=Dlr90NLDp-0 ).
I greci conferivano alla musica un potere sovrannaturale: un filosofo della civiltà classica, Aristosseno, diceva
che la musica può, a seconda dei casi:
- produrre un atto di volontà (energica),
- paralizzare la volontà stessa (snervante)
- provocare uno stato di ebbrezza (estasiante).
Platone ascrisse alla musica una potenza morale: essa deve influire sul carattere, informarlo al bene e
ispirare odio e ribrezzo per il male. Aristotele, d'accordo in genere con tali massime, riconobbe altresì nella
musica lo scopo di dilettare (negato però da Platone) e, dilettando, di nobilitare l'animo.
La musica ebbe pertanto un grande ruolo nelle religioni ellenistiche e misteriche come testimonia il mito di
Orfeo, che, come Omero, è non solo musicista ma anche poeta: ciò testimonia l’intimo legame tra musica e
poesia che, unite alla danza, si fusero nella struttura della tragedia. Noi conosciamo gli strumenti musicali
greci attraverso le rappresentazioni pittoriche che ci sono pervenute, ad esempio sui vasi (figura 1). I due
strumenti principali erano l’aulos, uno strumento a fiato e il tetracordo, uno strumento a quattro corde che
furono in seguito portate a sette da Terprando.
I greci capirono le connessioni tra la musica, la matematica e il movimento degli astri. Pitagora, accostando
la musica al movimento dei pianeti, capì che anch'essa era governata da precise leggi matematiche; portò la
sua intuizione sul monocordo e scoprì che se una corda produceva un suono di una certa altezza, per
ottenere un suono all'ottava superiore bisognava far vibrare metà della corda; per ottenere la quinta
bastava far vibrare i due terzi della corda, e via di seguito: questo schema complicato è stato ben
rappresentato e spiegato da un cartone animato di Walt Disney: “Paperino e il mondo della
MateMagica”(secondo contenuto multimediale: http://www.youtube.com/watch?v=2oyUCQhD2BM).
La musica greca antica, di Andrea Cuniolo, 1°A Scientifico, Liceo “G. Peano”, Tortona2
Figura 1: musici e satiri mentre suonano, figura di un vaso di terracotta dell’età classica.
La tragedia e la musica
Il nome “Tragedia” deriva dal termine greco Tragòs (caprone) e aveva in principio un carattere religioso
poiché derivava da un rituale in cui il sacerdote sacrificava un caprone sull’altare del dio Dioniso e cantava
vicende umane con finali drammatici. Secondo Aristotele, questo racconto cantato veniva chiamato
ditirambo e, col passare del tempo, perse ogni rapporto con il dio ellenico del vino e dell’ebrezza e il suo
culto e mutò in dialogo continuo cantato tra il protagonista e il coro. Dal “De Musica” di Aristide Quintiliano
sappiamo che il tropos (stile) tragico operava su un registro grave, a differenza dei tropoi ditirambici, di
registro medio, e nomico, di registro acuto. Per l’estensione che ricoprivano, i canti tragici potevano essere
destinati a un coro di non professionisti composto da uomini adulti, mentre i canti ditirambici potevano
essere eseguiti anche da un coro di ragazzi; lo stile citarodico invece pretendeva l’abilità propria di un
cantante solista. Infine, la tragedia assunse quello che poi è il suo carattere moderno di recitazione di
vicende umane drammatiche, completamente slegata dai riti religiosi. La perdita delle musiche originarie ha
fatto sì che illustri compositori dal Rinascimento a oggi abbiano sfruttato l’affascinante opportunità
d’inventare musiche sempre nuove sui testi dei drammi antichi: questa è la base del melodramma.
Il tempo della tragedia è un presente assoluto, "hic et nunc" che agisce in quella “realtà alternativa” che è il
momento teatrale. Lo spettatore vive una realtà che differisce da quella che sperimenta quotidianamente,
ma che è altrettanto reale. L'atto teatrale, che accade in un tempo presente contemporaneo a quello di chi
assiste, rende possibile qualsiasi evento imprevisto, esattamente come il presente dell’esperienza
quotidiana, pur rifacendosi ai miti che in quanto tali sono eventi passati e immutabili. L'eroe tragico,
impersonato dall'attore, non perde la sua facoltà di autodeterminazione: i testi tragici sottolineano la
volontà dell'uomo come elemento determinante, mettendolo a confronto con una alternativa, nella quale
egli può ancora scegliere. La contraddizione, all'interno dell'illusione teatrale, è tra il presente scenico e il
passato del mito, nel quale la scelta è già stata fatta. Nella tragedia prende forma il paradosso della
coesistenza di due diversi universi temporali. Il percorso obbligato del mito costituisce il destino dell'eroe
tragico, iniziando la riflessione umana sul contrasto tra necessità e libertà, riflessione con la quale anche il
mondo contemporaneo continua a confrontarsi. Mentre per Eschilo la tragedia è incentrata sulla giustizia
divina, sul rapporto dell'uomo e dell'intera stirpe umana con le divinità, per Sofocle gli dei sono potenti ma
lontani e la tragedia rappresenta il dolore e l'infelicità dell'uomo che non accetta mai compromessi. Euripide
si distingue dagli altri due grandi autori perché mette in evidenza il ruolo dell'irrazionale, della passione e
dei sentimenti, tralasciando in buona parte gli eventi mitici e soprannaturali.
Ai tempi di Pisistrato e ancor di più di Pericle il sorgere e lo svilupparsi della tragedia nazionale
rappresentano l'epoca del maggior fiorire della musica greca. I cori sono parti molto importanti della
tragedia greca, sebbene il loro ruolo sia massimo in Eschilo, minore in Sofocle e in Euripide. Che i cori
venissero cantati è ormai cosa certa, e sembra pure sicuro che la musica fosse scritta dai poeti tragici o
almeno da loro designata, togliendola da canzoni popolari note, che si adattavano alla situazione e ai
sentimenti espressi nelle loro tragedie. I cori consistevano in tre parti: strofa, antistrofa, ed epodo; le prime
due erano cantate dai cori separati che si univano nell'epodo.
La musica greca antica, di Andrea Cuniolo, 1°A Scientifico, Liceo “G. Peano”, Tortona3
La commedia
Una commedia è un componimento teatrale o un'opera cinematografica dalle tematiche leggere o atto a
suscitare il riso, di solito a lieto fine. Il termine ha assunto nei secoli varie sfumature di significato, spesso
allontanandosi di molto dal carattere della comicità. La commedia, nella sua forma scritta, ha origine in
Grecia nel VI secolo a.C.
La parola greca κωμoδία, "comodìa", composta di κwμος, "còmos", corteo festivo e ᾠδή, "odè", canto,
indica come questa forma di drammaturgia sia lo sviluppo in una forma compiuta delle antiche feste
propiziatorie in onore delle divinità elleniche, con probabile riferimento ai culti dionisiaci. Peraltro, anche i
primi ludi scenici romani furono istituiti, secondo Tito Livio, per scongiurare una pestilenza invocando il
favore degli dèi.
La commedia assunse una struttura autonoma durante le feste e le fallofòrie dionisiache e aveva un
carattere satirico e politico. La prima gara teatrale fra autori comici si svolse ad Atene nel 486 a.C. In altre
città si erano sviluppate forme di spettacolo burlesche come le farse di Megara, composte di danze e
scherzi, e simili spettacoli si svolgevano alla corte del tiranno Gerone in Sicilia, di cui non ci sono pervenuti i
testi.
La struttura della commedia greca è costituita dai seguenti elementi: prologo, parodo (cioè l'ingresso nel
coro) agone (introduzione del fulcro) della narrazione parabasi ed esodo.
Come nella tragedia, la commedia prevedeva il coro come parte musicale importante della sua
struttura. L’elemento lirico-musicale, però, importante in Aristofane proprio per la presenza del coro,
si ridusse progressivamente nelle epoche successive: i canti corali - che erano nella commedia antica
le parti più impegnate ideologicamente, più esplicitamente e scopertamente politiche - si
trasformano in semplici intermezzi (o interludi) fra un atto e l'altro, puri riempitivi senza rapporto
con l'azione scenica (tanto che il testo dei canti corali non viene neppure riportato dai papiri che
conservano le commedie menandree).
Musica e mito
Nella mitologia greca vi erano ben due muse dedicate alla musica (figura 2): Euterpe proteggeva la musica
lirica e aveva un flauto in mano, Melpomene era la musa della tragedia, portava una maschera tragica, la
clava di Ercole e una spada, la sua testa era decorata di pampini e calzava i coturni.
Figura 2: Apollo e le Muse
La musica è argomento anche di molti miti che trattano la nascita degli strumenti musicali. Ad esempio una
celebre statua di Mirone narra il mito dell’invenzione del flauto (figura 3): Atena creò lo strumento ma dopo
aver notato che mentre lo suonava le si deformava il volto lo gettò a terra. Lo raccolse un satiro di nome
Marsia che si esibì nell’agorà e si vantò di essere il più grande musico di sempre, anche migliore del dio
Apollo e della sua cetra. Infatti, sfidò quest’ultimo in un concorso musicale in cui il vincitore avrebbe fatto
dell’avversario ciò che voleva. In un primo momento sembrò prevalere Marsia ma Apollo lo sfidò a suonare
il proprio strumento al contrario: il dio riuscì a suonare la cetra capovolta, Marsia con il suo flauto emise
solo fiato senza alcun suono. Così Apollo venne proclamato vincitore e scorticò il satiro.
La musica greca antica, di Andrea Cuniolo, 1°A Scientifico, Liceo “G. Peano”, Tortona4
Figura3: Atena e Marsia, copia romana di originale greco di circa il 450 a.C. ad opera di Mirone
Un altro esempio di mito eziologico è quello di Siringa, riportato da Ovidio nelle “Metamorfosi”. Siringa era
una naiade, oggetto delle attenzioni di Pan, il dio dell’Arcadia, protettore dei pastori e delle greggi nonché
musico eccellente. Siringa non volle sottostare alle sue brame amorose e cercò di sfuggirgli; giunta sulle rive
del fiume Ladone e non avendo ormai scampo, si trasformò in una canna palustre. Mentre Pan sospirava
disperato l’amata perduta presso il fiume, udì un suono leggero e dolce provenire dalle canne; riunì insieme
alcuni giunchi e creò la siringa, dalla dolce e languida melodia a ricordare un amore incompiuto (figura 4).
Figura 4: la siringa (flauto) di Pan
Diverso e senza alcun intervento soprannaturale è il mito della nascita della lira (figura 5): Hermes
(Mercurio), da giovinetto, intrattenendosi a colloquio con una tartaruga, privò crudelmente l’animale della
sua casa trasformandola in uno strumento musicale dal suono celeste, che infine donò ad Apollo per farsi
perdonare di avergli sottratto una mandria di buoi. La lira divenne poi l’attributo di Orfeo, che in alcune
versioni del mito è figlio di Apollo.
La musica greca antica, di Andrea Cuniolo, 1°A Scientifico, Liceo “G. Peano”, Tortona5
Figura 5: la lira di Apollo: in questa immagine si può notare il guscio della tartaruga
Orfeo è il musicista e il poeta per eccellenza dell’antichità greca; il suo mito ha svolto un grande ruolo nella
religione ellenistica e nei culti orfici, che proprio da lui prendono il nome. La musica ha nel mito di Orfeo il
carattere estasiante descritto da Aristosseno. Orfeo vaga con la sua lira, regalatagli da Apollo e la sua
musica incanta non solo sugli uomini ma tutta la natura: gli animali lo seguono incantati, sospendendo la
loro ferocia e le loro lotte, e persino gli alberi e i sassi si muovono per ascoltarlo. Lo spirito apollineo
dell’armonia viene a contatto con lo spirito dionisiaco delle passioni e delle emozioni legate alla vita e alla
morte. La musica rasserena e consente di travalicare le emozioni che contrastano la coscienza. Orfeo, per la
sua musica e la sua poesia, rinuncia alla vita, venendo fatto a pezzi e divorato dalle baccanti (il famoso
sparagmòs), mentre la sua lira, immortale, viene portata in cielo tra le costellazioni. La testa di Orfeo finì nel
fiume Ebro, dove continuò prodigiosamente a cantare il nome della sua amata, simbolo dell'immortalità
dell'arte, scendendo fino al mare e da qui alle rive di Metimna, presso l'isola di Lesbo, dove Febo Apollo la
protesse da un serpente che le si era avventato contro. Secondo altre versioni, i resti del cantore sarebbero
stati seppelliti dalle impietosite Muse nella città di Libetra.
Musica e poesia
Due opere monumentali del V secolo a.C. sono i due inni delfici, scoperti nel 1893 fra le rovine della prima
sede del tesoro della lega di Delo a Delfi. Il primo è incompleto, mentre il secondo è una composizione in
otto parti di lunghezza diversa. Il poeta greco usava nuclei melodici preesistenti detti nomoi, osservati nel
patrimonio culturale ellenistico. Essi dovevano costituire una specie di serbatoio melodico che il musico poi
elaborava nelle proprie composizioni. Una melodia malinconica era l’epitaffio di Sicilo (figura 6; terzo
contenuto multimediale: http://www.youtube.com/watch?v=ThwqvrTg4MQ), scoperto in Asia Minore
(Turchia) nel 1883 su due versi “Fino a quando vivi, splendi: Niente ti affligga troppo! La vita dura un
attimo.”
La musica greca antica, di Andrea Cuniolo, 1°A Scientifico, Liceo “G. Peano”, Tortona6
Figura 6: Epitaffio di Sicilo
Per quanto riguarda invece la musica sacra, le forme della lirica corale furono: il peana in onore di Apollo, il
ditirambo in onore di Dioniso, l'imeneo, canto di nozze, il threnos, canto funebre, il partenio, canto di
fanciulle, gli inni in onore degli dei e degli uomini e gli epinici in onore dei vincitori dei giochi panellenici.
Nella lirica corale si realizza pienamente l'unione delle tre arti della Mousikè, perché alla poesia si aggiunge
la danza (il coro si muoveva coreograficamente durante l'esecuzione dei canti corali).Il ritmo di questi canti
era lo stesso della poesia. Il coro greco cantava all'unisono, utilizzando il procedimento dell'eterofonia:
veniva cantata un'unica melodia, ma ad altezze diverse.
Fini della musica in Grecia: Atene e Sparta
Oltre alla formazione culturale e fisica, nei Ginnasi (ovvero le scuole Ateniesi) l’insegnamento della musica
era obbligatorio. Il perfetto uomo greco doveva essere fisicamente prestante, intelligente e anche buon
musico. Infatti, la musica era intesa come uno strumento per elevare la spiritualità del singolo individuo.
Anche a Sparta lo studio musicale aveva uno scopo educativo ma veniva insegnata per inculcare lo spirito di
gruppo: l’insegnante impostava il tempo e sceglieva i brani da cantare, i discepoli dovevano seguire
ordinatamente tutti insieme, mentre era proibito il canto solista. Anche in questo si riconosce il carattere
“militaresco” e collegiale della civiltà spartana.
Musica greca nell’età moderna
Dalla fine del medioevo fino alla seconda metà del XVI secolo la monodia (cioè una composizione per una
voce solista avente una sola linea melodica) venne poco a poco abbandonata lasciando spazio alla polifonia
(stile compositivo che combina due o più voci). Quest’ultima aumentò il numero di voci e suoni fino a
rendere inintelligibile il brano o il canto. Lo stile musicale greco venne riscoperto all’inizio del XVII secolo
grazie al musicista e compositore Vincenzo Galilei (padre di Galileo Galilei), che riaffermò la monodia e
influenzò parecchi compositori celeberrimi come Bach e Haendel che, oltre a comporre musiche
polifoniche, elaborarono anche pezzi per strumenti non accompagnati. Più tardi, nel periodo classico, il
compositore tedesco Christoph Willibald Gluck compose un’opera basata sul mito di Orfeo. Nel pezzo più
famoso dell’opera, “La Danza Degli Spiriti Beati” emerge il suono del flauto per ricordare le antiche origini
della musica greca classica (quarto contenuto multimediale: http://www.youtube.com/watch?
v=BGkOf64pJ5s; di questo brano esiste anche un arrangiamento di Rachmaninoff: quinto contenuto
multimediale: http://www.youtube.com/watch?v=sg7NgxL1EGg). Sempre influenzato dal mito Orfico è il
melodramma satirico “Orfeo all’inferno” di Jacques Offenbach, che nasce come una parodia dell’opera
Gluckiana: il pezzo più famoso è il Can can finale (sesto contenuto multimediale:
http://www.youtube.com/watch?v=bLqMcN53QLA).
La musica greca antica, di Andrea Cuniolo, 1°A Scientifico, Liceo “G. Peano”, Tortona7
Contenuti multimediali
1) Canto gregoriano “Dies Irae”: http://www.youtube.com/watch?v=Dlr90NLDp-0
2) Walt Disney: “Paperino nel mondo della MateMagica”: http://www.youtube.com/watch?
v=2oyUCQhD2BM
3) Epitaffio di Sicilo: http://www.youtube.com/watch?v=ThwqvrTg4MQ
4) Christoph Willibald Gluck , da “Orfeo ed Euridice” : Danza degli Spiriti Beati:
http://www.youtube.com/watch?v=BGkOf64pJ5s
5) S. V. Rachmaninov , arrangiamento per pianoforte della Danza degli Spiriti beati:
http://www.youtube.com/watch?v=sg7NgxL1EGg
6) Jacques Offenbach, da “Orfeo all’Inferno”: Can can finale: http://www.youtube.com/watch?
v=bLqMcN53QLA
Fonti
- Lezioni di musica della Prof.ssa Ravazzi
- “La cultura greca” di Bruno Snell
- http://storie.rgpsoft.it
- http://operaomniablog.blogspot.it
Ringraziamenti
Si ringrazia calorosamente la Prof.ssa Daniela Bergomi dell’istituto “Giuseppe Peano” di Tortona per l’incoraggiamento a svolgere
questo approfondimento, e la Prof.ssa Stefanella Ravazzi dell’istituto “Luca Valenziano” per l’entusiasmo che sa trasmettere
nell’insegnare la storia della musica.
La musica greca antica, di Andrea Cuniolo, 1°A Scientifico, Liceo “G. Peano”, TortonaPuoi anche leggere