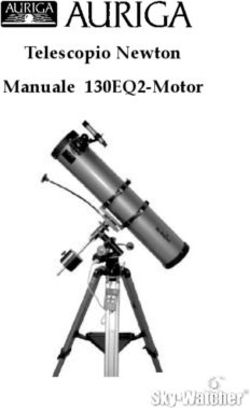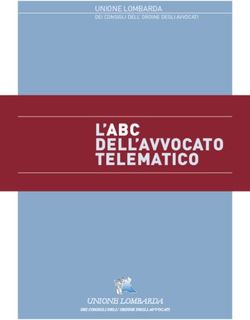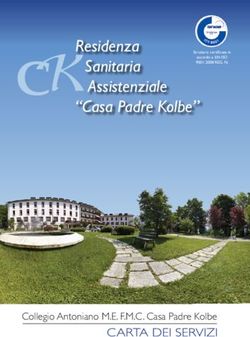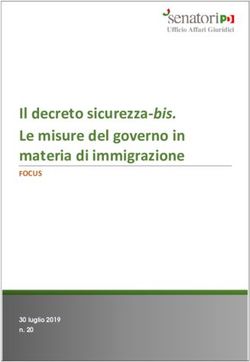La comunicazione non verbale in contesti face to face
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Anno Accademico 2004 – 2005
Facoltà Psicologia
Corso di laurea Scienze e Tecniche Psicologiche
3° anno - Comunicazione e processi cognitivi
La comunicazione
non verbale
in contesti
face to face
Dott. Federica Biassoni
Elaborato finale a cura di
Silvia Carne
Matricola n° 3104493LA COMUNICAZIONE NON VERBALE IN CONTESTI FACE TO FACE
Introduzione, obiettivi formativi dell’EPT ed aspettative personali
Il curriculum di psicologia della comunicazione e dei processi cognitivi di quest’anno prevede
al suo interno due percorsi formativi di carattere più pratico denominati E.P.T. (esperienza
pratica di tirocinio) da svolgersi nel primo e nel secondo semestre. Ognuno di questi due EPT
si struttura tre parti fondamentali: delle 150 ore destinate a questa attività, infatti, cinquanta si
considerano da svolgere all’interno di un contesto prettamente scolastico, ovvero in incontri di
gruppo guidati da un tutor, cinquanta prevedono esperienze prettamente pratiche, ovvero
interazioni od osservazioni all’interno di enti convenzionati con l’ateneo e infine cinquanta
ore di lavoro personale o di gruppo senza la presenza della tutor.
Nel secondo semestre abbiamo intrapreso lo studio della psicologia della comunicazione ed il
prof. Riva Giuseppe ha deciso di affiancare al corso in aula due esperienze pratiche con
tematiche molto diverse tra loro, sebbene ugualmente interessanti: la comunicazione non
verbale (CNV) in contesti face to face e la formazione a distanza (FAD). Nella condizione di
dover scegliere ho optato per la CNV in contesti face to face, seguendo un interesse personale
particolarmente spiccato.
Secondo il mio punto di vista, questo l’EPT CNV in contesti face to face aveva tre obiettivi
principali: innanzitutto fornire alle nostre idee confuse e poco chiare sulla comunicazione non
verbale e in particolare sulla mimica facciale una base teorica, che avesse però un forte taglio
pratico, cioè che fosse un vero e proprio strumento per “agire” sulle situazioni in cui ci
saremmo trovati; secondariamente il percorso progettato in questo EPT voleva renderci più
coscienti della quantità di informazioni che la CNV può fornirci e voleva ancor di più
consapevoli di quanto noi stessi trasmettessimo agli altri tramite la CNV nel momento in cui
entriamo in relazione con qualcuno. A questo proposito ci è sempre stata richiesta una duplice
attenzione, di “puntare un occhio su ciò che accade all’interno di noi e ciò che noi
comunichiamo e ciò che accade al nostro esterno, cioè cosa ci comunicano gli altri”.
Infine, questo EPT ha voluto di certo darci la possibilità di sperimentare ciò che abbiamo
imparato e non solo: abbiamo compreso a fondo il ruolo dello psicologo – e più in specifico di
psicologo della comunicazione – all’interno di settori molto diversi , valutandone criticità e
punti di forza. Questo confronto con la realtà lavorativa ci ha permesso di raffrontarci non
solo con le nostre aspettative personali ma anche con le nostre qualità e capacità.
Le attività nei servizi proposte sono state valutate da ognuno dei partecipanti al corso e
rispetto alle stesse abbiamo espresso una preferenza che è stata nella maggior parte dei casi
rispettata. La dott. Biassoni, ovvero la tutor che ci ha seguito e sostenuto in questo percorso
formativo, ci ha fornito un’ampia gamma di scelte sia nell’area della psicologia del lavoro e
2LA COMUNICAZIONE NON VERBALE IN CONTESTI FACE TO FACE
delle risorse umane (enti che si occupassero di inserimento e formazione lavorativi per
soggetti disabili, di selezione e formazione del personale lavorativo), sia nell’area della
psicologia dell’infanzia (enti che si occupassero dell’educazione in età prescolare, della
formazione di personale che lavorasse con i bambini), sia dell’area forse più classica della
psicologia, ovvero l’area clinica e della terapia (enti che offrissero sostegno psicologico e
terapia psicologica a soggetti portatori di disagi psicologici più o meno gravi).
Quanto alle mie aspettative personali, avevo idee poco chiare dell’argomento e ho trovato
molto interessante questo corso, tanto da sceglierlo subito non appena compreso di cosa si
trattasse.
Devo dire che mi aspettavo molta più teoria e molta meno pratica, non perché avrei preferito
fosse così, anzi, ma perché fino ad ora le nostre esperienze pratiche di tirocinio erano state
piuttosto deludenti in quanto si riservava sempre molto spazio alle basi teoriche senza fare il
passo successivo, ovvero imparare ad applicare queste conoscenze alla vita professionale, o
comunque senza avere la possibilità di sperimentare quanto appreso.
Concludendo posso ampiamente affermare che le mie aspettative personali sono state
ampiamente soddisfatte e anche superate.
Attività in aula: attivazione e contributo teorico
Gli incontri in aula hanno avuto come elemento chiave e portate la condivisione di pensieri e
vissuti all’interno del gruppo, oltre che un approfondimento graduale delle conoscenze tra i
vari partecipanti. La Dott. Biassoni ha sviluppato il percorso formativo offrendo momenti
molto diversi tra loro, in base anche alle diverse finalità che questi spazi avevano tra loro.
Ad una parte teorica in cui siamo stati introdotti agli studi sul FACS (Facial Action Coding
System) sono seguite interessanti e gradevoli esercitazioni in cui abbiamo cercato di simulare
le diverse AU e tramite uno specchio abbiamo osservato come i nostri muscoli facciali si
muovano nelle diverse configurazioni facciali. Inoltre, durante i primi incontri passavamo
molto tempo a osservare i nostri compagni mentre interpretavano le diverse AU.
Spesso ci sono stati proposti esercizi volti proprio a sensibilizzare la nostra attenzione nel
momento in cui osserviamo: dovevamo, per esempio, capire quale stato d’animo un nostro
compagno stesse mimando o quale intenzione comunicativa avesse.
Oltre a questi due tipi di attività, siamo stati spesso coinvolti in role playing e simulazioni in
laboratorio. I role playing non solo ci hanno divertito moltissimo ma hanno anche permesso la
partecipazione di tutti. Infatti ognuno di noi si è trovato nella condizione di coprire un ruolo e
3LA COMUNICAZIONE NON VERBALE IN CONTESTI FACE TO FACE
di osservare una simulazione. I role playing vertevano sempre sull’interpretazione di
personaggi che rappresentassero “caricature” dei personaggi reali, come ad esempio il critico,
lo scettico, l’entusiasta, oppure definissero ruoli professionali – lo psicologo del lavoro,
piuttosto che lo psicologo scolastico ecc.
Altro momento importante di ogni lezione è stata la compilazione del “bagaglio a mano”,
ovvero la stesura di un breve riassunto e commento al termine di ogni lezione al fine di avere
una sorta di traccia temporale del lavoro fatto e di fornire alla dott. Biassoni una sorta di
restituzione verbale di quanto fatto.
Il FACS: che cosa ho scoperto
Diversamente da quanto credevo, il FACS è uno strumento che fornisce la possibilità di
analizzare le modificazioni facciali delle diverse configurazioni ma non ne decreta il
significato, né pretende di inferire stati d’animo o emozioni vissute. Prima di approfondire
questo tema ritenevo infatti che il FACS assegnasse determinati significati alle diverse AU,
sebbene intuivo la possibilità che questi significati fossero molto generali e flessibili.
In realtà il FACS nasce dagli studi di Ekman e Friesen negli anni 70 (il primo manuale risale
al 1978) a partire da un’analisi anatomica di come la contrazione di ogni muscolo facciale e
della combinazione di muscoli facciali determinino dei cambiamenti nella configurazione
facciale. Essi associarono quindi i cambiamenti nell’aspetto osservabile del volto con l’azione
dei diversi muscoli.
Ekman e Friesen lavorarono allo scopo di creare uno strumento affidabile per categorizzare i
comportamenti facciali.
Stabilirono quindi l’esistenza di 44 action units (AU), costruendo una scala che ne definisse 5
livelli di intensità e il timing. Questo ultimo aspetto, ovvero la misurazione del tempo, mi ha
molto colpito, in quanto presuppone l’esistenza di un inizio e di una fine di ogni AU.
Come già detto questi strumenti sono da considerare come puramente descrittivi: non sono in
grado di fornire il significato di un determinato comportamento facciale.
I punteggi “grezzi” ottenuti applicando il FACS possono poi essere tradotti in dati dotati di
significato a livello psicologico attraverso tecniche diverse, come ad esempio FACSAID, un
sistema di interpretazione dei dati ottenuti grazie al FACS. A questo proposito è importante
sottolineare che l’interpretazione dei dati può essere considerata attendibile se confrontata con
altre informazioni provenienti da canali diversi rispetto alla comunicazione non verbale come
ad esempio la comunicazione verbale o la postura, ecc.
4LA COMUNICAZIONE NON VERBALE IN CONTESTI FACE TO FACE
Possiamo quindi affermare che gli studi che misurano le azioni facciali e poi si servono di
questionari self-report o di metodi di osservazione-attribuzione hanno dimostrato che le
espressioni facciali permettono di distinguere le emozioni piacevoli dalle emozioni spiacevoli,
ma non ulteriormente all’interno delle due categorie e forniscono informazioni accurate
sull’intensità dell’emozione.
Per quanto riguarda le AU ci siamo occupati di studiare e simulare le configurazioni della
parte superiore del viso e quelli della parte inferiore.
Rispetto alla parte superiore del viso, che coinvolge la zona della fronte, degli occhi e del
naso, abbiamo cercato di simulare diverse unità d’azione:
9 AU4 - abbassare le sopracciglia, ricorda un po’ l’espressione di chi non capisce
qualcosa
9 AU1 - sollevare le sopracciglia nella parte interna
9 AU2 - riguarda la parte esterna delle sopracciglia, quando viene sollevata
9 AU5 -sgranare gli occhi tramite il sollevamento della palpebra superiore
9 AU6 – strizzare lo sguardo tramite il sollevamento delle guance
9 AU7 – coinvolge la palpebra inferiore, contribuendo ad assottigliare l’apertura oculare
9 AU41 42 43 - riguardano ancora le palpebre ( abbassamento della palpebra superiore,
apertura oculare molto sottile, occhi chiusi e palpebre rilassate)
9 AU44 45 46 - riguardano i movimenti delle palpebre ( strizzare gli occhi, sbattere le
palpebre, ammiccare).
Nella tabella 1 (pag. 6) riporto alcune delle nostre simulazioni di AU della parte superiore del
viso svolte in aula.
Rispetto alla parte inferiore del viso, cioè rispetto alla zona del naso, della bocca e del mento
abbiamo studiato e simulato le seguenti AU:
9 AU9 - corrugare il naso
9 AU10 – alzare il labbro superiore
9 AU17 – alzare il mento, la bocca assume la forma di parentesi capovolta
9 AU15 – abbassare gli angoli della bocca
9 AU25 26 27 – coinvolge le labbra (aprire di poco le labbra, abbassare la mandibola,
sbadigliare)
9 AU16 - abbassare il labbro inferiore
9 AU20 – tirare il labbro
9 AU12 – fossette - stringe gli angoli della bocca tirandoli verso l’interno e restringendo
gli angoli del labbro.
5LA COMUNICAZIONE NON VERBALE IN CONTESTI FACE TO FACE
Nella tabella 2 (pag. 7) riporto alcune delle nostre simulazioni di AU della parte inferiore del
viso svolte in aula.
AU 4: porzione interna e/o centrale del sopracciglio abbassata leggermente,
diminuendo o riducendo la visibilità della porzione mediale della piega
palpebrale. Sopracciglia leggermente avvicinate; se non si vede il movimento si
deve vedere almeno una ruga oppure un rigonfiamento muscolare tra le
sopracciglia. Se una ruga od un rigonfiamento muscolare sono permanenti (nel
viso neutrale), devono aumentare leggermente.
AU 41: la palpebra superiore si abbassa riducendo l’apertura oculare (palpebra
rilassata come quando si è assonnati), la palpebra superiore è maggiormente
esposta rispetto al solito.
AU 42: l’apertura oculare è molto sottile; le palpebre
(soprattutto quelle inferiori) sono rilassate.
AU 43: gli occhi sono chiusi, non mostrano segni di tensione, pressione né
stiramento. Presenta 5 gradi di intensità.
AU 2 (unilaterale): Solleva la parte esterna della sopracciglia, che assumono
così una forma arcuata più sollevata nella parte laterale esterna. La parte laterale
della palpebra superiore è tirata verso l’alto.
AU5: Amplia l’apertura dell’occhio. Solleva la palpebra superiore in modo da
nasconderne buona parte. Come risultato di tale sollevamento della palpebra
superiore, una porzione maggiore di bulbo oculare è resa visibile: l’intera iride e
parte della sclera superiore a questa sono visibili. La persona sembrerà sgranare
gli occhi, come se il bulbo oculare sporgesse.
Tabella 1
6LA COMUNICAZIONE NON VERBALE IN CONTESTI FACE TO FACE
AU 15: Spinge gli angoli delle labbra verso il basso. Le labbra appaiono tese,
assottigliate e tirate verso il basso. Appaiono piccole rughe ai lati della bocca; può
appiattire o provocare rigonfiamenti sul mento.
AU 17: Innalza il mento e spinge il labbro inferiore verso l’alto.
Può causare la comparsa di rughe sul mento perché la pelle viene stirata e una
depressione sulla parte mediale inferiore dello stesso. La bocca assume la forma di
parentesi capovolta.
Se l’azione è forte il labbro inferiore può protendersi verso l’esterno.
AU 16: Il labbro inferiore è tirato verso il basso e appare come stirato
lateralmente.
Le labbra si dividono ed è possibile vedere le gengive ed i denti (anche le radici
dei denti) dell’arcata inferiore.
AU 20: Tira le labbra indietro lateralmente orizzontalmente.
Allunga la bocca; le labbra sono appiattite e stirate lateralmente.
Tira la porzione inferiore del solco nasolabiale e stira lateralmente la pelle sopra la
protuberanza del mento; il mento potrebbe apparire appiattito e/o corrugato.
Potrebbero stirarsi le narici.
AU 25: le labbra si separano esponendo maggiormente la mucosa labiale interna;
denti, gengive e la cavità orale possono essere visibili. I denti sono uniti.
Solleva il labbro superiore. La parte centrale del labbro superiore è tirato verso
l’alto, le parti laterali meno. Il labbro assume una forma trapezoidale.
Il triangolo infraorbitale è spinto il alto, si ispessisce il solco nasolabiale, si
ispessisce e si innalza l’ala nasale.
Se l’azione è forte le labbra si spalancano.
Tabella 2
7LA COMUNICAZIONE NON VERBALE IN CONTESTI FACE TO FACE
Simulazioni in laboratorio
Credo che le simulazioni in laboratorio siano state una delle parti più importanti di questo
EPT, oltre che una delle più interessanti. In quanto studenti ansiosi di sperimentare ci
aspettavamo da tempo ormai un corso che ci permettesse di “fare” e non solo di apprendere
imparando. Ritengo, infatti, che questo EPT più degli altri ci abbia permesso di applicare ciò
che ci veniva spiegato durante le lezioni.
Le prime osservazioni in laboratorio sono state davvero entusiasmanti: devo dire che mi
sentivo affascinata dagli schermi e dalla miriade di tasti, oltre che dalla possibilità di
osservare qualcuno in modo così analitico e allo stesso tempo privato, indiscreto forse.
Lavorare con strumenti come le telecamere e le videoregistrazioni consente una osservazione
più dettagliata e di concentrarsi maggiormente sui singoli soggetti, eliminando stimoli
disturbanti e ponendo attenzione, per esempio, alla mimica facciale piuttosto che alla postura
del soggetto. Inoltre aver la possibilità di rivedere delle registrazioni permette di cogliere
particolari e sfumature che possono essere sfuggite durante la prima osservazione.
Le prime simulazioni sono state le più complicate poiché qualcuno si sentiva a disagio e
imbarazzato all’idea di essere ripreso ma soprattutto all’idea di essere osservato
scrupolosamente. Inizialmente l’osservazione era uno strumento piuttosto difficile da
utilizzare in quanto trovavamo complicato mettere da parte le nostre impressioni e le nostre
inferenze riguardo a un comportamento per passare a un osservazione più oggettiva delle
variazioni di prossemica, postura e mimica facciale. Con l’esercizio questa pratica è diventata
più semplice e immediata e abbiamo lentamente compreso il meccanismo inferenziale che sta
alla base di molte delle nostre prime impressioni. Così, incontro dopo incontro, l’osservazione
diveniva un processo più semplice e immediato e riuscivamo a prestare attenzione a verbale e
non verbale.
Personalmente ho partecipato a due role playing molto diversi tra loro ma che mi hanno allo
stesso modo colpita e divertita.
Il primo role playing è stato svolto con un collega di corso il quale interpretava il ruolo di uno
psicologo che collabora con una scuola e interviene richiedendo un colloquio con i genitori di
un allievo, ragazzo scontroso e aggressivo, che aveva di recente insultato una sua docente. Il
mio ruolo era quello della madre del figlio. In questa situazione ho cercato di interpretare il
personaggio di una madre che adora alla follia il figlio, tanto da non voler vedere le sue
criticità e i suoi difetti, una madre che non vede problemi perché non desidera farlo. Il mio
collega invece rappresentava la figura professionale dello psicologo che vuole cercare un
punto di contatto per comunicare con la madre e con tutta la famiglia del ragazzo. Il colloquio
8LA COMUNICAZIONE NON VERBALE IN CONTESTI FACE TO FACE
è iniziato con la figura materna chiusa rispetto allo psicologo, che invece sembrava essere
propositivo e aperto al dialogo. La situazione però è cambiata da subito repentinamente in
quanto la madre si è sentita attaccata dalle parole dello psicologo che risuonavano alle sue
orecchie come un giudizio. Così c’è stato un forte conflitto tra i due. La mia consapevolezza
all’interno di questo role playing è stata di un livello medio, nel senso che molti dei segnali
non verbali che inviavo all’interlocutore erano inviati in modo consapevole e posso dire
fossero sotto il mio controllo. Un’altra parte di questi segnali, però, sono rimasti ad un livello
di inconsapevolezza e quindi me ne sono accorta solo in un secondo momento, quando ho
avuto modo di discutere della simulazione con il resto del gruppo. Mi sono resa conto, infatti,
di aver perso completamente il controllo dello sguardo e dei movimenti del capo che invece
hanno trasmesso l’aggressività del mio personaggio e la chiusura comunicativa. Era
sufficientemente consapevole delle braccia che spesso erano incrociate e delle gambe
accavallate.
Sono rimasta piuttosto colpita dalla reazione che hanno avuto il mio compagno e il
personaggio che egli interpretava. Infatti di fronte all’aggressività e alla chiusura della madre,
lo psicologo si è trovato in una condizione di impotenza, nel senso che dava l’impressione di
non sapere in che modo muoversi – si è appoggiato con la schiena alla sedia e è rimasto
immobile, i muscoli apparivano tesi, sia quelli facciali che quelli delle braccia; inoltre è
arrossito notevolmente e ha tenuto per tutto il tempo gli occhi molto aperti, come se fosse
incredulo.
La seconda simulazione a cui ho partecipato mi ha visto interpretare il ruolo di uno dei
componenti di un focus group di 5 persone. Questa simulazione è stata diversa dalle altre
perché abbiamo avuto la possibilità di osservare l’interazione tra più persone, constatando
quindi quali dinamiche entrino a far parte nella comunicazione nei gruppi. Il focus group era
costituito da: un entusiasta, due persone assai critiche (sebbene con motivazioni differenti),
uno scettici, una persona che, pur globalmente favorevole alla campagna, mantiene una
visione lucida di aspetti positivi e negativi. Il mio ruolo era proprio quest’ultimo. Il flusso
comunicativo tra questi cinque personaggi era gestito da una psicologa, interpretato da
un’altra collega, che cercava di trarre le conclusioni ai fini di una ricerca di mercato.
In questa simulazione, probabilmente anche per la stanchezza che sentivo in quella giornata,
sono stata molto meno consapevole di me stessa e degli altri rispetto al mio primo role
playing.
Ho notato in particolare che i due personaggi che dovevano essere critici riuscivano ad esserlo
in modo molto diverso: da una parte c’era il personaggio chiuso, immobile sulle sui
9LA COMUNICAZIONE NON VERBALE IN CONTESTI FACE TO FACE
convinzioni – immobilità fisica e gesti netti e decisi delle mani, dall’alto al basso, spesso
braccia conserte e gambe accavallate, capo inclinato; dall’altra parte c’era un personaggio
critico che si agitava e esprimeva le proprie idee con energia e trasporto – alto stato di
attivazione, ampi movimenti delle braccia, continui spostamenti sulla sedia, volume della
voce più alto, continui scuotimenti del capo.
Inoltre, discutendone a posteriori, abbiamo capito quanto può essere difficile per uno
psicologo gestire un incontro di gruppo, cercando di permettere a tutti di parlare nel momento
in cui desiderano esprimersi. Allo stesso tempo, però, lo psicologo deve comprendere le
intenzioni dei diversi partecipanti per non rischiare di mettere qualcuno nella situazione di
dover dire controvoglia.
La simulazione che ho preferito è stata quella dell’ultima lezione che aveva come consegna
quella di intervistare un compagno sulla sua esperienza universitaria cercando di comprendere
quando risponde in modo veritiero e quando mentendo. Ovviamente la consegna del
compagno era di rispondere in modo veritiero o mentendo. Inoltre una terza persona
osservava la nostra interazione. In questo caso quindi abbiamo cercato di scovare gli indizi
della menzogna e ci siamo resi conto di quanto sia difficile capire che qualcuno ci sta
mentendo se questo qualcuno è molto bravo a farlo. Un aspetto che mi ha molto colpito è
stato il fatto che in molti hanno osservato come il mentitore, dopo aver mentito, tenda a
sorridere, quasi in modo seducente, per conquistarsi la simpatia e la credibilità. I mentitori
meno esperti, inoltre, tendevano a chiudere rapidamente le affermazioni contenenti la
menzogna, evitando di giustificarle o ripetendo più volte la medesima giustificazione, quasi a
volersene convincere loro stessi per primi.
Il micronido di Grignano (Brembate): la mia esperienza sul campo
La mia osservazione sul campo si è svolta all’interno di un micronido della Sodexho con sede
in Grignano (frazione di Brembate). Per comprendere meglio l’ambiente in cui mi sono
trovata inserita è opportuno introdurre brevemente l’ideologia che sta alla base della Sodexho:
essa nasce con la volontà di creare e offrire, in tutto il mondo, tutti quei servizi che
contribuiscono a rendere più gradevoli i momenti di vita collettiva delle donne e degli uomini
di ogni età. I valori su cui si basa sono lo spirito di servizio, definito come uno stile e un modo
di essere volti alla capacità di ascolto, alla disponibilità e all’efficacia; lo spirito di squadra,
ovvero lo sforzo di lavorare insieme per raggiungere lo scopo nel migliore dei modi e infine
lo spirito di progresso, ovvero la costante tensione verso il miglioramento personale e
10LA COMUNICAZIONE NON VERBALE IN CONTESTI FACE TO FACE
collettivo. Sulla base di questi valori la Sodexho, partendo da un settore legato alla
ristorazione, ha creato un vero e proprio impero e si è mano a mano occupata di servizi molto
diversi tra loro sia per l’utenza che ne fa uso, sia per i professionisti che ne risultano coinvolti.
In modo particolare il settore educativo nasce da un desiderio e da un bisogno dei clienti stessi
della Sodexho. La dott. Chinnici, ovvero la mia responsabile all’interno dell’ente in cui sono
stata ospitata, nonché la coordinatrice tra i servizi (tra comune e Sodexho), mi ha spiegato che
sono stai i clienti di Sodexho ristorazione a richiedere che essa si occupasse anche del settore
educativo, considerando anche il fatto che l’azienda si occupava già della ristorazione
all’interno di scuole.
Il micronido di Grignano (Brembate) è un servizio comunale la cui amministrazione è
rimandata alla Sodexho. L’azienda quindi ha per cliente il comune al quale offre il proprio
servizio progettando i programmi e le attività del nido annualmente e occupandosi
dell’alimentazione dei bambini.
La struttura che ho avuto modo di visitare ospita otto bambini dagli 11 mesi ai 3 anni, anche
se la sua capienza permetterebbe di ospitarne fino a una quindicina. I bambini sono suddivisi
in due grande gruppi: le coccinelle (dagli 11 ai 24 mesi) e le api (dai 24 ai 36 mesi). Il nido si
trova all’interno di un caseggiato nel quale risiede anche l’asilo comunale. Al suo interno esso
è diviso in tre stanze: la stanza più grande (cioè è quella in cui si fanno la maggior parte delle
attività), il dormitorio e infine il bagno. Gli spazi sono molto ampi e colorati, numerose
finestre illuminano i locali. Ogni spigolo è protetto da della gommapiuma per evitare che i
bambini si facciano male. Tutto l’arredamento è a misura di bambino (tavoli e sedie piccoli,
scaffali bassi, oggetti leggeri). Inoltre è disponibile anche un ampio spazio all’aperto
(terrazzo) e uno studio ed un bagnetto privato ad uso del personale.
Nella stanza più grande le pareti colorate sono cosparse di disegni fatti dai bambini stessi. In
questo locale si trovano spazi molto diversi tra loro a seconda dell’attività a cui sono destinati:
gioco simbolico (angolo cucina, angolo mercato, lavatrice, ecc.), giochi a terra (un paio di
scaffali con diversi tipi di giochi tra cui peluche, animali di plastica, macchinine, costruzioni,
palle, ecc.), angolo morbido e della lettura (libri di stoffa e libri classici), gioco dei
travestimenti (una valigia contenente vestiti e parrucche), palestra (ovvero una sorta di piscina
di gommapiuma munita di scale di gommapiuma all’interno della quale ci sono palline
colorate di plastica), attività a tavolino (due tavoli da otto posti a testa con piccole sedie),
angolo dei giochi sonori e delle stimolazioni sensoriali.
In questo spazio, quindi, sono proposti ai bambini numerosi laboratori: laboratorio del colore,
laboratorio del pasticcio e della farina, laboratorio dei travestimenti, laboratorio psicomotorio,
11LA COMUNICAZIONE NON VERBALE IN CONTESTI FACE TO FACE
laboratorio psicomotorio, laboratorio dei giochi con l’acqua, laboratorio dei giochi all’aria
aperta.
Il dormitorio oltre ad essere utilizzato per la “nanna” è anche sfruttato come spazio
psicomotorio. Il soffitto costellato di stelle e angioletti appesi ad esso per un filo trasparente
mentre alle pareti sono appesi i materassini dei piccoli (vengono sganciati nel momento in cui
sono necessari). Inoltre in questa stanza si trova un grande poltrona morbida che i bambini
sembrano apprezzare moltissimo.
I bambini sono seguiti dalla coordinatrice (che svolge anche il ruolo di educatrice),
un’educatrice part time e una ausiliaria che si occupa della distribuzione degli alimenti e della
pulizia dei locali.
Il servizio offre due possibilità di partecipazione dei bambini: una partecipazione full time
dalle 7:30 del mattino alle 18:30 della sera e una partecipazione part time che prevede la
frequenza dei bambini nella mattinata (fino a dopo pranzo, verso le 13:00 circa) oppure nel
pomeriggio (opzione scarsamente sfruttata). La giornata tipo al nido di Grignano (Brembate)
inizia quindi alle 7:30 con l’accoglienza dei bambini e dei genitori. Questo momento si
estende fino alle 9:00. Agli accompagnatori si richiede, ove possibile, di rimanere con i loro
bambini quanto possono per rendere meno traumatico il distacco dalla figura di riferimento. I
piccoli sono lasciati liberi di muoversi e giocare liberamente fino all’arrivo di tutti i loro
compagni. Spesso i bambini più piccoli si addormentano in questa fase. Il momento
successivo è quello dello spuntino, un frutto, verso le 9:30 del mattino. Segue il cambio,
rituale molto importante, in cui i bambini si trovano in bagno con l’educatrice e apprendono,
sperimentando, i primi comportamenti autonomi o vengono cambiati direttamente
dall’educatrice se sono troppo piccoli. Le routines (il bagno, il pranzo, il saluto) rivestono un
ruolo importante sia per la valutazione dei miglioramenti del bambino sia per il suo
apprendimento delle regole sociali da tenere in determinate situazioni.
Superato questo momento finalmente ha inizio la vera attività: a seconda della
programmazione i bambini si trovano coinvolti in diversi tipi di operosità in spazi molto
diversi tra loro.
Le attività giornaliere rappresentano sicuramente la parte più interessante per quanto riguarda
il lavoro dello psicologo. Alla loro base, infatti, sta tutto un lavoro di programmazione
antecedente che coinvolge lo psicologo in primis e di conseguenza anche gli educatori che
dovranno interagire con i bambini. Se dovessimo definire la centralità delle attività che
vengono realizzate potremmo sicuramente dire che in tutte emerge una visione di gioco come
strumento fondamentale per la crescita e lo sviluppo del bambino. Il gioco, però, è visto non
12LA COMUNICAZIONE NON VERBALE IN CONTESTI FACE TO FACE
solo come fine a se stesso ma come sperimentazione, come esperienza del mondo. Ecco
perché la Sodexho dedica tanta importanza alla programmazione di attività che permettano al
bambino di fare, di sperimentare, giocando: quest’anno esse vertono attorno al tema delle
stagioni.
Accanto a questa attenzione al gioco ed ad attività mirate, la Sodexho riserva uno spazio
particolare al percorso effettuato dai bambini durante la permanenza al nido, definendo mano
a mano obiettivi e osservando successi e insuccessi nei tentativi di realizzazione dei piccoli.
Gli educatori, infatti, sono portati ad aggiornare il diario educativo di ogni singolo bambino
con una scadenza di circa un paio di mesi. Il diario educativo può essere considerato uno degli
strumenti più importanti per l’educatore e si suddivide in due parti: una prima parte più
generale comprensiva di una copia del programma educativo, di schede di eventuali
intolleranze o allergie alimentari e non di qualche bambino e del diario di sezione in cui viene
inserita la programmazione mensile. Ovviamente non dobbiamo pensare ad una
programmazione simile a quella delle scuole elementari: il percorso, infatti, deve essere molto
più flessibile e si deve adeguare alle esigenze e ai vissuti emotivi giornalieri dei bambini, oltre
che alle risorse attentive sfruttabili giorno per giorno (se i bambini sono particolarmente
agitati, per esempio, è impensabile l’idea di mantenere l’attività giornaliera prestabilita se
questa corrisponde alla lettura di un libro). La seconda parte del diario educativo invece è
costituita delle schede personali dei singoli bambini. All’interno possiamo trovare diverse
informazioni: 1) colloquio per l’inserimento, 2) osservazione dell’inserimento 3) scheda di
osservazione. Prima dell’inserimento del bambino al nido gli educatori sostengono un
colloquio con i genitori nel quale raccolgono molte informazioni sia per quanto riguarda
abitudini, sia per quanto riguarda il rapporto con i genitori, sia per quanto riguarda il livello di
sviluppo motorio e linguistico. In questa sezione si possono trovare inoltre dati di carattere
pratico/burocratico come quelli anagrafici o la segnalazione di allergie, malattie e altre
informazioni importanti.
L’osservazione dell’inserimento è uno strumento importantissimo per gli educatori.
L’inserimento è infatti un momento delicato per il bambino che deve abituarsi al nuovo
ambiente e anche a nuove figure a cui fare riferimento. i più piccoli passano le prime
settimane a guardare la porta speranzosi che la madre torni a prenderli.
Comprendiamo quindi quanto sia importante introdurre il bambino al nido nel modo migliore
possibile, cercando di non fargli vivere quest’esperienza dell’asilo nido come un trauma. Per
fare questo è previsto un programma piuttosto rigido secondo il quale la madre, o in generale
la figura a cui fa riferimento il bambino , deve accompagnare il bambino nella vita del nido
13LA COMUNICAZIONE NON VERBALE IN CONTESTI FACE TO FACE
lentamente, affiancandolo prima tutto il giorno quindi sempre meno fino a raggiungere una
pseudo autonomia dalla figura primaria. In realtà questi tempi non sono sempre rispettati dai
genitori che coinvolti dal lavoro e da altri impegni non riescono a seguire le indicazioni delle
educatrici. Il bambino in ogni caso è seguito con molta attenzione e soprattutto all’inizio si
può far uso di “compromessi psicologici”, come mostrare le foto della mamma, del papà e del
mondo del bambino fuori dal nido. Indipendentemente da ciò, le educatrici osservano con
attenzione il bambino in questi primi giorni di permanenza al nido e stendono una scheda
osservando i seguenti aspetti: separazione/ricongiungimento alla figura primaria, relazione
della coppia genitori-figlio, uso dello spazio, motricità, comunicazione (come comunica?
come reagisce quando si parla con lui?), relazioni del bambino, gioco, rapporto con gli
oggetti, reazioni particolari, routines. In base a ciò che il bambino esprime come esigenza
personale si definiscono gli obiettivi personali (per esempio se un bambino gattona e tenta di
alzarsi il suo obiettivo personale può essere quello di deambulare in modo sicuro).
La terza scheda del diario educativo personale è una vera e propria scheda di osservazione che
coinvolge le aree di sviluppo, i momenti di routines, i momenti di gioco, i momenti relazionali
e il livello del raggiungimento del livello personale. In base a quest’ultimo punto si
definiscono anche i nuovi obiettivi.
Accanto a una programmazione studiata con attenzione quindi la Sodexho evidenzia
l’importanza di un’educazione centrata sul bambino che parta dalle sue esigenze e dai suoi
bisogni e gli fornisca gli strumenti per soddisfare i proprio bisogni e di un contatto costante
con le famiglie di appartenenza, intendendo la crescita come una dimensione trasversale a
tutti i contesti in cui il bambino vive ogni giorno.
Il 21 aprile 2005 mi sono recata la prima volta all’asilo nido. Trovandosi vicino alla mia
abitazione non ho avuto particolari difficoltà nel trovarlo. Una volta giunta nella struttura, mi
sono sentita da subito a mio agio dato che la prima persona che ho incontrato è stata Sara1,
una delle bambine dell’asilo nido. La dott. Chinnici mi ha accolto immediatamente
indicandomi lo studio. La prima parte della mattinata è trascorsa all’interno di questa piccola
stanza in cui la dottoressa mi ha raccontato cosa sia la Sodexho e cosa significhi lavorare al
suo interno, concentrandosi in modo particolare sulle dinamiche che vertono intorno agli asilo
nido e a quello di Grignano (Brembate). Successivamente ho avuto modo di stare con i
bambini e farmi travolgere dalla loro entusiasmante vitalità, di vivere con loro il momento del
pranzo e del saluto dei bambini “part time” oltre a quello della “nanna”. Questo primo
approccio mi ha molto divertito ma mi ha anche aiutato a comprendere ancora una volta
1
Per tutelare i minori e le informazioni personali apprese durante questa esperienza utilizzerò nomi fittizi, escluso quello
della Dott. Chinnici.
14LA COMUNICAZIONE NON VERBALE IN CONTESTI FACE TO FACE
quanto può essere difficile la nostra professione e quanto può essere complesso lavorare a
contatto con i bambini.
La seconda giornata invece, il 27 aprile 2004, mi ha visto coinvolta nella vita pomeridiana del
nido a partire dal risveglio dei bambini fino al ricongiungimento con i genitori.
Successivamente ho avuto modo di assistere a un momento molto importante, ovvero una
riunione di collettivo tra la psicologa, coordinatrice tra i servizi della Sodexho, coordinatrice
del nido ed educatrice. Partecipare a questo momento stato molto importante perché ho
potuto osservare la dott. Chinnici al lavoro, gestendo una riunione decisionale.
Le mie osservazione sono state effettuate in due momenti molto diversi tra loro: durante un
dialogo e durante un collettivo tra il personale.
Ho deciso di osservare la psicologa con cui ho avuto modo di parlare proprio perché volevo
capire quali sensazioni mi desse parlare con questa professionista e comprendere anche quale
atteggiamento dovrebbe avere questa figura professionale nel momento in cui si relaziona.
In realtà ho trovato molto difficile estrapolare la mia osservazione dall’interazione in cui il
soggetto era coinvolto. È anche vero che ho incontrato diverse difficoltà nell’osservare con la
medesima attenzione tre soggetti in interazione poiché qualcuno catturava sempre la mia
attenzione e perdevo di vista la comunicazione non verbale degli altri due.
Osservazione n°1: ho deciso di osservare la CNV di una interlocutrice mentre si rivolgeva
direttamente a me. Questa osservazione è stata piuttosto complessa in quanto ero fortemente
interessata dal contenuto della conversazione all’interno della quale è avvenuta e perché
temevo che la mia interlocutrice pensasse che non fossi attenta o che non la ascoltassi. Ho
notato perciò solo alcuni particolari della CNV della persona che ho osservato e soprattutto ho
cercato di monitorare la mia CNV.
La mia interlocutrice ha utilizzato moltissimo la sua capacità di esprimere le proprie
intenzioni in modo non verbale, gesticolando molto e cercando costantemente lo sguardo
reciproco, quasi a volermi coinvolgere e conquistare.
Ciò che più mi ha colpito è stata la sua gestione dello spazio e la sua postura: non solo ha
cambiato posizione molto spesso, ma ha assunto sempre posizioni che indicavano un discreto
stato di rilassamento (non rivelava particolari chiusure e tendeva ad avvicinarsi molto a me
mentre parlava). Inoltre ha cambiato spesso la posizione delle gambe.
Quando parlava tendeva a guardarmi molto più di quanto faccia io quando mi rivolgo a
qualcuno, muoveva il capo spesso e sorrideva nei momenti di pausa, tirando le labbra e
mostrando i denti.
15LA COMUNICAZIONE NON VERBALE IN CONTESTI FACE TO FACE
Tendeva ad assottigliare molto gli occhi quando parlavo, come se cercasse di capire quello
che stavo dicendo e, nel momento in cui questo non avveniva, alzava più o meno lievemente
le sopracciglia. Inoltre quando le rivolgevo qualche domanda poco chiara strizzava gli occhi,
creando delle piccole rughe attorno agli stessi.
Quanto alla mia comunicazione non verbale, mi sono resa conto molto spesso di avere le
braccia incrociate. Effettivamente mi sentivo lievemente a disagio, più che altro perché
sentivo la persona molto vicina a me quando invece avrei creduto di sentirla molto più lontana
dal mio modo di essere. In qualche modo mi sembrava riflettesse il mio stato d’animo, tanto
che quando notavo una certa chiusura nella mia postura, la notavo anche nella mia
interlocutrice. Inoltre entrambe spesso ci toccavano il viso (gesti di autocontatto), soprattutto
nel momento in cui ci rivolgevamo all’altra persona.
Osservazione n° 2: Mi è sembrato molto interessante osservare l’interazione tra la psicologa,
la coordinatrice e l’educatrice part time durante il collettivo. In questa occasione
l’osservazione era favorita dal fatto che non era richiesta una mia partecipazione all’attività
trattandosi di una sorta di riunione d’equipe. Sono stata abbastanza consapevole della mia
comunicazione non verbale di tanto in tanto appuntavo qualcosa sul mio quaderno. Non mi
sono sentita particolarmente a disagio in quella situazione anche perché il clima era piuttosto
informale, sensazione data anche dal fatto che spesso si sorrideva e si rideva e, in un paio di
occasioni, è capitato che io stessa intervenissi nell’interazione.
La prima cosa che mi ha colpito moltissimo sono state la disposizione nello spazio dei
partecipanti in interazione e la prossemica: da subito, infatti, non solo si sono disposti a
cerchio, coinvolgendomi come fossi un partecipante al pari degli altri, ma si sono molto
avvicinati tra loro, mantenendo una distanza davvero minima, sancendo ancora una volta il
livello di intimità presente tra i tre.
La distanza è stata mantenuta quasi invariata, ad eccezione di due momenti in cui due dei
partecipanti si sono lievemente avvicinati, quasi a sfiorare l’uno il piede dell’altro, quando i
due sostenevano un punto di vista rispetto a quello del terzo partecipante che a sua volta ha
reagito in entrambe le situazioni chiudendosi (braccia conserte e gambe in contatto a livello
delle ginocchia).
Durante la seduta sono state discusse diverse proposte e tutti si sono esposti mostrando i
proprio punti di vista.
16LA COMUNICAZIONE NON VERBALE IN CONTESTI FACE TO FACE
Il ruolo di conduttrice del gruppo è stato svolto la maggior parte delle volte dalla psicologa,
nel senso che era la dottoressa a gestire il flusso di proposte e critiche sebbene non gestisse i
turni di parola ma semplicemente rivolgeva domande a entrambe o alla diretta interessata.
Dal comportamento degli altri due partecipanti nei confronti della conduttrice si può notare
come quest’ultima stesse in una posizione di “potere”: essi infatti gestivano i propri turni di
parola anche in base ai momenti di silenzio che offriva la conduttrice e cercavano spesso la
sua attenzione rispetto a quella dell’altra collega nel momento in cui parlavano.
La psicologa, quando si rivolgeva a qualcuno in particolare, tendeva a spostare ampiamente il
peso in avanti, tanto che ad un tratto si è completamente piegata in avanti, appoggiando i
gomiti alle ginocchia e avvicinandosi notevolmente al suo interlocutore. In queste situazioni
la conduttrice spesso attuava gesti di autocontatto (si toccava molto il mento e le guance).
Le reazioni degli altri soggetti ai suoi avvicinamenti, talvolta molto repentini, non hanno
evidenziato una situazione di imbarazzo o disagio rivelando invece una conoscenza
abbastanza approfondita tra i tre soggetti che a loro volta reagivano rimanendo immobili,
quasi a equilibrare l’eccesso motorio di uno degli interlocutori. Quando invece sostenevano i
propri punti di vista si portavano avanti con il busto quando sostenevano i propri punti di vista
in modo più animato (a volte era evidente uno stato di attivazione piuttosto alto dai continui
cambiamenti di postura – movimenti frequenti delle gambe – e dal colorito accesso del
volto).
Alla conduttrice venivano rivolte numerose affermazioni cariche di ironia, soprattutto da parte
di una delle sue collaboratrici, alle quali reagiva con un professionale distacco, sorridendo ma
mantenendo anche la sua posizione al di sopra delle parti. L’interlocutrice con cui
comunicava reagiva spesso con una chiusura (braccia conserte, gambe vicine) e abbassando il
capo, scuotendola lievemente.
Inoltre, la conduttrice ha cercato per tutto il tempo dell’interazione il contatto oculare con gli
altri due partecipanti che a loro volta raramente evitavano di sostenere lo sguardo reciproco.
Inoltre ho notato che la psicologa non rivolgeva mai sguardi d’intesa o complicità a una delle
due educatrici, anche quando sosteneva il punto di vista di una delle due, atteggiamento che
ho trovato molto professionale e che, del resto, ho considerato come sintomo di una persona
molto consapevole della sua comunicazione non verbale.
Quando il collettivo si è chiuso, i tre partecipanti avevano mantenuto più o meno le stesse
posizioni, ad esclusione di una delle due educatrici che appariva lievemente indietreggiata
rispetto all’inizio.
17LA COMUNICAZIONE NON VERBALE IN CONTESTI FACE TO FACE
Durante l’interazione spesso questa stessa educatrice cercava il mio sguardo in segno di
complicità, soprattutto quando la conduttrice e l’altra collega sostenevano le stesse idee. La
conduttrice, invece, mi ha rivolto solo qualche sguardo in quei rari momenti in cui sono
intervenuta, poiché l’argomento in discussione non era strettamente legato a problemi di cui
non ho sufficienti conoscenze.
Concludendo posso affermare che l’osservazione è stata piuttosto complessa, non tanto per
mancanza di materiale osservabile, ma piuttosto perché è difficile mantenere consapevolezza
di sé e degli altri nel momento in cui si fa qualcosa di particolarmente coinvolgente.
Inoltre spesso il meccanismo di osservazione è strettamente e automaticamente collegato a
quello di inferenza, nel senso che spesso avvertiamo sensazioni o proviamo stati d’animo
particolari senza renderci conto di quale meccanismo di comunicazione non verbale stia alla
base di queste esperienze emotive.
Inoltre mi sono resa conto che a contatto con i bambini è ancora più difficile mantenere la
propria consapevolezza comunicativa. Credo che questo sia dovuto al fatto che spesso si tende
ad imitare i bambini o comunque a essere altamente empatici con loro anche per il fatto che i
bambini riescono ad esprimere molto bene le loro emozioni e quindi viene molto semplice
sintonizzarsi con loro. L’esuberanza dei bambini, d’altra parte, lascia poco spazio ad altri
pensieri. Così l’osservazione è uno strumento molto importante, dal quale possiamo trarre
davvero molte informazioni, ma che va continuamente migliorato.
In questo senso bisogna sottolineare l’importanza dell’esperienza e l’importanza, ancora una
volta, della consapevolezza di ciò che si prova e ciò che si trasmette. Quando parlavo con la
dottoressa mi sentivo a mio agio e credo che questo sia legato al fatto che la professionista
avesse grande controllo di sé e mi parlasse in modo semplice, chiaro, fornendomi le
informazioni di cui avevo bisogno.
Devo ammettere che non mi aspettavo che la dott. Chinnici, nelle vesti di psicologa, svolgesse
un ruolo di questo tipo, nel senso che non avevo mai considerato l’aspetto organizzativo della
professione come qualcosa di così interessante. La dottoressa infatti non solo ricopre il ruolo
di mediatore tra l’azienda per cui lavora e coloro che offrono i servizi dell’azienda stessa, ma
si propone come coordinatrice di tutte le relazioni che coinvolgono l’asilo nido. Essere
psicologa quindi vuol dire molto più che mediare la comunicazione tra persone ma anche tra
servizi.
18LA COMUNICAZIONE NON VERBALE IN CONTESTI FACE TO FACE
Conclusioni e commenti sull’esperienza
La scelta di queste attività ci ha permesso di comprendere il ruolo dello psicologo all’interno
di ambiti molto diversi e soprattutto di capire quali strumenti potesse avere uno psicologo
della comunicazione rispetto alle altre professionalità.
Questo EPT si è rivelato altamente istruttivo in quanto abbiamo avuto modo di imparare “a
fare” in aula e poi applicare ciò che avevamo studiato al di fuori del contesto protetto delle
simulazioni, in diversi momenti di osservazione diretta in campo, ovvero nei diversi enti che
ci hanno ospitato.
Per la prima volta, forse, abbiamo davvero frequentato un EPT che rispettasse a pieno le
finalità che gli sono affidate, una vera esperienza pratica di tirocinio. Spesso l’esperienza di
tirocinio aveva poco a che fare con il pratico, mentre in questo caso siamo stati entusiasti
rispetto alle modalità in cui è stato progettato questo percorso. La parte delle lezioni in aula
dedicata alla teoria si è rivelata fondamentali per le simulazioni e per l’osservazione sul
campo.
Inoltre, lezioni e simulazioni ci hanno molto favorito nella comprensione di un altro corso,
ovvero psicologia della comunicazione. Questo insegnamento prevede spesso le visione di
frame di film per esercitare l’osservazione. In questo caso coloro che frequentavano questo
EPT sono stati molto avvantaggiati in quanto avevano già acquisito basi teoriche
sull’argomento e avevano già sperimentato cosa volesse dire osservare.
Ciò che mi porto a casa è sicuramente una maggiore consapevolezza di me stessa e dei miei
modi di comunicare e trasmettere le mie emozioni e i miei stati d’animo. Dal primo anno di
corso i docenti ci ripetono continuamente che noi stessi siamo il nostro primo strumento in
questa professione e quindi dobbiamo avere un livello di consapevolezza molto alto. Questo
EPT prima di qualsiasi altro ci ha fornito diverse modalità di conoscere il nostro modo di
comunicare e ovviamente ad osservare le svariate modalità con cui gli altri ci comunicano
qualcosa. In un certo senso possiamo dire di esserci sensibilizzati sia all’osservazione della
comunicazione non verbale sia alla gestione della stessa.
Non trovo in questo percorso particolari criticità, se non quella di aver avuto una durata
troppo limitata, ma credo siano vincoli imposti dall’università.
Ne approfitto per ringraziare vivamente la dott. Biassoni che è stata una tutor davvero attenta
e accogliente oltre ad una figura professionale ed una persona con cui è stato molto piacevole
scambiare opinioni e punti di vista.
19Puoi anche leggere