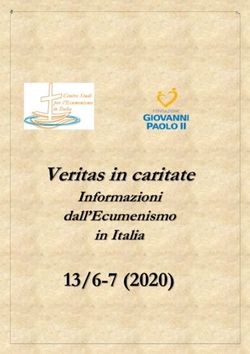L'erogazione di contributi comunali in epoca COVID
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
La Rivista delle amministrazioni pubbliche - 12/2020
L‘erogazione di contributi ASCOLTA!
LA VOCE
comunali in epoca COVID DEL DIRETTORE
· Quali regole per gli aiuti degli enti locali alle imprese in difficoltà?
· Formulario: Schemi di atti per l’erogazione di contributi alimentari
I termini di pubblicazione, il diritto all’oblio e i costi dell’accessoI DOCUMENTI
INFORMATICI DOPO
LE NUOVE LINEE
GUIDA AGID
Formazione, gestione
e conservazione
Gennaio 2021 - Codice 88.916.4688.0
F.to 17x24 - Pag. 182 - € 32.00
La rivoluzione digitale passa inevitabilmente dalla riprogettazione dei proces- iLibro
si e ciò pone a tutte le organizzazioni, pubbliche e private, due ordini di pro- L’acquisto dell’opera include l’accesso
blemi: delineare preliminarmente uno scenario di contesto e poi individua- alla versione digitale iLibro, che permet-
re le metodiche tecnico-organizzative adeguate a operarvi in una logica na- te: • la consultazione online; • l’utilizzo
tivamente digitale. del motore di ricerca per parola e concet-
Numerose sono le disposizioni di legge, le specifiche tecniche e le raccoman- ti all’interno del volume; • il collegamen-
to diretto alla normativa (sempre aggior-
dazioni in materia di formazione, protocollazione, gestione e conservazione dei
nata e in multivigenza).
documenti informatici, al punto che l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) ha re-
centemente operato per incorporarle tutte in un’unica linea guida dedicando
inoltre ampio spazio anche all’analisi delle validazioni temporali elettroniche, AGGIORNAMENTI NORMATIVI
delle firme elettroniche e dei sigilli elettronici (aspetti inevitabilmente correla- › Nuove Linee Guida AgID
ti al ciclo di vita del documento informatico).
In questo quadro, la presente opera si caratterizza sia per la completezza e FRANCESCO CICLOSI
l’elevato livello di approfondimento, sia per la capacità dell’autore di fornire
Professore a contratto di Informatica
una visione olistica delle problematiche inerenti la formazione, la gestione e la
presso l’Università degli Studi di
conservazione dei documenti informatici. Macerata e docente di Sicurezza
Si tratta di un approccio finalizzato a fornire al lettore gli strumenti e i signifi- nel master universitario di II livello
cati indispensabili per affrontare in modo consapevole e proficuo le sfide poste “Formazione, gestione e conservazione di
dalle tecnologie correnti, nell’attuale società dell’informazione. archivi digitali”
SERVIZIO CLIENTI Tel +39 0541 628200 - clienti.editore@maggioli.it
SAPERE È SAPER FARE www.maggiolieditore.itEditoriale
Erogazione di contributi comunali
in epoca COVID, tra normativa
comunitaria e (forse) nuovo Testo
unico degli enti locali: è una questione
non solo di risorse, ma (anche)
di competenza
di Tiziano Tessaro
Non era mai successo prima: l’erogazione dei contributi da parte dei Comuni aveva seguito sempre
binari e ambiti materiali consolidati, fin dall’epoca del Testo unico degli enti locali del 1915 e di
quello del 1934. E aveva sempre riguardato dazioni nei confronti dei soggetti che operano nel
campo di quello che ora chiamiamo no profit. Le cose sono cambiate, per evidenti motivi, nel corso
del 2020: destinatari dei contributi erogati dai Comuni – in termini di denaro, ovvero di esenzioni
(o, come si esprime l’art. 12 della legge 241(1990, la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi
ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere) – sono stati (anche)
soggetti che operano in ambito commerciale, in un ambito cioè caratterizzato dalla presenza del
mercato e che versavano in difficoltà a causa del COVID-19.
L’attuale fase emergenziale causata dall’epidemia ha provocato, come noto, un grave shock per
le economie dei Paesi coinvolti per fronteggiare il quale la Commissione europea ha previsto
specifiche misure a sostegno dell’economia dei diversi Stati membri che consentano, nel contempo,
di salvaguardare il sistema di libera concorrenza costituente uno dei fondamenti dell’Unione
europea. In tale contesto si inseriscono le misure straordinarie di sostegno economico adottate
sia dal Governo italiano che dagli enti locali in favore delle imprese colpite dagli effetti economici
negativi prodotti dalle restrizioni adottate in ragione del dilagare dell’emergenza epidemiologica.
Una finalità diversa da quella tradizionale nell’ambito del sociale, dello sport e della cultura ha quindi
ispirato i provvedimenti di erogazione dei contributi locali: il differente raggio di azione dei Comuni,
ossequiando evidentemente alla loro missione di enti a carattere generale delineata dall’art. 3 del Tuel
(a mente del quale Il comune è l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi
e ne promuove lo sviluppo), li ha trasformati in autentici attori del sostegno all’economia locale.
1Comuni d’Italia / 12_2020 Editoriale Ma proprio in ragione di ciò, si sono affacciati in modo significativo gli interrogativi volti a verificare la liceità di detti provvedimenti, ovverosia di misure con riferimento alle quali si è posta la questione della compatibilità delle stesse, da un lato, con la normativa eurounitaria in materia di aiuti di Stato, e in secondo luogo, con la normativa di riparto delle attribuzioni in ambito costituzionale. Sotto il primo profilo, come noto, l’art. 107 TFUE vieta, in linea di principio – dichiarandoli «incompatibili con il mercato interno» – «gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma» (formula che abbraccia pacificamente anche gli aiuti provenienti da amministrazioni pubbliche non centrali, quali Regioni o altri enti territoriali) «che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza», «nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri». Il divieto non è, tuttavia, assoluto e incondizionato. Lo stesso art. 107 TFUE prevede, infatti, una serie di deroghe, distinguendole in due categorie: da un lato, le ipotesi di compatibilità “di pieno diritto”, ricorrendo le quali la Commissione non ha poteri discrezionali in merito (paragrafo 2), dall’altro, i casi di aiuti “potenzialmente compatibili”, i quali possono essere autorizzati all’esito di una valutazione discrezionale delle istituzioni europee (paragrafo 3). Il successivo art. 108 TFUE prefigura una rigorosa procedura di controllo sulla compatibilità degli aiuti con la disciplina del Trattato, che vede come protagonista la Commissione e che si svolge con modalità diverse, secondo che si tratti di aiuti già esistenti ovvero di aiuti nuovi (nozione che abbraccia anche le modifiche di aiuti esistenti). In base alla costante giurisprudenza della Corte di giustizia, la valutazione della compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno rientra nella competenza esclusiva della Commissione, che opera sotto il controllo del giudice dell’Unione, con la conseguenza che ai giudici nazionali non è consentito pronunciarsi sul punto (ex plurimis, Corte di giustizia, 26 ottobre 2016, in causa C590/14 P, Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE; 15 settembre 2016, in causa C574/14, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA; 19 marzo 2015, in causa C672/13, OTP Bank Nyrt). Nell’attuazione del sistema del controllo degli aiuti, ai giudici nazionali spetta un ruolo “complementare e distinto”. Ad essi compete, in specie, la salvaguardia, fino alla decisione definitiva della Commissione, dei diritti dei singoli in caso di inadempimento dell’obbligo di notifica preventiva della misura alla Commissione da parte degli Stati membri, previsto dall’art. 108, paragrafo 3, TFUE. A tal fine, i giudici nazionali possono interpretare e applicare la nozione di «aiuto di Stato» per valutare se un provvedimento adottato senza seguire il procedimento di controllo preventivo debba esservi o meno soggetto, salva restando, in caso di dubbio, la possibilità di chiedere chiarimenti alla Commissione o, in alternativa, di sottoporre la questione in via pregiudiziale alla Corte di giustizia (facoltà, quest’ultima, che diviene un obbligo ove si tratti di giudice di ultima istanza, ai sensi dell’art. 267, paragrafo 3, TFUE). Inoltre, spetta ai giudici nazionali trarre tutte le conseguenze della violazione del citato art. 108, paragrafo 3, TFUE, sia per quanto riguarda la validità degli atti che comportano l’attuazione delle misure di aiuto, sia per quanto attiene al recupero degli aiuti concessi in violazione di tale norma. Sempre per affermazione della Corte di giustizia, in forza dell’art. 288, paragrafo 4, TFUE, la decisione della Commissione, una volta intervenuta – e fin tanto che non venga rimossa nei modi previsti (profilo sul quale si tornerà poco più avanti) – è, peraltro, obbligatoria in tutti i suoi elementi (dunque, anche in relazione alla qualificazione della misura come aiuto di Stato) nei confronti dello Stato destinatario. L’obbligatorietà vale per tutti gli organi dello Stato, compresi i giudici (Corte di giustizia, 13 febbraio 2014, in causa C69/13, Mediaset s.p.a.), imponendo loro – in base al principio di “primazia” del diritto dell’Unione – di non applicare le norme interne contrastanti (che potrebbero ostacolare, cioè, l’attuazione della decisione stessa) (in termini generali, Corte di giustizia, 21 maggio 1987, in causa 249/85, Albako). Si tratta di conclusione recepita in modo uniforme anche dalla giurisprudenza della Corte di 2
Editoriale Comuni d’Italia / 12_2020
cassazione (tra le altre, sez. lav., 5 settembre 2013, n. 20413; sez. V civile, 12 settembre 2012, n.
15207; sez. V civile, 11 maggio 2012, n. 7319)1.
Sotto tale aspetto, le domande da porsi nella pratica concernono proprio la sussumibilità di tali
interventi negli aiuti di Stato di soggetti che svolgono attività di impresa, riferendosi per tale ai
sensi del diritto UE in materia di concorrenza quei soggetti che svolgono attività economica di
scambio di beni o servizi sul mercato2.
Ci si è chiesti inoltre se ciò integri la fattispecie qui considerata, con riferimento all’attività finanziata
e a prescindere dalla forma giuridica, dalla finalità lucrativa o non lucrativa, dalla forma o fonte di
finanziamento, con riguardo ai soggetti che traggono un vantaggio diretto o indiretto dalla misura
prevista dall’atto (vale a dire i beneficiari, diretti o indiretti, della misura) svolgono una attività
economica. Va ricordato che un regime siffatto deve essere escluso ove questi non offrono beni o
servizi3 in un mercato, o il corrispettivo che ricevono non rappresenta una retribuzione4 per l’attività
svolta, ovvero agiscono esercitando il potere d’imperio5 dato che l’attività in questione è un compito
che rientra nelle funzioni essenziali dell’autorità pubblica o è ad esse connessa per la sua natura,
per il suo oggetto e per le norme cui essa è soggetta, oppure svolgono attività/forniscono servizi
organizzati su base solidaristica6, finanziati prevalentemente dalle casse pubbliche e il cui eventuale
corrispettivo pagato dal fruitore dell’attività/servizio copre solamente una frazione del suo costo
effettivo e non rappresenta una retribuzione per l’attività/il servizio svolto. Deve parimenti escludersi
ove questi soggetti svolgono attività di ricerca quali: attività di formazione volta a ottenere risorse
umane meglio qualificate; attività di ricerca svolta in maniera indipendente e volta all’acquisizione
di maggiori conoscenze e di migliore comprensione, inclusa la ricerca collaborativa; attività di
ampia diffusione dei risultati della ricerca su base non esclusiva e non discriminatoria; attività di
trasferimento di conoscenze i cui utili sono reinvestiti interamente nelle predette primarie attività
non economiche7; il finanziamento è concesso per la costruzione, l’estensione, l’ammodernamento,
la gestione o l’utilizzo di infrastrutture che non sono intese ad essere sfruttate per fini commerciali
(1) La Comunicazione 2009/C 85/01 sostituisce una ben nota e più risalente Comunicazione del 1995 relativa alla cooperazione
tra i Giudici nazionali e la Commissione in materia di aiuti di Stato che, come osservato dalla dottrina, aveva suscitato scarso
inte-resse fra i Giudici nazionali. E pur, tuttavia, alla luce del c.d. State Aid Action Plan del 2005 (Saap, secondo l’acronimo anglo-
sassone), la Commissione ha voluto rafforzare questa for-ma di collaborazione, precisando il ruolo decisivo del Giudice nazionale
nell’assicurare la tutela giurisdizionale.
(2) Vedi ad esempio, Corte di giustizia UE (CGUE), 12.9.2000, Pavlov e altri, Cause riunite da C-180/98 a C-184/98: “qualsiasi
ente che esercita un’attività economica, a prescindere dal suo stato giuridico e dalle sue modalità di finanziamento”. La Co-
municazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’art. 107, par. 1, Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea (2016/C 262/01), punto 2, disponibile al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CE-
LEX:52016XC0719(05)&from=EN, può fornire un utile supporto.
(3) L’art. 57 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) definisce i servizi come “prestazioni fornite normal-
mente dietro retribuzione”.
(4) La retribuzione non deve necessariamente provenire dall’utente/destinatario della prestazione e, pertanto, anche servizi
offerti gratuitamente agli utenti possono essere attività economiche.
(5) Tali attività comprendono ad esempio: le forze armate o le forze di pubblica sicurezza; la sicurezza e il controllo della
navigazione aerea, la sicurezza e il controllo del traffico marittimo; la sorveglianza antinquinamento; l’organizzazione, il finan-
ziamento e l’esecuzione delle sentenze di reclusione; la valorizzazione e il rilancio di terreni pubblici da parte delle autorità
pubbliche; la raccolta di dati da utilizzare a fini pubblici basata su un obbligo legale di dichiarazione imposto alle imprese
interessate (vedi punti 17 e 18 della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato - 2016/C 262/01 - di-
sponibile al seguente link: https://eur- lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0719(05)&from=EN).
(6) Possono rientrare in tale casistica, ad esempio, i regimi di sicurezza sociale, i sistemi di assistenza sanitaria, l’istruzione
quando sono organizzati su base solidaristica (vedi punti da 19 a 30 della Comunicazione della Commissione sulla nozione
di aiuto di Stato - 2016/C 262/01 - disponibile al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CE-
LEX:52016XC0719(05)&from=EN).
(7) Vedi punti 31 e 32 della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato (2016/C 262/01) disponibile al
seguente link: https://eur- lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0719(05)&from=EN.
3Comuni d’Italia / 12_2020 Editoriale
perché si tratta di una infrastruttura che non è utilizzata per offrire beni o servizi su un mercato 8
; il finanziamento è concesso per la costruzione, l’estensione, l’ammodernamento, la gestione o
l’utilizzo di infrastrutture che sono utilizzate sia per attività di natura economica che per attività di
natura non economica (uso misto), ma:
- l’uso economico rimane puramente accessorio in quanto l’attività economica è connessa
diret tamente o è necessaria o è intrinsecamente legata all’utilizzo non economico
dell’infrastruttura9, e
- l’attività economica rimane di portata limitata in termini di capacità dell’infrastruttura, condizione
che si presume quando la capacità assegnata ogni anno all’attività economica10 non supera il
20% della capacità annua complessiva dell’infrastruttura.
Lo stesso concetto di contributo ha evidentemente risentito di questa “trasformazione” funzionale.
Come è noto, infatti, secondo la giurisprudenza11, il provvedimento con cui si dispone in ordine
a un contributo ha natura di concessione, con la conseguenza che il relativo atto di erogazione
materiale non può essere valutato alla stregua dell’adempimento di una obbligazione meramente
civilistica, bensì deve essere valutato come un fatto rilevante nell’ambito di un rapporto di natura
preminentemente pubblicistica, tenuto altresì conto che, spesso, le leggi disciplinanti la subiecta
materia impongono contestualmente, al fine del conseguimento del pubblico interesse, specifici
obblighi a carico del beneficiario, il cui inadempimento può dar luogo alla comminatoria di
decadenza dal detto contributo, in guisa che l’attività amministrativa finalizzata alla concessione
dei contributi ex art. 12 della legge n. 241/1990, si muove in ambiente pubblicistico12.
È noto al riguardo che l’art. 12 della citata legge dispone “l’obbligo di predeterminare criteri
e modalità; ma ciò non significa affatto che si tratti di esercizio di poteri amministrativi, ché la
predeterminazione di criteri e modalità dell’erogazione può avvenire senz’altro nell’ambito di
attività negoziale”.
Anche sotto il profilo testuale, l’art. 12 della legge n. 241/1990, prescrive, al secondo comma, che i
“singoli provvedimenti” di cui al primo comma (i provvedimenti di concessione) devono esplicitare
l’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di intervento. Praticamente, la disposizione impone
l’adozione di singoli provvedimenti concessori (a fronte di ogni erogazione) che diano contezza del
rispetto delle regole procedimentali. Questa penetrante motivazione per ciascun provvedimento
finale, si spiega con il fatto che nella gestione delle risorse, della collettività, l’interesse dei terzi
è particolarmente forte. Ora la locuzione “provvedimento”, in questa “sedes materiae” (l’art.
12 è, infatti, inserito nel capo III, denominato “Partecipazione al procedimento amministrativo”)
sicuramente intende riferirsi all’esercizio di un potere amministrativo. Se così è, manca, in questa
fattispecie, uno dei presupposti prescritti dall’art. 1, comma 1-bis per rendere applicabile il diritto
privato: e cioè l’assenza di una legge che prescriva il compimento di atti autoritativi13. Di per sé
(8) Non sono utilizzate per offrire beni o servizi sul mercato quelle infrastrutture di ricerca nelle quali si svolge attività di
formazione volta a ottenere risorse umane meglio qualificate; attività di ricerca svolta in maniera indipendente e volta all’ac-
quisizione di maggiori conoscenze e di migliore comprensione, inclusa la ricerca collaborativa; attività di ampia diffusione
dei risultati della ricerca su base non esclusiva e non discriminatoria; attività di trasferimento di conoscenze i cui utili sono
reinvestiti interamente nelle predette primarie attività non economiche (vedi punto 203 della Comunicazione della Commis-
sione sulla nozione di aiuto (2016/C262/01) di Stato (2016/C, 262/01) disponibile al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0719(05)&from=EN).
(9) Questa condizione si può ritenere soddisfatta se le attività economiche in questione necessitano degli stessi fattori pro-
duttivi (quali materiali, attrezzature, manodopera e capitale fisso) delle attività principali non economiche).
(10) Vedi punti da 205 a 207 della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato (2016/C, 262/01) disponi-
bile al seguente link: https://eur- lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0719(05)&from=EN.
(11) TAR Sicilia, Catania, 11 settembre 2001, n. 1596
(12) Cfr. TAR Lazio, sez. IlI-ter, 8 marzo 2004, n. 2159
(13) E. Bruno, G. Fuoco, L’art. 1, comma 1-bis della legge n. 241/1990. Alla ricerca delle proprietà alchemiche del diritto privato, in Lxitalia.it.
4Editoriale Comuni d’Italia / 12_2020
l’intero sistema normativo dei contributi e ausili finanziari rappresenta una “deroga al principio di
eguaglianza: non tutti gli interessati possono beneficiarne, stante la limitatezza delle risorse”14.
Ed è proprio per questo, che essa prevede una predeterminazione e pubblicazione, dei criteri e
delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi nell’erogazione e che formeranno
poggetto della valutazione nell’esercizio dei suoi poteri di controllo.
Come noto, la vincolatività della regola con cui l’amministrazione ha inteso autolimitarsi determina
un qualificato affidamento nei soggetti che rientrano nelle previsioni erogatorie circa il rispetto
delle procedure: la predeterminazione e pubblicazione dei criteri e modalità cui le amministrazioni
devono attenersi, soddisfa infatti l’esigenza di trasparenza dell’azione amministrativa15.
Ogni “elargizione” di denaro pubblico, deve esser infatti ricondotta a rigore e trasparenza
procedurale e l’amministrazione agente, non può considerarsi, quindi, operante in piena e assoluta
libertà (non da ultimo anche con intenti anticipatori di contenziosi).
Emerge dal complesso normativo quindi, che tale potere discrezionale deve rispondere al principio
di pubblicità adeguata: l’erogazione non può prescindere da una prima fase nella quale la p.a.
stabilisce le regole e una successiva fase di pubblicità per far conoscere alla generalità dei soggetti
portatori di interessi lo scopo dell’amministrazione che consente di acquisire delle risorse a fronte
di una serie di requisiti prestabiliti. L’onere di pubblicità di un procedimento, volto all’erogazione di
finanziamenti pubblici, è legittimamente assolto con la pubblicazione di un avviso volto a rendere
nota l’esistenza di detto procedimento, e tale pubblicità deve avere la garanzia di raggiungere un
numero di soggetti potenzialmente assegnatari, possa cioè rispondere alla domanda in relazione
alle previsioni disposte nell’avviso.
Attraverso l’avviso, la pubblicità, si persegue inoltre l’obiettivo di rendere partecipe il più alto
numero di soggetti al beneficio, imponendo alla p.a. di stabilire dei parametri soggettivi ed
oggettivi certi e precostituiti (criteri) per dar corso ai benefici attenendosi alle proprie determinazioni
procedurali (modalità).
Insomma, l’azione amministrativa locale ha recuperato ai giorni nostri modelli e vicende che
sembrava appartenessero a un lontano passato, in cui i Comuni si avvalevano addirittura di strutture
dedicate ad hoc (l’ECA, ente comunale di assistenza), e per finalità puramente assistenziali e di
sopravvivenza alimentare (di cui si occupa nello specifico il Formulario a cura di Maurizio Lucca,
proponendo schemi d’atto di erogazione di contributi alimentari in epoca COVID-19). In pratica,
il panorama dei provvedimenti comunali si è arricchito di una serie di sfaccettature, che spaziano
dalle finalità di carattere meramente assistenziali, a finalità di sostegno alle attività no profit (e
più in generale, come dice l’art. 113-bis del Tuel, ai servizi sociali, educativi e del tempo libero), a
quelle infine, di carattere assolutamente innovativo, di stimolo all’economia.
Sulla base di queste coordinate, il numero di Comuni d’Italia propone una serie di interrogativi cui,
in primo luogo, un pregevole articolo di Maurizio Lucca e Massimo Venturato (in questa Rivista,
11/2020) cercano di dare una prima serie di risposte e soluzioni. La fattispecie qui illustrata, le sue
criticità, e la sua sussunzione nel regime normativo degli aiuti di Stato nella fase di emergenza
epidemiologica da COVID-19 viene compendiato inoltre nell’ottimo lavoro di Rossana Mininno che
ospitiamo (in questa Rivista, 11/2020). Non mancano tuttavia gli evidenti e intuibili rischi di una
siffatta estensione oggettiva della sfera di azione del Comune, magari in ambiti non consentiti dalla
disciplina costituzionale e comunitaria, o confliggendo con alcuni principi, come quello di libera
concorrenza: li mette in evidenza, suggerendo una serie di considerazioni di ordine sistematico,
lo scritto puntuale di Alberto Mingarelli.
(14) R. Villata, op. cit., p. 1556.
(15) Corte dei conti, sez. contr., 10 maggio 1993, n. 76.
5Comuni d’Italia / 12_2020 Editoriale In questo ultimo senso, fondamentale – per la stessa tenuta del bilancio del Comune – appare l’analisi approfondita dell’articolo di Vincenzo Giannotti (in questa Rivista, 11/2020) sulla destinazione delle risorse trasferite agli enti locali (c.d. “fondone”) da parte dello Stato, e in particolare sulla disamina delle criticità della relativa certificazione. Infine, in diretto collegamento con il profilo suaccennato di finanziamento eteronomo, l’interessantissimo pezzo di Massimiliano Alesio dal titolo, indubbiamente suggestivo, di “contributi comunali di emergenza pandemica” (in questa Rivista, 11/2020), intende coltivare l’ambizione di analizzare le erogazioni di qualsivoglia vantaggio economico, che i Comuni sono stati legittimati a corrispondere in base alla legislazione emergenziale, posta in essere in correlazione, diretta ed indiretta, con la pandemia da COVID-19. L’ambito dell’analisi è stato circoscritto ai contributi di natura “autonoma”, cioè a quelle erogazioni che, pur essendo finanziate da risorse statali, sono state demandate alla discrezionale definizione e corresponsione degli Enti Locali. Siffatti contributi presentano peculiari caratteri (erogazioni effettuate direttamente dai Comuni; connessione con l’emergenza pandemica; finanziamento eteronomo; discrezionalità nella predeterminazione dei criteri di dettaglio) e consistono in variegati interventi: dalle misure di solidarietà alimentare, connotate da assoluta e stringente emergenzialità, alle forme di finanziamento dei Centri estivi diurni, per pervenire, poi, al c.d. “Fondo COVID zone rosse”, foriero di rilevanti spunti di interpretazione. Siamo, forse, in presenza di una categoria nuova ed in parte autonoma di contributi, destinata a non esaurirsi, in conseguenza del perdurare dell’emergenza. Anche per tale ragione, converrà ancor più sviluppare l’approfondimento, sui profili specifici attinenti la scansione procedimentale, ma anche sulla destinazione delle risorse attribuite per superare l’emergenza: e proprio in riferimento a ciò lo studio intende porre in essere un utile spunto di iniziale riflessione. Non rimane quindi che constatare come l’apporto esterno alla finanza locale diventa essenziale in quest’epoca in cui le risorse scarseggiano ancora di più a causa delle note vicende pandemiche: siamo ben lontani dall’epoca in cui si predicava, con la legge 42/2009, la piena autosufficienza della finanza comunale e la responsabilizzazione completa nel reperimento delle risorse. Ma ciò non toglie che vi debba essere una (per usare un eufemismo) diligenza effettiva e attiva anche nella ricerca di quei fondi europei , non solo di quelli cui il nostro Paese attingerà nel periodo entrante: lo mettono in fondo in evidenza, Giorgia Marinuzzi e Walter Tortorella con uno studio accurato relativo a un’analisi di fine periodo riferita ai Comuni italiani beneficiari dei Fondi strutturali UE 2014/2020 (in questa Rivista, 11/2020). Leggendo invece, (e qui passiamo ad altro argomento) l’ulteriore articolo di Maurizio Lucca sui termini di pubblicazione, il diritto all’oblio e i costi dell’accesso mi sono peraltro venute alla mente le posizioni oscillanti che su un punto cruciale, quello della esecutività degli atti dei Comuni, si sono avvicendate in questi anni: con l’auspicio che queste cose siano ben conosciute a chi sta scrivendo in questo periodo la riforma del Testo unico enti locali e che parta da questi mattoncini per realizzare in modo soddisfacente il nuovo impianto normativo. Occorre dare conto al riguardo della previsione generale dell’art. 134 del Tuel, commi 13, a mente del quale: “1. La deliberazione soggetta al controllo necessario di legittimità deve essere trasmessa a pena di decadenza entro il quinto giorno successivo all’adozione. Essa diventa esecutiva se entro 30 giorni dalla trasmissione della stessa il Comitato regionale di controllo non trasmetta all’ente interessato un provvedimento motivato di annullamento. Le deliberazioni diventano comunque esecutive qualora prima del decorso dello stesso termine il Comitato regionale di controllo dia comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità. 2. Nel caso delle deliberazioni soggette a controllo eventuale la richiesta di controllo sospende l’esecutività delle stesse fino all’avvenuto esito del controllo. 3. Le deliberazioni non soggette a controllo necessario o non sottoposte a controllo eventuale diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione. (...)”. 6
Editoriale Comuni d’Italia / 12_2020
Detta pubblicazione è prevista dall’art. 124 del d.lgs. n. 267/2000 per le delibere degli organi
di governo dell’ente territoriale, quali Consiglio e Giunta municipali, e costituisce – tra l’altro –
segmento procedurale il cui adempimento è preordinato a far conseguire l’esecutività all’atto
stesso16.
Devo dire che a volte ho provato spesso autentico imbarazzo a rispondere alla domanda circa il
momento di esecutività della delibera o di una determina di un ente locale. Come è noto infatti,
l’indirizzo giurisprudenziale assolutamente prevalente e la tesi maggioritaria seguita dalla prassi e
dalla maggior parte degli autori17 ricollega l’esecutività al computo dall’inizio della pubblicazione: in
buona sostanza, il termine dei dieci giorni decorre dalla pubblicazione della deliberazione secondo
le modalità con cui la stessa pubblicazione si realizza, cioè a partire dalla materiale pubblicazione
sull’albo dell’Ente, come previsto ora dall’art. 124, comma 1, TUEL. Una tesi siffatta, che si ricollega
alla fase di prima applicazione della legge n. 142 del 1990, in cui il termine di cui all’art. 47 della
l. n. 142, ora trasfuso nel citato art. 134, attiene alla esecutività dell’atto e non alla pubblicità,
per la quale viene previsto un termine diverso, corrisponde al termine di dieci giorni. Ne deriva,
quindi, che l’art. 134, comma 3, TUEL, opera in relazione agli effetti giuridici della esecutività
delle delibere, mentre l’art. 124, comma 1, stabilisce il termine obbligatorio di pubblicazione di 15
giorni consecutivi, dal cui decorso e perfezionamento al 15° giorno consegue una presunzione di
conoscenza, e decorre – a pena di decadenza il termine di 60 gg. per proporre impugnazione da
parte dei terzi18; in relazione a ciò presupposto per l’impugnazione dei provvedimenti amministrativi
è la loro conoscenza da parte degli interessati, che per gli atti generali soggetti a pubblicazione
si verifica al termine fissato per legge dalla pubblicazione19, non rilevando ai fini della conoscenza
dell’atto “il termine di pubblicazione di dieci giorni fissato dall’art. 134 del TUEL […] atteso che
questo è fissato unicamente a determinare il termine di inizio di esecutività […] e non quello di
conoscenza delle deliberazioni stesse”20.
È noto tuttavia che, secondo una tesi minoritaria, che si fonda su un parere del Ministero dell’interno
(in data 13 settembre 2006) rimasto assolutamente isolato nella prassi dei Comuni, “il computo
iniziale dei 10 giorni debba compiersi con riferimento al termine della pubblicazione da effettuarsi
per 15 giorni”. Secondo il Ministero dell’interno, infatti, va condiviso l’orientamento della Corte di
Cassazione in base al quale solamente “alla scadenza del quindicesimo giorno il subprocedimento
di pubblicazione è perfezionato e le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità
alla scadenza del decimo giorno dalla eseguita pubblicazione, divengono esecutive”21. Va peraltro
notato che ora la norma dell’art. 124 del TUEL prevede testualmente l’esplicito riferimento alla
pubblicazione anziché all’affissione.
Non è fuor di luogo ricordare che, in passato, proprio il Ministero dell’interno aveva invece chiarito,
in risposta a un quesito, che le delibere “diventano esecutive dopo il decimo giorno dal primo
giorno della loro pubblicazione”22.
C’è da chiedersi, inoltre, se l’orientamento giurisprudenziale secondo cui “ai fini del compimento
del periodo di affissione indicato dall’art. 124 TUEL e in relazione ad ogni effetto giuridico connesso
(16) TAR Toscana, sez. II, n. 2833/2004; Cons. Stato, sez. V, n. 762/2004.
(17) Cfr. per la completa ricostruzione T. Tessaro, Gli atti amministrativi del Comune, Maggioli, Rimini, 2010, p. 307 ss., nonché
dello stesso Autore, L’albo pretorio on line, Maggioli, Rimini, 2010, p. 237.
(18) TAR Campania, Salerno, sez. I, n. 742/2007; TAR Lombardia, Milano, sez. I, n. 5008/2007; TAR Liguria, Genova, sez. I, n.
566/2007.
(19) Parere ANCI 146/UC/SD, 24 settembre 2007.
(20) TAR Lazio, sez. II, n. 6506/2002.
(21) Cass. civ., sez. I, n. 4397/1999.
(22) Circ. Ministero dell’interno, 15 ottobre 1990.
7Comuni d’Italia / 12_2020 Editoriale all’affissione, il giorno iniziale non può non restare compreso nel periodo, atteso che esso, come, peraltro, si ricava espressamente dal testo della norma, è uno dei giorni utili alle finalità (conoscenza legale per la generalità dei cittadini) dell’affissione stessa”23 vale tuttora per gli Enti locali o deve essere rivisto alla luce dei nuovi principi affermati dalla legge 190/2012, dal d.lgs. 33/2013, dalla ANAC)e dal Garante della privacy. In altri termini, il quesito verte cioè se, ai fini del calcolo del periodo di pubblicazione, debba o meno applicarsi l’art. 155 c.p.c., per il quale “nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l’ora iniziali”. A tale proposito prevale in giurisprudenza la considerazione che ai fini della pubblicazione per 15 gg. sull’albo dell’Ente “il dies a quo del periodo di affissione non può che comprendere il giorno iniziale”24. Ciò innanzitutto sulla base della dizione letterale della norma che indica espressamente il periodo di durata della pubblicazione delle deliberazioni (“sono pubblicate mediante affissione all’Albo pretorio, nella sede dell’ente, per quindici giorni consecutivi”) e secondariamente dell’osservazione che l’applicazione della regola generale di cui agli artt. 2963 c.c. e 155 c.p.c. per i termini processuali incontra un limite oggettivo. In particolare, è stato quindi ritenuto che “detta regola (nel computo del termine si esclude il giorno iniziale) costituisce certamente un «criterio generale per il computo del tempo» ma è data in funzione di un’attività o anche di una utilità per il soggetto, appunto legata al decorso del tempo, si riferisce, cioè, ai termini che assumono come punto di riferimento un evento dal verificarsi del quale acquista rilevanza giuridica l’attività o l’inattività del soggetto interessato e non torna, invece, applicabile allorché una norma di legge prenda in considerazione o assegni rilevanza ad una situazione secondo la sua durata effettiva”25. La questione ha assunto un suo specifico rilievo nella fattispecie relativa all’esecutività delle delibere di ricorso al Piano di riequilibrio, dove la giurisprudenza contabile ha optato per la prima delle descritte posizioni interpretative26, superando il suo stesso orientamento precedente e ritenendo quindi che l’esecutività si consegua al decorso dei 10 giorni dal primo giorno di pubblicazione. Sotto altro profilo, la posizione della giurisprudenza amministrativa secondo cui “la pubblicazione all’albo pretorio del Comune è prescritta dall’art. 124 T.U. n. 267/2000 per tutte le deliberazioni del comune e della provincia ed essa riguarda non solo le deliberazioni degli organi di governo (consiglio e giunta municipali) ma anche le determinazioni dirigenziali, esprimendo la parola “deliberazione” ab antiquo sia risoluzioni adottate da organi collegiali che da organi monocratici ed essendo l’intento quello di rendere pubblici tutti gli atti degli Enti locali di esercizio del potere deliberativo, indipendentemente dalla natura collegiale o meno dell’organo emanante”27, non sembra più avere, nemmeno lontanamente, un sia pur debole aggancio normativo. Come ormai affermato per tabulas dall’art. 23 del d.lgs. n. 33/2013, vi è una sostanziale diversità ontologica tra pubblicazione delle delibere (che assolve come noto una funzione di pubblicità legale, ex artt. 124 e 134 del Tuel) e la pubblicazione delle determine, che adempie in questo caso alla mera funzione di pubblicità notizia. Se, infatti, la norma (art. 23, comma 1) stabilisce che “Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti”, non rimane che concludere che la pubblicazione delle determine dirigenziali non rappresenta affatto, a differenza di quanto stabilito per le delibere (art. 134 Tuel), un caso di pubblicità legale. (23) Cass. civ., sez. I, n. 12240/2004. (24) Cass. civ., sez. I, n. 12240/2004. (25) Cir. Ministero dell’interno, 13 settembre 2006, cit. (26) Corte conti, sez. contr. Campania, n. 23/2020/PRSP. (27) Cons. Stato, sez. V, n. 1370/2006; Id., sez. IV, n. 1129/1977 e n. 3058/2002; TAR Lazio, sez. II, n. 3958/2003. 8
Editoriale Comuni d’Italia / 12_2020
Diversamente opinando, si introdurrebbe un meccanismo di acquisizione dell’esecutività delle
determine – almeno di quelle di impegno – del tutto in contrasto con il dettato normativo (a mente
del quale art. 183, comma 7, del Tuel, “I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano
impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria”).
Già in passato, del resto, l’equiparazione più in generale tra atti collegiali e atti monocratici del
comune era stata esclusa in radice28, anche per la c.d. fase integrativa dell’efficacia: non esisteva,
infatti, l’obbligo di sottoporre i provvedimenti monocratici al vaglio del Comitato regionale di
controllo, né l’efficacia delle ordinanze poteva dipendere da alcuna forma di controllo, o da visti29.
A proposito, anzi, della possibilità di controllo delle determine dirigenziali da parte del Prefetto,
il Ministero dell’interno aveva fatto uso esplicito del principio ubi lex dixit voluit, escludendo la
loro sottoposizione alla forma di verifica anzidetta.
E ancor prima lo stesso Ministero dell’interno (risoluzione 27 marzo 2001, n. 3) aveva affermato
che solo la potestà autonoma dell’ente è competente a disciplinare le forme di pubblicità per le
determinazioni di cui all’art. 183, comma 9, Tuel: tanto più ora che, expressis verbis, solo il Piano
per la prevenzione della corruzione potrà stabilire obblighi ulteriori di pubblicazione (art. 1, comma
9, lett. f), della l. n. 190/2012), anche per ciò che concerne le determinazioni di impegno di spesa.
E infatti, la giurisprudenza più recente 30 ha rilevato che, “pur se le determinazioni dirigenziali
rientrano nella nozione più vasta di deliberazione come riportata dall’art. 124 del TUEL, non si può
affermare lo stesso sull’estensione a queste dei limiti all’esecutività previsti dal seguente art. 134”.
La sentenza del Consiglio di Stato sottolinea in particolare che “se la necessaria pubblicità
dell’azione degli Enti locali, infatti, richiede di applicare ai provvedimenti monocratici le stesse
fondamentali regole di pubblicità degli atti degli organi collegiali, ciò non vuol dire che per gli
stessi valgano anche le disposizioni che riguardano il conseguimento dell’efficacia”31. Diviene, qui,
chiaro lo scopo della previsione normativa volta a garantire la massima diffusione, con i normali
mezzi tecnologici, delle informazioni in questione, in un’ottica di tutela delle risorse pubbliche
cui è dichiaratamente volta la normativa in esame (art. 1 del d.lgs. n. 33/2013). L’argomento
trattato nell’articolo di Maurizio Lucca che spazia anche in altri ambiti peculiari, comunque situati
nel terreno di confine tra diritto di accesso, i suoi costi e quello del diritto all’oblio, si ricollega
idealmente quindi al commento che ospitiamo di Francesco Modafferi, il quale mette in risalto
come, secondo l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, le dichiarazioni, le comunicazioni e gli
atti presentati o acquisiti dagli uffici dell’amministrazione finanziaria, contenenti i dati reddituali,
patrimoniali e finanziari, inseriti nelle banche dati dell’anagrafe tributaria, ivi compreso l’archivio
dei rapporti finanziari, costituiscono documenti amministrativi; l’accesso documentale difensivo
può essere esercitato, indipendentemente dalla previsione e dall’esercizio dei poteri processuali,
da parte del giudice, previsti dal codice di procedura civile (Cons. Stato, Ad. plen., n. 19/2020,
pubblicata il 25 settembre 2020).
Ancora in riferimento alla fattispecie più sopra riferita, ovverosia dell’approvazione dei piani
di riequilibrio finanziario pluriennale, in cui la giurisprudenza costituzionale ha avuto modo di
(28) Cfr. per riferimenti, T. Tessaro, Accesso, informazione, pubblicazione informatica: i nodi della previsione dell’art. 32 della
legge 69/2009 tra facili entusiasmi e inevitabili semplificazioni (prima parte), in La Gazzetta degli Enti Locali, 3.11.2009; Ac-
cesso, informazione, pubblicazione informatica: i nodi della previsione dell’art. 32 della legge 69/2009 tra facili entusiasmi e
inevitabili semplificazioni (seconda parte), in La Gazzetta degli Enti Locali, 5.11.2009.
(29) TAR Campania, Salerno, n. 371/1993; Cons. Stato, sez. V, n. 845/1991.
(30) Cons. Stato, sez. V, n. 515/2015.
(31) Sul punto cfr. T. Tessaro, Esecutività delle determine: era ora. E il nuovo testo unico degli enti locali?, in La Gazzetta degli
Enti Locali, 2.3.2015.
9Comuni d’Italia / 12_2020 Editoriale sottolineare ripetutamente che si tratta di attribuzioni di natura giurisdizionale, in quanto si tratta di funzioni – siano esse relative al controllo che alla giurisdizione – in cui l’attività della Corte dei conti risulta rigorosamente ancorata a parametri legali ( tanto che la stessa attività di controllo è sottoponibile al sindacato giurisdizionale delle Sezioni riunite in speciale composizione, in conformità ai principi contenuti nella sentenza n. 39 del 2014 di questa Corte» (Corte cost. n. 228 del 2017)), si colloca l’ulteriore lavoro di Francesco Modafferi che mette in evidenza la peculiarità dei trattamenti di dati effettuati dall’autorità giudiziaria, nel più vasto ambito del settore pubblico, ma che non rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento 679/2016. Per concludere sul punto ,e su quelli che precedono, in un ideale punto di confluenza: non sarà un male, a mio avviso, che il nuovo Testo unico enti locali si occupi – oltre che del soggetto deputato alla pubblicazione degli atti, e, come detto in precedenza, della disciplina della esecutività degli atti – anche della competenza specifica all’erogazione dei contributi, e cio’ a causa del fatto che nella Penisola si assiste a una vasta gamma di comportamenti; certo, la giurisprudenza ha messo in evidenza come per l’erogazione dei contributi è necessario seguire una vera e propria procedura ad evidenza pubblica, dotata dello stesso rigore di una procedura concorsuale o di appalto, quanto alla coerenza tra presupposti, criteri di valutazione e provvedimento finale, in cui non devono cioè sussistere crasi logiche o motivazionali tra i presupposti ed il provvedimento (che vengano assorbite e/o giustificate nell’area grigia della discrezionalità) per cui quest’ultimo deve essere il prodotto dell’applicazione matematica dei punteggi o dei presupposti desumibili dalla premessa ed esposti all’evidenza pubblica precedentemente i termini per le istanze. Ora il giudice amministrativo32 rimarca che i margini “politici” o discrezionali che l’amministrazione pure possiede e possiede in maniera particolarmente estesa devono essere tutti assolti a livello di regolamentazione della procedura, ossia al momento in cui vengono fissati (e resi noti) i criteri generali che, ex art. 12, l. 241/1990, disciplineranno il procedimento. Sulla scorta di ciò, si sottolinea, non possono quindi più sussistere contributi straordinari, svincolati cioè da situazioni in cui l’attività concessoria posta in essere dalla p.a. è procedimentalizzata, ma essa deve al contrario essere soggetta a precise regole di evidenza pubblica, disposta con atto finale che è un provvedimento autoritativo tipico (ossia assunto in esito all’esercizio di un potere previsto dall’ordinamento) e che, come tale, deve ritenersi priva di alcun margine di discrezionalità, se non nei limiti tecnici imposti dalla necessità di apprezzare adeguatamente elementi di fatto presupposti ed esposti alla fede pubblica nella relativa procedura di evidenza. Ecco che quindi, avendo natura di concessione, si afferma, negli enti locali, esso rientra nella competenza del dirigente o del responsabile apicale della struttura, e non può formare oggetto di deliberazione della Giunta, a pena di nullità, stante la violazione dell’art. 107 del d.lgs. 267/2000, che fonda la c.d. “riserva di gestione” in favore dei dirigenti rispetto agli organi politici. Alla natura di atto di discrezionalità tecnica che necessariamente deve avere il provvedimento di erogazione del contributo consegue che il provvedimento di concessione deve avere carattere “automatico” rispetto alle premesse di evidenza pubblica che ex art. 12, l. 241/1990 dovrebbero preesistergli, ragion per cui è assegnato alla competenza dirigenziale e non alla competenza della Giunta33. Come detto, la prassi dei Comuni non sempre va in questa direzione. E ho netta la sensazione che, anche in questo caso, il Testo unico degli enti locali si lascerà sfuggire l’occasione irripetibile di disciplinare in modo analitico le competenze dirigenziali, e segnatamente quelle in tema di erogazione dei contributi (magari auspicabilmente aggiungendo un punto specifico nella elencazione delle attribuzioni indicate nelle varie lettere dell’art. 107, comma 3, TUEL): a chi (32) TAR Sicilia, Catania, sez. I, del 17 giugno 2005, n. 1032. (33) TAR Sicilia, Catania, sez. I, del 17 giugno 2005, n. 1032. 10
volesse obiettare che si tratta di un mero tuziorismo, si può replicare che in passato il legislatore
si è peritato, ad esempio, di stabilire addirittura (art. 183, comma 9, TUEL) che gli atti di spesa
sono “da definire “determinazioni” e da classificarsi con sistemi di raccolta che individuano la
cronologia degli atti e l’ufficio di provenienza”. Non sarebbe uno scandalo, quindi, scrivere a
chiare lettere chi adotta tali atti: né credo sia sufficiente fare riferimento al fatto che la norma di
cui all’art. 12, legge 241/1990 postula che siano interamente predeterminate le ragioni ed i criteri
che assisteranno l›amministrazione procedente nell›emanazione di provvedimenti concessori di
benefici, in quanto secondo la giurisprudenza pacifica, l’art. 12, l. 7 agosto 1990, n. 241, rivolto
ad assicurare la trasparenza dell’azione amministrativa, si pone come precetto che si atteggia
a principio generale dell’ordinamento e impone che l’attività dell’amministrazione debba non
solo essere preceduta da una adeguata pubblicizzazione dell’avvio del procedimento, ma debba
rispondere a referenti di carattere assolutamente oggettivo, precedenti al singolo provvedimento34.
Insomma, comunque la si guardi, quella della erogazione dei contributi, trattata nel numero, è una
questione di competenza: all’esterno, se si tratti di competenza comunale o, invece, competenza
statale; all’interno, se essa integri una competenza di carattere politico, ovvero invece gestionale.
Sullo sfondo, c’è il significato – autentico e concreto, e non certo figurativo – da attribuire al citato
art. 3 del Tuel (a mente del quale Il comune è l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne
cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo), su cui occorrerà – anche in riferimento alle fattispecie
sopra delineate – interrogarsi: se conservare la norma così com’è, essendo anteriore alla riforma
costituzionale del 2001, oppure se essa richieda un suo adattamento.
Buona lettura
(34) TAR Lazio, sez. III, 8 marzo 2004, n. 2154; ex plurimis, cfr.: TAR Campania, Napoli, sez. V, 2 febbraio 2004, n. 1232; TAR
Puglia, Lecce, sez. II, 2 febbraio 2002, n. 572; Cons. Stato, ad. gen., 28 settembre 1995, n. 95. In dottrina Vipiana, L’autolimite
della pubblica amministrazione, Milano, 1990; Virga, Eccesso di potere per mancata prefissione di parametri di riferimento, in
Scritti in onore di M.S. Giannini, I, Milano, 1998, p. 587.
11Direttore scientifico Via del Carpino, 8 Per ulteriori informazioni
Tiziano Tessaro 47822 Santarcangelo www.periodicimaggioli.it
Magistrato Consigliere di Romagna (RN)
Tel. 0541.628736/8272 - Il pagamento dell’abbonamen-
presso la Corte dei conti, to deve essere effettuato con
sez. Emilia-Romagna Fax 0541.624887
maggioliadv@maggioli.it bollettino di c.c.p. n. 31666589
www.maggioliadv.it intestato a Maggioli s.p.a. –
Direttore responsabile Periodici
Paolo Maggioli
Filiali: Via Del Carpino, 8 – 47822
Milano Santarcangelo di Romagna (RN).
Direzione, amministrazione
Via F. Albani, 21 20149 La rivista è disponibile anche
e diffusione
Milano - Tel. 02.48545811 nelle migliori librerie.
Maggioli Editore
Fax 02.48517108 In mancanza di esplicita revoca,
è un marchio Maggioli s.p.a.
Bologna da comunicarsi in forma scritta
Via del Carpino, 8 – 47822 San-
tarcangelo di Romagna (RN) Galleria del Pincio, 1 – 40126 entro il termine di 45 giorni
Tel. 0541.628111 Bologna - Tel. 051.229439- successivi alla scadenza dell’ab-
Fax 0541.622100 228676 - Fax 051.262036 bonamento, la Casa Editrice,
al fine di garantire la continuità
Roma
Comitato scientifico del servizio, si riserva di inviare
Piazza delle Muse, 8 – 00197
Massimiliano Alesio, Giovanni il periodico anche per il periodo
Roma - Tel. 06.5894164
Balsamo, Daniele Campalto, successivo. La disdetta non sarà
Bruxelles ritenuta valida qualora l’abbo-
Roberto Camporesi, Riccardo
Avenue d’Auderghem, 68 nato non sia in regola con tutti i
Carpino, Caterina Cittadino, Bruxelles - Belgium
Eva Contino, Carla Franchini, pagamenti. Il rifiuto o la restitu-
Tel. +32 27422821 zione dei fascicoli della rivista non
Vittorio Galatro, Luigi Lovec- Mob. +32 493061872
chio, Maurizio Lucca, Leopoldo costituiscono disdetta dell’abbo-
international@maggioli.it namento a nessun effetto.
Mazzarolli, Fabio Melilli, Paola
Menta, Paola Minetti, Alberto I fascicoli non pervenuti posso-
Registrazione
Mingarelli, Paola Morigi, Maria no essere richiesti dall’abbonato
presso il Tribunale di Rimini il
Giuliana Murianni, Riccardo non oltre 20 giorni dopo la rice-
15.3.1967 al n. 25
Nobile, Luigi Oliveri, Francesca zione del numero successivo
Palazzi, Alessandro Petrillo, Maggioli s.p.a.
Alberto Pierobon, Cinzia Renna, Azienda con Sistema di Gestione Note per gli autori
Carlo Saffioti, Agostino Tabarri- Qualità certificato ISO 9001:2015 Chi volesse contribuire con
ni, Tiziano Tessaro, Walter Tor- Iscritta al registro operatori della articoli può inviare icontributi a:
torella, Francesco Tramontana, comunicazione n. di iscrizione al cgalli@maggioli.it
Fabio Trojani, Luciano Vandelli, ROC: 10649
Francesco Verbaro L’Autore dovrà indicare recapito
e qualifica professionale.
Tipografia di stampa
Progetto grafico I manoscritti non pubblicati non
Maggioli SPA - Santarcangelo di
Candida Corsi si restituiscono.
Romagna (RN)
Redazione Condizioni di abbonamento 2020 Tutti i diritti riservati
Via del Carpino, 8 – 47822 San- I prezzi resteranno bloccati È vietata la riproduzione, anche
tarcangelo di Romagna (RN) Tel. al 2019 per tutto il 2020: parziale, del materiale pubblicato
0541.628111 ANNUALE: senza autorizzazione dell’editore.
• Rivista cartacea + digitale: Le opinioni espresse negli
Servizio abbonamenti euro 270,00 (Iva inclusa). articoli appartengono ai singoli
Tel. 0541.628779 • Rivista digitale (pdf): autori, dei quali si rispetta la
Fax 0541.624457 euro 185,00 (Iva inclusa). libertà di giudizio, lasciandoli
abbonamenti@maggioli.it Il prezzo di una copia responsabili dei loro scritti.
www.periodicimaggioli.it della rivista è di euro 53,00. L’autore garantisce la paternità dei
Servizio clienti L’abbonamento alla Rivista dà di- contenuti inviati all’editore manle-
clienti.editore@maggioli.it ritto ad una serie di servizi online vando quest’ultimo da ogni even-
Pubblicità inclusi: archivio storico digitale, tuale richiesta di risarcimento danni
Maggioli ADV - Concessionaria newsletter, l’esperto risponde e proveniente da terzi che dovessero
di pubblicità video corsi online. rivendicare diritti su tali contenuti.
Hanno collaborato a questo numero
Maurizio Lucca Francesco Modafferi
Segretario generale di amministrazioni locali. Dirigente di ruolo del Garante
Alberto Mingarelli per la protezione dei dati personali.
Vice procuratore generale presso Tiziano Tessaro
la Procura Regionale per il Veneto Magistrato Consigliere presso la Corte dei conti, sez. Emi-
della Corte dei conti. lia-Romagna.Puoi anche leggere