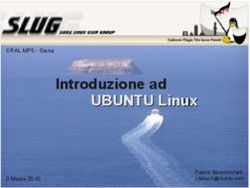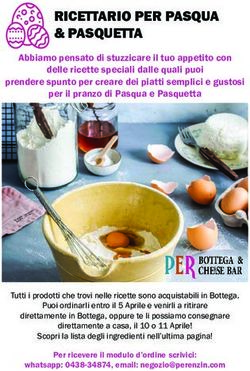Il genio di Leonardo da Vinci, tra Arte e Tecnologia - 500esimo anniversario della morte di Leonardo (1519 - 2019) - Scuola ...
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Il genio di Leonardo da Vinci, tra Arte e Tecnologia
500esimo anniversario della morte di Leonardo (1519 - 2019)
Prof. Manrico Bissi15 aprile 1452: le origini di un ‘’Omo sanza lettere’’
Leonardo nacque il 15 aprile 1452 nella casa padronale dei Da Vinci «So bene assai che, per non essere io
ad Anchiano (Comune di Vinci, presso Firenze). Era figlio illegittimo letterato, a qualcuno di presuntuoso
del notaio Piero Da Vinci e della sua domestica, tale Caterina. Egli fu parrà ragionevolmente di potermi
comunque accolto con benevolenza dalla famiglia, e compì i suoi biasimare per l’essere io omo sanza
primi studi a Vinci, sotto la guida del nonno e degli zii paterni. Parve lettere. Gente stolta! Poiché non
subito un ragazzo molto curioso e di mente vivace, però incline al sanno questi che le mie cose son più
disordine e poco costante nei suoi impegni di studio.
da esser tratte dalla Esperienza, che
d’altrui Parola, la quale esperienza fu
maestra di chi bene scrisse, e così per
maestra io la piglio, e quella in tutti i
casi seguirò».
L. Da Vinci, ‘’Codice Atlantico’’La Firenze di Lorenzo il Magnifico e la bottega del Verrocchio
Negli anni Sessanta del Quattrocento il giovane Leonardo si
trasferì a Firenze presso la famiglia del padre Piero. La città si
trovava ormai governata da Lorenzo de’ Medici, che aveva
investito considerevoli somme di denaro nello sviluppo delle
Arti e nell’abbellimento della propria capitale. In tale contesto,
Leonardo mostrò particolare interesse per il disegno e per il
rilievo, tanto che nel 1469 il padre lo fece entrare in qualità di
apprendista nella bottega dell’artista Andrea del Verrocchio.Il controverso rapporto con il Verrocchio
2
1
BATTESIMO DI CRISTO (Andrea del Verrocchio con
aiuti di Leonardo e Botticelli), 1475-1478
«Per Andrea del Verrocchio, che stava facendo una
tavola dove S. Giovanni battezzava Cristo, Leonardo
lavorò un Angelo, che teneva alcune vesti; e benché
fosse giovanetto, lo condusse di tal maniera che
molto meglio de le figure d'Andrea stava l'Angelo
di Leonardo. Il che fu cagione ch'Andrea mai più
non volle toccar colori, sdegnatosi che un fanciullo
ne sapesse più di lui»
G. Vasari, ‘’Vite dei più eccellenti pittori’’ 1568Il controverso rapporto con il Verrocchio
Angelo del
BATTESIMO DI GESU’
Studio per la manica di un Angelo Studio per drappeggioIl trasferimento nella Milano di Ludovico il Moro
Dai primi anni Ottanta del Quattrocento Leonardo si trova a Milano. Il suo
trasferimento fu probabilmente favorito dal Magnifico, abituato a inviare i
migliori artisti fiorentini in tutte le principali città italiane per celebrare la
grandezza della propria Corte toscana. Lo stesso Leonardo si trovò bene a
Milano: la città era molto meno imbevuta di astrattismo e filosofia, ed anzi
le guerre di Ludovico Sforza (Il Moro) stimolavano alla sperimentazione di
nuovi meccanismi militari e logistici, che tanta
affascinavano la curiosità di Leonardo.L’Uomo come parte di una Natura organica: la Vergine delle Rocce
VERGINE DELLE
ROCCE (Leonardo),
I versione
1483-1486
1 Assenza di aureola
2 Postura delle mani
3 Sguardo espressivo
dell’angelo
1 3 1 3
2 2
VERGINE DELLE
ROCCE (Leonardo),
II versione
1499 circaLa ritrattistica e lo studio dei ‘’moti dell’animo’’
LA GIOCONDA (Leonardo),
1503-1506
LA BELLE FERRONIERE
(Leonardo), 1490-1495
DAMA CON L’ERMELLINO
(Leonardo), 1490 circaLa ritrattistica e lo studio dei ‘’moti dell’animo’’
«Questo vecchio, di poche ore
innanzi la sua morte, mi disse lui
passare i cento anni, e che non si
sentiva alcun mancamento ne la
persona; e così standosi a sedere
in letto nello Spedale di S. Maria
Nova a Firenze, sanza movimento
passò di questa vita. E io ne feci
notomia, per vedere la causa di sì
dolce morte».
(Leonardo, Quaderno di
Anatomia)
STUDIO PER LA
BATTAGLIA DI ANGHIARI
(Leonardo), 1503 DISEGNI DI ANATOMIA (Leonardo)Il capolavoro di Leonardo: l’Ultima Cena «Dette queste cose, Gesù si commosse profondamente e dichiarò: di Gesù. Simon Pietro gli fece un cenno e gli disse: ‘’Di', chi è colui ‘’In verità, in verità vi dico: uno di voi mi tradirà’’. I discepoli si a cui si riferisce’’. Ed egli reclinandosi così sul petto di Gesù, gli guardarono gli uni gli altri, non sapendo di chi parlasse. Ora uno disse: ‘’Signore, chi è?’’. Rispose allora Gesù: ‘’È colui per il quale dei discepoli, quello che Gesù amava, si trovava a tavola al fianco intingerò un boccone e glielo darò’’ (Giovanni 13-21, 13-26)».
Il capolavoro di Leonardo: l’Ultima Cena Nel 1494 Leonardo ricevette l’incarico di dipingere un’Ultima Cena per il refettorio del convento di S. Maria delle Grazie, luogo caro a Ludovico il Moro perché destinato alla celebrazione dinastica della famiglia Sforza. Nella grande chiesa aveva da poco finito di lavorare anche il Bramante. L’Ultima Cena di S. Maria delle Grazie costituisce una summa di tutti gli studi compiuti ida Leonardo in quegli anni (sfumato, prospettiva aerea, moti dell’animo), rappresentandone il capolavoro assoluto.
Il capolavoro di Leonardo: l’Ultima Cena
Andrea Giovanni Tommaso Giuda Taddeo
Giacomo min. Pietro GESU’ Giacomo mg. Matteo
Bartolomeo Giuda Iscariota Filippo Simone
«Dette queste cose, Gesù si commosse profondamente e dichiarò: di Gesù. Simon Pietro gli fece un cenno e gli disse: ‘’Di', chi è colui
‘’In verità, in verità vi dico: uno di voi mi tradirà’’. I discepoli si a cui si riferisce’’. Ed egli reclinandosi così sul petto di Gesù, gli
guardarono gli uni gli altri, non sapendo di chi parlasse. Ora uno disse: ‘’Signore, chi è?’’. Rispose allora Gesù: ‘’È colui per il quale
dei discepoli, quello che Gesù amava, si trovava a tavola al fianco intingerò un boccone e glielo darò’’ (Giovanni 13-21, 13-26)».Il capolavoro di Leonardo: l’Ultima Cena
B
GESU’
A
A
B
«Soleva andar la mattina a buon'ora a montar sul ponte, dal
nascente Sole sino a l'imbrunita sera non levarsi mai il pennello di
mano, ma scordatosi il mangiare e il bere, di continuo dipingere».
Matteo Bandello , Novella LVIII, sec. XVI.Il capolavoro di Leonardo: l’Ultima Cena
B
GESU’
A
A
B
«Soleva andar la mattina a buon'ora a montar sul ponte, dal
nascente Sole sino a l'imbrunita sera non levarsi mai il pennello di
mano, ma scordatosi il mangiare e il bere, di continuo dipingere».
Matteo Bandello , Novella LVIII, sec. XVI.Breve ritorno a Firenze: la ‘’Battaglia di Anghiari’’ Dopo la morte di Lorenzo il Magnifico la città di Firenze si costituì in repubblica sotto il governo di Pier Soderini: questi, nel 1503, affidò a Leonardo, da qualche anno tornato in città dopo il lungo e prolifico soggiorno milanese, l'incarico di decorare una delle grandi pareti del nuovo Salone dei Cinquecento nel Palazzo Vecchio. Si trattava di un'opera grandiosa per dimensioni e per ambizione: la Battaglia di Anghiari, un episodio degli scontri tra esercito fiorentino e milanese avvenuto il 29 giugno 1440. Nel complesso la decorazione doveva quindi celebrare il concetto di Libertà repubblicana, attraverso le vittorie contro nemici e tiranni.
Breve ritorno a Firenze: la ‘’Battaglia di Anghiari’’
Le grandi ‘’lezioni’’ di Leonardo nella Pittura
PROSPETTIVA AEREA
Attraverso l’osservazione diretta, sperimentale, della
Natura, Leonardo comprende che le montagne e i
rilievi in lontananza sfumano in tinte grigio-azzurre,
perché si ‘’mescolano’’ all’aria che si interpone tra
di essi e l’occhio dell’osservatore. Inoltre, secondo
Leonardo, l’aria al suolo è più densa e quindi copre
di più le forme e i colori, mentre quella in alta quota
è più rarefatta e quindi più trasparente.
TECNICA DELLO SFUMATO
Sempre osservando la Natura, Leonardo comprende
che la luce è fatta di ‘’corpuscoli’’ che avvolgono i
contorni di ogni oggetto, annullandoli e sfumandoli
nei colori dell’ambiente circostante. Egli si distacca
dalla scuola pittorica fiorentina, che dava grande
importanza al disegno dei contorni, anticipando la
resa della luce che sarà propria dei Macchiaioli.
FISIOGNOMICA
Si ritiene che Leonardo abbia sezionato almeno 30
cadaveri per studiare la struttura e il funzionamento
del corpo umano. Da queste osservazioni, egli ricavò
una restituzione assai realistica dei muscoli facciali,
con i quali ha reso in maniera assai efficace i volti e
le espressioni dei personaggi rappresentati.Leonardo, il grande ‘’ingegnere’’: il pedalò
Leonardo, il grande ‘’ingegnere’’: l’automobile
Leonardo, il grande ‘’ingegnere’’: i cuscinetti a sfera
Leonardo, il grande ‘’ingegnere’’: le chiuse fluviali
A
B
Verso la metà del Quattrocento, venne messo in opera un sistema di
conche che permetteva le comunicazioni fra bacini di diverso livello.
Contrariamente all'opinione comune, Leonardo non è autore dei Navigli,
bensì uno dei numerosi ingegneri che li hanno studiati e perfezionati. Tra C
il 1506 e il 1513 Leonardo da Vinci infatti studiò la conca del naviglio di
S. Marco. Il suo progetto consisteva nell'allacciare il Naviglio Martesana
alla cerchia interna dei Navigli attraverso le due chiuse, di S. Marco e
dell'Incoronata; in questo modo si sarebbe potuta attraversare la città
via acqua, e in prospettiva collegare l'Adda al Ticino. Da notare un'idea
originale di Leonardo: il portello inferiore, manovrabile dall'alzaia, per
diminuire o aumentare la portata dell'acqua.Approfondimento: tracce leonardesche nel Piacentino «Vedesi nelle montagne di Parma e Piacentia le moltitudini di nichi e coralli intarlati, ancora appiccicati alli sassi, de’ quali quand’io facevo il gran cavallo di Milano, me ne fu portato un gran sacco nella mia fabbrica da certi villani». L. Da Vinci, Codice Leicester, foglio 9r
Approfondimento: tracce leonardesche nel Piacentino
La Madonna di Camaldoli, della
seconda metà del Quattrocento,
venne eseguita a più mani nella
bottega del Verrocchio: lo storico
Carlo Starnazzi vi ha riconosciuto
la mano giovanile di Leonardo. Al
Botticelli sembra invece risalire il
disegno della cornice eseguito sul
retro della tavola, molto simile
alla cornice dorata del famoso
Tondo botticelliano conservato a
Piacenza. Anche il Botticelli seguì
l’apprendistato dal Verrocchio.Approfondimento: tracce leonardesche nel Piacentino
«Piacenza è terra di passo, come
Fiorenza»
L. Da Vinci, Codice Atlantico
Durante il suo soggiorno milanese, Leonardo si propose ai
fabbriceri del Duomo di Piacenza come scultore per fondere
le nuove porte bronzee della Cattedrale, in sostituzione dello
scultore Ambrogio Ferrero già incaricato del progetto. La
proposta del genio fiorentino rimase, purtroppo, inascoltata.Il genio di Leonardo da Vinci, tra Arte e Tecnologia
500esimo anniversario della morte di Leonardo (1519 - 2019)
Prof. Manrico BissiPuoi anche leggere