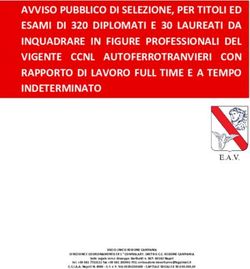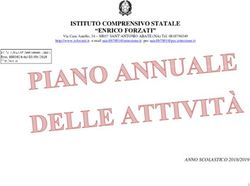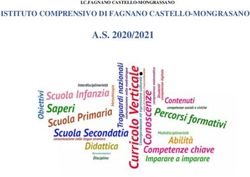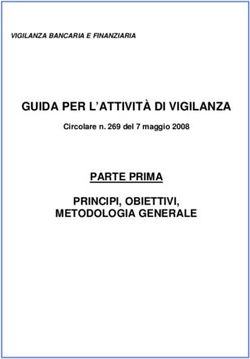DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5 BSU - ESAME DI STATO A.S. 2017-2018
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA “DANIELE CRESPI”
Liceo Internazionale Classico e Linguistico VAPC02701R
Liceo delle Scienze Umane VAPM027011
Via G. Carducci 4 – 21052 BUSTO ARSIZIO (VA)
Tel. 0331 633256 - Fax 0331 674770 CertINT® 2012
www.liceocrespi.gov.it E-mail: comunicazioni@liceocrespi.it
C.F. 81009350125 – Cod.Min. VAIS02700D
ESAME DI STATO A.S. 2017-2018
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5 BSU
INDICE DEL DOCUMENTO
Indice del documento pagina 1
Composizione del Consiglio di Classe pagina 2
Presentazione della Classe e suo percorso storico pagine 3-6
Sintesi del percorso formativo pagina 7
Obiettivi trasversali effettivamente conseguiti pagina 8
Attività curricolari ed extracurricolari pagine 9-10
Programma disciplinare di Religione Cattolica pagine 11-12
Programma disciplinare di Italiano pagine 13-17
Programma disciplinare di Latino pagine 18-22
Programma disciplinare di Storia pagine 23-27
Programma disciplinare di Filosofia pagine 28-32
Programma disciplinare di Scienze Umane pagine 33-41
Programma disciplinare di Inglese pagine 42-46
Programma disciplinare di Spagnolo pagine 47-49
Programma disciplinare di Matematica pagine 50-51
Programma disciplinare di Fisica pagine 52-54
Programma disciplinare di Storia dell’Arte pagine 55-56
Programma disciplinare di Scienze pagine 57-61
Programma disciplinare di Scienze Motorie pagine 62-63
Alternanza scuola lavoro pagine 64-67
Simulazioni delle prove d’Esame pagine 68-84
Allegati - Indice pagina 85
Allegato 1 - Prima prova: griglia di valutazione pagina 86
Allegato 2 - Seconda prova: griglia di valutazione pagina 87
Allegato 3 - Terza prova: griglie di valutazione pagina 88
Allegato 4 - Griglia di Istituto per il colloquio dell’Esame di Stato pagina 89
Allegato 5 - Allegato riservato ai sensi della l. 104/92
1COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Docente Coordinatore della Classe: prof. Marzio Consani
Docente Materia / e Firma del Docente
Nicola Paolillo Religione
Marzio Consani * Italiano
Anna Barbatti Latino
Elena Verderio Storia - Filosofia
Marisa Merola # Inglese
Valentina Campiglio Spagnolo
Marina Celora Matematica – Fisica
Marco Falciola * Storia dell’arte
Giuseppe Scattarreggia Scienze naturali
Giuseppe Lombardo Scienze umane
Michele Lo Verme * Scienze motorie
Cristina Boracchi Dirigente Scolastico
* Con l’asterisco sono contrassegnati i Commissari interni d’Esame
# dal 14/12/2017
Rappresentanti di classe (studenti) Firma del Rappresentante di classe
Alessia Maino
Chiara Pavan
2PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO PERCORSO STORICO
1 Babolin Alice 15 Mastorgio Martina
2 Bassi Alessia 16 Menzaghi Greta
3 Bellizzi Matteo 17 Moglia Stefano
4 Buttol Letizia 18 Mosca Federica
5 Caccia Viola 19 Nava Sara
6 Cavinato Alessia Jasmine 20 Orto Giulia
7 Ceriotti Giulia 21 Pante Federica
8 Crosta Francesca 22 Pavan Chiara
9 Fantin Sara 23 Puricelli Chiara
10 Fimiani Alice 24 Rampinini Beatrice
11 Flora Elkida 25 Tartaglia Elena
12 Ghiringhelli Giada 26 Testa Francesca
13 Lunardi Martina 27 Toniolo Alice
14 Maino Alessia
Numero complessivo degli studenti: 27 alunni
Risultato dello scrutinio finale dell’anno scolastico precedente:
N° studenti N° promossi con debito
N°totale studenti N°studenti promossi
non promossi formativo
28 21 1 7
La classe 5BSU, attualmente composta da 27 allievi, 25 ragazze e 2 ragazzi, nel corso del
quinquennio si è così modificata:
all’inizio della prima liceo gli alunni erano 28, alla fine dell’anno 2 studenti non sono stati ammessi
alla classe successiva.
In seconda, la classe era costituita da 28 studenti poiché 2 allievi si sono inseriti all’inizio dell’anno,
1 proveniente da questo istituto e 1 da altro istituto. Al termine dell’anno scolastico tutti gli
studenti sono stati ammessi alla classe successiva (21 promossi a giugno, 7 dopo verifiche per
sospensione di giudizio).
3All’inizio della terza liceo la composizione della classe risultava immutata. Al termine dell’anno
scolastico tutti hanno avuto accesso alla classe successiva (26 promossi a giugno, 2 dopo verifiche
per sospensione di giudizio).
In quarta la classe risultava così costituita da 28 alunni. 27 alunni vengono ammessi alla classe
successiva (21 promossi a giugno, 6 dopo verifiche per sospensione di giudizio); 1 studente non
viene ammesso alla classe successiva.
Attualmente la classe si compone di 27 alunni.
Relazione del coordinatore classe 5bsu
Nel corso degli anni, gli studenti hanno mantenuto con i docenti un rapporto corretto e rispettoso,
assumendo un atteggiamento complessivamente adeguato nei confronti dell’impegno
scolastico.
Se la maggior parte degli alunni risulta diligente e volenterosa, non altrettanto soddisfacente è
apparsa la partecipazione attiva e propositiva all’attività didattica, ma ciò sembra dovuto
soprattutto ad una naturale ed innata riservatezza, unita ad un certo timore di mettersi in gioco di
fronte a insegnanti e compagni. Alla luce di ciò, i docenti della classe hanno sollecitato gli studenti
ad una maggiore partecipazione, e la situazione, particolarmente nell’ultimo biennio, è andata
progressivamente migliorando, sebbene in modo diversificato tra le discipline.
Complessivamente, soprattutto nel triennio, si è salvaguardata spesso la continuità didattica in
molte discipline (fra cui quella di indirizzo), ma appare necessario sottolineare che la classe ha
cambiato insegnante di inglese ogni anno.
Per quanto riguarda il rendimento, alcuni alunni hanno raggiunto, grazie ad uno studio
approfondito e sistematico, un rendimento buono od eccellente in tutte le discipline, altri hanno
ottenuto risultati discreti, anche se talora diversificati, a seconda delle materie per cui sono più
portati o che prediligono, mentre pochi altri mostrano ancora qualche difficoltà nell’applicare
correttamente le regole studiate e nell’utilizzare le conoscenze acquisite in maniera autonoma e
critica; tuttavia, anche costoro sono riusciti a conseguire risultati complessivamente sufficienti ed
appaiono in grado di affrontare adeguatamente le prove dell’Esame di Stato.
La Programma del Consiglio di classe ha tenuto conto anche dei Bisogni Educativi Speciali degli
alunni interessati apportando le opportune misure compensative e/o dispensative per un
apprendimento più efficace.
4Nel corso del quinquennio, la classe ha avuto l’occasione di approfondire le proprie conoscenze ed
arricchire il bagaglio culturale grazie alla partecipazione alle numerose iniziative proposte dalla
scuola, dal teatro in lingua straniera alla partecipazione a convegni in relazione ai diversi ambiti
disciplinari, dall’educazione alla cittadinanza al dialogo interreligioso, dai progetti Ben-essere alla
partecipazione a gite e visite di istruzione.
Inoltre nell’ambito dell’Offerta Formativa fornita dall’Istituto, gli studenti hanno intrapreso lo
studio della musica nel primo biennio, e ciò ha consentito a molti degli alunni della classe di
conseguire il diploma ABRMS di I grado di teoria musicale, e, a partire dalla classe terza, hanno
avuto la possibilità di affrontare lo studio di una seconda lingua straniera, nel loro caso lingua e
letteratura spagnola.
In particolare il progetto che ha caratterizzato pienamente il loro corso di studi è stato l’Alternanza
scuola-lavoro, dove tutti si sono distinti per impegno, partecipazione e assunzione di
responsabilità in relazione ai diversi contesti nei quali hanno operato. Ciò è stato confermato dai
giudizi positivi espressi dai “tutor aziendali” che li hanno seguiti in questa esperienza,
evidenziando la loro capacità di sapersi “mettere in gioco” e di interagire con i diversi utenti con
cui si sono rapportati.
Il progetto di alternanza scuola –lavoro presenta, infatti, come principale obiettivo quello di
formare lo studente attraverso l’acquisizione di competenze che integrino conoscenze e abilità e
valorizzino inoltre le qualità personali.
L’alternanza si inserisce inoltre fra quelle attività capaci di sviluppare nuovi interessi e consolidare
passioni ancora latenti, portando gli allievi a prefiggersi nuovi obiettivi formativi e professionali e
ad impegnarsi per raggiungere la loro realizzazione.
5CONTINUITÀ DIDATTICA NELLE VARIE MATERIE
Materia 1° 2° 3° 4° 5°
anno anno anno anno anno
Religione X
Italiano X X X
Latino X X X
Storia X X
Filosofia X X
Matematica X X X
Fisica X X
Inglese X
Spagnolo X X X
Scienze X X X
Scienze Umane X X X X
Storia dell’arte X X
Educazione fisica X X X X
Frequenza scolastica
Nel corso dell’ultimo anno la frequenza scolastica di tutti gli alunni è stata regolare.
6SINTESI DEL PERCORSO FORMATIVO
TEMPI SCOLASTICI
Quadro orario settimanale della classe
Materia Ore/settimana
Lingua e lettere italiane 4
Latino 2
Scienze Umane 5
Storia 2
Filosofia* 2
Matematica 2
Fisica** 2
Scienze 2
Storia dell’arte 2
Inglese 3
Seconda lingua: Spagnolo* 2
Scienze motorie 2
Religione 1
Totale 31
* In compensazione oraria è stato deliberato dal MIUR l’inserimento della seconda lingua
straniera spagnolo con riduzione del 20% del monte ore curricolare di Filosofia (nel terzo,
quarto e quinto anno)
** Durante il I quadrimestre sono state dedicate 27 ore di lezione (44% circa del totale) alla
didattica CLIL.
7OBIETTIVI TRASVERSALI EFFETTIVAMENTE CONSEGUITI
OBIETTIVI FORMATIVI
Sono stati conseguiti dalla maggioranza della classe, a diversi livelli, i seguenti obiettivi formativi,
programmati all’inizio dell’anno:
Consolidare il rispetto delle regole concordate
Partecipare democraticamente ed in modo responsabile alle attività di classe.
Potenziare un atteggiamento critico, riflessivo e disponibile al confronto con gli altri.
Analizzare le proprie attitudini ed aspettative in ordine alla scelta universitaria
Tali obiettivi, fissati nella Programma iniziale dell’anno scolastico in corso, si possono considerare
complessivamente raggiunti, seppur a livelli diversificati: quasi tutti gli studenti hanno mostrato
una crescita nella capacità di dialogare e nel rispetto delle regole, alcuni hanno potenziato un
atteggiamento critico-riflessivo nella consapevolezza delle proprie capacità e dei propri limiti.
OBIETTIVI DIDATTICI
I seguenti obiettivi didattici sono stati raggiunti a diversi livelli, anche in virtù di predisposizioni
personali, del metodo di studio adottato e della continuità dell’impegno domestico:
Acquisire organicamente i contenuti ed usare i linguaggi specifici delle varie discipline
Perfezionare un metodo di studio rigoroso e sistematico
Applicare le capacità di selezione, analisi e sintesi
Incentivare la multidisciplinarietà e l’interdisciplinarietà
Contestualizzare problemi e documenti di tipo letterario, storico, filosofico, artistico e socio-
antropologico
8ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI
Classe 3a
prevenzione tossicodipendenze
dialogo interreligioso: tavola rotonda + seminario
FilosofArti di Gallarate: partecipazione alla lezione magistrale di F.Trabattoni e alla
rappresentazione teatrale del dialogo platonico Critone della Compagnia Carlo Rivolta
giornata della memoria: visione dello spettacolo teatrale “Se questo è un uomo” c/o Teatro
Sociale di Busto A. a cura di Educarte
progetto alternanza scuola-lavoro dal 4 al 15 aprile 2016 + corso INAIL sulla sicurezza
progetto green school in collaborazione con la provincia di Varese
Internazionalizzazione (E-twinning)
Corsa campestre (su libera adesione)
Educazione alla cittadinanza: Italiano: discussioni in classe su tematiche d’attualità a sfondo
etico e sociale; Storia: la scoperta dell’altro; Religione: laboratori del dialogo e tavola
rotonda delle religioni; sperimentazioni e riflessioni intorno ai concetti di dialogo, conflitto
e violenza; Scienze umane: compilazione di una relazione relativa alla pratica
dell’osservazione partecipante
Viaggio di istruzione di un giorno a Verona
Classe 4a
Progetto Ben-essere – Educazione alla cittadinanza: partecipazione al seminario sulla
Violenza di genere c/o Molini Marzoli di Busto A.
Giornata della Memoria: visione, analisi e commento del film Freedom Writers
Partecipazione di un gruppo di studenti, su libera adesione, alla conferenza pomeridiana I
giusti ottomani nel genocidio armeno presso il memoriale della Shoah a Milano
FilosofArti, su libera adesione: partecipazione alla Lectio magistralis di Umberto Galimberti
Alternanza scuola-lavoro dal 27 marzo al 7 aprile 2017
Corsa campestre (su libera adesione)
Viaggio di istruzione in Andalusia
Educazione alla cittadinanza: Italiano: discussioni in classe, prendendo spunto da autori
trattati in letteratura: Machiavelli, Guicciardini, Parini, Alfieri, Manzoni; Latino: l’arte della
retorica da Cicerone ai giorni d’oggi; Religione: relazione e discussione; Scienze umane:
compilazione di una relazione relativa all’attività; analisi dei fenomeni del conformismo e
dell’omologazione in sociologia; Storia e Filosofia: sviluppo del tema Individuo, società,
Stato: analisi dei diversi modelli (Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau); le rivoluzioni del
Seicento-Settecento; l’età napoleonica; lo Stato-nazione e l’identità nazionale, con
particolare riferimento al Risorgimento e al processo di costruzione dello Stato nazionale in
Italia.
Classe 5a
Progetto Ben-Essere: prevenzione ludopatie
Giornata della Memoria: Incontro c/o Teatro Manzoni di Busto A. con prof.ssa Laura Boella,
docente di Filosofia Morale all’Università Statale di Milano, sul tema Responsabilità come
presenza al proprio tempo
9 Alternanza scuola-lavoro: partecipazione al ciclo di incontri sui diritti del fanciullo con Pellai
e Lancini e, nell’ambito di FilosofArti, lezioni magistrali di U.Galimberti, M.Recalcati e U.
Curi su tema Paideia – Educazione; Visita alla scuola Montessori di Castellanza
Ecologicamente: attività laboratoriale sulle biotecnologie
Teatro in lingua: visione dello spettacolo teatrale in lingua inglese The picture of Dorian
Gray e visione dello spettacolo teatrale in lingua spagnola Bodas de sangre
Partecipazione al seminario su Giovanni Falcone con la presenza di G. Costanza c/o Aula
Magna
Partecipazione al seminario di approfondimento storico In cerca del ’68, c/o Teatro delle
Arti di Gallarate
Partecipazione al Salone dell’orientamento di Verona
Corsa campestre (su libera adesione)
Viaggio di istruzione a Vienna
Educazione alla cittadinanza:
Storia: per acquisire consapevolezza delle forme assunte dallo Stato nazionale italiano e
della sua identità culturale; per acquisire consapevolezza del processo di unificazione
europeo e riflettere sulle prospettive future: i problemi dell’Italia pot-unitaria; Stato
liberale, Stato totalitario, Stato democratico; la Costituzione della Repubblica italiana e i
suoi valori; le tappe del processo di unificazione europea.
Filosofia: a partire dall’incontro con L. Boella, analisi di alcune prospettive filosofiche sul
problema etico e politico tra Ottocento e Novecento, sviluppando il tema Individuo, Stato,
leggi, giustizia, responsabilità.
Italiano: discussioni in classe, prendendo spunto da autori e opere trattati in letteratura;
Latino: il rapporto potere/intellettuali; Scienze umane: attività collegate all’ASL. Spagnolo:
Conversazione e confronto con la professoressa Arciniega sul tema “Guerra civil y el
franquismo”
10PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI
PROGRAMMA DISCIPLINARE DI RELIGIONE 5BSU
LIBRI DI TESTO: La Bibbia
OBIETTIVI RAGGIUNTI
CONOSCENZE
Interpretazione di passi evangelici esaminati inerenti ai temi.
Conoscenza di aspetti della Chiesa nell’epoca moderna.
Consapevolezza del dialogo interreligioso e il suo contributo per la pace fra i popoli.
Aspetti circa l’insegnamento della Chiesa sulla vita, il matrimonio e la famiglia.
Analisi del rapporto tra: filosofia/teologia; scienza/fede; rivelazione/ragione.
COMPETENZE
Lo svolgimento delle aree tematiche passa attraverso alcuni obiettivi didattici la cui acquisizione è
stata perseguita nel corso di quest’anno:
Ascoltare e comprendere le opinioni degli altri.
Formarsi una propria opinione ed esprimerla.
Intervenire chiedendo la parola e rispettare il proprio turno.
Comprendere le argomentazioni degli altri.
Sostenere le proprie posizioni in maniera motivata.
Mettersi in discussione, nella consapevolezza del valore di questo atto.
CAPACITÀ
Capacità di confronto inter-cristiano, interreligioso e interculturale.
Capacità di comprendere e rispettare posizioni diverse in campo religioso ed etico.
Capacità di passare gradualmente dal piano delle conoscenze a quello della consapevolezza e
dell’approfondimento in rapporto alla rilevanza del cristianesimo sulla cultura e sulla vita
individuale e sociale, in particolare per quanto concerne la crescita civile della società italiana ed
europea.
CONTENUTI DISCIPLINARI
Per favorire lo spirito di ricerca, si è partiti dall’esperienza dello/la studente/ssa e del testo biblico;
è stato esplicitato il percorso didattico - educativo; si sono affrontate le problematiche da ottiche
diverse, riflessione sistematica sul fatto religioso (studio metodologico e corretto del fatto
religioso, conoscenza oggettiva del fatto religioso...); ricerca documentata per una rilettura in
chiave ermeneutica religiosa dell’esperienza; dialogo interdisciplinare ed apertura alla realtà
esterna.
Argomenti trattati:
Presa di coscienza di sé.
Il senso del rispetto davanti all’altro
Il valore del rispetto e della dignità
Violenza sulle donne.
11Uomo - donna.
Incoraggiamento e scoraggiamento
Giornata della memoria.
Adolescenza
L’amore come dono
Alcuni accenni alla bioetica
METODI E MODALITA' DI LAVORO
Lezione frontale, analisi del testo, lezione dialogata, discussione guidata.
STRUMENTI DI VERIFICA
Gli studenti sono stati valutati: in base al grado di raggiungimento degli obiettivi, al loro impegno
in classe, al grado di attenzione, di interesse, di coinvolgimento attivo.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Il giudizio dell’IRC si esprime in : Ottimo, Buono, Discreto, Sufficiente, Insufficiente.
ascolto/ comprensione partecipazione al dialogo mettersi in discussione
insufficiente Non ascolta Non interviene Non si mette in
discussione
sufficiente Ascolta Manifesta solo assenso o Non si mette in
dissenso discussione
discreto Ascolta e prova a Interviene qualche volta, Qualche volta prova a
comprendere la posizione provando ad esprimere la mettersi in discussione
degli altri propria posizione
buono Ascolta e comprende la Interviene ed esprime la Si mette in discussione
posizione degli altri propria posizione
ottimo Ascolta e comprende le Interviene ed esprime la Si mette in discussione ed
argomentazioni degli altri propria posizione è consapevole del valore
motivandola di questo atto
L’INSEGNANTE
Prof. Nicola Paolillo
12PROGRAMMA DISCIPLINARE DI LETTERATURA ITALIANA a.s. 2017/18 CLASSE 5BSU
OBIETTIVI RAGGIUNTI
CONOSCENZE
Elementi e autori principali della storia della letteratura italiana da Leopardi al secondo
Novecento
Brani antologici fondamentali per la conoscenza dei singoli autori
Struttura e tematiche del Paradiso dantesco; sette canti del Paradiso
COMPETENZE
Gli alunni, a diversi livelli, sono in grado di:
Rispondere in modo circostanziato e sintetico a domande poste;
Organizzare in modo autonomo la presentazione di un argomento;
Operare collegamenti all’interno e all’esterno della disciplina;
Esporre in modo chiaro e corretto, utilizzando il linguaggio specifico della disciplina.
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI
La classe conosce in modo abbastanza completo gli elementi esemplari della storia della
letteratura Italiana dalla produzione di Leopardi alla poesia e narrativa di metà Novecento,
con qualche incursione anche nella letteratura della seconda metà del secolo (Fenoglio,
Pasolini, Calvino, Merini) all’interno dei rispettivi contesti storico-culturali. Sa inoltre
contestualizzare opere e brani studiati nella storia e nella cultura del periodo a cui
appartengono, una parte degli alunni in modo autonomo, altri se opportunamente guidati.
Gran parte della classe, infine, sa esporre i contenuti generali utilizzando il lessico specifico
della disciplina.
CONTENUTI DISCIPLINARI
Divina Commedia - Paradiso
Edizione libera
- La struttura del Paradiso
- Temi e toni della III cantica
- Lettura e analisi dei seguenti canti: I – III – VI – XI – XV – XXXI - XXXIII
Storia della letteratura
Manuale in adozione: Bologna Corrado – Rocchi Paola, Rosa Fresca Aulentissima , Ed. Loescher
13VOLUME 4 - Neoclassicismo e Romanticismo
- Giacomo Leopardi : vita, opere, poetica ; i “luoghi comuni” della critica
Lettura e analisi :
Canti : L’infinito ; Alla luna; A Silvia ; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia ; Il
sabato del villaggio; A se stesso ; La ginestra (passi)
Operette Morali: Dialogo della Moda e della Morte ; Dialogo della Natura e di un Islandese;
Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere (testo non presente sul manuale
in adozione)
Zibaldone: La poetica del vago,dell’indefinito
VOLUME 5 - Naturalismo e Decadentismo
- Poetiche del Naturalismo francese e del Verismo italiano.
- Giovanni Verga: vita, opere, poetica; dalla produzione “mondana” al verismo; i “vinti”; il
narratore regresso e il discorso indiretto libero; la Sicilia fra realtà storica e mito; dalla
coralità dei Malavoglia alla figura “eroica (?)” di Mastro don Gesualdo
Lettura e analisi:
Lettura integrale de I Malavoglia
Vita dei campi: La lupa; Cavalleria rusticana;
Novelle rusticane: La roba
Mastro-don Gesualdo: La morte di Gesualdo
- Il Decadentismo: definizione e caratteri; simbolismo e decadentismo
- Il Simbolismo europeo e Baudelaire
- La lirica simbolista: cenni su Verlaine, Rimbaud, Mallarmé
Lettura e analisi:
Charles Baudelaire: L’albatro; Corrispondenze
Paul Verlaine: Arte poetica (brani); Canzone d’autunno(non presente sul testo in adozione);
Arthur Rimbaud: Vocali;
- Giovanni Pascoli: vita, opere, poetica. L’incidenza dell’elemento biografico; il fanciullino;
il nido; il rapporto morboso con l’eros; i legami con il simbolismo; linguaggio
pregrammaticale, grammaticale e post grammaticale nelle poesie di Pascoli.
Lettura e analisi:
Myricae: Lavandare; Il lampo; Il lampo(non presente sul testo in adozione); Il tuono;
L’assiuolo
Primi poemetti: Italy; Digitale purpurea
Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno; Nebbia
- Gabriele D’Annunzio: vita, produzione poetica; una personalità poliedrica e fuori dal
comune; l’estetismo; la vita come opera d’arte; i romanzi (Il piacere, Il trionfo della morte,
Le vergini delle rocce, Il fuoco); il superomismo; la fase notturna; il capolavoro: Alcyone
Lettura e analisi:
Lettura integrale de Il piacere
Alcyone: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto; Stabat nuda Aestas
Il notturno: Il cieco veggente
14VOLUME 6 - Il Primo Novecento
- Luigi Pirandello: vita, saggi, novelle, romanzi, teatro; l’umorismo e il sentimento del
contrario; grottesco e pietà; il relativismo gnoseologicola depersonalizzazione; la
maschera; il metateatro
Lettura e analisi:
Lettura domestica integrale de Il fu Mattia Pascal
Novelle per un anno: Il treno ha fischiato; La signora Frola…(testo non presente sul
manuale in adozione); La patente (testo non presente sul manuale in adozione)
Uno, nessuno, centomila: Mia moglie e il mio naso
Enrico IV: Pazzo?«ora sì…e per sempre»
Visione di Sei personaggi in cerca d’autore (nella messa in scena della Compagnia dei
Giovani: De Lullo, Valli, Falk, Albani)
- I futuristi: Marinetti; L’avvio del movimento; le altre arti; La guerra, la politica e il regime;
Lettura e analisi:
Filippo Tommaso Marinetti: Primo manifesto del futurismo;
Manifesto tecnico della letteratura futurista;
Altri futuristi: Govoni, Il palombaro; Palazzeschi, La fontana malata
- Le altre avanguardie: Dadaismo; surrealismo; espressionismo; Manifesto del
Dadaismo, Manifesto del Surrealismo
- I Crepuscolari: Una variegata geografia poetica; Modelli e temi; le personalità poetiche:
Corazzini, Moretti, Gozzano e la dimensione quotidiana della poesia; malinconia ed ironia;
l’attraversamento di D’Annunzio
Lettura e analisi:
Sergio Corazzini: Desolazione del povero poeta sentimentale
Marino Moretti: A Cesena; Io non ho nulla da dire(non presente sul testo in adozione);
Guido Gozzano: Invernale(non presente sul testo in adozione); La signorina Felicita; Totò
Merùmeni; Un rimorso
- Italo Svevo: vita e opere; i tre romanzi; l’evoluzione della figura dell’inetto; l’ambiguità di
Zeno; salute e malattia; l’ironia
Lettura e analisi:
Lettura domestica integrale de La coscienza di Zeno
Una vita: Il gabbiano (cap.VIII)
Senilità: Il desiderio e il sogno (brani); la memoria
La coscienza di Zeno: Il fumo; Salute e malattia(non presente sul testo in adozione)
- Giuseppe Ungaretti: vita, opere, poetica; Dal Porto sepolto all’Allegria; Dall’Allegria al
Sentimento del tempo; dal versicolo all’ermetismo
Lettura e analisi:
L’allegria: Il porto sepolto; Veglia; I fiumi; San Martino del Carso; Soldati; Fratelli; Sono una
creatura; Mattina
Sentimento del tempo: Sentimento del tempo
- Umberto Saba: vita, opere, poetica. Malattia e psicanalisi; La donna e la città amate; la
poesia pura
Lettura e analisi:
Il Canzoniere: Trieste; Città vecchia; A mia moglie; Fanciulli al bagno; Amai; Mio padre è
stato per me l’assassino(non presente sul testo in adozione)
15- Cenni sull’ermetismo
- Eugenio Montale: vita, opere, poetica. Il male di vivere; il paesaggio ligure; il correlativo
oggettivo; la ricerca del “varco”.
Lettura e analisi:
Ossi di seppia: I limoni; Non chiederci la parola;Meriggiare pallido e assorto;Spesso il male
di vivere…; Forse un mattino…(non presente sul testo in adozione); Cigola la carrucola…
Le occasioni: La casa dei doganieri; Non recidere, forbice, quel volto; Ti libero la fronte dai
ghiaccioli
La bufera e altro: La bufera
Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, milioni di scale
- Carlo Emilio Gadda: vita e opere; il dolore, il garbuglio e l’ironia; la scelta del “giallo”; il
pastiche linguistico.
Lettura e analisi:
Lettura domestica integrale de Quer pasticciaccio brutto de via Merulana
Meditazione milanese: Le relazioni necessarie
Eros e Priapo: Ritratto di un “duce” ridicolo
La cognizione del dolore: Vagava sola, nella casa
Quer pasticciaccio..: Orribile delitto a via Merulana; La scoperta del cadavere della signora
Balducci (testo non presente sul manuale in adozione);
VOLUME 7
- Beppe Fenoglio: vita e opere; l’esperienza partigiana; il “fenglese”
I ventitre giorni di Alba: Gli inizi del partigiano Raoul (testo non presente sul manuale in
adozione);
Il partigiano Johnny: Una definizione di partigiano
- Pier Paolo Pasolini: vita, opere, poetica; Pasolini e il cinema
Lettura e analisi:
Lettere luterane: Fuori dal Palazzo
Scritti corsari: Intellettuale e potere(non presente sul testo in adozione); ; La televisione,
strumento di potere(non presente sul testo in adozione);
Ragazzi di vita: Il ferrobedò; Il riccetto e la rondinella; la fine di Genesio
- Italo Calvino: la vita e le opere; Dal romanzo neorealista al filone fantastico; dal filone
realistico all’influsso dello strutturalismo
Lettura e analisi: Se una notte d’inverno…: Stai per cominciare a leggere…
Le Cosmicomiche: Sul far del giorno(testo non presente sul manuale in adozione);
- Alda Merini: vita e opere
Lettura e analisi di poesie tratte dalle seguenti opere:
La terra santa; Poesie per Charles; La gazza ladra. Venti ritratti; Aforismi
(Tutti i testi letti non sono presenti sul manuale in adozione)
METODI E STRUMENTI
- Lezioni frontali per la presentazione dei principali blocchi tematici e autori
- Lettura e analisi guidata di testi attraverso il coinvolgimento degli studenti
- Uso di audiovisivi e supporti informatici (visita di siti internet di interesse culturale)
16STRUMENTI DI VERIFICA
I QUADRIMESTRE: almeno due prove scritte di tipologia A. B.D. e due valutazioni orali, di cui una
costituita da una prova scritta di analisi e commento di passi del Paradiso dantesco.
II QUADRIMESTRE: Almeno tre prove scritte di tipologia A. B.C.D. e due valutazioni orali, di cui una
costituita da una prova scritta di analisi e commento di passi del Paradiso dantesco.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Per le prove scritte si vedano le griglie allegate al presente documento
Per le prove orali la griglia di valutazione comune.
Per i questionari scritti costituiscono parametri di valutazione:
la pertinenza alla richiesta
la conoscenza articolata e sicura dei contenuti
la capacità di analisi e sintesi
la corre ezza e la proprietà linguis ca
Busto Arsizio, 15 maggio 2018
L’insegnante
prof. Marzio Consani
17PROGRAMMA DISCIPLINARE DI LATINO
DOCENTE: Prof.ssa ANNA ELENA BARBATTI
TESTO ADOTTATO:
Giovanna Garbarino – Lorenza Pasquariello, VELUTI FLOS, vol. 2, ed. Paravia
OBIETTIVI RAGGIUNTI
Per quanto concerne il latino, la classe nel triennio ha mantenuto la continuità didattica. Gli alunni
hanno partecipato con sufficiente interesse al dialogo educativo – benché la ricezione degli
argomenti sia avvenuta in modo piuttosto passivo – e sono apparsi nel complesso motivati allo
studio, sebbene non tutti si siano accostati con sicurezza alla disciplina, anche a causa di carenze
nelle competenze di base. La maggiore o minore serietà nell’impegno e l’efficacia del metodo di
cui ciascuno si è valso hanno determinato risultati diversi; in alcuni casi, il permanere di lacune e
difficoltà ha costituito un ostacolo alla realizzazione di un percorso pienamente positivo. Il livello
medio della classe in termini di conoscenze, competenze e capacità pregresse risulta nel
complesso accettabile.
FINALITÀ
Trascrivo, con riferimento alla Programma disciplinare inserita nel P.T.O.F., le finalità disciplinari,
alla realizzazione delle quali ho lavorato nel corso dell’anno scolastico e che ritengo siano state
comprese e fatte proprie dalla classe in modi e a livelli di consapevolezza diversi.
Educazione linguistica:
1.Valersi consapevolmente delle categorie metalinguistiche.
2. Acquisire la consapevolezza del rapporto di vicinanza/alterità tra latino e italiano.
3. Istituire un confronto consapevole fra la traduzione e il testo originale correttamente analizzato.
Educazione letteraria:
1. Acquisire una consapevolezza sempre maggiore delle tappe che hanno condotto la civiltà in cui
viviamo ad assumere la propria fisionomia.
2. Acquisire ulteriore consapevolezza delle basi comuni e dello spessore storico delle istituzioni
letterarie europee.
3. Mettere maggiormente a fuoco un quadro di valori morali e civili condivisi.
CONSOLIDAMENTO DI CAPACITÀ
Anche in merito al consolidamento delle capacità che trascrivo qui di seguito, devo registrare
come esso sia avvenuto per il gruppo classe solo in modi e a livelli di consapevolezza diversi (e
talora, a mio avviso, non si sia realizzato):
1. Consolidare la capacità di vagliare criticamente le informazioni e controllare la complessità
sapendo scegliere in ogni circostanza solo ciò che è pertinente.
2. Consolidare l’abitudine ad analizzare e a comprendere qualsiasi messaggio in tutta la sua
complessità, cercando il massimo di informazioni attraverso un’indagine sistematica di tutte le
sue strutture.
3. Consolidare l’abitudine a procedere nell’analisi di un oggetto con metodo e rigore tenendo
conto di numerose variabili, non sempre note (inferenza).
CONOSCENZE
1. Riprendere e consolidare le conoscenze di morfologia e sintassi acquisite nel biennio.
182. Familiarizzare con il lessico di pi largo uso negli autori.
3. Acquisire lineamenti di storia letteraria latina.
4. Conoscere gli autori pi signi ca vi (valendosi del sostegno di letture in lingua originale o in
traduzione).
OBIETTIVI
Riporto qui di seguito, sempre con riferimento alla Programma disciplinare inserita nel P.T.O.F., gli
obiettivi disciplinari specifici relativi alla classe quinta, precisando come, a mio avviso, la classe nel
suo complesso abbia raggiunto tali obiettivi a un livello nel complesso accettabile, benché in modo
non uniforme e a livelli di consapevolezza diversi:
1. Procedere nell’analisi di un testo con metodo.
2. Controllare la comunicazione verbale, vagliando le informazioni e scegliendo solo quelle più
funzionali.
3. Operare collegamenti e confronti all’interno e all’esterno della disciplina.
4. Rispondere in modo circostanziato e sintetico a domande poste.
5. Rielaborare le informazioni apprese, esprimendo un punto di vista personale a proposito di
questioni inerenti al percorso di studi.
COMPETENZE
Trascrivo, sempre con riferimento alla Programma disciplinare inserita nel P.T.O.F., le competenze
disciplinari specifiche relative alla classe quinta, precisando come la classe nel complesso abbia
acquisito tali competenze a un livello accettabile, con una maggiore debolezza in merito all’analisi
di brani letterari in lingua.
1. Saper comprendere brani letterari in lingua con individuazione delle strutture del periodo latino
e degli aspetti retorici.
2. Saper collocare storicamente e culturalmente testi, autori, tematiche.
3. Saper analizzare con precisione brani letterari presentati in classe sul piano grammaticale e
stilistico.
4. Saper esporre in modo chiaro e corretto, utilizzando il linguaggio specifico della disciplina.
5. Saper operare collegamenti e confronti.
CONTENUTI DISCIPLINARI
L’ETÀ DI AUGUSTO (raccordo con programma classe IV)
Q. ORAZIO FLACCO
Vita e opere (spec. Sermones, Carmina, Epistulae).
Letture:
Sermones: I, 9 (fotocopia) – L’arrampicatore sociale
II, 6, vv. 79-117 (pp. 556-559) – Il topo di campagna e il topo di città
Carmina: I, 9 (pp. 570-572) – Non pensare al futuro
I, 11 (pp. 572-574) – Carpe diem
L’ETÀ GIULIO-CLAUDIA
Quadro storico e contesto culturale; i generi letterari.
L. ANNEO SENECA
Vita e opere: i Dialogi e la saggezza stoica; le Epistulae ad Lucilium e la pratica quotidiana della
filosofia; lo stile della prosa senecana; le tragedie; l’Apokolokýntosis.
Letture:
19De brevitate vitae, 1, 1-4 (pp. 744-746) – Il valore del tempo
10, 2-5 (pp. 751-752, in italiano) – Il valore del passato
12, 1-7; 13, 1-3 (pp. 752-754, in italiano) – La galleria degli occupati
De ira, I, 1, 1-4 (pp. 759-760, in italiano) – L’ira
Epistulae ad Lucilium: 1, 1-5 (pp. 755-757) – Riappropriarsi di sé e del proprio tempo
47, 1-4 (pp. 738-740) – Come trattare gli schiavi
M. ANNEO LUCANO
Vita; il Bellum civile e la distruzione dei miti augustei; il linguaggio poetico dell’autore.
Letture:
Bellum civile, VI, vv. 750-767; 776-820 (pp. 813-815, in italiano) – Una funesta profezia (un
episodio di nekyomanteia).
A. PERSIO FLACCO
Vita; satira e stoicismo; forma e stile.
PETRONIO
Il Satyricon: la questione dell’autore; il contenuto dell’opera; la questione del genere letterario; il
realismo petroniano.
Letture:
dal Satyricon:
Cena Trimalchionis, 32-33 (pp. 832-833, in italiano) –Trimalchione entra in scena
37-38, 5 (pp. 835-837, in italiano) – La presentazione dei padroni di casa
50, 3-7 (pp. 839-840, in italiano) – Trimalchione fa sfoggio di cultura
71, 1-8; 11-12 (pp. 841-842, in italiano) – Il testamento di Trimalchione
110, 6-112 (pp. 842-843, in italiano) – La matrona di Efeso
DALL’ETÀ DEI FLAVI AL PRINCIPATO DI ADRIANO
Quadro storico e contesto culturale; i generi letterari (cenni).
M. VALERIO MARZIALE
Vita e poetica; gli Epigrammata: tecnica compositiva, temi e stile.
Letture:
dagli Epigrammata
I, 4 (fotocopia e pp. 879-880) – Distinzione tra letteratura e vita
I, 10 (fotocopia e p. 881) – Matrimonio di interesse
I, 30 e I, 47 (fotocopia e p. 868) – Da medico a becchino
IV, 24 (fotocopia) - Le amiche di Licoride
V, 34 (fotocopia e p. 887) – In morte di Erotion
8, 79 (p. 888) – La “bella” Fabulla
X, 4 (pp. 877-878) – Una poesia che “sa di uomo”
X, 8 (fotocopia e p. 881) – Matrimonio di interesse
X, 43 (fotocopia e p. 881) – Matrimonio di interesse
XIV, 56 (fotocopia e p. 866) – Dentifricio
M. FABIO QUINTILIANO
Vita e opere; l’Institutio oratoria e i rimedi alla corruzione dell’eloquenza.
Letture:
dall’Institutio oratoria, Proemio, 9-12 (pp. 900-901, in italiano)
I, 2, 4-8 (pp. 903-904, in italiano) – Svantaggi dell’istruzione individuale
I, 2, 18-22 (p. 905, in italiano) – Vantaggi dell’insegnamento collettivo
I, 3, 8-12 (pp. 907-908) – L’importanza della ricreazione
20II, 2, 4-8 (pp. 908-909) – Il maestro ideale
P. CORNELIO TACITO
Vita e opere: l’Agricola, la Germania, il Dialogus de oratoribus; le Historiae e gli Annales e la
storiografia “tragica”.
Letture:
Annales: I, 1 (p. 973, in italiano) – Il proemio
XV, 38-39 (pp. 979-980, in italiano) – Nerone e l’incendio di Roma
XV, 44, 2-5 (p. 980, in italiano) – La persecuzione dei cristiani
XV, 62-64 (fotocopia) – Morte di Seneca
XVI, 18-19 (fotocopia) – Morte di Petronio
DALL’ETÀ DEGLI ANTONINI AI REGNI ROMANO-BARBARICI
Quadro storico e contesto culturale; l’affermarsi del Cristianesimo e la letteratura cristiana (cenni).
APULEIO
Vita; il De magia; i Metamorphoseon libri e il genere del romanzo.
Letture:
Metamorphoseon libri: III, 24-25 (pp. 1016-1018, in italiano) – Lucio diventa asino
V, 22-23 (pp. 1026-1028, in italiano) – La trasgressione di Psiche
VI, 20-21 (pp. 1029-1030, in italiano) – Psiche è salvata da Amore
XI, 13-15 (pp. 1021-1022, in italiano) – Il ritorno alla forma umana e il
significato delle vicende di Lucio
STRUMENTI, METODI E MODALITÀ DI LAVORO
Declino qui di seguito METODI e STRATEGIE adottati per conseguire i risultati attesi in riferimento
alla disciplina e agli obiettivi.
Storia della letteratura e antologia di Autori:
– Lezioni frontali per la presentazione dei principali blocchi tematici e autori.
– Lettura e presentazione di brani significativi in lingua originale o in traduzione italiana.
– Spiegazione in classe dei testi, con il coinvolgimenti degli studenti nell’analisi contenutistica e
retorica.
Lingua:
– Analisi guidata dei testi d’autore per favorire il ragionamento sulle strutture morfosintattiche e
arricchire la riflessione lessicale sui termini latini e il loro esito in italiano.
MODALITÀ DI RECUPERO
– Puntualizzazione di parti del programma.
– Correzione collettiva ragionata dei compiti in classe.
– Recupero in itinere mediante assegnazione di esercizi.
MODALITÀ DI VERIFICA
Numero di verifiche effettuate nel primo quadrimestre:
– due prove scritte
– una prova orale
21Numero di verifiche effettuate nel secondo quadrimestre:
– due prove scritte
– una prova orale
Tipologia delle prove di verifica:
Prove scritte:
– Analisi testuali (di brani in prosa o passi poetici noti).
Prove orali:
– Quesiti letterari con indicazione del numero massimo di righe (questionari a risposta sintetica e
singola).
– Interrogazioni.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Per la valutazione degli alunni si sono tenuti in considerazione:
– Il livello di partenza dei singoli.
– Il livello medio della classe.
– Il grado di conoscenza dei contenuti.
– La rispondenza agli obiettivi via via definiti.
– La capacità di una corretta esposizione orale e scritta.
– L’uso di un linguaggio specifico.
– La capacità di rielaborazione personale dei contenuti studiati.
– La capacità interpretativa dei brani e dei testi letti.
– La puntualità e la qualità nello studio e nello svolgimento del lavoro domestico assegnato.
– L’apertura al dialogo educativo.
In particolare, hanno costituito parametri di valutazione per i questionari scritti:
– La pertinenza alla traccia.
– La conoscenza articolata e sicura dei contenuti.
– La capacità di analisi e sintesi.
– La correttezza e la proprietà linguistica.
Circa la determinazione numerica – sia per le prove orali sia per le prove scritte – si rimanda alle
griglie di valutazione deliberate dal Dipartimento di Lettere (come da P.T.O.F.)
Busto Arsizio, 15 maggio 2018 L’insegnante
Anna Elena Barbatti
22DOCUMENTO DISCIPLINARE DI STORIA
TESTO IN ADOZIONE
GIARDINA A.- SABBATUCCI G- VIDOTTO V., Nuovi profili storici, vol. 2- Dall’età delle
rivoluzioni alla fine dell’Ottocento, Laterza, Roma-Bari 2012.
GIARDINA A.- SABBATUCCI G.- VIDOTTO V., Nuovi profili storici, vol. 3- Dal 1900 ad oggi,
Laterza, Roma- Bari 2012.
OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI
CONOSCENZE: comprendere come si sono sviluppati istituzioni e fenomeni fondamentali del
mondo contemporaneo, riscontrando continuità e rotture, dalla metà dell’Ottocento alla seconda
metà del Novecento.
COMPETENZE:
1. conoscere ed utilizzare il lessico storico;
2. orientarsi all’interno dei contesti storici studiati;
3. analizzare e interpretare un testo storico.
Livelli di conseguimento
Si segnala che la docente è stata assegnata alla classe nell’ultimo biennio. Se all’inizio della classe
quarta si erano evidenziate alcune difficoltà, metodologiche ed espositive, nello studio disciplina,
grazie alla disponibilità al dialogo educativo e all’attenzione, gli studenti hanno mostrato di saperle
affrontare e superare. Tuttavia, pur aderendo alle diverse occasioni di approfondimento proposte,
emerge che solo pochi alunni hanno dato un effettivo contributo personale alle lezioni; il resto
della classe ha invece preferito assumere un atteggiamento di presenza silenziosa, anche se non
indifferente, durante le diverse attività svolte.
In merito al conseguimento degli obiettivi disciplinari stabiliti e alle prestazioni, nel complesso si
possono considerare raggiunti tutti gli obiettivi didattici indicati, seppur a differenti livelli, come
mostrano le valutazioni individuali. Si evidenzia che solo qualche studente, anche grazie alla
conoscenza completa e approfondita dei contenuti, unita a consolidate capacità analitiche, utilizza
con proprietà il lessico storico e riesce a compiere autonomamente sintesi coerenti. Per qualche
alunno invece, anche per una conoscenza superficiale e un’applicazione non sempre rigorosa,
permangono alcune difficoltà nell’analisi e nell’esposizione.
CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI
Si segnala che all’inizio dell’a.s. si è reso necessario recuperare alcuni contenuti previsti per la
classe quarta; ciò, unito anche alla riduzione di alcune ore di lezione concomitanti con altre attività
didattiche, ha comportato una riduzione degli argomenti relativi alla seconda metà del Novecento
previsti in sede di Programma iniziale.
Lo Stato unitario italiano (vol. 2, unità 23, parr.1,2,3,4,5)
I problemi dell’Italia post-unitaria e i governi della Destra Storica: il modello centralistico e
l’unificazione legislativa-burocratico-amministrativa; il sistema scolastico; pareggio del bilancio e
progresso economico; il “Grande brigantaggio” nel Sud; la “questione veneta” e la III guerra di
indipendenza; la “questione romana”.
23La seconda rivoluzione industriale e l’età dell’Imperialismo (vol. 2, capp. 18, 22; vol. 3,
capp.1,2,)
La seconda rivoluzione industriale: caratteri generali; le differenze con la Prima Rivoluzione
Industriale; scoperte scientifiche e progresso tecnologico; le conseguenze sociali; proletariato e
capitalismo.
La crisi del sistema politico liberale e i processi di democratizzazione: la “nazionalizzazione delle
masse”; il Socialismo: la Prima Internazionale; la Comune di Parigi; la Seconda Internazionale; la
dottrina sociale della Chiesa Cattolica (la Rerum Novarum).
Origini del movimento femminista: il “femminismo di prima ondata” e le suffragette (1848- 1914):
la linea liberale e la linea socialista.
Testi: vol. 3, testo 16 (pp.138-140), “Le suffragette”, da S.Rowbotham , Esclusa dalla folla.
Le politiche imperialistiche: la crisi economica del 1873-76 e le sue conseguenze; colonialismo e
imperialismo; le interpretazioni storiografiche dell’imperialismo.
Lo sviluppo economico del capitalismo monopolistico nella “Belle Époque”: i nuovi sistemi
produttivi, taylorismo e fordismo; la società di massa e la cultura popolare; la Belle Époque.
Testi: vol. 3, testo 1d (pp.101-103), “La psicologia delle folle” da G. le Bon, La psicologia delle folle.
L’Italia dalla Sinistra Storica all’"età giolittiana” (vol. 2, unità 23, parr.6,7,8,9,10; vol. 3, cap. 4)
La caduta della Destra Storica e il “trasformismo” di Depretis; la politica autoritaria di F. Crispi e le
imprese coloniali italiane; la “crisi di fine secolo” e il regicidio; la politica liberale- conservatrice di
Giolitti e le riforme; il “grande balzo industriale”; il movimento socialista italiano tra riformisti,
massimalisti, rivoluzionari, anarchici; il movimento della Democrazia Cristiana; i problemi sociali e
l'emigrazione; l’emergere del nazionalismo; le spinte al colonialismo e la guerra di Libia; la fine del
“compromesso giolittiano”; le elezioni del 1913 e il “patto Gentiloni”.
Testi: vol. 3, testo 20d (pp. 149-150), “Il ministro della mala vita” da G. Salvemini, Il ministro della
mala vita e altri scritti sull’età giolittiana; testo 21 (pp. 151-153), “Il ministro della buona vita” da
G. Ansaldo, Le lettere.
Il Novecento tra guerra e rivoluzione (vol. 3, cap.5)
La “Grande guerra”: la situazione internazionale all’origine della Prima Guerra mondiale: le cause
del conflitto; l'assassinio di Sarajevo e l'inizio delle operazioni militari; neutralismo e interventismo
in Italia; caratteri della “Grande guerra”: dalla "guerra di movimento" alla "guerra di posizione; la
“svolta” del 1917; la fine del conflitto.
La pacificazione “impossibile”: i Quattordici punti di Wilson; i trattati di pace; la Società delle
Nazioni.
Testi: vol. 3, scheda I Balcani (pp. 91-96); testo 29d (p. 280 ), I “Quattordici punti” di Wilson; testo
30d (pp.280-283) da J. M. Keynes, Le conseguenze economiche della pace.
Le rivoluzioni russe del 1917 e la nascita dell’URSS (vol. 3, cap.6)
L’Impero russo all’inizio del XX sec. e la rivoluzione del 1905.
Il 1917: la “rivoluzione di febbraio” e la fine dell’Impero zarista, il dualismo di potere (Governo
provvisorio e Soviet), il rientro di Lenin e le Tesi di aprile, la rivoluzione bolscevica dell’ottobre
1917; la guerra civile e l’invasione straniera; la costruzione dell’Unione Sovietica; la Terza
24Internazionale e la nascita dei partiti comunisti in Europa; la morte di Lenin e l’ascesa di Stalin; i
provvedimenti economici: il comunismo di guerra; la NEP; il primo piano quinquennale.
Testi: Lenin, Tesi di aprile (fornito dalla docente).
Il primo dopoguerra
Il caso italiano: dallo Stato liberale al regime fascista (vol. 3, cap. 8)
La situazione postbellica; la “questione fiumana” e il “mito della vittoria mutilata”; la fondazione
dei "Fasci di combattimento e delle corporazioni"; la fondazione del Partito Popolare; le elezioni
del 1919 e la vittoria dei “partiti popolari”.
Dal "biennio rosso" al “biennio nero”: la fine del compromesso giolittiano e la debolezza dei
governi liberali; la fondazione del Partito Comunista d’Italia; la nascita del Partito fascista e lo
squadrismo; la crisi del 1921; la “marcia su Roma” e il primo governo Mussolini.
La “dittatura legale”: la Riforma Gentile, la legalizzazione della milizia, “la legge Acerbo” e le
elezioni del 1924, l’assassinio di Matteotti e la “secessione dell'Aventino”; la presa del potere e il
regime autoritario di massa; le “leggi fascistissime” e l’eliminazione delle opposizioni; gli
intellettuali italiani e il fascismo; i Patti lateranensi e la soluzione della “questione romana”;
l’inquadramento delle masse; il corporativismo.
Testi: da B. Mussolini, Discorso del 3 gennaio 1925 (fornito dalla docente).
La situazione in Europa e negli USA (vol. 3, cap. 7, parr. 1,2,3,4; cap. 9, par.
1)
Il “biennio rosso” in Europa; tendenze conservatrici e isolazioniste negli USA: i “ruggenti anni
Venti” e la red scare.
L’età dei totalitarismi (vol. 3, capp. 9; 10, 11 )
La “grande crisi” del 1929 (vol. 3, unità 5): cause e le modalità della crisi negli USA; le teorie di J.M.
Keynes e il New Deal di Roosevelt; la diffusione della crisi e le conseguenze in Europa.
Il concetto di totalitarismo: origine del concetto; caratteristiche dei totalitarismi nel Novecento
secondo un confronto tra le analisi "classiche" di H. Arendt e di Friedrich- Brzezinskj.
Testi: vol. 3, 46 (da H. Arendt, “Totalitarismi e società di massa”), 47 (Friedrich- Brzezinskj, “I
caratteri del totalitarismo”).
Il nazionalsocialismo in Germania: la crisi economica tedesca e disgregazione della Repubblica di
Weimar; la presa del potere da parte di Hitler e la proclamazione del Terzo Reich; ideologia e
propaganda; il controllo sociale; il dirigismo economico; l’espansionismo; i provvedimenti contro i
“nemici oggettivi”, la politica razziale e antisemita.
Testi: Programma del Partito Nazionalista dei Lavoratori tedeschi (fornito dalla docente); estratti
dal Mein Kampf (fornito dalla docente)
Lo stalinismo in Unione Sovietica: la pianificazione economica e i suoi effetti sulla struttura
sociale; la mobilitazione totalitaria delle masse lavoratrici; il regime autoritario fondato sul culto
della personalità; l’eliminazione degli avversari e le “grandi purghe”; i gulag.
Il regime fascista in Italia negli anni Trenta
Il regime e la costruzione del consenso; lo scontro per l’Azione Cattolica; la fascistizzazione della
società; il dirigismo economico e la scelta autarchica; l’ambigua politica estera: dalla posizione
mediatrice all’imperialismo; la partecipazione alla guerra civile spagnola; la guerra d’Etiopia e la
25proclamazione dell’Impero; la politica estera fascista di avvicinamento alla Germania nazista; la
guerra civile spagnola; l'Asse Roma- Berlino e il Patto anti- Comintern; le leggi razziali del “38 in
Italia.
Testi: G. Gentile- B. Mussolini, La voce “fascismo” nell’Enciclopedia Treccani (fornito dalla
docente); 57d (p. 502-503), La Dichiarazione sulla razza.
La Seconda Guerra Mondiale (vol. 3, cap. 13; cap. 14 parr.1,2,3,4,5)
Le relazioni internazionali alla vigilia del conflitto: la politica dell’appeasement di Gran Bretagna e
Francia; l’Anschluss dell’Austria, la questione dei Sudeti e la Conferenza di Monaco; l’invasione
italiana in Albania e il Patto d'acciaio; il Patto Molotov- Ribbentrop; dall’offensiva tedesca in
Europa alla mondializzazione del conflitto; la “Shoah”; collaborazionismo e Resistenza.
Il crollo della Germania e del Giappone; la fine del conflitto e l’utilizzo della bomba atomica.
La situazione geopolitica al termine del conflitto: verso il “mondo a due blocchi” (cenni).
Testi: vol.3, testo 53 “L’Arcipelago Gulag e Auschwitz: un dibattito” (pp. 490-494) confronto tra E.
Nolte- Kocka.
L’Italia: dalla Resistenza alla Costituzione della Repubblica Italiana (vol. 3, cap. 16, parr. 1,2,3,4,5)
La situazione italiana durante la guerra: l’antifascismo, la caduta del fascismo, l’8 settembre 1943,
la Resistenza italiana, l’occupazione tedesca e la Repubblica di Salò.
La “guerra civile” e la fine del conflitto: il referendum e le elezioni del “46; i lavori della
Costituente; struttura e principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana nel
confronto critico con lo Statuto Albertino.
Testi: testo 77 (559-561), “La guerra civile, una definizione controversa” da C. Pavone, Una guerra
civile. Saggio storico sulla moralità storica della Resistenza.
Costituzione della Repubblica Italiana (artt.1-12).
Le lezioni successive al 15 maggio saranno dedicate a chiarimenti e approfondimenti, in particolare
riprendendo i contenuti del seminario di studio sul “68, al quale la classe ha partecipato nel mese
di marzo, e sulle principali tappe del processo di unificazione europea.
METODOLOGIA DI LAVORO E STRUMENTI
Metodologia di lavoro
Partendo dal riconoscimento della centralità dello studente nel processo didattico ed educativo, si
precisa che nella trattazione dei contenuti si sono alternati: lezioni frontali secondo il metodo
narrativo il pi possibile dialogate; lezioni a partire dall’analisi e dalla contestualizzazione di
documenti storici e/ o di brani storiografici; momenti di discussione e di approfondimento su
tematiche di attualità. In particolare, si segnala che la classe ha partecipato: al seminario con G.
Costanza su Giovanni Falcone; in relazione al “Progetto Memoria” alla lezione di L. Boella, docente
di Filosofia Morale c/o l’Università Statale di Milano, sul tema Responsabilità come presenza al
proprio tempo; al convegno In cerca del “68 c/o il Teatro delle Arti di Gallarate (23- 24 marzo).
In relazione all’Educazione alla Cittadinanza, la docente ha cercato di stimolare eventuali
collegamenti multidisciplinari, in particolare con Filosofia, sull’analisi dei modelli politici tra
Ottocento e Novecento, sviluppando il tema Individuo, Stato, leggi, giustizia, e delle diverse
interpretazioni filosofiche del totalitarismo.
Strumenti: manuale in adozione; appunti delle lezioni; documenti storici e/o brani storiografici
significativi forniti dalla docente (via web); strumenti multimediali.
26VERIFICA E VALUTAZIONE
In relazione al conseguimento degli obiettivi didattici sopra indicati, le verifiche sono state:
calendarizzate; esplicitate dall’insegnante nelle finalità di volta in volta proposte; preparate in
coerenza con il lavoro svolto in classe. Si precisa che nelle verifiche sono stati riportati in calce i
criteri di valutazione, il punteggio e i vincoli previsti per ogni esercizio.
Tipologie di verifica
Prove scritte, in particolare:
Primo quadrimestre (settembre- dicembre 2017): due verifiche scritte di tipologia B di III
prova dell’esame di Stato; per un gruppo di studenti valutazione orale di recupero;
Secondo quadrimestre (gennaio- giugno 2018): due prove scritte di tipologia B dell’Esame
di Stato; una prova scritta di tipologia mista; eventuali interrogazioni.
Durante il corso degli ultimi due a.s., in accordo con il docente di Lettere, sono state proposte alla
classe tracce di I prova scritta dell’Esame di Stato secondo la tipologia B (saggio breve/ articolo di
giornale di argomento storico-politico) e C (tema storico).
Criteri di valutazione
Per le interrogazioni orali: conoscenze, uso del lessico disciplinare ed esposizione, analisi e
sintesi, contestualizzazione e capacità di confronto;
Per le prove scritte di tipologia B: conoscenza dei contenuti, capacità espressive ed
operative, capacità di rielaborazione e sintesi.
La valutazione individuale ha inoltre tenuto conto dei risultati del controllo operato mediante le
verifiche e dei progressi compiuti dallo studente rispetto al livello di partenza; tale valutazione ha
considerato anche la partecipazione del singolo all’interno dello standard della classe.
Griglia di valutazione
Per la valutazione delle prove orali e della prova scritta semistrutturata è stata utilizzata la griglia
del Dipartimento di Filosofia e Storia riportata nel PTOF; per la valutazione delle prove scritte
secondo la tipologia B di terza prova dell’Esame di Stato si rimanda alla griglia allegata al presente
documento.
____________________________________________________________________________
Busto Arsizio, 15 maggio 2018 La docente, prof.ssa Elena Verderio
27Puoi anche leggere