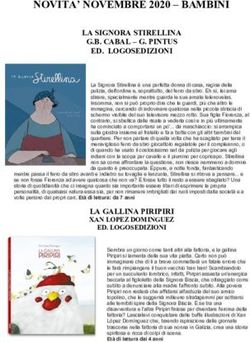Educare gli adolescenti alla spiritualità e alla religiosità
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Politiche e servizi
Giuseppe Milan e Margherita Cestaro
Educare gli adolescenti alla
spiritualità e alla religiosità
Nel tempo della «modernità arida», le dimensioni dell’interiorità e
della spiritualità si sono del tutto prosciugate oppure possono an-
cora trovare una sorgente di «acqua» cui attingere? In particolare, è
ancora possibile – e se sì mediante quali «vie» – educare adolescenti
e giovani ad una «spiritualità religiosamente orientata»? Queste le
domande di fondo attorno alle quali ruota la riflessione qui proposta
a partire da alcuni dati emersi dallo Studio longitudinale Crescere su
un campione di circa 450 minori residenti nelle province di Padova
e Rovigo.
I
Crescere in un mondo arido1 Nel leggere criticamente la realtà odier-
na e le voci autorevoli che tentano di inter-
n un tempo in cui uomini e donne pretarla, si può assumere – almeno per un
vestono prevalentemente in unifor- po’ – una modalità per certi versi sovver-
me, indossando costumi identitari siva e mette-
imposti dal mercato effimero del- re in dubbio AUTORI
le cose e delle immagini, e vagano perfino con-
spesso senza centro e senza periferia lungo cetti omologa- Giuseppe Milan, professore or-
itinerari eterodiretti, sottoposti a comandi ti, forse pre- dinario, Dipartimento di Fi-
che irrigidiscono pensieri e comportamenti, suntuosi, che losofia, Sociologia, Pedagogia
è necessario chiederci se la vita interiore si impongono il e Psicologia Applicata (FISP-
sia prosciugata fino a ridursi all’arida mate- loro dettato e PA), Università di Padova.
rialità che pervade oggi gli spazi e i tempi affermano che Margherita Cestaro, assegnista
della nostra navigazione. Che ne è della di- la «vita è così», di ricerca presso Dipartimen-
mensione dell’interiorità e della spiritualità, che «il mon- to FISPPA, Università di Pa-
per secoli al centro della riflessione filosofi- do è così». È dova.
ca, religiosa e delle scienze umane in genere? ir riverente,
Studi Zancan · 5/2016 · 17Milan G. e Cestaro M.
ad esempio, criticare l’idea di «moderni- È la narrazione metaforica di una deso-
tà liquida»? Certo, non si possono trattare lazione, cioè di una solitudine senza sole,
con ingenua superficialità le idee forti, che senza cielo: un desiderio di cielo e di re-
fanno definitivamente parte del nostro vo- lazione che non trova risposta, che viene
cabolario, di un pensatore come Zygmunt tradito da un capovolgimento che nega
Bauman (2000). Tuttavia mi piace immagi- ogni verticalità e lascia spazio soltanto alla
nare che lo stesso grande pensatore possa banale cosalità. È la negazione dell’Oltre,
per un po’ partecipare al gioco dell’irrive- l’invischiamento in un hic et nunc che bloc-
renza – e perfino dell’auto-irriverenza – ri- ca nell’immobilità, da dove non si può né
spetto a concetti e termini cristallizzati, per partire per altri orizzonti né tornare a qual-
assumere modalità interpretative plastiche cosa di irrimediabilmente perduto. Deside-
e alternative. rio e memoria muoiono nella dimensione
Sono perciò convinto che non sia un’e- di un’orizzontalità cieca.
resia proporre un rovesciamento termino- In altri modi ne parla un filosofo, Martin
logico e sostenere che oggi viviamo una Buber, quando insiste sull’orfanezza antro-
«modernità arida»: ciò che più decisamente pologica ed esistenziale figlia di «un’epoca
qualifica l’oggi non è una sovrabbondanza, senza dimora», caratterizzata dalle chiusure
ma un’assenza. Assenza di un’acqua capace nell’egolatria di un «io senza tu». È neces-
di dissetare. L’esistenza oggi è spesso aridi- sario, allora, travalicare il mondo soffocan-
tà. La vita interiore si è fortemente prosciu- te della cosalità, l’onnipotenza dell’Esso:
gata e, con essa, si è prosciugato il senso oltrepassare la superficie delle cose e delle
più autentico del tempo e dello spazio, del- persone, pure ridotte a oggetto, per imboc-
la memoria e del progetto, della prossimità care un’importantissima via di fuga, una
e del viaggio. La virtualità fagocita la realtà, vera e propria «intuizione», che etimolo-
la appiattisce, la disorienta, trasformando gicamente allude all’«andare al tu» ma che
le traiettorie esistenziali individuali e col- in realtà è via per ritornare autenticamente
lettive in una sorta di eterno vagabondare a se stessi. È la «fantasia reale», un «tuffo
senza mete e orizzonti. coraggioso» nell’oltre, che consente di ac-
Torna in mente la suggestiva favola di cedere alle profondità e alle altezze e, in
Woyzeck, dell’autore di teatro drammatico questa prospettiva, di incontrare l’altro tu, e
Georg Büchner (1813-1837), che descrive l’Altro Tu, ritrovando perciò propriamente
un mondo spento, desolato, morto: «C’era se stessi (Milan G., 1994, 102-111).
una volta un povero bambino e non aveva Naturalmente non si tratta di una fanta-
papà e non aveva mamma, erano morti tut- sia avulsa, di una mera «favola personale»
ti, e non c’era più nessuno al mondo. Tutti (come viene definita in ambito psichiatri-
morti, allora lui è partito e ha cercato gior- co) che consenta una sorta di evasione dal-
no e notte. E siccome sulla terra non c’era la concretezza e dalla pesantezza della vita,
più nessuno, ha voluto andare in cielo: c’era bensì di quell’accesso all’intimità delle cose
la luna che lo guardava così buona; e quan- che è possibile proprio andando al di là delle
do finalmente era arrivato alla luna, quella cose, attraverso le cose, incontrando autenticamen-
era un pezzo di legno marcio. E allora è an- te la realtà delle cose: un accesso che si può
dato dal sole e quando era arrivato al sole, sperimentare nella normalità della quoti-
quello era un girasole appassito. E quando dianità e delle realtà che la abitano, quando
arrivò alle stelle, erano dei moschini d’oro lo sguardo si fa attento, capace di cogliere
[...]. E lui voleva tornare sulla terra, anche ciò che spesso è invisibile agli occhi. E si
la terra era una pentola capovolta. E lui era matura così una familiarità con il sacro che
solo solo. E allora si è seduto e si è messo a dà senso alle cattedrali del nostro andare
piangere, ed è ancora là seduto, solo solo» quotidiano. È quanto intende evidenziare
(Büchner Z., 1978, 155-156). la seguente pagina autobiografica del teolo-
18 · Studi Zancan · 5/2016Educare gli adolescenti alla spiritualità
go-filosofo Leonard Boff sul profondissi- Proprio attraverso l’umile materialità di
mo significato di una «brocca». questa brocca, che include memorie e at-
tese, si può attingere ad un mondo che va
«oltre», che introduce ad altri orizzonti, ad
C’è una brocca di alluminio. Di quel- altre intuizioni, ad altre comprensioni. Si
lo antico, buono e lucente. Il manico è spalanca un infinito, un mare di significati e
rotto. Ma le conferisce un aspetto di anti- di provocazioni.
chità. Vi hanno bevuto gli undici figli da Per spiare il mistero – l’intima spiritualità
piccoli a grandi. Essa ha accompagnato
del mondo, delle cose, di noi stessi – abbia-
la famiglia nei molti traslochi. Dalla cam-
pagna al villaggio. Dal villaggio alla città. mo bisogno di questa sorgente, di questa
Dalla città alla metropoli. Ci furono na- maieutica capace di attraversare le stratifi-
scite. Ci furono morti. Prese parte a tut- cazioni apparenti e resistenti dell’empirico
to. Venne sempre con noi. È la continuità e di svelare capitali invisibili, mondi na-
del mistero della vita nelle diversità delle scosti, tesori dimenticati sotto la coltre di
situazioni di vita e di morte. Essa rimane. un’esteriorità patinata. Abbiamo bisogno di
Sempre lucente e antica. Credo che quan- sfidare il buio, di percorrere attimi ed epo-
do entrò in casa doveva essere già vec- che notturne, dando senso perfino all’in-
chia. Di quella vecchiaia che è giovinezza cedere dell’oscurità più nera, per cogliere
perché genera la vita. Pezzo centrale della finalmente l’irrompere di un raggio di luce
cucina. Ogni volta che si beve da lei non
capace di vincere quel tempo morto e di far
si beve acqua. Ma la freschezza, la dol-
cezza, la familiarità, la storia familiare, la esplodere il giorno.
reminiscenza del bimbo avido che sazia Abbiamo bisogno di attingere a qualcosa
la sete. Potrebbe essere una qualunque di eccedente e spregiudicato anche rispetto
acqua. In questa brocca, è sempre fresca al consolidato e rassicurante recinto della
e buona. In casa tutti quelli che si disse- razionalità, del risaputo e dell’abitudinario,
tano bevono da questa brocca. Come in consapevoli che «anche il muro più spesso
un rito tutti esclamano: com’è bello bere ha crepe sottilissime attraverso le quali si in-
da questa brocca! Com’è buona qui l’ac- filtra il mistero» (Florenskij P.A., 2009, 243).
qua! E si tratta dell’acqua che, secondo i Molti dei grandi artisti ci ricordano l’inti-
giornali, viene inquinata. Viene dal fiume ma necessità di questo «sguardo», di questo
sudicio della città. Piena di cloro. Ma per
desiderio che consente di oltrepassare «la
via della brocca l’acqua diventa buona,
salubre, fresca e dolce. siepe» di leopardiana memoria, per tentare
Il figlio ritorna. Ha girato il mondo. di accedere ad altri orizzonti, fino «all’ulti-
Ha studiato. Arriva. Bacia la madre. mo orizzonte», dove il dialogo con l’infinito
[…] «Mamma, ho sete! Voglio bere sa regalare alla nostra navigazione il senso
dalla vecchia brocca!». di un naufragio salvifico e dolce, tutt’altro
[…] Non per saziare la sete del cor- che pauroso e distruttivo.
po. Questa, tante acque la saziano. Ma la Di quest’acqua, di questo mare abbiamo
sete dell’archetipo familiare, la sete dei tutti bisogno, e non c’è età del tutto disseta-
penati paterni, la sete fraterna, archeo- ta, che giustifichi soste, rifiuti o indifferenza
logica, delle radici da dove viene la linfa rispetto a questo nutrimento esistenziale.
della vita umana. Questa sete soltanto la
Tanto più l’età dell’adolescenza, con le
brocca la può saziare. Beve una prima
brocca. Avidamente. Termina con un specifiche sfide di «acrobaticità», «vulnera-
lungo sospiro, come chi si è tuffato e ri- bilità», «progettualità» (Milan G. e Cestaro
torna in superficie. Poi ne beve un’altra. M., 2016b) e che, come recita l’etimologia
Lentamente. È per gustare il mistero che del termine, è la specifica età del «crescere»,
la brocca contiene e significa. (Boff L., necessita di quel nutrimento autentico, ca-
1982, 7-8). pace di far prevalere la speranza pur in un
contesto arido.
Studi Zancan · 5/2016 · 19Milan G. e Cestaro M.
Può essere l’educazione – come indica È una questione di «religione»?2
l’eterna metafora dell’educatore-giardiniere
– la via per risvegliare le energie individuali Gli adolescenti e i giovani di oggi sono
e collettive? Come semi piantati in un giar- abitati da «un desiderio di cielo»? Da uno
dino arido, le risorse delle persone attendo- «sguardo» capace di «cogliere ciò che è in-
no, per «crescere», chi sappia innaffiare e visibile agli occhi»? In altre parole, tra di
rassodare al punto giusto il terreno. loro, trovano ancora posto le dimensioni
Ci vuole però la creatività pedagogi- della spiritualità e della religiosità? E se sì,
ca della «testardaggine» che, quando tutto quale significato esse assumono?
sembra sterile e bloccato, ancora spera e Nel cercare di rispondere a tali interro-
crede nella generatività della cura autenti- gativi, si fa riferimento ai dati emersi dallo
ca, dell’amore responsabile, della fedeltà al studio longitudinale CRESCERE, che se-
compito. gue nel tempo un campione di circa 450
Il grande regista Andrej Tarkovskij, all’ini- ragazzi residenti nelle provincie di Padova
zio del film «Sacrificio», presenta la suggestiva e Rovigo, dagli 11 ai 18 anni d’età3.
«leggenda dell’albero inaridito». Racconta di un Una prima considerazione sembra emer-
monaco che ogni giorno usciva con un cari- gere con una certa evidenza: nel passaggio
co speciale e ripeteva un itinerario solo ap- dalla preadolescenza all’adolescenza la reli-
parentemente ingenuo e improduttivo: pas- gione comincia a distinguersi dalla spiritua-
so dopo passo, secchio dopo secchio, con lità.
un andirivieni continuo, portava l’acqua sulla Alla domanda «Credi a qualche tipo di
montagna e innaffiava un albero inaridito, religione?», la percentuale di risposte af-
credendo senza ombra di dubbio nella ne- fermative registra infatti una sensibile di-
cessità di ciò che faceva, senza abbandonare minuzione passando dai 12 e ai 14 anni
neppure per un istante la fiducia nella forza (rispettivamente dal 87% al 68%), mentre
miracolosa della sua fede. Alla fine, vide il aumentano gli incerti (dal 8,4% al 17,8%) e
miracolo: una mattina i rami dell’albero si ri- coloro che dichiarano di «non credere» (dal
animarono e si coprirono di foglie. 4,7% al 13,9%).
«Ma questo è forse un miracolo? È sol- Specularmente, diminuisce la percentua-
tanto la verità!» – scrive Tarkovskij – «è la le di coloro per i quali la religione è «mol-
verità che si fa strada quando si insegue to/abbastanza importante» (passando dal
con fede un ideale, un sogno, compiendo 75% a 12 anni, al 61% a 13 anni e al 57% a
i piccoli difficili passi di ogni giorno per- 14 anni) mentre aumenta la quota di colo-
ché il nostro albero inaridito possa fiorire ro che la considerano «poco/per nulla im-
e crescere» […] «Il nostro mondo è scis- portante» (25% a 12 anni; 39% a 13 anni;
so in due parti: il bene e il male, la spiri- 54% a 14 anni). Nello specifico, per quanto
tualità e il pragmatismo. Il nostro mondo riguarda l’importanza attribuita alla religio-
umano è costruito, è modellato sulla base ne, è interessante notare l’esistenza, tra i
delle leggi materiali poiché l’uomo ha co- 12 e i 13 anni, di una correlazione positi-
struito la propria società sul modello della va tra l’importanza attribuita alla religione
morta materia. Perciò egli non crede nello e la fiducia in se stessi: più la religione ha
Spirito e rifiuta Dio. C’è una speranza che un ruolo importante nella vita dei ragazzi,
l’uomo sopravviva, nonostante tutti i se- più il livello di autostima è elevato. Anche
gni del silenzio apocalittico preannunciato rispetto al grado di benessere espresso, me-
dall’evidenza dei fatti? La risposta a questo diamente si registra come esso assuma un
interrogativo, forse, è contenuta nell’antica livello maggiore nei ragazzi che credono.
leggenda sulla resistenza dell’albero inaridi- Con il procedere dalla preadolescenza
to, privato dei succhi vitali» (Tarkovskij A., all’adolescenza le risposte sembrano inol-
2002, 211). tre radicalizzarsi verso posizioni estreme,
20 · Studi Zancan · 5/2016Educare gli adolescenti alla spiritualità
rivelando la tendenza, tipica di questa fase ma dai confini «assai porosi» (ibidem).
evolutiva, a dicotomizzare il proprio giu- Più che di un vero e proprio rifiuto, quel-
dizio su poli opposti e nettamente distinti. lo dei giovani con il credere è un rapporto
Nel passaggio dai 12 ai 14 anni, la quota di lasciato in sospeso, in «standby» (Castegna-
coloro che attribuisce nessuna importanza ro A. e altri, 2013), costantemente rinviato,
alla religione aumenta di circa 21 punti per- ma mai del tutto reciso. Tra il credere e il
centuali (passando dal 13% al 34%) mentre non credere, la maggioranza si colloca in-
diminuisce la quota di coloro che consi- fatti in una «terra di mezzo» (ibidem), in cui
derano la religione molto importante (dal a dominare è una costante condizione di
35% al 12%). incertezza e di ricerca. Emerge l’affermarsi
Come leggere questi dati? Essi registrano di un «sentire religioso soggettivo e auto-
un progressivo e inesorabile calo dell’inte- nomo» in cui non manca anche la tendenza
resse religioso negli adolescenti? Si potreb- a costruirsi una «fede su misura» (Garelli
be essere indotti a tale conclusione se non F., 2016). Quella giovanile appare delinearsi
fosse per un’altra batteria di risposte che così come una fede «nomade», «sempre più
possono sembrare «paradossali» e «con- individuale e solitaria, tipica del pellegrino»
traddittorie» se confrontate con le prece- (Bichi R. e Bignardi P., 2015). Tale è «l’uo-
denti. Circa l’80% dei tredicenni afferma di mo inquieto in perenne ricerca» colui per il
«essersi interrogato almeno una volta nella quale «è solo possibile cercare» (Castegnaro
vita sull’origine del mondo e dell’universo» A. e altri, 2013).
mentre il 52% di essi ritiene che «esista un Tuttavia, malgrado la religiosità giova-
essere superiore». nile si presenti incerta, fluida in costante
Col procedere dell’età, dunque, ciò che peregrinare e per nulla «lineare», essa rivela
realmente cala sembra essere l’interesse per tracce di un’inquietudine e di una spiritualità
la religione, intesa per lo più come osservan- animata da profonde domande di senso (Bichi
za a regole e pratiche religiose, mentre per- R. e Bignardi P., 2015, Garelli F., 2016).
mane la curiosità per interrogativi di fondo Rispetto alle generazioni che li hanno
inerenti l’esistenza e il senso della vita. preceduti, i giovani di oggi non appaiono
È una tendenza che conferma quanto già dunque «meno spirituali» e «meno reli-
evidenziato dalle più recenti ricerche sulla giosi». Ad abitarli è piuttosto un bisogno
religiosità giovanile aventi come target i co- di «personalizzazione del credere» (Caste-
siddetti Millennials: giovani di età compresa gnaro A. e altri, 2013; Bichi R. e Bignardi
tra i 18 e i 29 anni. Al riguardo, gli ultimi dati P., 2015), da intendersi come una risorsa
raccolti registrano una religiosità giovanile da valorizzare poiché esprime l’esigenza di
in movimento, piuttosto articolata e varie- passare da una «identità religiosa trasmes-
gata al suo interno, rispetto alla quale non sa» ad una «identità religiosa scelta» (Caste-
sembra potersi affermare «la marginalità o gnaro A. e altri, 2013), riconosciuta come
l’irrilevanza della condizione di ’credenti’» fondamento e orientamento per la propria
(Garelli F., 2016). A fronte di una sensibi- vita e per la propria identità personale.
le crescita dei «non credenti» da un lato e
dell’assottigliarsi del numero di «credenti
convinti e praticanti» dall’altro, permane Educare ad una spiritualità
infatti una larga quota di giovani che man- religiosamente orientata
tengono, per motivi indotti dalla tradizio-
ne e dall’educazione ricevuta, un «legame Arrivati a questo punto, la domanda
esile» con la religione cattolica. Fortemente pedagogica che possiamo porci è: come
variegate al loro interno, quelle dei «creden- guardare alla spiritualità in modo tale da
ti» e dei «non credenti» sono piuttosto delle prenderci cura della educabilità della persona
categorie tra loro non rigidamente distinte umana colta nella sua singolarità?
Studi Zancan · 5/2016 · 21Milan G. e Cestaro M.
Un aiuto in tale direzione ci viene dal manifestano, a modo loro, l’esigenza di una
riconoscere il desiderio come uno dei tratti spiritualità orientata verso la vita di quag-
salienti della spiritualità. Radicandosi nel- giù, che ha meno a che fare con il tema del
la contingenza dell’esistenza personale, comportamento morale o con le pratiche
il «desiderio» rivela infatti ciò che attrae e religiose e più con il bisogno di ritrovare se
orienta lo sguardo «verso le stelle» (dal la- stessi, di dare significato alla propria vita, di
tino «de»-«sidera» che significa «mancanza cercare un miglior equilibrio vitale (Caste-
di stelle»). È ciò che, nel trascendere l’e- gnaro A. e altri, 2013).
sperienza, consente di arricchirla di sen- Forse questa può sembrare unicamen-
so. Diversamente detto, è proprio in tale te una forma di «spiritualità laica». Eppu-
«alzare lo sguardo verso le stelle» a partire re proprio in essa si cela quel desiderio di
da domande di senso, che si esprime l’aprirsi «passare dal credere in Dio [trasmesso], al
dell’io, colto nella «intimità» della sua «vita credere al mistero di Dio, dalla dogmatica
interiore», al senso di Infinito e di Assoluto. È alla mistica, dalla teologia alla poesia […]
pertanto in tale «desiderare», quale movimen- che di per sé indica un potenziale di ric-
to interiore del trascendere, che possiamo rico- chezza spirituale da valorizzare» (ibidem).
noscere le tracce di una spiritualità che rive- La sfida educativa che allora si pone è
la la natura relazionale della persona umana quella di promuovere il passaggio da un deside-
come essere «Io-Tu» (Buber M., 1993). Si rio di senso, proprio di una sensibilità spirituale
tratta di una relazionalità che, in quanto di- nomade, a una spiritualità religiosamente orienta-
mensione costitutiva dell’essere umano, si ta. Come? Riteniamo che alcuni «strumen-
esprime nell’esistenza di ciascuno in senso ti» utili a favorire tale passaggio risiedano
sia orizzontale – le relazioni con gli altri e proprio in alcune capacità-chiave che, ra-
con la comunità – sia verticale – la relazione dicandosi nella relazione, consentono di
con la profondità del proprio sé e con l’altez- qualificare un agire educativo religiosamen-
za di ciò che «va oltre» la realtà empirica e si te orientato. Ad essere chiamato in gioco è
dispiega nell’orizzonte etico-valoriale fino infatti uno stile relazionale che sappia tra-
a raggiungere, per chi sceglie, la relazione dursi in quella che possiamo definire l’arte:
con il Tu di Dio (Milan G. e Cestaro M., – dell’ascolto: quale disponibilità e capa-
2016a; Cestaro M., 2013). cità di cogliere la «parola giusta» (Ebner F.,
Volgendo lo sguardo a questo nostro 1998) che l’altro pronuncia sapendone «in-
tempo, tristemente segnato da quello che tuire» (Buber M., 1993) le domande di sen-
Papa Francesco definisce un processo di so che lì vi si celano. Porsi in ascolto solle-
«desertificazione spirituale» (2013, p. 86) cita dunque ad entrare nella relazione con il
ma al tempo stesso contraddistinto da un desiderio di incontrare l’altro «là dove egli
«rinnovato interesse spirituale» (De Fiores è», di «rendersi presenza» – accogliente e
S. e Goffi T., 1999, 1517), possiamo rico- non giudicante – affinché egli possa a sua
noscere come emerga con forza l’esigenza volta «rendersi presente» (ibidem) prima di
di riscoprire una spiritualità «esistenzialmen- tutto a se stesso;
te esperita» mediante le relazioni che il sin- – del testimoniare: quale capacità di «mo-
golo intrattiene con se stesso, con gli altri e strare», mediante il proprio modo di rap-
con il mondo. portarsi con se stesso, con gli altri e con la
Si sta facendo strada cioè «un’apertura al vita, le «ragioni» per le quali valga davvero
trascendente» a partire «dall’uomo e dalle la pena credere. Saper essere dei testimoni
sue esperienze» (ibidem, 1519). Espressio- credibili si profila così come una responsa-
ne di un tale desiderio spirituale, che nasce bilità che sollecita ogni credente – in par-
dall’uomo, dalla sua umanità e dalla sua sete ticolare se educatore – ad impegnarsi in
di senso, sono proprio i giovani che abitano un’arte dell’accompagnamento che sappia
questo nostro tempo liquido e plurale. Essi camminare al «ritmo salutare della prossi-
22 · Studi Zancan · 5/2016Educare gli adolescenti alla spiritualità
mità» (Papa Francesco, 2013, 169) per ren- Note
dere visibile come, in qualità di singoli e di
comunità, si sta compiendo quel cammino 1 Il presente paragrafo è di Giuseppe Milan.
di fede che si afferma di aver scelto; 2 Il presente paragrafo e il successivo sono
– del ricorrere ad un linguaggio vicino ed acces- di Margherita Cestaro. Per la loro stesura
l’Autrice fa riferimento all’articolo Adole-
sibile all’interlocutore: quale capacità di adot-
scenti, spiritualità. Religiosità: quale educa-
tare un linguaggio che, ancorandosi alle
zione, contenuto in «Studium Educationis»,
esperienze di vita dei preadolescenti e degli 3/2016.
adolescenti, sia in grado di «tradurre» sul 3 CRESCERE è l’acronimo di Costruire Re-
piano esistenziale quelle parole e quei con- lazioni ed Esperienze di Sviluppo Condivi-
cetti religiosi che possono spesso risultare se con Empatia, Responsabilità ed Entusia-
loro «astratti» e «criptici». Ad essere inter- smo. Lo studio è realizzato dalla Fondazione
pellate sono pertanto la sensibilità e la de- Emanuela Zancan onlus, con il sostegno
licatezza con cui l’adulto-educatore sa farsi della Fondazione Cassa di Risparmio di Pa-
prossimo sapendo pronunciare la «parola dova e Rovigo, in collaborazione con molti
giusta» quella cioè che sa intercettare, acco- partner locali (Barbero Vignola G. e altri,
2016; Vecchiato T. e Canali C., 2013). Per
gliere e alimentare quel desiderio profondo
informazioni: www.crescerebene.org.
di senso, di autenticità, di amare e di sentir-
si amati che abita il cuore di adolescenti e
giovani, come di ogni essere umano;
– di generare «esperienze di bellezza»: qua- SUMMARY
li occasioni preziose in cui il bello che la
natura e le diverse forme artistiche quoti- In the age of «arid modernity», have the
dianamente regalano possa – come direbbe dimensions of interiority and spirituality
Socrate nel Fedro – consentire all’anima di dried up completely, or can they still find
«mettere le ali», favorendo cioè l’incontro a spring of «water» from which to draw?
tra la parte «più intima» di sé e «quel qual- In particular, is it still possible – and in
cosa» che si intuisce essere racchiuso e, al this case, through what ways – to educa-
tempo stesso, «andare oltre» quella bellezza te adolescents and young people in a «re-
percepita. ligiously oriented spirituality»? These are
Raccogliere allora la sfida di educare ado- the essential questions around which the
lescenti e giovani ad una spiritualità religio- reflection presented in this article cen-
samente orientata, sollecita ad assumere nei ters, starting from some data from the
loro confronti uno sguardo educante, capace Longitudinal Study Crescere, based on a
di riconoscere, accogliere, favorire e orien- sample of about 450 minors residing in
tare quel desiderio – a volte solo sopito e the provinces of Padova and Rovigo.
latente ma comunque presente – di una re-
lazione intima, personale e incarnata, nella
propria umanità, con il Tu di Dio. L’appello
che implicitamente essi sembrano rivolgere
è quello di poter fare esperienza di una «religio-
sità incarnata» nei volti e nelle relazioni che
essi incontrano e vivono.
Studi Zancan · 5/2016 · 23Milan G. e Cestaro M.
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Bauman Z. (2000), Modernità liquida, Feltrinelli, Milano.
Barbero Vignola G., Bezze M., Canali C., Crocetti E., De Leo D., Eynard M., Maurizio R.,
Milan G., Ongaro F., Schiavon M. e Vecchiato T. (2016), Crescere: uno studio longitudinale
per il benessere dell’infanzia, «Studi Zancan», 1, pp. 21-32.
Bichi R. e Bignardi P. (2015), Dio a modo mio. Giovani e fede in Italia, Vita e Pensiero, Milano.
Boff L. (1982), I sacramenti della vita, Edizioni Borla, Roma.
Buber M. (1993), Il Principio dialogico e altri saggi, San Paolo, Cinisello Balsamo.
Büchner G. (1978), Woyzeck, in ID., Teatro, Adelphi, Milano, pp. 155-156.
Castegnaro A., Dal Piaz G. e Biemme E. (2013), Fuori dal recinto. Giovani, fede, chiesa: uno
sguardo diverso, Ancora, Milano.
Cestaro M. (2013), Educare «stando nel mezzo». Mediazione interculturale tra ricerca e formazione,
Cleup, Padova.
De Fiores S. e Goffi T. (a cura di) (1999), Nuovo dizionario di spiritualità, San Paolo, Cinisello
Balsamo.
Ebner F. (1998), La parola e le realtà spirituali. Frammenti pneumatologici, San Paolo, Cinisello
Balsamo.
Florenskij P.A. (2009), Ai miei figli. Memorie di giorni passati, Mondadori, Milano.
Papa Francesco (2013), Evangelii gaudium. Esortazione apostolica sull’annuncio del Vangelo nel
mondo, Paoline, Milano.
Garelli F. (2016), Piccoli atei crescono. Davvero una generazione senza Dio?, Il Mulino, Bologna.
Milan G. (1994), Educare all’incontro. La pedagogia di Martin Buber, Città Nuova, Roma.
Milan G. e Cestaro M. (2016a), We can change! Seconde generazioni, mediazione interculturale, città.
Sfida educativa, Pensa MultiMedia, Lecce.
Milan G. e Cestaro M. (2016b), Adolescenti, spiritualità, religiosità: quale educazione?, «Studium
Educationis, 3, pp. 43-59.
Tarkovskij A. (2002), Scolpire il Tempo, Ubulibri, Milano.
Vecchiato T. e Canali C. (2013), Crescere oggi: ricerca e politiche sociali per la crescita positiva, in
F. Mazzucchelli (a cura di), La preadolescenza. Passaggio evolutivo da scoprire e da proteggere,
Franco Angeli, Milano, pp. 31-46.
24 · Studi Zancan · 5/2016Puoi anche leggere