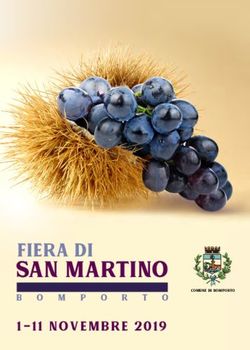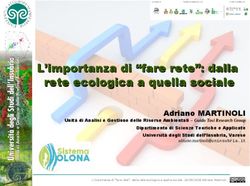Dal paesaggio perduto ai progetti di paesaggio - note a margine di una proposta di Donatella Blunda per Alcamo Marina - Città del Vino
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Dal paesaggio
perduto ai progetti
di paesaggio
note a margine di una proposta di Donatella Blunda per
Alcamo Marina
Ferdinando Trapani
Dipartimento di Architettura
Scuola PolitecnicaDalle regole alla visione
1. Introduzione
2. Paesaggio, Patria, Identità
3. Che fare? La legge urbanistica nazionale
4. Come fare? Il codice dei Beni Culturali individua i limiti allo sprawl e la tutela della
campagna
5. I tentativi della Regione Toscana per lo spreco di suolo
6. Una ipotesi per gestire il territorio già nei primi momenti in cui si manifestò
l’abusivismo: La città in estensione di Giuseppe Samonà (1976-1980)
7. Tutta la città ha un valore da conoscere per cambiarla. Ma qual è e come si può
misurare?
8. Caracas
9. Alcamo Marina
10. Istambul
11. Conclusioni: premesse ad un elogio dell’abusivismo. Tracce per la rigenerazione
urbana dell’abusivismo tutto da re-interpretare in chiave di inconscio collettivoAlle origini dell'abusivismo in Italia I paesaggi urbani, rurali e naturali dei territori si consolidano nei tempi che precedono il secondo conflitto mondiale fino a quasi la fine degli anni sessanta. Poi accade qualcosa che determina l'avvento di un cambiamento profondo e che chiude per sempre il lungo periodo del rapporto biunivoco tra città e campagna sullo sfondo delle aree naturali. L'avvento della crisi energetica, dal 1973, coincide con ondate di trasformazioni sociali ed economiche che provocano effetti sugli assetti fisici ovunque.
Nelle aree costiere di tutto il mondo si vanno a
concentrare le forti spinte all'urbanizzazione
stanziale dovute sia alla costruzione di vere e
proprie nuove città o per la residenza
stagionale e per il turismo.
Nel Mezzogiorno italiano, ma non solo, si concentra
una massa di cementificazione creata soprattutto
leva delle rimesse
sulla base della
dell'emigrazione di ritorno grazie alla
disponibilità di valuta pregiata a fronte di una
fortissima svalutazione della lira.
stravolgimento del
La spinta allo
territorio italiano e soprattutto di quello
costiero del Mezzogiorno ha determinato oggi una
situazione paradossale: la principale risorsa locale
di crescita e sviluppo, ossia il mare, la costa e il
fonte di
turismo, sono diventati una crescente
costi e di impoverimento delle
collettività.Dopo i tentativi da parte dello Stato di affrontare l'abusivismo con i condoni e le sanatorie, emerge una nuova domanda sociale di qualità dell'abitare, non solo in termini di nuove leggi in urbanistica. I paesaggi urbani, rurali e naturali dei territori dell'Occidente si consolidano in modo equilibrato tra tradizione e modernità nei tempi che precedono il secondo conflitto mondiale -nonostante le distruzioni belliche- fino a quasi la fine degli anni sessanta.Emerge una nuova domanda sociale di qualità dell'abitare che non si esaurisce nei tentativi di una nuova legge urbanistica ma soprattutto di recupero della bellezza del paesaggio perduto.
Oggi, le politiche emergenti di rigenerazione
urbana ecosostenibili dimostrano che bisogna
avere qualche idea di innovazione sociale
prima di agire sui comportamenti e riflettere, dopo,
della giustizia distributiva e
sui temi
redistributiva. Quello che manca è un
progetto di paesaggio come obiettivo
finale delle azioni di contrasto all'abusivismo in una
chiave di riuso e rigenerazione di tessuti e morfologie
edificate che non sono mai state vere e proprie parti
urbane.
Quello che rimane di una 'città diffusa'
alla maniera meridionale, ossia una 'città dispersa',
deve in effetti essere oggetto di interventi che invece,
ancora una volta, potrebbero costituire nuove parti
diuna 'città in estensione' come la
vedeva Giuseppe Samonà proprio alla fine degli anni
'70 (guarda caso).Il contributo al convegno punta ad esaltare l'importanza degli
studi sugli assetti del paesaggio antecedenti il secondo conflitto
mondiale così come voleva l'ispirazione della 'città bella'
di Pierluigi Cervellati e che per una prospettiva
futura vede invece le pratiche e le politiche di progetto di
territorio e di paesaggio (con riferimento alle impostazioni
territorialiste di Magnaghi).
Caracas
I casi di e di Istambul dimostrano che la
partecipazione attiva dei cittadini nel recupero e la
determinazione sociale sulle politiche di vertice costituiscono
elementi decisivi per la gestione sostenibile delle trasformazioni
urbane.
Per il territorio alcamese l'ipotesi di recupero di Alcamo
Marina di Donatella Blunda presenta aspetti interessanti
per nuove traiettorie di senso.Paesaggio, Patria, Identità Per capire la nozione di paesaggio prendo a prestito la famosa metafora di John Ruskin (“Il paesaggio è il volto amato della patria”), aggiornandola così: il paesaggio è il volto di una comunità ecologica, l’immagine di un sistema vivente in cui tutte le componenti antropiche e naturali, presenti e passate, sono poste in relazione (compreso l’osservatore, che ne fa parte integrante). Come scrive Tiziana Banini: il paesaggio è “l’espressione visibile dell’interazione unica e irrepetibile tra uomo e ambiente” (Banini). Tratto da Paesaggio e decrescita di PAOLO CACCIARI 12 Novembre 2012: http://www.eddyburg.it/2012/11/paesaggio-e- decrescita.html Nella sua relazione al Senato, Croce si appella ai precedenti americani ed europei e allude a ciò che è e resta il «doppio cuore» del problema, cioè da un lato la relazione tra natura e cultura (in Italia tra città e campagne), e dall’altro l’equilibrio tra interesse pubblico e proprietà privata. Un «grandissimo interesse morale e artistico legittima l’intervento dello Stato», scrive Croce, perché il paesaggio «non è nient’altro che la rappresentazione materiale e visibile della patria». (S. Settis, 2010) Settis: Perché gli italiani sono diventati nemici dell’arte: http://www.ilgiornaledellarte.com/articoli/2012/10/114543.html
Che Fare? La legge urbanistica italiana (n.1150/1942) partiva dal contrasto alle spinte di concentrazione urbana Partiamo dalla legge madre dell’urbanistica italiana,la 1150 del 1942. L’articolo 1 definisce la “Disciplina dell’attività urbanistica e suoi scopi”: “L’assetto e l’incremento edilizio dei centri abitati e lo sviluppo urbanistico in genere nel territorio del Regno sono disciplinati dalla presente legge. Il Ministero dei lavori pubblici vigila sull’attività urbanistica anche allo scopo di assicurare, nel rinnovamento ed ampliamento edilizio delle città, il rispetto dei caratteri tradizionali, di favorire il disurbanamento e di frenare la tendenza all’urbanesimo”.
Come Fare? Il codice dei beni culturali punta al minor consumo di suolo Codice dei beni culturali e del paesaggio, d.lgs 42/2004 Articolo 135 Pianificazione paesaggistica 1. Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, (...) (...) 4. Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare: a) (...); b) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate; c) alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio; d) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali (...).
rigenerare l'abusivismo significa ritrovare una nuova condizione di equilibrio tra città e campagna “ (…) Tutto il territorio nazionale, escluse le città, è campagna composta di due parti: quella coltivata e coltivabile, con case isolate e con piccoli nuclei edilizi, e quella non abitata in modo permanente, formata da grandi aree geografiche di riserva ecologica, biologicamente necessaria e in parte montuosa. (…) Da noi la metà della superficie del territorio è occupata da imprese capitalistiche e da proprietà assenteista in affittanza coltivatrice; vi è dunque, dopo l’attuazione della legge stralcio, largo spazio per l’espansione delle imprese di proprietà direttamente coltivatrice, che dovrebbero essere costituite in forme associative da promuovere sulla base dell’esproprio generalizzato, proprietà da istituire insieme alla trasformazione di ordinamenti produttivi, come unica condizione per uno sviluppo economico, sociale, civile e culturale del territorio. (…) Tutto questo programma, per diventare vivo in rapporto alle esigenze di un habitat adatto al livello civile dell’uomo del nostro tempo, dipende da una effettiva comparabilità delle condizioni di cultura dell’habitat contadino con quello urbano, nel momento in cui queste trasformazioni si attuano. (...) È possibile così dare una forma integrata alla comunità per tutte le estensioni di campagna, suddivise in modo che le sue parti possano essere progettate come lo è l’edilizia della città e concepite in un insieme unitario che abbia, sul piano della forma, un ordinamento rispondente a norme regolatrici di tutte le aree agricole.” Da: Giuseppe Samonà (1980), “Come ricominciare. Il territorio della città in estensione secondo una nuova forma di pianificazione urbanistica”, in: Parametro n. 90.
Una forma di equilibrio tra città e campagna: la città in estensione “ È una trasformazione della campagna in cui tutte le cose del suo territorio, assumono un particolare valore insediativo di posizione analogo alla tipologia della città. Così gli spazi della campagna sono organizzati per parti con norme che la vincolano anche formalmente alle parti stesse, modellandole sulla estensione e la qualità dei processi agricoli legati alla presenza umana accentrata e sparsa. Si forma in tal modo un insieme stanziale in prevalenza agricolo contadino, rappresentato con sistemi di spazio territoriale che, associati a quelli industriali e infrastrutturali, potrebbero essere espressi con senso architettonico e dare alla campagna artificializzata il carattere di città, qualora l’insieme stanziale della campagna assumesse gli aspetti di civiltà urbana, organizzando le tappe conflittuali della partecipazione degli abitanti alla configurazione di questa nuova città.” Da: Giuseppe Samonà (1980), “Come ricominciare. Il territorio della città in estensione secondo una nuova forma di pianificazione urbanistica”, in: Parametro n. 90.
I tentativi in Toscana per limitare lo spreco di suolo “(...) Al fine di contrastare e ridurre al minimo strettamente necessario il consumo di suolo ciò che nel testo vigente e' soltanto un enunciato di principio viene pertanto tradotto in una serie di dispositivi operativi concreti: - si definisce in modo puntuale il territorio urbanizzato, differenziando le procedure per intervenire all'interno dello stesso da quelle per la trasformazione in aree esterne, con particolare riferimento alla salvaguardia del territorio rurale e al fine di promuovere il riuso e la riqualificazione delle aree urbane degradate o dismesse; - in aree esterne al territorio urbanizzato non sono consentite nuove edificazioni residenziali. Limitati impegni di suolo per destinazioni diverse da quella residenziale sono in ogni caso assoggettati al parere obbligatorio della conferenza di copianificazione d'area vasta, chiamata a verificare puntualmente, oltre alla conformità al PIT, che non sussistano alternative di riutilizzazione o riorganizzazione di insediamenti e infrastrutture esistenti; - nel territorio urbanizzato, per promuoverne il riuso e la riqualificazione, ferme restando una serie di condizioni generali sono introdotte alcune semplificazioni.” Anna Marson, Assessore regionale all'urbanistica. Da: http://www.eddyburg.it/2013/10/legge-urbanistica-regionale-della.html
Tutta la città ha un valore da conoscere per
cambiarla. Ma qual è e come si può misurare?
La rigenerazione dell'abusivismo è solo un pezzo, un brano di un
unico testo: la città nuova e il suo disegno.
Prima di tutto serve la sua piena conoscenza che deve essere
aperta e condivisa. Le nuove tecnologie (Sistemi Informativi
Territoriali, web gis, ecc.) consentono sia alle PA che a tutte le
rappresentanze della Cittadinanza Attiva di verificare se le
trasformazioni della città esistente, l'unica veramente trasformabile
in modo eco-sostenibile, rispondono all'interesse pubblico oltre
che ai legittimi interessi imprenditoriali.
La città da conoscere assomiglia ad una impresa, che ha i suoi
fattori di capitalizzazione :
Capitale infrastrutturale
Capitale finanziario
Capitale naturale
Capitale umano
Capitale spaziale/localizzativo
cfr.: Goodwin, N. R. (2003). Five Kinds of Capital: Useful Concepts for Sustainable Development.
Global Development and Environment Institute.“Apparentemente si tratta di una sistemazione dei percorsi pedonali all’interno di un abitato informale; in realtà Esclerologias è un progetto di rigenerazione in grado diattivare le energie comunitarie della popolazione residente in un barrio di Caracas. La Vega è un esteso insediamento abusivo di circa 392 ettari situato nella zona sud–est di Caracas in cui abitano circa 95 mila persone. All’inizio del XX secolo, l’apertura di uno stabilimento per la produzione di cemento provoca la formazione di piccoli nuclei di abitazioni che vengono edificate nella zona nonostante l’elevata pendenza (che arriva fino al 40%) e il terreno instabile soggetto a dissesto idrogeologico”. Da:http://www.architetturaecosostenibile.it/architettura/progetti/nel-mondo/popolazione-evitare-abusivismo-edilizio-767/
Da:http://www.architetturaecosostenibile.it/architettura/progetti/nel-mondo/popolazione-evitare-abusivismo-edilizio-767/
Da:http://www.architetturaecosostenibile.it/architettura/progetti/nel-mondo/popolazione-evitare-abusivismo-edilizio-767/
Da:http://www.architetturaecosostenibile.it/architettura/progetti/nel-mondo/popolazione-evitare-abusivismo-edilizio-767/
LeRiqualificazione
b della costa di Alcamo, Architettura, Università di Firenze, a.a. 2009/2010
Tesi di Donatella Blunda
Relatore: prof. Francesco Ventura
Correlatore: prof. Mauro Marinelli
donablunda@libero.it
«Le nostre città non sono l’opera delle attuali generazioni,
né di quelle precedenti, né di questo secolo,
né di quello passato.
Esse sono l’opera, perseverante e continua,
di molte generazioni, di molti secoli,
di molte civiltà diverse.
Sono quei monumenti storici ai quali
ogni generazione, ogni secolo ed ogni civiltà ha
aggiunto al suo passaggio una nuova pietra,
che non è stata posta per capriccio,
Ma con deliberata intenzione».
Ildefonso CerdàLa costa di Alcamo comprende circa sette chilometri di litorale marino di natura sabbiosa, l’insediamento urbano arriva a contare circa 30'000 abitanti nella stagione estiva e 800 in quella invernale. Il sito si trova in una posizione mediana nel golfo di Castellammare, tra diverse realtà ambientali-paesaggistiche vincolate e riserve naturali, al confine delle due province di Trapani e Palermo, e in prossimità dell’aeroporto internazionale Falcone-Borsellino. La riqualificazione della costa di Alcamo si prefigge di indagare una parte del territorio del comune alcamese che, pur avendo notevoli qualità paesaggistiche, è soggetta a un tipo di urbanizzazione, in molti casi, incontrollata e informale e sprovvista di servizi minimi infrastrutturali. Il progetto mira a riqualificare il sito dal punto di vista ecologico, ambientale, turistico, del trasporto pubblico, di ordine e decoro urbano, attraverso una linea strategica finalizzata da un lato, a far emergere le principali risorse naturali e dall’altro, a potenziare quelle socio- antropiche più rilevanti.
LIVELLO TERRITORIALE Potenziamento del percorso ferroviario della linea Palermo-Trapani e il prolungamento di questa fino all’aeroporto V. Florio di Birgi. Realizzazione del secondo binario, l’introduzione dei treni ad alta velocità e di una linea tranviaria utilizzante gli stessi binari. Obiettivo duplice: ecologico attraverso l’uso di mezzi su rotaia, e l’altro economico-sociale con un sistema di trasporto più dinamico ed efficiente. TOD, Transit oriented development, della città di Ottawa. Si definisce TOD, un’area residenziale o commerciale di densità medio-alta posizionata entro un raggio pedonale da una fermata o stazione dei mezzi pubblici veloci, progettata in modo da favorirne e facilitarne l’uso.
Nella cultura siciliana vi è una marcata identità sociale. L’identità è ciò che distingue l’uno dall’altro attraverso comportamenti, modi di agire e regole. Il sistema delle regole sociali ha prevalso sul sistema delle regole pubbliche. Nello stesso PRG, si può notare come gli spazi pubblici più diffusi, a parte l’area demaniale della spiaggia, siano rappresentati dalle aree dei parcheggi, mai realizzati, e la zonizzazione di gran lunga più estesa è quella di edilizia-stagionale. Le abitazioni o i villini prevalgono sulla piazze e sugli slarghi pedonali, il trasporto automobilistico su quello pubblico, la viabilità veicolare su quella ciclabile e pedonale. La costa di Alcamo non è solo costituito da edilizia, ma quasi al 50% anche da verde agricolo e incolto. Ma non solo. Questo paesaggio “nascosto” non è piatto, ma è costituito da colline, valli e torrenti che nelle stagioni invernali sfociano nel mare. In una parte della costa il verde si fonde con la spiaggia, divenendo vegetazione dunale e formando lembi di macchia arborea. Si è di fronte alla realtà paesaggistica.
LIVELLO LOCALE Triplice strategia Responsabilità sociali Attraverso riqualificazioni ambientali ed edilizie, piano del colore, incentivazione all’apertura di attività ricettive nelle strutture esistenti. Realtà nascoste Protezione delle aree verdi più rilevanti e delle aree con vincolo idrogeologico, rimboschimenti, realizzazione di percorsi pedo-ciclabili naturalistici. Liberare spazi collettivi Realizzazione di spazi di fruizione pubblica in aree non edificate, parcheggi, spazi ludici, riqualificazione degli slarghi esistenti.
RIGENERAZIONE, SPINTE SPECULATIVE, CONSENSO, PARTECIPAZIONE Il progetto di trasformazione urbana di Taksi Gezi Park a Istambul e alcune immagini delle proteste
Oltre l'etica: per la rigenerazione dell'abusivismo forse esistono valori da interpretare (nonostante tutto) “Genova (…) Se si osserva il modo con cui sono costruite le città del Nord, impressiona la legge e il piacere della legalità universalmente diffuso, nonché l'obbedienza: s'indovina in tutto questo quell'interiore disporsi all'uguaglianza e inserirsi in un ordine che deve aver dominato l'anima di tutti i costruttori. Invece qui ad ogni angolo di strada, trovi un uomo che sta per conto proprio, che conosce il mare, l'avventura e l'Oriente, un uomo che è avverso alla legge e al vicino, come a qualcosa di tedioso, e che misura tutto il già costituito, il vecchio, con l'invidia nello sguardo: egli vorrebbe, con una mirabile sottigliezza della fantasia, dare ancora una volta nuove fondamenta a tutto questo, almeno nel pensiero, porvi mano ed entrarvi con lo spirito, fosse anche soltanto per l'attimo di un meriggio assolato, quando la sua anima insaziabile e melancolica si sente per una volta sazia, e ai suoi occhi può mostrarsi solo qualcosa di suo, e niente più di estraneo”. Nietzsche, F.N. (1882), Die fröhliche Wissenschaft. Trad. it.: , Idilli di Messina - La Gaia Scienza - Frammenti postumi (1881-1882), Adelphi, Milano 1995: pag. 209
• Grazie per l’attenzione • trapanif@gmail.com
Puoi anche leggere