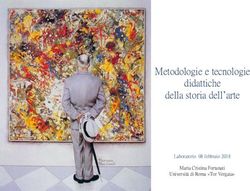Da Marianna a Maria Cristina - Il Castello di Agliè tra antico e moderno - editris - Editris 2000
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Da Marianna
a Maria Cristina
Il Castello di Agliè
tra antico e moderno
Atti della giornata di studio
Torino, Palazzo Carignano, 23 novembre 2018
a cura di
Luisa Berretti e Alessandra Giovannini Luca
editrisIndice
N IO MON
MO D
RI
IA
T
PA
LE
•
N D I AL •
WO RL D
MO
HE
IT
E
IN
R
AG
E • P AT RI M O
Organizzazione Residenze Sabaude
delle Nazioni Unite iscritte nella Lista del
per l’Educazione, patrimonio mondiale
la Scienza e la Cultura nel 1997
Il presente volume è stato realizzato con i fondi della Legge n. 77 del 20 febbraio 2006 “Misure
speciali di tutela e fruizione dei siti e degli elementi italiani di interesse culturale, paesaggistico Premesse 5
e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell’UNESCO”.
Programma della giornata di studio 8
Introduzione
Luisa Berretti, Alessandra Giovannini Luca 9
Tuscolo, Veio e il recupero dell’antico tra Carlo Felice e Maria Cristina.
Storia delle collezioni archeologiche del Castello di Agliè
Jacopo Corsi, Alba Maria Isa Scalia 13
Il restauro dei materiali ceramici e metallici della collezione veientana
nel Castello di Agliè. Problematiche specifiche, impostazione metodologica,
primi interventi conservativi
Marco Paolini, Alessandro Sani 41
Materiali organici su reperti metallici da Veio conservati
presso il Castello di Agliè
Mauro Rottoli 65
Da Marianna a Maria Cristina: aggiornamenti di gusto negli arredi per il castello
Alessandra Guerrini 79
Memorie glittiche da Firenze e Roma: due raccolte di impronte di intagli e cammei
nelle collezioni del Castello di Agliè
Lucia Pirzio Biroli Stefanelli 95
La committenza di Maria Cristina per i dipinti e le sculture di Agliè
Monica Tomiato 121
Progetto grafico, redazione, impaginazione:
Editris Duemila snc, Torino
www.editris2000.it I bozzetti di Altacomba
Maria Ludovica Vertova 131
Collaborazione alla revisione redazionale e agli apparati:
Albertina Ciani
I tessuti d’arredo della prima metà dell’Ottocento nel Castello di Agliè
Nessuna parte di questo libro può essere riprodotta o trasmessa in Gian Luca Bovenzi 147
qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo elettronico, meccanico o altro senza
l’autorizzazione scritta dei proprietari dei diritti e dell’editore.
Tutti i diritti riservati. Cristalli e porcellane per Maria Cristina: provenienze, iconografie, dispersioni
L’editore è a disposizione per eventuali diritti non riconosciuti. Alessandra Giovannini Luca 159
© 2020 Editris Duemila snc
© 2020 DRM Piemonte
Conclusioni
ISBN 9788889853580 Alessandra Guerrini 172
In copertina:
Manifattura francese, Bordura di papier peint, 1826 circa. Apparati 174
Castello di Agliè, Galleria Verde.Premesse
I siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale sono, per la loro unicità, punte di ec-
cellenza del patrimonio culturale, paesaggistico e naturale italiano e della sua rappresenta-
zione a livello internazionale. In sintesi, questa è la premessa contenuta nel primo articolo
della legge n. 77, approvata dal Parlamento italiano il 20 febbraio 2006 con l’obiettivo di
promuovere migliori condizioni per la salvaguardia e la valorizzazione dei siti selezionati
dall’UNESCO in base alla Convenzione per il patrimonio mondiale firmata a Parigi il 16
novembre 1972. Tra questi, il sistema delle residenze sabaude, che comprende ventidue
complessi monumentali del Piemonte e che include il Castello di Agliè.
Il volume che vede ora luce è il frutto di un progetto avviato dalla Direzione Regionale
Musei, referente UNESCO per il sito “Le Residenze Sabaude”, nell’ambito del Piano di Ge-
stione finalizzato a promuovere, incrementare e favorire la conoscenza delle residenze e lo
studio delle specifiche problematiche culturali, artistiche, storiche, ambientali, scientifiche
e tecniche del loro immenso patrimonio.
Grazie ai finanziamenti della legge 77 è stato possibile, tra il 2009 e il 2016, effettuare la
catalogazione di 11.594 beni che appartengono alle collezioni del Palazzo Reale di Torino,
del Castello di Racconigi e del Castello di Agliè, ospitati sia negli ambienti abitualmente
inseriti nel percorso di visita, sia in spazi per i quali è in corso la progettazione di nuovi
allestimenti per la riapertura al pubblico. Le varie tappe della ricerca sono state marcate
nel tempo con iniziative di disseminazione dei risultati, attraverso conferenze e giornate
di studio; nel caso del Palazzo Reale, la catalogazione è stata interamente riversata sul sito
dei Musei Reali. Quest’anno, a causa delle restrizioni imposte dall’emergenza Covid-19,
la scelta si è orientata sulla pubblicazione del volume Da Marianna a Maria Cristina. Il
Castello di Agliè tra antico e moderno, che raduna gli atti della giornata di studio promossa
nel 2018 da Alessandra Guerrini e che si basa sui dati raccolti durante le varie fasi della ca-
talogazione. I temi, uniti dal filo della committenza dinastica, intrecciano, sullo sfondo del
gusto per l’ambientazione e l’arredo delle sale del castello, l’archeologia, la pittura, le arti
decorative, il restauro. Lo scandaglio degli archivi restituisce momenti inediti sulla storia
delle acquisizioni e sulla trama delle dispersioni, su artisti e laboratori artigianali ancora
poco noti, e illumina un nodo importante dei grandi progetti culturali perseguiti dai Savoia
all’affacciarsi dell’Europa moderna.
Che la ricerca sia il fondamento di ogni seria politica di tutela è un principio ormai larga-
mente condiviso, ma è bene ricordare che senza conoscenza non c’è possibile racconto del
patrimonio, e che senza racconto la gestione dei beni rischia di diventare un’attività mec-
canica, incapace di generare quei processi di riappropriazione da parte delle comunità che
costituiscono il fine ultimo delle organizzazioni museali e anche, in definitiva, quello della
nuova pubblicazione sul Castello di Agliè. La tappa successiva sarà la restituzione online
dei dati di catalogo, per costruire intorno al patrimonio delle Residenze Reali Sabaude un
disegno sempre più ampio di accessibilità e di partecipazione.
Valentina Barberis Enrica Pagella
Responsabile ufficio UNESCO Direttrice ad interim
Direzione Regionale Musei Piemonte Direzione Regionale Musei Piemonte
5Premesse Premesse
La pubblicazione di questi studi rappresenta un tassello importante per la compren- e contigue al cuore del palazzo seicentesco voluto da Filippo San Martino di Agliè, che
sione delle collezioni e degli allestimenti del Castello di Agliè e risulta fondamentale per non fu mai modificato durante i grandi interventi settecenteschi del duca del Chiablese.
trasmettere queste conoscenze, elaborate attraverso ricerche archivistiche, a un pubblico A seguito degli approfondimenti che in questo volume si presentano, e dopo lo studio
più ampio ed allargato. degli inventari storici e il ritrovamento degli arredi che erano originariamente posti nella
Sebbene non sia stata l’artefice di questi studi ho appoggiato con entusiasmo l’idea sala della collezione di Veio, si è concepita l’idea progettuale del futuro intervento, che
della loro pubblicazione, perché non fosse stato vano il lavoro di coordinamento e studio ne prevede il riallestimento per ricostruire, attraverso questo fondamentale tassello, la
portato avanti da Alessandra Guerrini, che mi ha preceduto nella direzione del castello, configurazione decorativa della prima metà dell’Ottocento, commissionata da Carlo Feli-
e l’impegno degli studiosi che qui hanno offerto il loro contributo. Sforzi che si ritagliano ce e Maria Cristina, periodo a cui risale l’ultimo allestimento decorativo con una visione
tra il lavoro incalzante e le emergenze, ma che mi paiono davvero così sostanziali per la complessiva dell’intero castello.
conoscenza del complesso e per permettere di poter fare scelte ponderate e consapevoli Per il secondo piano invece, fortemente condizionato dalle scelte di arredo compiute
nei lavori di restauro e riallestimento della residenza. dai duchi di Genova tra la seconda metà dell’Ottocento e la vendita del castello allo Stato
L’insieme di questi contributi è il frutto di anni di campagne di catalogazione dei beni nel 1939, le ricerche in corso consentiranno di arrivare nel riallestimento a una meditata
esistenti nel castello e, grazie ad essi, è stato evidenziato che nell’ambito degli apparati disposizione del mobilio e dei dipinti, basata sulla documentazione fotografica degli anni
decorativi il risultato pervenutoci è un complesso di grande qualità rappresentante la Trenta del Novecento e al contempo consapevole dei molteplici riutilizzi di arredi anche
cultura ottocentesca degli anni della Restaurazione. importanti di epoca precedente.
Questi studi risultano ora propedeutici per l’elaborazione del progetto di riallestimen- Il valore scientifico di questa pubblicazione è quindi arricchito dal risvolto pratico de-
to di alcune zone del castello previsto nell’ambito degli interventi promossi dal Piano terminato dagli interventi di restauro e riallestimento che ne conseguiranno, e che a loro
strategico “Grandi progetti culturali” - annualità 2017-2018, finanziato dal Ministero volta rappresenteranno un campo aperto di ricerca a cui saranno chiamati gli studiosi
per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo e i cui lavori inizieranno la primavera per approfondire i molto probabili indizi che emergeranno durante i lavori. Sono ancora
prossima. moltissimi gli sforzi scientifici di ricerca che devono essere condotti sul Castello di Agliè
Questo progetto spazia su diversi ambiti del complesso architettonico e del parco, ma per giungere a una conoscenza approfondita di questo bene e gli studi presenti, se colma-
sul piano degli allestimenti interni prevede l’intervento su alcune aree del primo e del no alcune lacune, aprono altri immensi scenari di indagine.
secondo piano dell’edificio. Sarà nostra cura continuare in questa direzione, in cui teoria e pratica si fondono
Gli studi che oggi si pubblicano sono stati fondanti per individuare le scelte di riallesti- insieme per allargare il campo della conoscenza e giungere alla riorganizzazione del per-
mento del primo piano e, in particolare, della sala che ospitava la collezione di Veio, volu- corso di visita dell’intero castello, che sarà sempre più ampio e potrà prevedere percorsi
ta da Maria Cristina nel quarto decennio e che era situata a fianco del Salone Arduino e tematici differenti che il visitatore sceglierà di percorrere in base ai suoi interessi.
simmetricamente alla Sala Tuscolana. Il locale era stato modificato e in tempi successivi Ci aspetta un futuro di grande lavoro, che prevede la stretta collaborazione tra storici,
adibito a “guardaroba” delle porcellane e infine, nella seconda metà dell’Ottocento, a storici dell’arte, restauratori e architetti per un impegno multidisciplinare che dovrà sfo-
biblioteca dei duchi di Genova. Le ricerche hanno consentito di comprendere il ruolo ciare in ulteriori studi, al fine di indirizzarne le scelte attuative.
primario rivestito dalle sale dei reperti archeologici del castello all’interno del pensiero
ideatore degli allestimenti ottocenteschi di Carlo Felice e della sua consorte, che insieme Alessandra Gallo Orsi
condivisero questa passione per i ritrovamenti artistici dell’antichità, tramandata dalla
Direttrice del Castello di Agliè
famiglia di lei oltre che dalla sorella del re sabaudo: i sovrani scelsero di collocare i reperti
in due sale distinte in base ai luoghi di ritrovamento, Tuscolo e Veio, ma entrambe vicine
6 7San Giovanni Battista di Cirié
Tuscolo, Veio e il recupero dell’antico tra
Carlo Felice e Maria Cristina.
Storia delle collezioni archeologiche
del Castello di Agliè
Jacopo Corsi, Alba Maria Isa Scalia
Come ben noto, nel Castello di Agliè sono conservati due importanti nuclei di
antichità, che costituiscono rispettivamente la collezione «tuscolana» e la collezione
etrusca o «veiente», la cui formazione è frutto di un lungo processo che ebbe inizio
negli anni Venti dell’Ottocento. I reperti provengono in prevalenza dagli scavi delle
antiche città di Tuscolo e Veio, intrapresi dal principe Luciano Bonaparte tra il 1804
e il 1820, e dalle successive campagne dirette, tra il 1825 e il 1843, dal marchese Luigi
Biondi e dall’architetto Luigi Canina, su incarico del re Carlo Felice prima e della
regina Maria Cristina dopo1.
Già a partire dagli anni Quaranta del Novecento, le collezioni sono state oggetto di
diversi lavori di ricerca che, nonostante le molte lacune documentarie, hanno cerca-
to di fare chiarezza su alcuni aspetti iconografici, cronologici e prettamente archeo-
logici2. Solo di recente l’attenzione si è spostata sulla storia del collezionismo anti-
quario e dinastico, e sul programma ideologico e politico che ha mosso gli interessi
della committenza nella formazione della raccolta privata3. Partendo da quanto già
1
Si vedano L. Mercando, Le collezioni archeologiche, ricerca Tusculum, diretto dalla Scuola Spagnola di
in D. Biancolini, E. Gabrielli (a cura di), Il Castello Studi Archeologici a Roma: F. Salcedo Garcés, Tu-
di Agliè: gli appartamenti e le collezioni, Torino 2001, scolana Marmora. Escultura clásica en el antiguo
pp. 105-113; M.V. Cattaneo, Gli inizi della collezione Tuscolano, Serie Arqueológica, 14, Madrid 2016.
archeologica di Agliè. L’impegno per l’antico di Carlo Per quanto riguarda invece gli studi inerenti la
Felice e Maria Cristina di Savoia: da Tuscolo a Veio collezione veiente bisogna aspettare la monografia
(1821-1839), in «Studi Piemontesi», vol. XXIX, di F. Delpino, che ricostruisce la storia degli sca-
2000, pp. 405-430; F. Delpino, Cronache veientane. vi e include un catalogo di tutti i reperti etruschi
Storia delle ricerche archeologiche a Veio, I: Dal XIV conservati ad Agliè (F. Delpino, 1985).
alla metà del XIX secolo, Roma 1985. 3
Va senza dubbio ricordato il lavoro di M.V.
2
La prima opera unitaria dedicata ai reperti di Cattaneo, 2000, la quale focalizza l’attenzione sul
Tuscolo è quella di M. Borda, Monumenti archeo- collezionismo e sull’interesse antiquario dei sovra-
logici tuscolani al Castello di Agliè, Roma 1943. ni Carlo Felice e Maria Cristina. Tra i tanti docu-
Lo studioso analizza principalmente i caratteri menti citati, la minuziosa rassegna prende in esa-
artistici delle opere, fornendo una valutazione me gli Atti del Camerlengato e le dodici Relazioni
sia stilistica che cronologica, basata su confron- degli Scavi alla Villa Tuscolana di Luigi Biondi, da
ti iconografici e fonti letterarie antiche. Un ulte- cui estrapola importanti dati sulle indagini archeo-
riore studio, questa volta incentrato sull’analisi logiche e il ritrovamento di molte opere tra il 1825
del contesto archeologico e sulla creazione di un e 1829. Si veda anche L. Mercando, 2001; E.
corpus complessivo delle opere di statuaria prove- Micheletto, Collezionismo dinastico a Torino nell’Ot-
nienti da Tuscolo, è quello pubblicato a cura di tocento. Le raccolte sabaude di archeologia e il Regio
Fabiola Salcedo Garcés al termine del progetto di Museo di Antichità, in Colligite fragmenta: aspetti e
tendenze del collezionismo archeologico ottocentesco in
Piemonte, atti del convegno (Tortona, 2007), Bordi-
ghera 2009, pp. 395-418, e F. Delpino, La «scoperta»
Nella pagina a fianco: sarcofago con Apollo, di Veio etrusca, in Ricerche Archeologiche in Etruria
Atena e le Muse, particolare, II secolo d.C. Meridionale nel XIX secolo, atti dell’incontro di stu-
Castello di Agliè, Sala Tuscolana, n. inv. 469. dio (Tarquinia, 1996), Firenze 1999, pp. 73-85.
12 13Il restauro dei materiali ceramici e metallici
della collezione veientana
nel Castello di Agliè.
Problematiche specifiche, impostazione
metodologica, primi interventi conservativi
Marco Paolini, Alessandro Sani
Premessa
Nel giugno 2016, su impulso della dottoressa Alessandra Guerrini e a seguito di ac-
cordi fra i diversi enti del MiBACT coinvolti1, i due grandi nuclei in cui si suddivide la
collezione di reperti rinvenuti nel sito archeologico di Veio nell’Agro romano, ossia i
manufatti ceramici e quelli metallici, sono stati affidati a restauratori specializzati nei
suddetti materiali costitutivi e trasferiti rispettivamente nei Laboratori di restauro di
Palazzo Carignano e dell’ex-museo di Antichità di Torino. La movimentazione dell’inte-
ra collezione, che consta di circa duecentosettantotto pezzi totali di cui centosettantotto
ceramici e cento metallici, è stata preceduta da una scrupolosa ricognizione preliminare,
atta a verificare la presenza di ogni reperto all’interno dei depositi e a valutare l’eventuale
necessità di preconsolidamenti o altri piccoli interventi come bendaggi o supporti interi-
nali volti a garantire l’integrità dei pezzi durante il trasporto2.
La verifica ha preso in esame anche le cassette impilabili in plastica munite di ma-
niglie e coperchio in cui i reperti si trovavano imballati all’interno del deposito, giudi-
candole perfettamente idonee allo spostamento, previa modifica o implementazione
del materiale ammortizzante presente all’interno3. Il trasferimento è avvenuto accor-
pando i reperti in venticinque colli totali, con costante accompagnamento da parte
Il lavoro descritto non sarebbe stato possibile senza la competenza di settore che per il coinvolgimen-
l’impulso e la competenza della dott.ssa Alessandra to del restauratore Alessandro Sani e dell’arche-
Guerrini, allora direttrice del Castello Ducale di ologa Stefania Ratto) e la Soprintendenza Beni
Agliè, alla quale va il nostro più sentito ringrazia- Architettonici di Torino (per il coinvolgimento
mento per la sensibilità e disponibilità dimostrate; del restauratore Marco Paolini).
desideriamo ringraziare le soprintendenti architet- 2
I reperti si trovavano originariamente deposita-
to Luisa Papotti e dottoressa Egle Micheletto, e la ti all’interno della cosiddetta Palestra o Sala dei
allora direttrice del Polo Museale dottoressa Daila Comici degli Appartamenti dei duchi di Genova
Radeglia per la loro convinta adesione e collabora- al secondo piano nobile, poi trasferiti negli anni
zione al progetto; la dottoressa Stefania Ratto, il dot- 2000-2001 (a cura dell’allora responsabile delle
tor Andrea Martelli, il dottor Jacopo Corsi, infine collezioni del Castello di Agliè dottoressa Edith
le restauratrici Roberta Bianchi, Linda Josephine Gabrielli, del funzionario archeologo dottor
Lucarelli, Tiziana Sandri, Maria Grazia Ferrara, Alessandro Betori e dei restauratori Marco Paolini
Emanuela Ozino Calligaris e Amalia Criscione per e Cristina Meli) nell’Appartamento del Re, all’in-
il concreto aiuto e supporto scientifico nello svolgi- terno delle armadiature della Sala della Stireria
mento dei lavori. situata al piano terreno.
3
Si tratta di spessori e divisori in polietilene
1
L’accordo è stato raggiunto fra il Polo Musea- espanso (Ethafoam) e involucri in carta velina,
le del Piemonte (cui facevano capo i reperti), la utilizzati per i reperti sia ceramici che metallici.
Soprintendenza Archeologica di Torino (sia per
Nella pagina a fianco: testa velata in terracotta n. inv. 2573 dalla stipe votiva, particolare.
41San Giovanni Battista di Cirié
Materiali organici su reperti metallici da Veio
conservati presso il Castello di Agliè
Mauro Rottoli
Materiali e metodi
Tra i materiali della collezione del Castello di Agliè è presente un gruppo di ma-
nufatti metallici etruschi (soprattutto bronzi) provenienti da Veio. Si tratta di armi e
di altri oggetti – in parte pertinenti a un carro, in parte di più incerta interpretazione
(arredi?) – sui quali deve ancora essere operato un nuovo studio archeologico e tipo-
logico di dettaglio.
Durante il restauro, Alessandro Sani ha osservato in connessione ai metalli la pre-
senza di frammenti di legno e tessuto discretamente conservati. Sulla base delle sue
indicazioni è stata così effettuata, presso il Laboratorio di restauro della SABAP-TO,
la campionatura dei resti organici, estendendo il controllo a tutti i manufatti metallici
dello stesso gruppo, per la ricerca anche delle tracce più labili. La campionatura è sta-
ta effettuata prelevando schegge di dimensioni millimetriche, mentre si osservavano
direttamente sui supporti tutti i parametri utili per la ricostruzione delle modalità di
lavorazione del legno e dei tessuti. Per il riconoscimento delle specie lignee e delle fibre
tessili, i campioni prelevati (in totale ventisette) sono stati poi osservati in microsco-
pia ottica a luce trasmessa e a luce riflessa presso il Laboratorio di Archeobiologia dei
Musei Civici di Como. Per l’individuazione degli oggetti è stato utilizzato il vecchio nu-
mero di inventario e una preliminare attribuzione funzionale del reperto. Nel caso di
gruppi di oggetti con lo stesso numero di inventario si è adottata una siglatura di labora-
torio, al fine di identificare con maggiore precisione oggetti e punti di prelievo (tab. 1).
La conservazione del materiale organico: aspetti generali
Come è noto, i materiali metallici, soprattutto nelle sepolture, possono permettere
la conservazione della sostanza organica grazie a complessi fenomeni di impregna-
zione e sostituzione o, in particolare per le leghe di rame, grazie all’azione tossica,
antibiotica e antifungina del metallo e dei prodotti derivati dalla sua alterazione.
La conservazione è un fenomeno complesso, sempre parziale e disomogeneo, che
dipende, oltre che dal contatto con i metalli e dalla loro composizione, da una serie
di fattori microambientali, non ancora ben conosciuti (condizioni di umidità, tem-
peratura, pH ecc.), che si determinano nel terreno in prossimità dei manufatti. Negli
scavi più recenti, dove il controllo dei reperti metallici è stato completo o quasi, no-
nostante si rilevi solitamente una grandissima variabilità di situazioni, la possibilità
di osservare tracce organiche sui reperti metallici è risultata sempre decisamente
elevata (tracce presenti su oltre il 50% degli oggetti1): più costante in rapporto ai
1
Cfr. ad esempio E. Castiglioni, M. Rottoli, I re- la morte. Le necropoli picene di contrada Cugnolo a
sti organici della tomba 9 e della tomba 16, in G. Torre di Palme, Fermo 2018, pp. 77-83.
Postrioti, D. Voltolini (a cura di), Il prestigio oltre
Nella pagina a fianco: tela di lino conservata all’interno del terminale in bronzo n. inv. 2618,
di funzione sconosciuta, particolare. Castello di Agliè, Depositi.
64 65Da Marianna a Maria Cristina:
aggiornamenti di gusto negli arredi
per il castello
Alessandra Guerrini
Marianna, Carlo Felice, Maria Cristina: il riarredo di Agliè e le carte dipinte
La tempesta napoleonica è finita. Il congresso di Vienna si è chiuso, i Savoia
sono tornati nei loro Stati, ma solo nel 1817 Carlo Felice di Savoia rimette piede in
Piemonte, vivendo soprattutto a Govone. Scoppiati i moti del 1821, diventa re dopo
l’abdicazione di Vittorio Emanuele I e in una difficile situazione di servitù, dopo la
repressione dei moti nei confronti degli occupanti austriaci.
«Dopo la prima ondata repressiva, in autunno, più volte sollecitato da Vienna e da Pietrobur-
go, Carlo Felice decise di rientrare nei suoi Stati. […] Il 10 ottobre era a Govone, ed entrava in
Torino il 17, colmo di “répugnance extrème” verso la città teatro di uno “scandale orrible”»1.
Carlo Felice non amava Torino e tutta la sua vita pubblica come re si svolse in un
continuo peregrinare tra una residenza e l’altra, a seconda delle stagioni: Govone ed
Agliè d’estate, Genova e Nizza d’inverno, con periodici passaggi da Torino in occa-
sione di momenti particolari dell’anno, in cui era necessario presenziare a cerimonie
pubbliche e feste religiose. Govone e Agliè, com’è noto, erano le sue preferite: il re
investì cifre cospicue per renderle nuovamente abitabili, aggiornare gli edifici e i loro
arredi e risistemare con grandi lavori i giardini delle due residenze.
Ma in quell’anno 1821 Agliè non faceva ancora parte delle
dimore reali: era infatti appannaggio della sorella del re,
la duchessa vedova del Chiablese Marianna (fig. 1).
Durante gli anni napoleonici quest’ultima si era
trasferita a Roma, mentre il castello era stato
abbandonato e spogliato dopo il completo ri-
modellamento che il marito, il duca Bene-
detto Maurizio, aveva fatto realizzare nella
felice stagione di fine Settecento.
1
G. Locorotondo, voce Carlo Felice di Savoia, re
di Sardegna, in Dizionario biografico degli italiani,
vol. XX, Roma 1977, pp. 365-366.
Nella pagina a fianco: manifattura Giustiniani,
Fermacarte raffigurante mosaici e sfinge della Casa del
Fauno, particolare, 1831-1834 circa. Castello di Agliè,
Galleria Verde, n. inv. 805.
1. Ambito di Giovanni Panealbo, Ritratto di Marianna
di Savoia duchessa del Chiablese, 1775-1785. Castello di
Racconigi, Appartamento della dama d’onore, n. inv. 2518.
78 79Alessandra Guerrini Aggiornamenti di gusto negli arredi per il castello
9. Manifattura Zuber, Bordura
di papier peint, 1822 circa.
Castello di Agliè, Depositi,
senza inventario.
10. Manifattura Zuber (attr. a), anch’esse al secondo piano entro le sovrapporte. Si trattava di fogli unici, da cui le
Bordura di papier peint, 1822 circa.
Castello di Agliè, Depositi,
figure potevano essere ritagliate e applicate, come in questo caso, su fondo dipinto16.
senza inventario. Per tutte le altre stanze non abbiamo allo stato attuale dati che ci consentano di
riconnetterle a una manifattura specifica, pur essendo tutte le carte di gusto francese.
11. Manifattura francese, Papier peint con
bordura, 1826 circa.
D’oltralpe pure dovrebbero essere le carte vellutate della Galleria Verde (fig. 11), repli-
Castello di Agliè, Galleria Verde. cate in rosso nel pregadio dell’Appartamento reale e nella Tribuna reale che si affaccia
sulla chiesa parrocchiale di Agliè, parte delle stesse vicende costruttive settecentesche
del castello. Di queste è difficile reperire i modelli, ma dovrebbero arrivare direttamen-
te da Parigi passando da Genova, secondo un documento del 28 aprile 1826: «È qui
giunta in Dogana da Parigi una cassa assai voluminosa contenente carte di tappezzeria
che si suppongono commissionate dalle LL.MM. per Mobigliamento di una Galleria
nel Real Castello d’Agliè»17. È possibile che in questa cassa ci fosse anche la tappezze-
ria più preziosa in assoluto, quella della Sala Gialla, descritta nell’inventario del 1831
come «tappezzeria di carta a fondo giallo con rosoni in argento» (fig. 12), mentre la
A destra:
12. Manifattura francese, Papier peint
16
Ne è andato uno in vendita tutto intero: Auction Lobetti in AST, SR, DG, Reali Principi, Casa del
con bordura, 1826 circa. France, 31 maggio 2006, lotto 177. duca del Genevese, Real Casa, Corrispondenze,
Castello di Agliè, Sala Gialla. 17
Lettera del primo segretario da Genova sig. registro 3, lettera del 28 aprile 1826, fogli 33-34.
84 85Memorie glittiche da Firenze e Roma:
due raccolte di impronte di intagli e cammei
nelle collezioni del Castello di Agliè
Lucia Pirzio Biroli Stefanelli
Le due raccolte di impronte gemmarie (A e B) che si conservano nel Castello di
Agliè, pervenute probabilmente in momenti diversi, sono al momento prive di do-
cumentazione di archivio che ne certifichi i modi e i tempi dell’acquisizione, ma per
una di queste (B) è accertata l’appartenenza alla regina Maria Cristina di Borbone.
Le impronte sono tratte da incisioni in pietra dura – intagli e cammei – di epoche
differenti, dall’antichità all’età moderna, e da alcune medaglie1. Sono state prodotte
entrambe nella prima metà dell’Ottocento, in due diverse città (Firenze e Roma), e la
scelta delle immagini che propongono risponde a criteri e finalità differenti.
Sono documenti di quella che Ennio Quirino Visconti definisce «la comoda in-
venzione delle impronte che i valorosi incisori dei secoli XV e XVI per solo profitto
dell’arte introdussero»2, impronte che nel corso del XIX secolo avevano raggiunto
una grandissima diffusione e costituivano pertanto una delle attività commerciali
di maggiore successo tra quelle legate alla presenza di visitatori stranieri a Roma
nell’ambito del Grand Tour3. Oggetto di numerosi studi e ricerche anche molto ap-
profondite – tra l’altro una mostra a Göttingen è stata dedicata qualche anno fa
esclusivamente alle impronte4 – dispongono di un’ampia e ricca bibliografia alla
quale si rimanda per uno sguardo generale e un approfondimento, ma è opportuno
sottolineare come le impronte costituissero, soprattutto a partire dal Settecento, uno
degli strumenti principali per lo studio e la conoscenza della glittica, in particolare
quella antica di età greco romana, e non solo: si prendevano impronte (in cera, in
ceralacca, in zolfo, poi sostituito a cavallo dei due secoli da un tipo particolare di
scagliola bianca, materiale più resistente che consentiva una migliore definizione
dei dettagli dell’immagine) per poter esaminare nei minimi particolari gli intagli
e i cammei, per documentare esemplari appartenenti a grandi e piccole collezioni,
Ringrazio Alessandra Guerrini per avermi invitato 3
A. Pinelli, Souvenir. L’industria dell’antico e il
a partecipare alla giornata di studio e aver successi- Grand Tour a Roma, Bari 2010.
vamente rintracciato su mio suggerimento impor- 4
V. Kockel, D. Graepler (a cura di), Daktyliotheken.
tanti documenti di archivio e Riccardo Gennaioli Götter & Caesaren aus der schublade. Antiken
per il confronto con il materiale fiorentino. Gemmen in Abdrucksammlungen des 18. und 19. Ja-
harhunderts, catalogo della mostra (Augsburg, Göt-
1
A: nn. inv. 1548-1550; B: nn. inv. 1538-1547. tingen 2006-2007), München 2006. Sull’argomento
2
E.Q. Visconti, Esposizione dell’impronte di anti- vedi anche E. Zwierlein-Diehl, Glaspasten im Mar-
che gemme raccolte per uso di sua Eccellenza il Sig. tin-von-Wagner Museum Univesrsität Würzburg,
Principe D. Agostino Chigi, in Opere varie italiane vol. I, München 1986; Eadem, Antike Gemmen und
e francesi di Ennio Quirino Visconti raccolte e pub- ihr Nachleben, Berlin - New York 2007, con ampia
blicate per cura del dottor Giovanni Labus, vol. II, bibliografia; H.C. Knüppel, Daktyliotheken. Konzepte
Milano 1829, p. 146. einer Historischen Publikationsform, Mainz 2009.
Nella pagina a fianco: Antonino Pio che sacrifica alla Speranza. Impronta del cammeo in onice n. 35
in Impronte di gemme scolpite, e incise della R. Galleria di Firenze, particolare, post 1796. Castello di Agliè,
Galleria d’Arte, n. inv. 1548.
95Lucia Pirzio Biroli Stefanelli Memorie glittiche da Firenze e Roma
8. Ambito romano, Impronte gemmarie raffiguranti opere di Villa Albani, del Museo di Firenze 10. Ambito romano, Impronte gemmarie raffiguranti sculture del Museo di Napoli e Opere di Gibson
e del Museo di Parigi (ripiano 3), 1833-1843. Castello di Agliè, Galleria d’Arte, n. inv. 1538. (ripiano 5), 1833-1843. Castello di Agliè, Galleria d’Arte, n. inv. 1542.
non è documentata la presenza a Roma, che devono il loro successo e diffusione
alla novità dei soggetti e all’originale motivazione alla base della loro creazione. Le
incisioni di Beltrami e di altri incisori romani (qui non presenti) costituiscono in-
fatti un aspetto eccentrico della mania collezionistica del conte Giovanni Battista
Sommariva (1760-1826)27, che voleva sempre portare con sé le immagini dei dipinti
e delle sculture riprodotti in miniature a smalto e incisioni in pietra dura. I relativi
stampi sono tutti presenti nella collezione di Paoletti che sembra essere l’unico, con il
più tardo Liberotti, ad aver abitualmente il Museo Sommariva (almeno una selezione
molto ampia delle incisioni) nella sua produzione, e ad averne pubblicato una serie
separata con il testo del catalogo in francese28 (fig. 9);
– n. 5: Museo di Napoli (il cammeo con Medusa non è ripreso dalla tazza Farnese, ma
da un rilievo della villa Albani, oggi a Parigi), Opere di Gibson. L’inglese John Gibson,
a Roma dal 1817, è l’unico scultore, oltre ai grandi Canova e Thorvaldsen, ad avere
una sezione personale, seppur ridotta, introdotta dall’impronta di un cammeo con il
27
F. Mazzocca, G.B. Sommariva o il borghese me- 104-116; Eadem, Aveva il marchese Sommariva…
cenate: il “cabinet” neoclassico, la galleria romanti- una sua favorita idea, II. Le incisioni di Giovanni
ca di Tremezzo, in Itinerari. Contributi alla Storia Beltrami, in «Bollettino dei Musei Comunali di
dell’arte in memoria di Maria Luisa Ferrari, vol. II, Roma», n.s., vol. XI, 1997, pp. 111-131.
Firenze 1981, pp. 145-293 e inoltre L. Pirzio Biro- 28
J. Delatour, Un catalogue en camées: le Museo du
li Stefanelli, Aveva il marchese Sommariva… una Comte Sommariva, in https://blog.bibliotheque.
sua favorita idea, I. Opere di incisori romani docu- inha.fr/fr/posts/museo-sommariva.html.
9. Ambito romano, Impronte gemmarie raffiguranti opere del Museo Sommariva (ripiano 4), 1833-1843. mentate nella collezione Paoletti, in «Bollettino dei
Castello di Agliè, Galleria d’Arte, n. inv. 1545. Musei Comunali di Roma», n.s., vol. IX, 1995, pp.
104 105La committenza di Maria Cristina per i dipinti
e le sculture di Agliè
Monica Tomiato
«Per munificenza di S.M. Maria Cristina di Borbone Regina vedova
di Sardegna e per disposizione di S.E. il Conte Filiberto
di Colobiano suo Cavaliere di Onore e Gran Mastro»
Questo contributo affonda le sue radici nel passato, quando all’inizio degli anni
Duemila Piergiorgio Dragone mi diede l’opportunità di collaborare con lui ai volumi sul-
la cultura figurativa piemontese dell’Ottocento voluti dalla Cassa di Risparmio di Torino.
Fu in quell’occasione che mi occupai per la prima volta della figura di Maria Cristina di
Borbone quale mecenate e committente d’arte contemporanea1. Confesso che le scelte
della vedova di Carlo Felice m’erano sembrate già allora significative e degne d’attenzio-
ne non solo per il livello degli artisti coinvolti – tra i più richiesti e apprezzati dell’epoca,
da Vincenzo Camuccini a Francesco Podesti, a Pietro Tenerani fra gli scultori – ma so-
prattutto perché nel loro complesso lasciavano scorgere un ambizioso, programmatico e
neppur troppo dissimulato proposito di rivaleggiare con il mecenatismo di Carlo Alberto
di Savoia Carignano, nuovo re di Sardegna e abile promotore di una complessa politica
artistica finalizzata all’esaltazione della dinastia regnante e della storia sabauda.
Col passare del tempo mi sono ancor più persuasa – e in questo mi trovo pienamente
d’accordo con Edith Gabrielli2 – che sarebbe davvero riduttivo voler considerare Maria
Cristina una semplice, per quanto facoltosa, amante delle belle arti. Le molteplici cure
da lei rivolte al Castello di Agliè e la sua determinazione nel portare a compimento i
lavori di ricostruzione dell’Abbazia di Altacomba riflettono, al contrario, un impegno
progettuale di ampio respiro e per tanti aspetti speculare alle iniziative di Carlo Alberto.
Già la vasta rassegna torinese del 1980 sulla Cultura figurativa e architettonica negli
Stati del re di Sardegna 1773-1861, vera pietra miliare degli studi, aveva affrontato il
tema della committenza di Maria Cristina in rapporto con il complesso scenario politico
e culturale degli anni Trenta e Quaranta, aprendo così un affascinante fronte di ricerca
e proponendo, soprattutto, un esemplare modello d’indagine fondato su uno studio si-
stematico e approfondito delle fonti documentarie ma sempre, comunque, attento agli
oggetti. A distanza di quarant’anni questo tipo di approccio mi sembra aver mantenuto
intatta la sua validità e credo che proprio in questa direzione si debba proseguire.
1
M. Tomiato, Agliè e la vedova di Carlo Felice Cristina di Borbone, regina vedova di Sardegna, in
Maria Cristina, in P. Dragone (a cura di), Pittori Maestà di Roma. Da Napoleone all’Unità d’Italia,
dell’Ottocento in Piemonte. Arte e cultura figurativa catalogo della mostra (Roma, 2003), Roma 2003,
1830-1865, Torino 2001, pp. 88-91. pp. 398-400.
2
E. Gabrielli, Le committenze romane di Maria
Nella pagina a fianco: AST, SC, Archivi Privati, Canina Luigi, mazzo 13, Esposizione a uso di Album delle
opere di Belle Arti eseguiti per munificenza di S.M. Maria Cristina di Borbone Regina vedova di Sardegna e per
disposizione di S.E. il Conte Filiberto di Colobiano suo Cavaliere di Onore e Gran Mastro.
121I bozzetti di Altacomba
Maria Ludovica Vertova
Il presente studio si basa su una ricerca condotta negli anni successivi alla mia
tesi di laurea1, quando i documenti archivistici raccolti vennero pubblicati in un
volume sostenuto dal compianto professor Gianni Carlo Sciolla2. Nella documen-
tazione ci sono diversi cenni ai bozzetti delle sculture dell’Abbazia di Altacomba (o
Hautecombe) conservati presso il Castello di Agliè, serviti in questa sede per offrire
delle indicazioni cronologiche utili all’allestimento di un percorso museale dei gessi
e delle terrecotte3.
Come è noto l’Abbazia di Altacomba, ridotta nel periodo napoleonico a un rudere,
venne acquistata dal re Carlo Felice in seguito a un viaggio in Savoia avvenuto nel
1824 in compagnia della sorella Marianna, duchessa del Chiablese. Egli volle restau-
rare il complesso abbaziale perché era espressione del legame del re con i suoi ante-
nati e con la regione sabauda, e contribuiva a celebrare la dinastia secondo i dettami
politico-culturali della Restaurazione. Ernesto Melano fu incaricato direttore dei lavo-
ri da Carlo Felice proprio per le sue capacità, secondo le parole del sovrano, di «faire
revivre l’ancien eglise»4. Dapprima si trattava di sgomberare la chiesa dalle macerie
per il crollo della cupola e di iniziare a recuperare quelle zone che erano rimaste an-
cora parzialmente integre, quali l’ingresso con la Cappella di Belley, la zona dell’altare
e del transetto con la Cappella dei Principi e la Cappella di Romont (denominata poi
Cappella di San Felice) al centro della navata minore nord. Dalla copiosa corrispon-
denza tra Melano e Filiberto Avogadro di Collobiano, Segretario di Gabinetto e primo
ufficiale di Carlo Felice, emerge che i lavori scultorei per l’abbellimento delle parti
suddette poterono iniziare nel 1825 a seguito dell’impiego di Ludovico e Benedetto
Cacciatori. Quest’ultimo venne assoldato dopo un concorso organizzato, su incarico
del re, da Lodovico Ciriaco Bonamico, console di Carlo Felice a Milano. Come si evince
da una lettera del gennaio del 1825 di Collobiano a Bonamico, il re su consiglio dello
stesso Collobiano voleva uno scultore già attivo nel cantiere del duomo milanese, così
come espresso in alcuni estratti della missiva: «S.M. il Re nostro Signore vuole che
siano rialzati quei monumenti medesimi, e la Chiesa ricostrutta nello stile medesimo
in cui esistevano. […] Li disegni furono approvati nello stile gotico quali erano dalla
S.M. ordinati […] pregandoVi a volersi compiacere di procurarmi uno delli scultori
del Duomo di cotesta capitale; nissuno può a parer mio eseguire le sculture dello stile
di quei tempi meglio di costoro, i quali continuamente esercitati in sì fatto stile loro
riescirà semplice e naturale lo adattarsi ai disegni che saranno proposti»5.
1
M.L. Vertova, Benedetto Cacciatori e la committen- 4
Ibidem, p. 131, doc. n. 1.
za Savoia, tesi di Laurea, Università degli Studi di 5
La corrispondenza tra Collobiano e Bonamico è
Pavia, Facoltà di Lettere e Filosofia, a.a. 1994/1995. conservata in Archivio di Stato di Torino, Sezione
2
Eadem, Hautecombe: il restauro ottocentesco, To- Corte (di seguito: AST, SC), Materie Ecclesiastiche,
rino 2009. Abbazie, Hautecombe. Qui di seguito, per comodità,
3
A questo proposito ringrazio Alessandra Guerrini si riporta il riferimento nella pubblicazione: M.L.
che mi ha offerto questa occasione. Vertova, 2009, pp. 143-144, doc. n. 9.
130 131San Giovanni Battista di Cirié
Cristalli e porcellane per Maria Cristina:
provenienze, iconografie, dispersioni
Alessandra Giovannini Luca
La giornata di studio dedicata alle vicende che hanno interessato il Castello di
Agliè e le sue raccolte nella prima metà del secolo XIX è stata l’occasione per avviare
alcune indagini su una categoria di beni ampiamente rappresentata nella dimora al-
ladiese ma che ancora attende, nel suo complesso, una piena riconfigurazione stori-
co-critica: si tratta di un gruppo di manufatti vitrei e ceramici eterogeneo per ambiti
culturali, committenze e cronologie, nel quale rientra anche un corpus di porcellane
e cristalli annoverabile nel patrimonio di Maria Cristina di Borbone e costituente
l’argomento di questo contributo1.
Negli anni Trenta dell’Ottocento la Casa di Sua Maestà la regina vedova possedeva
una cospicua dotazione di servizi da tavola: il registro Vassella, cristalli, porcellane e al-
tri oggetti esistenti negli uffizi del 1838 elencava e descriveva infatti una «vassella detta
di S.M. la regina», una «vassella dorata», un’altra «detta di Augusta», una «porcellana
detta Valesa», una «vassella detta di Sardegna», una «porcellana detta di Sassonia» e
infine una «porcellana dorata a disegni coloriti rappresentanti i costumi del regno di
Napoli eseguita a Parigi»2. Quest’ultimo servizio, che per brevità verrà chiamato “di
Napoli”3, può essere agevolmente identificato con una serie tuttora conservata presso
il Castello di Agliè, composta da diversi elementi di porcellana dipinta e dorata e con-
notata dalle iniziali in caratteri gotici di Maria Cristina di Borbone («MCB»), sormon-
tate dalla corona reale e inserite entro una cornice polilobata4 (figg. 1-7).
I dati relativi al contesto di produzione del servizio sono desumibili con facilità
dalle marche e dalle iscrizioni presenti su molti dei suoi componenti e, incrociati con
i documenti d’archivio, consentono di datarlo intorno al 1833. Alla manifattura pa-
rigina di Jean-Baptiste-Edouard Honoré, attiva a partire dal 1820, spettò l’esecuzio-
1
Databili tra il primo quarto dell’Ottocento e gli e 0100401895, in sigecweb.beniculturali.it, 2017;
anni di Tomaso di Savoia Genova, i servizi in A. Guerrini, Castello di Agliè, in S. Ghisotti, C.
ceramica, vetro e cristallo oggi esistenti presso Goria (a cura di), Le stanze magnifiche. Mobili, ar-
il Castello di Agliè sono stati in parte esaminati redi e decorazione d’interni, Genova 2018, pp. 128-
da chi scrive nel corso di una campagna di pre- 129 e p. 131.
catalogazione svolta nel 2017; il loro censimento 2
Archivio di Stato di Torino, Sezioni Riunite, Duca
è stato effettuato dai volontari del Servizio Civi- di Genova (in seguito: AST, SR, DG), Casa di Maria
le Nazionale nel 2018. Per un primo inquadra- Cristina, Amministrazione, Inventari, mazzo 2313.
mento delle serie affrontate in questo contributo 3
Ivi, Tenimenti, Tenimento di Agliè, mazzo 61,
vedi A.M. Aimone, I servizi da tavola del castello Inventario generale del Castello di Agliè 1876, c. 36,
ducale di Agliè, in La mensa dei poveri e dei re. 7.1.
Cultura enogastronomica e di corte nelle terre sabau- 4
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
de, atti delle giornate di studi (Agliè, 2015), s.l., per la città metropolitana di Torino (in seguito:
s.a., s.p.; A. Giovannini Luca, schede OA codice SABAP-TO), Biblioteca, Castello di Agliè 1964, pp.
ICCD nn. 0100402041, 0100401996, 0100401894 42-46.
Nella pagina a fianco: Jean-Baptiste-Edouard Honoré, Raffaele Giovine, Piatto decorato con
Barbiere ambulante in Napoli, particolare, 1833 circa. Castello di Agliè, Stireria, senza inventario.
158 159Alessandra Giovannini Luca Cristalli e porcellane per Maria Cristina
15. Jean-Baptiste-Edouard Honoré, Raffaele Giovine, 16. Sgroppo, Levilly, Contadina di Triventi, in
Piatto decorato con Contadina di Triventi, 1833 Royaume des deux Siciles: costumes dessinés sur les
circa. Castello di Agliè, Stireria, n. inv. 759. lieux, P. Marino, Paris, A. Campani, Firenze, 1826.
Parigi, Bibliothèque de l’Institut National d’Histoire
de l’Art, Collections Jacques Doucet, 4 Est 557.
raffiguranti il Mercato di Caserta, un Cantastorie sul molo di Napoli e il Ritorno dalla
festa della Madonna dell’Arco12 (figg. 17-19), nonché da tre piatti che al centro reca-
no, rispettivamente, il Mercato di Caserta, il Real casino di caccia nel lago di Fusaro a
Bacoli (edificio di cui Ferdinando IV aveva promosso la realizzazione) e il Real casino
di caccia di Persano, nei pressi di Salerno, edificato a partire dal 1752 per volere del 17-18. Jean-Baptiste, Edouard Honoré, Raffaele
Giovine, Rinfrescatoio decorato con il Ritorno
re Carlo III di Borbone, nonno di Maria Cristina13 (figg. 20-21). A fronte di questi dalla festa della Madonna dell’Arco e il Mercato
riscontri, il ventaglio iconografico allo stesso tempo ampio e circostanziato del servi- di Caserta, 1833 circa. Castello di Agliè,
zio “di Napoli” si attesta non solo come l’esito di una selezione ponderata e attenta Galleria Verde, n. inv. 682.
dei modelli figurativi allora in circolazione, ma consente di ipotizzare un diretto 19. Jean-Baptiste, Edouard Honoré, Raffaele
coinvolgimento della regina vedova nella scelta dell’assetto decorativo; non sarebbe Giovine, Rinfrescatoio decorato con un Cantastorie
del resto giustificabile altrimenti la presenza sul cavetto del piatto n. inv. 779 di un sul molo di Napoli, particolare, 1833 circa.
Castello di Agliè, Galleria Verde, n. inv. 681.
soggetto del tutto estraneo all’impronta partenopea e centro-italiana che informa gli
altri manufatti: si tratta della Veduta della statua di san Carlo Borromeo (detta del san
Carlone) ad Arona, sul lago Maggiore, dipinta dall’atelier di Giovine e puntualmente
derivata dall’acquatinta disegnata da Müller e incisa da Paolo Fumagalli tra il 1816 e
il 1818, in seguito inserita nel Manuel pittoresque des étrangers à Milan, stampato nel
1832 a Milano da Epimaque et Pascal Artaria14 (figg. 22-23). fortemente condizionate dai soggiorni di Maria Cristina di Borbone entro e fuori i
Nell’analisi del servizio “di Napoli” c’è poi un altro aspetto che occorre conside- confini del regno di Sardegna15. Il corpus fu acquisito all’inizio del 1834 grazie all’in-
rare, legato alla sua estensione originaria e alle vicende di circolazione, che furono termediazione di Luigi Lacroix, gioielliere della Real Casa preposto all’acquisto di
12
I rinfrescatoi sono contrassegnati dai nn. inv. 681 bum disegnato e litografato da G. Lenghi, Souvenir e s.n. Sul tema delle vedute cfr. infra. giugno si trovava a Nizza; ad agosto era a Govone; a
e 682. Per una descrizione del ritorno dei cosiddetti de Naples. Customs and Costumes of the Neapolitans, 14
Nei mesi di settembre, ottobre e novembre del settembre era ad Agliè e successivamente a Como):
fujenti (o battenti) nei paesi casertani dalla festa del- Napoli 1830-1840 circa. Il Cantastorie sul molo di 1835 la regina vedova aveva soggiornato a Como, AST, SR, DG, Casa di Maria Cristina, Contabilità,
la Madonna dell’Arco vedi L’Italia descritta e dipinta Napoli presente sul manufatto n. inv. 682 riprende recandosi anche in visita ad Arona il 21 novem- Conto amministrativo 1835, passim. Vedi inoltre
con le sue isole di Sicilia, Sardegna, Elba, Malta, Eolie, lo schema compositivo di uno dei piatti passati in bre: G. di Milano, Milano 25 novembre, in «Gazzetta M.V. Cattaneo, 1830-1840: inediti per il castello, il
di Calipso ecc.: […] Regno di Napoli, vol. II, Torino asta da Wannenes nel 2014: Wannenes Art Auction, piemontese», 25 novembre 1835, s.p. parco e i giardini di Agliè, in «Studi piemontesi», vol.
1837, pp. 88-89. Un utile confronto visivo si trova Porcellane e vetri, 26 settembre 2014, lotti 939-940. 15
A titolo esemplificativo, si considerino i soggiorni XXXII, 2003, fasc. 2, p. 394, nota 8.
nella tavola di medesimo soggetto inserita nell’al- 13
I piatti sono contrassegnati dai nn. inv. 771, 772 della regina vedova nell’anno 1835 (da gennaio a
164 165Puoi anche leggere