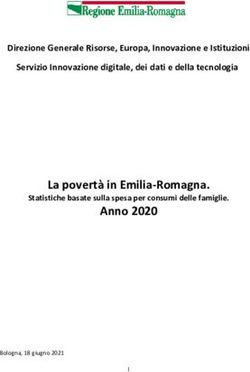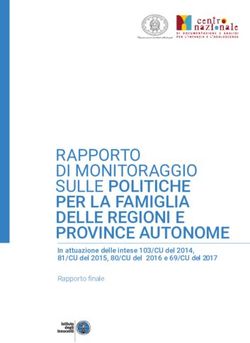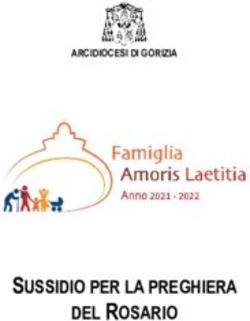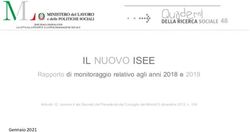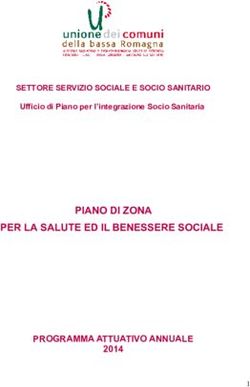COSTRUIAMO IL WELFARE DI DOMANI - SPECIALE NELLA CRISI, OLTRE LA CRISI - QUOTIDIANO SANITÀ
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in a. p. - 45% -
art. 2 comma 20/b legge 662/96 - Filiale di Milano
anno xlIII agosto-ottobre 2013
Speciale
Nella crisi, oltre la crisi
COSTRUIAMO IL WELFARE DI DOMANI
Proposta per una riforma delle politiche
e degli interventi socio-assistenziali
attuale e attuabile
Prospettive Sociali e Sanitarie n. 8-10 – agosto-ottobre 2013
8-10SPECIALE n. 8–10
Nella crisi, oltre la crisi. COSTRUIAMO IL WELFARE DI DOMANI anno xlIII agosto–ottobre 2013
Proposta per una riforma delle politiche e degli
interventi socio-assistenziali attuale e attuabile Direzione
a cura di P. Bosi, E. Ranci Ortigosa Emanuele Ranci Ortigosa
con contributi di: M. Baldini, F. Bertoni, P. Bosi, E. Ciani, (direttore responsabile)
S. Colombini, M. Forni, A. M. Candela, D. Mesini, Ugo De Ambrogio, Sergio Pasquinelli
S. Pasquinelli , E. Pepe, M. Raciti, F. Ragazzini, (vicedirettori)
E. Ranci Ortigosa, M. Sala, E. Università
Welfare Caporedattore
1 La direzione verso cui andare Francesca Susani (pss@irsonline.it)
M. C. Guerra
Redazione
5 Capitolo 1. Le nostre proposte per una riforma delle politiche Claudio Caffarena, Ariela Casartelli, Diletta
e degli interventi socio-assistenziali attuale e attuabile Cicoletti, Valentina Ghetti, Graziano
13 Capitolo 2. La distribuzione delle risorse finanziarie dei Giorgi, Francesca Merlini, Daniela Mesini,
programmi per l’assistenza in Italia Paolo Peduzzi, Franco Pesaresi, Dela Ranci
Agnoletto, Edoardo Re, Giorgio Sordelli,
Appendice. Una ricostruzione delle risorse finanziarie Patrizia Taccani
destinate alla protezione sociale e all’assistenza
29 Capitolo 3. Il programma di sostegno delle responsabilità Comitato scientifico
familiari Paolo Barbetta, Alessandro Battistella,
Luca Beltrametti, Paolo Bosi, Annamaria
42 Capitolo 4. Il RMI: articolazione, beneficiari e sostenibilità Campanini, Maria Dal Pra Ponticelli,
finanziaria Maurizio Ferrera, Marco Geddes da Filicaia,
69 Capitolo 5. Riformare l’assistenza ai non autosufficienti: Cristiano Gori, Antonio Guaita, Luciano
verso la dote di cura Guerzoni, Francesco Longo, Gavino
Maciocco, Marco Musella, Franca Olivetti
Appendice. Le Regioni e la rete dei servizi Manoukian, Giuseppe A. Micheli, Nicola
82 Bibliografia Negri, Fausta Ongaro, Valerio Onida,
Marina Piazza, Costanzo Ranci, Chiara
83 Osservazioni della Regione Emilia-Romagna Saraceno, Maria Chiara Setti Bassanini,
sulla proposta di riforma Antonio Tosi
86 Osservazioni della Regione Puglia
sulla proposta di riforma Contatti
Via XX Settembre 24, 20123 Milano
Con questo fascicolo di PSS, vi proponiamo un numero triplo, uno tel. 02 46764276 – fax 02 46764312
www.pss.irsonline.it
Speciale di ben 89 pagine, contenente l’importante proposta di ri-
forma del welfare che è stata in una prima fase presentata dall’Irs Ufficio abbonati
e pubblicata sul numero 20–22/2011 di questa stessa rivista. Daniela Mezzera (pss.abbo@irsonline.it)
L’ulteriore sviluppo e approfondimento che qui presentiamo è stato
Abbonamento 2013
elaborato dall’Ars, associazione non profit, con il coinvolgimento ccp. n. 36973204
dell’Irs, e del Capp dell’Università di Modena e Reggio Emilia, la IBAN IT57 J076 0101 6000 0003 6973204
partecipazione delle Regioni Emilia-Romagna e Puglia, il patroci- € 59,00 (privati); € 69,00 (ass. di volontariato
nio della Fondazione Cariplo. e coop. sociali); € 89,00 (enti); € 96,00 (estero).
L’abbonamento decorre dal 1º gennaio
al 31 dicembre.
Costo aggiuntivo per PDF online: € 25,00
(enti, associazioni e coop.); € 15,00 (privati)
Prezzo per copia: € 7,50 (arretrati € 12,00)
Progetto grafico e impaginazione
Riccardo Sartori
Stampa
Grafica Sant’Angelo
Via Vicinale 6, Sant’Angelo Lodigiano (LO)
Tel. 0371 210290
Prospettive Sociali e Sanitarie
Registrazione
è stampata usando le carte Reci-
tal white e Respecta 100 di Burgo Tribunale di Milano n. 83 del 5-3-1973
Distribuzione, composte al 100%
da fibre riciclate ISSN 0393/9510
Foto di copertina
Tibor Fazakas È vietata la riproduzione dei testi, anche
www.opart.ro parziale, senza autorizzazione.La direzione verso cui andare Maria Cecilia Guerra
Viceministro del
Lavoro e delle
Politiche sociali
Ringrazio quanti hanno lavorato a questa ricer- opportunità, è che i pur limitati finanziamenti
ca per il contributo molto importante che han- che vengono destinati vengono dispersi in un
no dato e stanno dando al dibattito su questi mare di progetti. La parola è progetti, della qua-
temi.1 Sottolineo anche la loro forte attenzione lità di molti dei quali sono certa, ma che sono,
a offrire un contributo positivo e propositivo per come dicevo, anch’essi temporanei, e attivano
la costruzione delle politiche sociali, attenzio- quindi esperienze anche positive ma che poi non
ne che non sempre gli accademici riescono ad lasciano tracce, scompaiono. Passati i sei mesi,
avere (posso dirlo perché vengo da quel mon- passato l’anno, passato l’anno e mezzo non ci
do). Denuncio anche, a premessa, un conflitto sono più. Questo non è un buon modo di inve-
d’interessi: nel senso che ho partecipato a una stire i nostri soldi pubblici.
prima fase di queste ricerche, quando non ero La regressione in atto in campo sociale è evi-
impegnata nel Parlamento e nel Governo, e dente per l’incrociarsi di due fattori: da un lato
quindi penso di potermi riconoscere in questo ovviamente la crisi, cha fa emergere in manie-
approccio con più facilità che altri. ra più compiuta il bisogno, lo rende ancora più
Passo subito a esporre alcune sottolineatu- drammatico; dall’altro l’abbandono di cui quelle
re, cui aggiungo alcune mie riflessioni, anche politiche soffrono proprio anche in termini di
in relazione al compito che sto attualmente attenzione, di pensiero, di prospettive. Manca
svolgendo. Vorrei che fosse a tutti chiaro che il totalmente un disegno con finalità espresse e
sistema socio-assistenziale, i cui limiti già era- obiettivi chiari da perseguire, con disegni cor-
no stati evidenziati dalla Commissione Onofri relati di finanziamento, di governo, di gestione,
a metà degli anni Novanta, nel tempo è peg- disegni chiari, che possano essere riconosciuti. I
giorato. Purtroppo anche in questi quindici finanziamenti su cui si concentra spesso l’atten-
anni i nostri interventi in campo sociale sono zione non sono le erogazioni monetarie a singoli
ancora peggiorati, sia in quantità che in quali- beneficiari, che hanno tutti i limiti che la ricerca
tà. Dovremmo quindi tenere sempre presenti evidenzia, e che sono comunque, diciamo, strut-
le analisi sui limiti del sistema attuale che sono turali. I finanziamenti di cui si parla più spes-
state proposte nella ricerca, con tutte le debite so, ed è importante che se ne parli, sono quelli
sottolineature e specificazioni che essa effettua. attraverso i fondi, il famoso Fondo nazionale per
Richiamo qui in particolare la frammentazione le politiche sociali e il Fondo per la non autosuf-
e la categorialità del sistema, a cui aggiungerei ficienza, che assorbono una quota percentuale
un ulteriore elemento, implicito in quello che molto bassa nel complesso delle risorse di cui il
è stato detto ma che mi sta particolarmente a sociale si avvale, complesso di risorse importan-
cuore, e cioè la temporaneità. L’ottica è sempre te, anche se sottodimensionato e, come la ricer-
più di brevissimo periodo: si interviene con pic- ca evidenzia, non speso sicuramente al meglio.
coli interventi spot di cui non discuto la qualità, Allora ci si concentra sui fondi, ma le ristrettez-
perché spesso possono anche essere di qualità, ze crescenti che hanno ridotto questi finanzia-
ma che nascono già destinati a morire, sono tem- menti ne rendono anche difficile l’utilizzo per
poranei. Alcuni degli interventi più importanti alimentare interventi sul territorio in termini
introdotti in questi ultimi anni nascono con un di servizi duraturi.
finanziamento a tempo, già destinato presto ad Come la ricerca evidenzia, nel sistema fiscale
esaurirsi. Ad esempio, la Social card si esaurisce non c’è un insieme di risorse che sono destinate
alla fine di quest’anno. Non sto discutendo la al sociale, diversamente da quanto avviene per
qualità di questo strumento, che a suo tempo ho i servizi destinati alla sanità. Non ci sono livelli
fortemente criticato, e che tuttora critico per il essenziali che debbano essere garantiti, se non
suo carattere fortemente categoriale e limitato, quelli impliciti in alcuni importanti trasferi-
ad esempio per età (anziani oltre i 65 e bambini menti monetari nazionali, tra cui per esempio
minori di tre anni). Voglio piuttosto evidenzia- l’indennità di accompagnamento. Non c’è quindi Note
re che comunque anche quella che è stata forse una responsabilità, da esercitare e da verificare, 1 Il contributo che pub-
l’innovazione più consistente che c’è stata negli per definire e sviluppare un’offerta dei servizi, blichiamo è tratto
dall’intervento che il
ultimi anni, era nata con un limite temporale, un monitoraggio da poter fare, un percorso che
Viceministro Guerra ha
era temporanea. porti, nel tempo che ci vorrà, ad attenuare le tenuto all’incontro orga-
Un altro aspetto critico che incontro nell’eser- fortissime differenze che abbiamo sul nostro nizzato da IRS lo scorso
cizio delle mie responsabilità sulle politiche territorio, tipicamente tra Nord e Sud, ma mol- 10 luglio a Roma, presso
sociali, e ora anche sulle politiche delle pari to anche all’interno del Nord e all’interno del la Camera dei Deputati.
Welfare n. 8-10/2013 1Sud. Non c’è insomma un pensiero, una strate- perché cerca di dare un sostegno forte a chi ne ha
gia, come dicevo. Per questo la ricerca svolta da realmente bisogno, prendendo atto del vincolo
IRS e Capp, al di là del fatto che possiamo essere di risorse che di fatto al momento non pare supe-
d’accordo con tutte le proposte in essa formu- rabile. Ma qui si incontrano appunto difficoltà
late, o solo con una parte di esse, o addirittura e resistenze, per la paura di por mano a politi-
con nessuna di esse, è comunque un contributo che redistributive che quindi penalizzino anche
molto importante di conoscenza e soprattutto qualcuno. Questo blocca i propositi di riforma, e
di offerta di un ripensamento a 360° del nostro non solo quelli nel campo delle politiche sociali.
sistema sociale. Un contributo che per giunta Atteggiamenti di tal genere sono diffusi, e non
assume un‘ottica coraggiosa, perché formula solo difendono tutti gli interessi costituiti a pre-
delle chiare proposte facendo esplicitamente i scindere dal merito, ma ostacolano lo sviluppo
conti con gli attuali vincoli di risorse, vincoli che di politiche destinate a persone che non sono
nessun politico, ma anche molti altri soggetti, in grado di aggregarsi, tipicamente i poveri. Le
non sono disposti a considerare e mettere in con- politiche per la povertà sono la cartina al torna-
to nelle posizioni che assumono e neppure nelle sole di un sistema sociale, e non è un caso che noi
proposte che talora formulano. non abbiamo una rete di interventi universale
Passo ora a un secondo ordine di considera- inerente alla povertà. Non ce l’abbiamo perché
zioni: che cosa la politica è disposta ad accettare non c’è un’istituzione politica forte che riesca a
di una ipotesi così coraggiosa? I temi che vengo- assumere il coraggio e guadagnare il consenso
no trattati sono in parte assolutamente nuovi per introdurla, perché i poveri, proprio per la
nei contenuti e nell’elaborazione, ma in parte loro condizione, non si aggregano, non si orga-
riprendono anche contenuti che gli stessi auto- nizzano, non sviluppano forza di pressione.
ri esprimono da molti anni, da tutta una lunga Altra difficoltà che vedo contrapporsi alle
esperienza di vita e di riflessione sul sociale. Un proposte avanzate è quella che si incontra impe-
primo punto di attenzione riguarda la critica che gnandosi a promuovere contenuti e politiche che
viene formulata nella ricerca rispetto al sistema non siano spendibili in uno slogan: come fai a
vigente, critica che condivido, come ho detto, ma portare in campagna elettorale un discorso come
sulla quale occorre fare attenzione perché può quello qui proposto, si obietta. È molto più facile
essere usata, o strumentalizzata, per alimen- dire “tolgo l’IMU” e non lo dico come battuta, ma
tare ipotesi molto diverse da quelle degli autori lo dico perché l’IMU vale quattro miliardi!
della ricerca. Faccio un esempio. La cosiddetta L’ipotesi che ci viene proposta è quindi un’idea
riforma fiscale assistenziale del Ministro Tre- molto importante di riforma delle misure e di
monti partiva proprio dall’osservazione che ci ridistribuzione. Ma proprio per questo credo sia
sono degli sprechi nel sistema, per trarne però difficile assumerla e realizzarla. Richiamo come
la conseguenza che c’era quindi la possibilità di esempio una riforma che stiamo costruendo, che
tagliare e risparmiare. In quella logica anche la ha una analoga ispirazione: la riforma dell’Isee.
riforma dell’Isee era pensata sostanzialmente Viene data come acquisita, ma non lo è, perché
come una riforma che permettesse di ridurre c’è ancora un passaggio importante, quello del
le risorse da spendere in questo settore. E con parere del Parlamento. È una riforma che è stata
analoghe intenzionalità si erano attivate altre predisposta in un lungo cammino partecipativo:
campagne negli anni scorsi: tipicamente la cam- regioni, comuni, sindacati, il forum delle fami-
pagna dei falsi invalidi, che partendo dall’idea glie, il forum del terzo settore, le federazioni del-
condivisibile che quando dai una erogazione le persone con disabilità. Alla fine del percorso
monetaria devi andare a verificare che le condi- sono inevitabilmente rimaste delle differenze di
zioni a cui è assoggettata siano realmente rispet- vedute, ma si sono anche trasmesse e condivise
tate, ha costruito nell’immaginario e nel sentire delle idee e trovate delle soluzioni. Quali sono
collettivo l’idea che buona parte della spesa che le difficoltà incontrate e che ancora cercano di
va all’indennità di accompagnamento va a degli opporre resistenza? Prima la paura: la paura
“scrocconi”. E questo ha creato una difficoltà che l’Isee possa essere pensato e utilizzato per
enorme nel rapporto tra istituzione e persone tagliare la spesa sociale. Ci abbiamo messo un
non autosufficienti e con disabilità, anche per- anno per far capire che non è questo, che si trat-
ché tale campagna ha per lo più nascosto il dato ta di un’azione redistributiva, per garantire la
di realtà per il quale negli ultimi anni le persone qualità della spesa sociale. Dato che in molti casi
invalide che sono state realmente provate come gestiamo la spesa sociale con strumenti seletti-
false sono poche migliaia. La campagna quindi vi, occorre che questa selezione sulla condizio-
non è stata costruita su dati di verità. ne economica venga fatta attraverso strumenti
C’è un altro approccio, che si oppone a pro- equi, visibili, controllabili e controllati. Questo
poste come quelle presentate nella ricerca, che è il messaggio fondamentale dell’Isee, ed è diffi-
si basa sulla paura terribile di toccare l’esisten- cilissimo da far passare.
te: non si possono fare politiche se non incre- Noi avevamo preparato la riforma, per come è
mentando. E questo è sicuramente il punto in adesso, già nell’agosto del 2012, ma poi abbiamo
cui noi ci troviamo: è molto difficile pensare ed trovato una serie di ostacoli e impedimenti che
attuare delle politiche che abbiano un qualche per me sono stati una scuola di vita sul funzio-
elemento di riforma delle misure in atto e di namento della nostra amministrazione. Questa
ridistribuzione. riforma, che ha una visione ampia perché met-
La proposta che ci viene fatta dall’IRS e dal te insieme tutti gli elementi che devono essere
Capp è molto coraggiosa anche perché ha ele- considerati per valutare la condizione economi-
menti importanti di ridistribuzione, proprio ca (definizione del nucleo familiare, definizione
2 n. 8-10/2013 Welfaredel reddito, il patrimonio, la scala di equivalenza, agire. E quindi anche questo stimolo della ricerca
costi dell’abitare, costi della disabilità e della non è molto importante, perché dalle dichiarazioni
autosufficienza), incontra oggi ancora difficoltà si passi a pratiche conseguenti.
perché ogni parlamentare, che ha i suoi riferi- Mi piace porre in questa luce e richiamare
menti in gruppi di interesse alla fine ne porta la sperimentazione di una nuova carta acquisti
avanti la specifica istanza. È quindi difficilissimo nei termini proprio dell’inclusione attiva. È un
pensare di realizzare una riforma come quella programma per ora rivolto alle 12 città con più
proposta in questa ricerca, proprio perché ha di 250.000 abitanti, di cui è stata inserita nel
una visione complessiva, che deve confrontarsi decreto sul lavoro l’ estensione a tutte le regioni
anche con atteggiamenti invece molto partico- del Sud. È uno strumento per il contrasto alla
laristici, di quanti faranno a gara per portare a povertà che a causa della limitatezza delle risorse
casa il proprio specifico risultato, poterlo van- è per ora ancora categoriale, cioè riservato alle
tare come proprio merito. Riforme di questo famiglie con minori e in cui vi sono adulti con un
tipo potranno passare e funzionare se una par- forte disagio lavorativo, cioè che non lavorano o
te estesa della collettività, e conseguentemente sono molto precari; viene impostata e attivata
delle sue rappresentanze politiche e sociali, le però con l’intendimento di coinvolgere anche la
matureranno, le faranno proprie. filiera dei servizi sociali dei Comuni, in un’ottica
Ci sono altri elementi molto importanti nel- di presa in carico, di progetto personalizzato e
la ricerca, per esempio il riferimento al nucleo di inclusione attiva. Una sperimentazione che
familiare. Nel nostro ordinamento il “nucleo quindi potrà darci degli elementi anche molto
familiare” è definito diversamente da istituto a innovativi nel panorama dei nostri strumenti di
istituto, non è lo stesso nucleo considerato per contrasto alla povertà, che, anche quando ci sono,
le detrazioni fiscali, per l’Isee, per gli assegni sono strumenti di mera erogazione monetaria.
familiari. Si propongono tre definizioni diverse Richiamo anche il Fondo nazionale politiche
e questo è un problema importante. Abbiamo sociali, che finalmente a luglio è stato approva-
anche una certa ideologia della famiglia (cosa to, quando ne avevamo deciso la ripartizione
diversa dalla famiglia reale) che spesso porta i già a gennaio. Anche su questo fondo una storia
suoi sostenitori a ignorare che non è quello il inenarrabile, che andrebbe conosciuta, per far
concetto che è fatto proprio dalle politiche, con capire come e perché non siamo ancora riusciti
risultati che sono stravaganti, perché rischiano a distribuirlo e perché, per poterlo fare, abbiamo
di contraddire e nuocere proprio a quello che si dovuto addirittura fare ricorso ad un intervento
pensa di dover ottenere. normativo.
Oltre all’aspetto della ristrutturazione delle Abbiamo concordato con le regioni di ancora-
misure e della redistribuzione del finanziamen- re anche quella modesta cifra a obiettivi di servi-
to nel progetto ci sono altri due elementi che zio per costruire insieme degli obiettivi condivi-
voglio brevemente sottolineare. Uno è la presa si, anche piccoli, anche più generici di quello che
in carico, cioè la valutazione di ogni situazione sarebbe necessario vista la pochezza delle risor-
che necessita di intervento per le sue specificità. se, che consentono comunque di capire dove
L’intervento è sempre più multidimensionale, queste iniziative e queste risorse vanno e dove
cioè ha bisogno di qualcuno che gestisca il contri- dovrebbero continuare ad andare per costruire
buto finanziario ma anche di persone esperte e progressivamente un sistema di servizi più arti-
capaci di occuparsi dei potenziali destinatari e di colato e più strutturato. Se non facciamo que-
strutturare un piano personalizzato. Un secondo sto rischiamo di spendere anche puntualmente
elemento è l’idea della persona non come ogget- e bene i soldi, perché nessuno li butta via, ma di
to da assistere, quasi addirittura una persona rimanere sempre al punto di partenza.
inferiore, ridimensionata, ma la persona vista Insomma teniamo alta la prospettiva, e quel-
in un’ottica di inclusione sociale e di attivazione: la proposta dalla ricerca è secondo me la dire-
alla persona viene riconosciuta la potenzialità, la zione verso cui guardare e andare. Non posso
possibilità e quindi la dignità di essere protago- naturalmente promettere di mettere tutte que-
nista della propria esistenza. Questa concezione ste proposte nella legge di stabilità di settembre
è assunta in buona parte delle nostre leggi: per di quest’anno, ma sicuramente i suggerimenti
esempio siamo stati uno dei primi paesi a sotto- che sono venuti, anche per il ruolo particolare
scrivere la convenzione per la disabilità, ma non in cui mi trovo oggi, sono di particolare stimolo
abbiamo ancora tradotto il pensiero nel nostro e interesse. #
Milano, 26 settembre 2013
Costruiamo il welfare di domani
Una proposta di riforma delle politiche e degli interventi
socio-assistenziali attuale e attuabile
www.prosp.it/26settembre
Welfare n. 8-10/2013 3Nella crisi, oltre la crisi
Costruiamo il welfare di domani
Proposta per una riforma delle politiche e degli
interventi socio-assistenziali attuale e attuabile
Sergio Pasquinelli, Marcella Sala di Ars e IRS;
Il percorso di lavoro e i componenti il gruppo di ricerca
Paolo Bosi, Massimo Baldini, Emanuele Ciani,
L’ impostazione e le prime declinazioni delle pro- Sara Colombini del Capp, Università di Modena e
poste di riforma illustrate in questo fascicolo di Reggio Emilia; Francesco Bertoni della Provincia
PSS hanno avuto una prima presentazione pubbli- di Bologna. Al progetto hanno partecipato con loro
ca a Milano il 29 settembre 2011, in un convegno dirigenti e funzionari le Regioni Emilia Romagna
con 500 partecipanti e qualificati interlocutori (Maura Forni, Monica Raciti e Francesca Ragaz-
istituzionali (si veda Prospettive Sociali e Sani- zini) e Puglia (Anna Maria Candela, Emanuele
tarie n. 20–22/2011). Ad essa hanno fatto seguito Pepe, Emanuele Università). Su alcune parti del
vari scritti e confronti nel merito, in numerose sedi contrasto alla povertà si è attivata una collabo-
istituzionali, politiche, sindacali, sociali, culturali. razione con l’equipe impegnata nella proposta di
L’ulteriore sviluppo, l’approfondimento e la Reddito di inclusione sociale promossa originaria-
verifica dell’agibilità economica e sociale delle mente da Acli e Caritas, e coordinata da Cristiano
proposte sono stati svolti da Ars, associazione Gori, favorita dalla partecipazione di alcuni ricer-
non profit, con il coinvolgimento dell’IRS e del catori (Baldini, Ciani, Mesini, Sala) a entrambe le
Capp dell’Università di Modena e Reggio Emilia, ricerche. Il supporto amministrativo e segretariale
la partecipazione delle Regioni Emilia Romagna e è stato assicurato da Ars e IRS.
Puglia, il patrocinio di Fondazione Cariplo. Il testo presentato è il frutto del lavoro di
L’esito del lavoro svolto è stato presentato e tutto il gruppo e rappresenta l’esito di incontri,
discusso in un Seminario di Welforum Regioni e discussioni, osservazioni e integrazioni reciproche.
Welforum Grandi Comuni il 3 luglio 2013, ospitato Volendo indicare chi, in varia misura, ha contribu-
a Palazzo Marino dal Comune di Milano, e suc- ito all’elaborazione e redazione delle diverse parti
cessivamente il 10 luglio, a Roma, in un secondo del testo che segue l’apertura del viceministro M.
seminario ristretto dedicato a interlocutori istitu- C. Guerra: in ordine alfabetico, al capitolo 1, E.
zionali, governativi e parlamentari, e a referenti Ranci Ortigosa; al capitolo 2, M. Baldini, F. Berto-
nazionali di partiti, sindacati, organizzazioni ni, P. Bosi, E. Ciani, S. Colombini; al capitolo 3, P.
sociali e di assistenza. Arricchito e verificato da Bosi, S. Colombini, E. Ranci Ortigosa, M. Sala; al
questi confronti, il lavoro viene pubblicato in que- capitolo 4, M. Baldini., P. Bosi, E. Ciani, S. Colom-
sto fascicolo di Prospettive Sociali e Sanitarie per bini, D. Mesini, E. Ranci Ortigosa, M. Sala; al
essere presentato il 26 settembre 2013, a Milano, capitolo 5, F. Bertoni, S. Pasquinelli; al contributo
in un convegno aperto con autorevoli e significati- della Regione Emilia Romagna M. Forni, M. Raci-
ve partecipazioni (www.prosp.it/26settembre). ti, F. Ragazzini; al contributo della Regione Puglia
Il lavoro è stato coordinato da Emanuele Ranci A. M. Candela, E. Pepe, E. Università. La pubbli-
Ortigosa e Paolo Bosi e svolto da un’equipe compo- cazione è a cura di P. Bosi ed E. Ranci Ortigosa,
sta da Emanuele Ranci Ortigosa, Daniela Mesini, l’editing è di M. Sala.
4 n. 8-10/2013 WelfareLe nostre proposte per una riforma 1
delle politiche e degli interventi
socio-assistenziali attuale e attuabile
1.1 L’impatto sociale della crisi evidenzia e drammatizza i gravissimi 1.5 L’attuale distribuzione dei benefici offre opportunità per reperire
limiti del nostro sistema assistenziale, mai ripensato e riformato nel risorse
suo insieme Il piano di finanziamento delle riforme prende le mosse dalla scarsa equità sociale
Nel campo socio-assistenziale le risorse sono scarse e soprattutto male utilizzate. e dalla bassa azione redistributiva dell’attuale spesa assistenziale: alla metà più
Le prestazioni sono rigide e monetizzate, con penalizzazione dei servizi e quindi ricca delle famiglie (dal 6º decile in su) affluisce il 37% di tutta la spesa assisten-
dell’occupazione. Gli interventi sono settoriali, categoriali, parcellizzati, su seletti- ziale e pure il 37% delle risorse per le misure che dovrebbero integrare redditi
vità incoerenti. C’è forte contraddizione in termini di sussidiarietà verticale fra carenti, il 32% delle risorse per il sostegno economico delle famiglie con figli, tut-
disciplina istituzionale autonomistica e gestione centralistica delle funzioni e risor- te misure di integrazione del reddito delle famiglie finanziate dalla fiscalità gene-
se, che penalizza fortemente la sussidiarietà orizzontale e la vitalità dei territori. rale e condizionate alla situazione economica dei beneficiari.
La materia socio-assistenziale soffre di un protratto abbandono e di una conse- A fronte di queste situazioni abbiamo milioni di famiglie in povertà assoluta, o con
guente accentuata obsolescenza. Stenta perfino ad essere riconosciuta e trattata carichi di figli minori o di anziani non autosufficienti, che non possono contare su
nel suo insieme, e mai è stata oggetto di interventi complessivi di riforma, nem- alcun sostegno pubblico certo. L’intervento pubblico, finanziato con il prelievo
meno a fronte della crisi economica in atto. Tale dato è sorprendente perché le cri- fiscale su tutti i contribuenti, deve privilegiare queste situazioni di disagio estre-
tiche all’attuale sistema e alle misure che lo compongono sono ricorrenti e larga- mo o di accentuata difficoltà rispetto a situazioni dove l’entità delle risorse fami-
mente condivise dagli esperti e da molti degli attori. Eppure non emergono signi- liari dovrebbe solidalmente garantire un certo livello di benessere a tutti i compo-
ficative iniziative di ripensamento e di rinnovamento. Ci si limita a chiedere più nenti del nucleo. Va aggiunto che l’azione redistributiva che assumiamo nelle
risorse, con buone ragioni ma inevitabile scarso esito. nostre proposte non è tale da mettere in crisi il tenore di vita delle famiglie che
subissero delle decurtazioni.
1.2 I vincoli di spesa rendono cruciale e urgente ottimizzare l’uso di
tutte le risorse presenti per migliorare il sistema 1.6 Un’impostazione generale e tre importanti politiche specifiche
Se le risorse sono scarse occorre difenderle e ove possibile accrescerle, ma occorre Le riforme proposte derivano tutte da un’analisi e un’impostazione generale con-
anche usarle al meglio, affrontando quindi i limiti delle attuali misure, e anche le divise, che si articolano poi in tre grandi politiche specifiche, descritte nei capitoli
prevedibili resistenze che ogni effettivo cambiamento incontra. Questo vale in 3, 4 e 5: sostegno alle famiglie con figli, contrasto alla povertà e inserimento
particolare per i quattro quinti delle risorse, oggi dedicati tutti a erogazioni eco- sociale, sostegno alla cura di non autosufficienti e disabili.
nomiche gestite a livello centrale dall’Inps. È necessario allora progettare e intro- L’impostazione generale è di tipo universalistico; può associare all’universalismo
durre misure nuove che le sostituiscano per massimizzare l’efficacia nella riduzio- una selettività sulla condizione economica, misurata con l’Isee in approvazione,
ne e nella gestione dei bisogni, l’equità nella distribuzione di oneri e benefici, l’at- per prevedere compartecipazioni selettive alla copertura del costo dei servizi; assu-
tivazione e integrazione di tutte le risorse presenti e disponibili. Sono fattori di me generalmente le famiglie anagrafiche come unità potenzialmente solidali di
qualità decisivi, che possono nascere e svilupparsi solo entro un sistema che tra- riferimento; assume l’attuale spesa sociale come vincolo nella configurazione del
sferisca ai territori buona parte delle funzioni e delle risorse. finanziamento delle riforme proposte; privilegia nella risposta a situazioni di biso-
gno interventi appropriati ai singoli casi, su progetti concordati con i beneficari per
1.3 Si possono fare riforme anche nella attuale situazione di vincoli alla valorizzarne le risorse e responsabilizzarli, interventi che ricompongano se oppor-
spesa pubblica tuno prestazioni diverse, sia monetarie che di servizi; comporta la definizione, a
Alla base della nostra proposta si pone una scelta: non subire la disaggregazione e garanzia delle persone in condizioni di bisogno, di livelli essenziali, in termini sia di
i confini angusti imposti tradizionalmente alle politiche socio-assistenziali, ma diritti esigibili che di standard di offerta; individua la responsabilità primaria per
alzare la posta, ridefinire il campo, mettere sul piatto tutte le funzioni, le misure, l’attuazione sul territorio delle politiche e degli interventi sociali nel Governo locale
le risorse sociali pubbliche, finanziate con il prelievo fiscale, di qualsiasi origine a livello di ambito, per lo più pluricomunale; mira a sviluppare una forte e diffusa
storica e di qualsiasi classificazione giuridica, rivederle nel loro insieme in funzio- collaborazione fra attori pubblici e attori sociali per la programmazione e l’integra-
ne degli attuali bisogni sociali, con criteri generali e politiche specifiche coerenti. zione degli interventi, estesa agli attori privati per la produzione dei servizi.
Queste politiche riformate esigono in molti casi come condizione essenziale di fat-
1.4 Ridefinire il campo, le funzioni e le risorse delle politiche socio- tibilità l’esistenza o lo sviluppo accelerato di una rete territoriale di servizi per
assistenziali l’orientamento, l’accesso, la presa in carico, il case management.
Le politiche socio-assistenziali gestiscono una spesa complessiva pari a 67 miliardi
di euro, 4,28 punti del Pil, di cui 54 miliardi, pari a 80% del totale, assorbiti da 1.7 e 1.8 Le buone ragioni per una coraggiosa iniziativa politica
programmi nazionali gestiti dall’Inps e da detrazioni previste dalla fiscalità I risultati attesi dall’attuazione delle proposte che formuliamo sono:
nazionale; 8,5 miliardi, quasi il 14% del totale, gestiti da Comuni, Regioni ed altri • sostegno più efficace per chi è in situazione di bisogno, grazie ad interventi
enti, per servizi e anche erogazioni monetarie; 5 miliardi stimati di spesa sociosa- universalistici, appropriati e adeguati alle specifiche situazioni;
nitaria per la non autosufficienza. Tali risorse, che evidenziano l’attuale concentra- • distribuzione più equa dei benefici (superando in particolare l’attuale sbilan-
zione sulle erogazioni monetarie a danno dei servizi, sono state da noi imputate a ciamento a scapito delle famiglie giovani e con figli), che vengono assicurati a
tre diverse grandi politiche: sostegno alle famiglie con figli, contrasto alla povertà tutti coloro che sono in analoghe condizioni di bisogno e vengono rapportati
e inserimento sociale, sostegno alla cura di non autosufficienti e disabili. alla consistenza e intensità dei loro bisogni (equità);
• superamento del limite ricorrente della temporaneità e della episodicità, per
Welfare n. 8-10/2013 5una riconfigurazione strutturale del sistema assistenziale, su criteri di coeren- ne delle risorse presenti nelle persone, nelle famiglie e sul territorio, con
za dell’insieme e di continuità degli interventi e dei relativi finanziamenti; maggiori possibilità di attivazione della comunità locale nelle sue diverse
• riallocazione di azioni e risorse entro le politiche considerate, con ridotta componenti sociali, pubbliche e private;
richiesta di risorse aggiuntive (economicità); • responsabilizzazione dei governi locali, in una dimensione di intervento terri-
• sviluppo di servizi sui territori finanziato con una quota delle risorse ora toriale adeguata e maggiori opportunità per un governo e una gestione più
assorbite dai trasferimenti monetari gestiti dall’Inps, per creare occupazio- partecipati;
ne, in particolare per le donne, facilitare l’emersione del lavoro informale; • riconoscimento delle persone nei loro progetti di vita e nelle loro relazioni,
• maggiori economicità ed efficienza, grazie al decentramento delle responsa- valorizzazione delle risorse loro e del contesto familiare e sociale, per un wel-
bilità, delle funzioni, delle risorse che favorisce la mobilitazione e integrazio- fare comunitario.
ta ricostruzione del campo che la Commissione
1.1 L’impatto sociale della crisi evidenzia e
Onofri aveva effettuato nel 1997. Da allora, riper-
drammatizza i gravissimi limiti del nostro
correndo gli anni, si vede come di tale materia
sistema assistenziale, mai ripensato e
se ne consideri di volta in volta solo una frazio-
riformato nel suo insieme
ne, rinunciando a trattarne l’insieme. Così è
Osservando il welfare del nostro Paese subito accaduto con la l. 328 del 2000, che ha attivato
emerge la forte differenza fra le sue principali la programmazione sui territori ma di cui sono
componenti nelle loro evoluzione storica, confi- rimasti senza seguito i previsti interventi sulle
gurazione formale, strutturazione istituzionale erogazioni monetarie nazionali. Così è stato per
e organizzativa. In materia di lavoro, previden- la riforma costituzionale del 2001, la cui attribu-
za, scuola e sanità vi sono stati ricorrenti inter- zione della materia assistenziale alla competenza
venti di riforma, discussi e discutibili, che han- legislativa esclusiva delle Regioni e della materia
no comunque strutturato sistemi di governo, di amministrativa ai Comuni non ha per nulla inci-
organizzazione, di finanziamento e individuato so sulla preesistente distribuzione di funzioni
anche diritti e prestazioni. La materia socio-assi- e risorse. Così è stato per il federalismo fiscale,
stenziale soffre invece di un protratto abbando- che ha considerato marginale tale materia e si è
no e di una conseguente accentuata obsolescen- limitato a una confusa operazione amministra-
za. Stenta perfino a essere riconosciuta e trattata tiva volta a cercare come finanziare le risorse che
nel suo insieme, e nel suo insieme mai è stata già Regioni e Comuni gestivano, manipolando
oggetto di interventi complessivi di riforma, e riduttivamente la tematica dei livelli essenziali.
neppure di riordino (per un confronto fra assi- Forse una prima sortita per l’allargamento del
stenza sociale e sanità, si veda la tavola 1). campo fu purtoppo quella con cui il Ministro
Tale dato è sorprendente perché le critiche Sacconi, con la delega sulla riforma del fisco e
all’attuale sistema e alle misure che lo compon- dell’assistenza, tentò di assestare un duro colpo
gono sono ricorrenti e largamente condivise all’assistenza pubblica per regredire alla bene-
dagli esperti e da molti degli attori. E anche per- ficenza da affidarsi agli enti caritativi. Neppure
ché la crisi in atto alimenta una preoccupante tale incursione valse a stimolare un approccio
ulteriore divaricazione fra bisogni crescenti e più ampio e adeguato al problema, volto almeno
risposte in campo. Eppure né la critica al sistema ad ammodernare, o meglio a riformare realmen-
assistenziale, né il drammatizzarsi della situa- te in base a criteri di efficacia e equità l’intera
zione sociale riescono a stimolare e alimentare politica assistenziale e i suoi vari interventi.
nelle istituzioni di governo e nelle organizzazio- Se ci interpellassimo sul perché di tale omis-
ni di rappresentanza politica, sindacale, sociale, sione, potremmo richiamare la marginalità in cui
significative iniziative di ripensamento e di con- la classe dirigente, non solo quella politica, rele-
seguente rinnovamento. Ci si limita a chiedere ga tale materia; la cultura lavoristica del mondo
più risorse, con buone ragioni ma inevitabile sindacale e di parti significative della sinistra; il
scarso successo, soprattutto perchè la richie- timore che approcci contrari al welfare possano
sta non è inserita in una prospettiva di riforma approfittare del cambiamento con esiti regres-
del sistema criticato agibile e credibile, perchè sivi; l’indisponibilità a intraprendere iniziative
accompagnata da proposte adeguate a perse- che possano trovare resistenze e reazioni in
guirla efficacemente. aree di consenso e rappresentanza organizzata,
Una prima ricorrente abdicazione attiene anche in termini corporativi, senza riuscire ad
l’entità della posta in gioco, malgrado la corret- attivare contestualmente correnti di consenso
e sostegno in altre aree del sociale frammentate
TAVOLA 1 Differenze fra sanità e assistenza sociale e disperse (i poveri chi li rappresenta?).
L’esito di tutto questo è la permanenza e anzi
SSN Sociale
il riprodursi del sistema già criticato dalla Com-
Tre riforme negli ultimi 30 anni Nessuna riforma compiuta missione Onofri: campo non definito, risorse
Organizzazione “a sistema” (aziende sanitarie) su Organizzazione indefinita e variabile tra Regioni e provenienti da più fonti senza alcun coordina-
3 livelli di responsabilità Comuni su livelli di governo con loro propria auto- mento e in parte alcuna certezza, tre livelli di
nomia governo con loro proprie autonomie, certezza
Livelli essenziali (LEA) definiti e aggiornati Livelli essenziali (LEPS) non ancora definiti e esigibilità solo per le erogazioni monetarie
Diritti esigibili (anche se diversamente attuati sul Diritti esigibili su alcune erogazioni monetarie, nazionali e per gli interventi prescritti da inter-
territorio) per accesso a servizi solo interessi protetti (molto venti della magistratura, e in particolare dal Tri-
diversi, di fatto) bunale per i minorenni, su singoli casi.
Budget nazionale almeno figurativo con riparti- Risorse non prefissate e da più fonti, nessuna Le risorse sono scarse e soprattutto male
zione fra le Regioni ripartizione e perequazione utilizzate. Le prestazioni sono rigide e mone-
6 n. 8-10/2013 Welfaretizzate, con penalizzazione dei servizi e anche TAVOLA 2 L’impatto della spesa sociale sulla povertà (2011)
dell’offerta di lavoro che essi attivano. Gli inter-
venti sono settoriali, categoriali, parcellizzati, su % di riduzione del rischio di povertà dovuta a trasferimenti sociali
70,0
selettività incoerenti. C’è forte contraddizione
in termini di sussidiarietà verticale fra discipli- 60,0
60,1
na istituzionale autonomistica e gestione cen- 54,2
52,2
tralistica delle funzioni e risorse, che penalizza 50,0
50,0 50,0 49,8 49,4
47,4 46,9
45,6 45,0
anche fortemente la sussidiarietà orizzontale e 43,8 43,3
la vitalità dei territori. 40,0 38,3 37,1 37,1
35,2
La tavola comparativa a livello europeo (tavo- 33,3 32,8
30,0 29,7 29,1
la 2) esemplifica i giudizi espressi, evidenziando 30,0 26,8 26,6
che, relativamente a un obiettivo che è centrale 23,7
19,7
per un sistema assistenziale, quale il contrasto 20,0 17,7
alla povertà, le nostre erogazioni assistenzia- 13,7
li nazionali abbattono molto poco il rischio di 10,0
povertà e sono quindi poco efficaci e poco eque.
Sulle carenze antiche è sopravvenuto l’impat- 0,0
to delle trasformazioni sociali (invecchiamento
Latvia
Austria
Cyprus
Greece
EU27
poland
Luxemb
Estonia
Lithuania
Slovakia
Czech Rep.
Romania
Finland
France
Netherl
Spain
Denmark
Germany
Slovenia
UK
Malta
Italy
Ireland
Sweden
Belgium
Bulgaria
portugal
Hungary
e immigrazioni) e poi della crisi: disoccupazione
e cassa integrazione in aumento, impoverimen-
to crescente e diffuso (povertà assoluta che nel Note: Irlanda dato 2010. Fonte: Eurostat, EU-Silc, 2011.
2012 interessa il 6,8% delle famiglie, vale a dire
4.814.000 persone, in aumento del 1,6% rispet- priate, e non ne sono verificati l’uso e gli esiti.
to al 2011), diseguaglianze accentuate (indici di Queste caratteristiche riducono gravemente
Gini pari a 0,323 per redditi e 0,613 per ricchez- l’efficacia delle azioni e quindi il buon uso delle
za, che ci pongono al sesto posto per entità del- risorse.
le diseguaglianze fra 30 Paesi Ocse), riduzione Per ridurre sofferenza e fragilità e promuo-
dei consumi, oneri crescenti sulle famiglie. E a vere il benessere e l’autonomia di persone e
fronte di questo nessuna manutenzione e tanto famiglie occorre quindi optare per un approccio
meno innovazione del sistema vigente; mode- universalistico, rivolto cioè a tutti coloro che
ste nuove misure ripetitive dei limiti di quelle sono in situazioni di bisogno ritenute meritevoli
antiche, taglio della spesa pubblica per funzioni di attenzione e sostegno, attivando interventi
sociali e per Regioni ed enti locali. appropriati e fra loro adeguatamente integrati,
sulla base di una valutazione professionale, se il
caso è complesso; si tratta di interventi persona-
1.2 I vincoli di spesa rendono cruciale e
lizzati, negoziati con il beneficiario per respon-
urgente ottimizzare l’uso di tutte le risorse
sabilizzarlo e ottenere la sua collaborazione, che
presenti per migliorare il sistema
mirino quindi anche alla sua soddisfazione insie-
Che si potrebbe invece fare? Come si può far me a quella degli operatori professionali.
fronte alle crescenti sofferenze e fragilità sociali È chiaro che tali requisiti per l’efficacia posso-
con gli attuali vincoli stringenti di spesa pubbli- no essere presenti e operare solo sul campo, sul
ca? Occorre in primo luogo riprendere coscienza territorio, in quel diretto rapporto tra servizi,
del limite delle misure attuali e dell’attuale uso professionisti e utenti che si sviluppa dall’acces-
delle risorse (si tende a trascurarlo!): se le risor- so alla presa in carico e accompagnamento.
se sono scarse occorre difenderle e ove possibile
accrescerle, ma occorre anche usarle al meglio,
Migliorare l’equità
affrontando quindi i limiti dell’attuale uso, delle
attuali misure, e anche le prevedibili resistenze Il confronto fra i Paesi europei sull’abbattimen-
che ogni effettivo cambiamento incontra. Pro- to della povertà già evidenzia la modestissima
gettare e introdurre quindi misure nuove per azione redistributiva del nostro sistema. Anche
massimizzare efficacia, equità, efficienza, con in questo caso una delle prime ragioni è la man-
le opportune gradualità e con adeguate garan- canza dell’approccio universalistico, che esige
zie (livelli essenziali) per chi è in situazione di per medesime condizioni di bisogno analoghi
vulnerabilità e di bisogno. interventi per tutti (equità orizzontale) e per chi
ha bisogni maggiori interventi più consistenti
(equità verticale). L’equità deve ovviamente
Massimizzare l’efficacia
essere un requisito della norma, ma anche un
L’attuale sistema assistenziale nella sua compo- dato di realtà effettiva sul territorio, dove devo-
nente centrale, pari a più di quattro quinti della no essere garantiti determinati livelli di servizi,
spesa totale, non è stato costruito né mai riordi- fruibili ed esigibili.
nato in base a una visione complessiva, ma per Se si impone un forte vincolo di risorse, vanno
stratificazioni successive di interventi e politi- in tal caso privilegiate le situazioni più fragili e
che, che quindi risultano settoriali, categoriali, problematiche, anche per carenza di risorse eco-
frammentati. Vengono così sistematicamente nomiche proprie. Da qui una possibile selettività
ignorate significative quote di popolazione in sulle condizioni economiche, misurate con l’Isee,
condizione di bisogno. Anche a coloro che sono delle famiglie, considerate come unità economi-
assistiti, vengono erogate prestazioni standar- che solidali. Naturalmente questo non deve far
dizzate e solo monetarie, non quelle più appro- perdere entro le realtà familiari un’attenzione
Welfare n. 8-10/2013 7specifica alle esigenze delle singole persone. o attivando nuove misure analoghe a quelle tra-
Una delle disequità più evidenti è di tipo dizionali è ormai impedita dalla crisi economi-
generazionale: una proporzione sbilanciata di ca, che comporta bisogni crescenti e contestuale
risorse pubbliche va a beneficio delle fasce di indisponibilità di nuove risorse. Non è né serio
popolazione più anziane, a scapito dei giovani né credibile pensare di poter costruire un siste-
e in particolare di coloro, tra questi, che si assu- ma parallelo a quello esistente, o anche solo di
mono la responsabilità di crescere figli. poter varare misure parallele a quelle esistenti,
lasciando continuare a operare, così come ora
opera, l’attuale sistema. Non lo è perché non è
Ottimizzare la cost-effectiveness
tempo di risorse aggiuntive disponibili tali da
La frammentazione, l’incoerenza, la rigidità alimentare due sistemi assistenziali paralleli;
delle erogazioni monetarie nazionali le rende non lo è perché comunque non è accettabile non
anche non integrabili con altre misure e risorse utilizzare al meglio le risorse dei cittadini che il
del territorio. Il sistema attuale non può quin- sistema fiscale preleva per assicurare lo svolgi-
di favorire l’individuazione e la valorizzazione mento “al meglio” di funzioni pubbliche. Siamo
di tutte le risorse disponibili (di utente, fami- a un capolinea: è necessario procedere alla rifor-
glia, contesto, enti e servizi pubblici e privati, ma delle misure nazionali in atto che ingessano
ecc.), per una loro convergenza sul problema o l’intero sistema, per aprire possibilità di effetti-
la fragilità da trattare, con la nascita spontanea vo perseguimento, nell’attuale situazione, del-
o progettata di reti collaborative, e il progressivo le finalità indicate e ogni giorno più urgenti. È
sviluppo in un quadro di crescente integrazione un passo oneroso, per questo sempre rinviato,
istituzionale, finanziaria, organizzativa, opera- ma oggi indifferibile se si vuole fare una seria
tiva. Ne risultano compromessi pesantemen- politica sociale, a sostegno di quanti, sempre
te sia l’efficienza organizzativa e operativa del più numerosi, vivono e soffrono grandi difficoltà
sistema e dei servizi, sia l’economicità, anche per economiche e sociali.
il mancato coinvolgimento di potenziali risorse Sull’analisi della situazione attuale e la conse-
presenti nel contesto. guente scelta di fondo, che abbiamo espresso nei
primi due paragrafi, abbiamo declinato i seguen-
ti ulteriori passi del percorso di ricerca:
Decentrare sul territorio funzioni e risorse
•• definizione del campo socio-assistenziale
per un welfare comunitario
(cap. 1, par. 1.4);
Efficacia, equità, attivazione e integrazione delle •• quantificazione delle risorse economiche in
risorse possono essere alimentati anche da azio- gioco (cap. 1, par. 1.5; cap. 2, par. 2.1);
ni spontanee ma sono anche il frutto di attività •• analisi della distribuzione sociale delle ero-
di programmazione, monitoraggio, controlli, gazioni assistenziali nazionali, per valutarne
valutazione, propri di un sistema di governance benefici e limiti nel sostegno ai bisogni sociali
partecipativa. E risulta evidente che sono dimen- (cap. 2).
sioni e qualità del sistema e delle singole azioni Abbiamo dedicato i capitoli successivi alla defi-
che possono nascere e svilupparsi solo entro un nizione e allo sviluppo delle tre grandi politiche
sistema fortemente decentrato, che investa sul che abbiamo voluto approfondire (sostegno alle
territorio come campo di azione e di sviluppo. famiglie con figli, cap. 3; contrasto alla povertà,
Nella misura in cui verranno decentrate funzio- cap. 4; sostegno alla non autosufficenza, cap. 5),
ni, risorse, responsabilità gestionali e professio- procedendo per ciascuna di esse alla:
nali ai territori le potenzialità di tale sviluppo •• individuazione delle principali criticità e
verranno fortemente accresciute, certo nella degli ostacoli al cambiamento degli interven-
misura in cui sui territori si proporranno pre- ti nazionali che assorbono la maggior parte
senze e iniziative di governo e di azione sociale delle risorse;
qualificate e significative per la crescita di un wel- •• formulazione di criteri, contenuti, percorsi
fare davvero comunitario, ovvero di comunità nel tempo e sui territori, per la riforma delle
più interattive e solidali, nelle loro componenti principali politiche individuate;
culturali, professionali, organizzative, istituzio- •• verifica dell’agibilità economica e socia-
nali e economiche. le delle proposte utilizzando le possibili
simulazioni.
1.3 Fare riforme anche nella attuale
situazione di vincoli alla spesa pubblica 1.4 Ridefinire il campo, le funzioni e le
risorse delle politiche socio-assistenziali
Efficacia nella riduzione e nella gestione dei biso-
gni, equità nella distribuzione di oneri e benefi- Abbiamo osservato in apertura che il quadro
ci, attivazione e integrazione di tutte le risorse normativo e di conseguenza quello istituzionale
presenti e disponibili, sono fattori di qualità che e finanziario non è frutto di una chiara e coerente
il nostro sistema socio-assistenziale dovrebbe impostazione concettuale. Il primo passo allo-
assumere come criteri guida e perseguire. L’at- ra da intraprendere per poter procedere oltre è
tuale sistema invece non lo fa, e la configura- quello di assumere una impostazione concettua-
zione delle misure nazionali è tale da impedire le e di articolare una conseguente ridefinizione
la correzione del sistema per sviluppi coerenti e ricollocazione degli attori coinvolti, delle fun-
ai criteri richiamati. La politica delle aggiunte, zioni, delle risorse economiche. Viene effettuato
del cercare di fronteggiare esigenze o pressioni riprendendo quanto a suo tempo assunto dalla
sociali aggiungendo risorse alle misure esistenti Commissione Onofri e attualizzandolo.
8 n. 8-10/2013 WelfareAlla base della nostra proposta di riforme Le risorse che il nostro Paese dedica alla com-
si pone quindi una scelta: non subire la disag- ponente socio assistenziale del welfare sono
gregazione e i confini angusti imposti tradi- certamente insufficienti, come evidenziano
zionalmente alle politiche socio-assistenziali, anche i confronti a livello europeo. Se l’attuale
ma alzare la posta, ridefinire il campo, mettere situazione sconsiglia, o addirittura rende impro-
sul piatto tutte le funzioni, le misure, le risorse ponibili aumenti della spesa pubblica finanziati
sociali pubbliche, di qualsiasi origine storica e di con aumenti della pressione fiscale generale,
qualsiasi classificazione giuridica, rivederle nel risorse aggiuntive per l’assistenza potrebbero
loro insieme in funzione degli attuali bisogni/ essere recuperate con revisioni della attuale
domande sociali, con criteri generali e politiche allocazione e distribuzione della spesa pubblica
specifiche coerenti. fra le diverse politiche, o quale frutto di risparmi
L’oggetto che si intende qui considerare e realizzati con interventi redistributivi in campo
riformare sono specificamente le politiche socia- previdenziale, o della stessa spesa assistenziale.
li (socio-assistenziali in termini un po’ obsoleti), Sono state in merito avanzate di recente signi-
quelle che: ficative proposte di revisione equitativa delle
•• trattano problemi di benessere della persona, erogazioni previdenziali più elevate, in parti-
delle famiglie, delle popolazioni, con preven- colare le “pensioni d’oro”.1 A esse si avvicinano
zione, ascolto, accompagnamento, soste- ipotesi di possibili interventi redistributivi o
gno economico o con prestazioni di servizi, radicalmente innovativi effettuabili riformando
ponendosi spesso al confine con sanità, scuo- le erogazioni assistenziali gestite dall’Inps, per
la, lavoro e altre politiche pubbliche; assicurare a diritti fondamentali oggi gravemen-
•• sono finanziate con il prelievo fiscale, non con te trascurati risposte certe, ispirate a criteri di
contributi o premi; equità sociale e di efficacia a fronte di bisogni
•• vanno individuate in base alla loro funzione, meritevoli di tutela e sostegno pubblico.
non alle classificazioni amministrative, di cui Innovazioni nella fiscalità generale e nel campo
scavalcano i confini; della previdenza sarebbero auspicabili, ma pro-
•• i cui interventi consistono in erogazioni babilmente lunghe e molto esposte a resistenze
monetarie, servizi, detrazioni fiscali, che van- e concorrenzialità sulla distribuzione fra diverse
no considerati gestiti da sistemi territoriali politiche egualmente rilevanti (lavoro, scuola,
organizzati e operanti con logiche e modalità ricerca, ecc.) delle risorse con esse recuperate.
operative coerenti, coordinate, integrate in Per questo privilegiamo qui un percorso di revi-
funzione dei destinatari. sione e riallocazione delle risorse già oggi impe-
Queste scelte fondamentali ci consentono di gnate nel settore socio assistenziale che, ancor
poter procedere alla conseguente individuazio- più se scarse, vanno utilizzate massimizzando
ne e ricostruzione delle risorse pubbliche coin- obiettivi di efficacia e di equità. Cautelandoci
volte nel campo socio-assistenziale. La effettuia- così anche contro la ricorrente comoda obiezio-
mo con le modalità e gli esiti descritti nel primo ne del “non ci sono le risorse”, per sano realismo
paragrafo del capitolo 2, e nell’allegato che det- assumere il vincolo di far conto sulla sola spesa
taglia ulteriormente metodologia e entità consi- attualmente impegnata nel settore socio-assi-
derate. Ci limitiamo quindi qui a richiamare che stenziale, per cercare come riqualificarne l’uti-
le politiche socio-assistenziali gestiscono una lizzo guidati dai criteri guida ora esposti. Da qui
spesa complessiva pari a 67 miliardi di euro, 4,28 l’indagine sui beneficiari delle attuali misure e
punti del Pil, di cui 54 miliardi, pari all’80% del sulla condizione economica delle loro famiglie,
totale, assorbiti da programmi nazionali gestiti sia per individuare gli esclusi o comunque i pena-
dall’Inps e da detrazioni previste dalla fiscalità lizzati dall’attuale sistema e l’ammontare delle
nazionale; 8,5 miliardi, quasi il 14% del totale, risorse che sarebbero necessarie per trattare in
gestiti da Comuni, Regioni e altri enti, per servizi modo un po’ più adeguato i loro bisogni, sia per
e anche erogazioni monetarie; 5 miliardi stimati indagare in quali segmenti della spesa attua-
di spesa sociosanitaria per la non autosufficien- le e in quale misura sia possibile identificare
za. Tali risorse sono state da noi per quanto pos- risparmi di risorse che possano essere destinati
sibile imputate a tre diverse grandi aree di poli- a coprire i costi dei primi soggetti, appunto gli
tiche: sostegno alle famiglie con figli, contrasto esclusi o penalizzati.
alla povertà e inserimento sociale, sostegno alla
cura di non autosufficienti e disabili, per somme
1.5 L’attuale distribuzione dei benefici offre
pari rispettivamente a 21, 18, 24 miliardi circa.
opportunità per reperire risorse
La ricostruzione effettuata evidenzia anche uno
sbilanciamento accentuato a favore delle eroga- Il piano di finanziamento delle riforme prende le Note
zioni economiche soprattutto nazionali, rispet- mosse proprio dalla scarsa equità sociale e dalla 1 Amato G., “Un fondo
to ai servizi, superiore a quello dei Paesi europei a bassa azione redistributiva della attuale spesa comune per l’equità
noi confrontabili. Tali dati concorrono a spiegare assistenziale. Ad esempio, come verrà dettaglia- previdenziale”, Il Sole
la bassa efficacia rispetto ai bisogni trattati della tamente descritto nel capitolo 2, l’analisi della 24 Ore, 21 luglio 2013;
nostra spesa socio-assistenziale che accompagna distribuzione delle erogazioni monetarie nazio- Boeri T., “Pensioni d’oro,
la sua scarsa efficacia redistributiva fra i soggetti nali fra decili di famiglie definiti in base alla loro è l’ora della trasparen-
za”, La Repubblica, 13
in difficoltà, e quindi la sua poca equità. Occorre condizione economica analizzata utilizzando
agosto 2013; Salerno N.
quindi un intervento di riforma che tratti e inno- l’Isee in via di approvazione, evidenzia che: C., “L’equità delle pen-
vi congiuntamente i caratteri e i contenuti degli •• alla metà più ricca delle famiglie (dal 6º decile sioni vista dalla Corte
interventi per migliorarne l’efficacia, la distribu- in su) affluisce il 37% di tutta la spesa assisten- costituzionale”, La
zione sociale, l’equità. ziale e pure il 37% delle risorse per le misure Voce, 26 agosto 2013.
Welfare n. 8-10/2013 9Puoi anche leggere