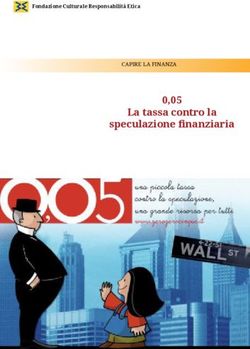Cittadinanza e educazione stradale - Percorso 3 - Cittadinanza e educazione stradale
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Percorso 3
Cittadinanza e… educazione
stradale
AGORÀ DELLE IDEE SICURI IN STRADA
È notte inoltrata e, su una strada statale di provincia, in un’automobile di media cilindrata, Matteo, Emi-
liano, Cristina, Federica e Veronica tornano alle loro case dopo una serata passata in discoteca. Ridono,
scherzano, cantano. È normale alla loro età, anche se forse qualcuno di loro ha bevuto un po’ troppo e, tra
questi, proprio Matteo che sta guidando.
La strada non è ben illuminata e, dopo una delle tante curve, vediamo improvvisamente riflesse negli oc-
chi dei cinque ragazzi le luci di un camion che sembra essere comparso dal nulla. Matteo prova a evitarlo
e, facendolo, sterza bruscamente a destra. Ma la strada è stretta e l’auto finisce nella ripida scarpata.
Mentre seguiamo la scena dell’auto che precipita sempre più giù, udiamo le urla disperate dei ragazzi,
vediamo il panico nei loro occhi che non capiscono cosa sta succedendo, le loro braccia che tentano di
aggrapparsi a qualcosa per non essere violentemente sballottati nell’auto che ancora non si ferma. Fi-
nalmente, la corsa ha termine, l’auto si è fermata sul fondo del dirupo. I ragazzi, sconvolti e forse feriti,
ma vivi, sono immobilizzati dalla paura. Ci tranquillizziamo, pensando che ce l’abbiano fatta, anche se il
nostro cuore ancora batte veloce per la forte emozione provata.
Improvvisamente però, quando ancora i ragazzi non sono usciti dall’auto, un violento scoppio ci scuote.
L’auto è di colpo esplosa, con i ragazzi ancora al suo interno! La sensazione che ora proviamo è di terrore,
disperazione, disgusto…
Il luogo da cui abbiamo assistito a tutto ciò non è la strada, ma la comoda poltrona di casa nostra. E,
tuttavia, non stiamo vedendo un film. Si tratta invece di una pubblicità sociale per la prevenzione degli
incidenti stradali. Infatti, alla fine della scena appena descritta, una voce fuori campo raccomanda ai
giovani di prestare attenzione alla guida e, soprattutto, di non guidare dopo aver bevuto. Si tratta, più
specificamente, di ciò che gli anglosassoni chiamano fear appeal (letteralmente “appello alla paura”),
termine utilizzato proprio per indicare quei messaggi che fanno uso dell’intimidazione per cambiare gli
atteggiamenti e i comportamenti di soggetti a rischio.
(Tratto da: Sabina Cedri, L’utilizzo della “paura” nei messaggi per la prevenzione degli incidenti stradali,
in “Il Centauro”, n. 99 - Ottobre 2005)
2DEBATE
IL CONTESTO
Lo spot di cui hai appena letto è un caso estremo di pubblicità intimidatoria. In genere, in Italia, questo tipo
di comunicazione sociale non viene utilizzata. In altri Paesi, invece, il ricorso alla paura negli spot è molto più
frequente. Vengono usate immagini che rimandano alla morte o ad altri pericoli conseguenti a infortuni su
strada: lapidi di cimiteri, giovani corpi su lettini dell’obitorio, sedie a rotelle ecc. L’obiettivo è quello di suscitare
in chi osserva paura o addirittura terrore, provando a fargli percepire un senso di vulnerabilità, e a indurlo a
modificare comportamenti considerati sbagliati da chi ha commissionato la campagna di comunicazione.
LA QUESTIONE
È difficile è stabilire se messaggi basati sul fear appeal siano efficaci o meno. Gli studiosi dibattono su
questo argomento da tempo e non sono giunti a posizioni condivise.
Secondo alcuni esiste una correlazione positiva tra la paura suscitata e l’efficacia persuasiva del
messaggio: maggiore è il livello di intimidazione, maggiore sarebbe il cambiamento nel comportamento.
Secondo altri, invece, minore è il livello di paura veicolato dal messaggio, maggiore è la possibilità che esso
provochi un cambiamento. Secondo questa posizione, un elevato livello di paura può causare il cosiddetto
“effetto boomerang”: di fronte a un messaggio fortemente intimidatorio, gli osservatori sarebbero a tal
punto sconvolti da non voler più proseguire nella visione. Oppure: scene molto realistiche e paurose
potrebbero indurre i destinatari a non credere che un simile incidente possa capitare proprio a loro. Ancora:
un messaggio estremamente intimidatorio, a causa delle immagini forti, potrebbe far perdere la
concentrazione relativamente ai contenuti che si intende veicolare. Infine, questi messaggi possono non
essere particolarmente efficaci proprio per i soggetti più a rischio, come i giovani, abitualmente esposti a
immagini di questo tipo anche in altri contesti (film, videogiochi ecc.).
ASSEGNAZIONE DEI COMPITI E SVOLGIMENTO DEL DIBATTITO
1. La classe si divide in due gruppi (ciascuno dei quali avrà un portavoce). L’insegnante assegna:
• al primo gruppo il compito di sostenere l’idea in base alla quale
l’utilizzo del fear appeal può essere efficace nelle pubblicità sociali
finalizzate alla prevenzione degli incidenti stradali
• al secondo gruppo il compito di sostenere l’idea in base alla quale
l’utilizzo del fear appeal può essere controproducente nelle pubblicità sociali
finalizzate alla prevenzione degli incidenti stradali
2. Ogni gruppo ha 15 minuti per cercare delle argomentazioni a favore della propria idea e per stilare una
scaletta dell’intervento che effettuerà.
3. A turno il portavoce di ciascun gruppo espone le riflessioni precedentemente codivise con i propri
compagni, cercando di dimostrare la validità delle idee sostenute.
4. L’insegnante stabilisce quale delle due tesi sia stata sostenuta in maniera più pertinente ed efficace. 3Unità di apprendimento 1
Il rispetto delle regole in strada
1. Il Codice della strada
Pedoni, biciclette, motociclette, automobili, scooter, autobus, tram, camion… Gli utenti
della strada sono così tanti e così diversi tra loro per esigenze e caratteristiche che spesso
la loro «convivenza civile» sullo stesso nastro d’asfalto si trasforma in un’impresa molto
complicata.
Proprio perché è «di tutti», la strada è il luogo dove più facilmente gli individui possono en-
trare in conflitto tra loro: per questo motivo una corretta educazione stradale non implica
solo l’essere in grado di saper condurre una macchina o un
COSTITUZIONE Art. 16
motorino, ma l’essere consapevoli che quando si è in strada,
Ogni cittadino può circolare e
soggiornare liberamente in qual- sia come pedoni che alla guida di un veicolo, si fa parte di una
siasi parte del territorio nazio- comunità e quindi si è tenuti a conoscere e a rispettare delle
nale, salvo le limitazioni che la regole condivise, per tutelare la sicurezza propria e quella
legge stabilisce in via generale degli altri, e non correre inutili rischi.
per motivi di sanità o di sicurezza.
Nessuna restrizione può essere La nostra Costituzione, all’articolo 16, spiega in sostanza
determinata da ragioni politiche. che ciascuno è libero di muoversi fino a quando questa sua
Ogni cittadino è libero di uscire libertà non va a limitare quella degli altri.
dal territorio della Repubblica e La strada, infatti, è un luogo pubblico, in cui si può circolare,
di rientrarvi, salvo gli obblighi di
sostare, chiacchierare, incontrarsi, a patto che si rispettino le
legge.
stesse regole, valide per tutti, dai pedoni agli automobilisti.
■ Le norme del Codice della strada
stabiliscono i diritti e i doveri degli
utenti della strada e le sanzioni che
4 vanno applicate a chi non le rispetta.Percorso 1 • Cittadinanza e… educazione stradale
Queste norme sono raccolte nel Codice della strada, che stabilisce i diritti e
i doveri degli utenti della strada e le sanzioni che vanno applicate a chi non
le rispetta.
Gli articoli del Codice della strada sono ispirati ad alcuni principi fondamen-
tali, ovvero:
• regolare il traffico stradale e assicurare una circolazione scorrevole;
• garantire la sicurezza di tutti gli utenti, dai pedoni ai ciclomotoristi agli au-
tomobilisti;
• tutelare l’ambiente;
• ridurre i consumi energetici;
• stabilire sanzioni per coloro che non rispettano queste regole.
Il Codice della strada si divide in diverse sezioni che riguardano:
• le disposizioni generali sulla circolazione;
• la classificazione delle strade;
• la classificazione dei veicoli;
• la guida dei veicoli;
• le norme di comportamento;
• la violazione delle norme e le relative sanzioni.
Le regole del Codice non valgono solo per gli automobilisti e per tutti coloro
che conducono un mezzo a motore, ma devono essere conosciute e rispettate
anche da ciclisti e pedoni. Molte norme, infatti, non riguardano solo aspetti
tecnici relativi alla guida di un mezzo meccanico, ma sono semplici regole di
convivenza sociale, legate al buon senso e alla civiltà di ciascuno, più che alla
viabilità.
Non esistono categorie disciplinate e categorie indisciplinate: la stessa per-
sona può spostarsi un giorno a piedi e l’altro in automobile, in bicicletta o in
moto. Se è una persona civile e responsabile, sarà anche un pedone, un auto-
mobilista, un ciclista, un motociclista responsabile.
In Italia, la prima regolamentazione relativa alla circolazione stradale si ebbe
nel 1865: una legge, perfezionata e integrata nel 1868, che stabiliva il compor-
tamento da tenere alla guida di veicoli, che erano, all’epoca, ancora a trazione
animale.
Con l’arrivo dei primi mezzi a motore, la situazione si fece più complicata.
Alla fine della seconda guerra mondiale, nell’estate del 1945, il numero di auto
presenti in Italia era di circa 200.000 unità. Si trattava di vetture di genere molto
diverso: a benzina, a nafta, a gas di legna. La necessità di una disciplina che re-
golasse questa nuova situazione in continua evoluzione si fece più forte.
In una conferenza che si tenne nel 1949 a Ginevra, l’Italia si impegnò a regola-
mentare i trasporti stradali e automobilistici.
Il primo Testo unico sulla circolazione stradale è del 1959: Testo unico
una raccolta di 147 articoli che sono alla base del primo Codi- Un Testo unico è un decreto che
è emanato quando il Parlamen-
ce della strada italiano. to avverte la necessità di racco-
Nel 1992 è nato il Nuovo Codice della strada: il numero di gliere in un unico testo una disci-
mezzi privati e pubblici in costante aumento e lo sviluppo plina che precedentemente era
della rete autostradale avevano reso indispensabili modifi- frammentata in più atti. I Codici
invece nascono già come una
che, aggiunte e cambiamenti alle norme già esistenti.
raccolta organica e unitaria.
5Area di competenza 3 Noi e il rispetto delle regole
Entrato in vigore il 1° gennaio 1993, il Codice è stato costantemente aggiorna-
to nel corso degli anni per adeguarsi alla normativa europea e stare al passo
con la società e i problemi che si presentano in fatto di strade e circolazione
stradale.
Alcune importanti novità, ad esempio, si sono avute nel 2003 con:
• l’introduzione del «patentino» per la guida del ciclomotore: i ragazzi dai
14 ai 18 anni, ma anche i maggiorenni che non hanno altro tipo di patente,
devono conseguire questo documento di certificazione per poter condurre
un ciclomotore, frequentando appositi corsi organizzati dalla scuola o dalle
autoscuole e superando un esame di idoneità;
• la «patente a punti»: al momento del rilascio, alla patente di guida vengono
attribuiti 20 punti; ad ogni infrazione considerata grave ne viene sottratto un
certo numero (che raddoppia per i neopatentati).
Il Codice della strada, inoltre, prevede (articolo 1, comma 3) «al fine di ridurre
il numero e gli effetti degli incidenti stradali e in relazione agli obiettivi e agli
indirizzi della Commissione Europea» la definizione di un Piano Nazionale
della Sicurezza Stradale.
La sicurezza stradale, infatti, è una materia di cui l’Unione europea si occupa
da tempo attraverso diversi programmi d’azione, l’ultimo dei quali, pubbli-
cato nel giugno del 2019, si pone un obiettivo ambizioso: «zero vittime» della
strada entro il 2030. La Commissione europea invita i Paesi membri al con-
seguimento di tale obiettivo attraverso le rispettive strategie nazionali per la
sicurezza stradale.
2. Le regole della sicurezza
La legge detta disposizioni a tutela della sicurezza personale di chi guida, dei
passeggeri e dei pedoni. Tutti, senza eccezione, devono rispettare le regole,
affinché sulle strade ci sia più sicurezza e più serenità.
L’arresto del veicolo
La velocità deve essere commisurata alla visibilità, vale a dire che il condu-
cente deve tenere un’andatura che gli consenta di fermare il veicolo nello
spazio che è in grado di vedere perfettamente.
Se, per esempio, la visibilità è di 100 m, la velocità a cui si viaggia deve essere tale
da permettere la fermata in questo spazio, che viene definito spazio d’arresto.
Lo spazio d’arresto è somma di due fattori estremamente variabili: lo spa-
zio di reazione percorso durante il «tempo di reazione», cioè in quel lasso di
tempo che va dall’avvistamento dell’ostacolo all’inizio della frenata, e lo spa-
zio di frenatura necessario al veicolo per arrestarsi (calcolato dal momento in
cui inizia la frenata fino all’arresto totale del veicolo).
Il primo di questi fattori dipende, com’è ovvio, dalle condizioni psicofisiche
del conducente; il secondo, invece, dall’efficienza del veicolo (freni, pneuma-
tici) e dalle condizioni del fondo stradale.
La velocità e l’aderenza (la resistenza che il fondo stradale oppone al movi-
mento delle ruote) sono gli elementi che permettono, sia pure approssimati-
6 vamente, di calcolare sia lo spazio di reazione sia lo spazio di arresto.Percorso 1 • Cittadinanza e… educazione stradale
Considerando un veicolo con pneumatici in buone condizioni, alla velocità
di 70 km/h su strada asciutta, lo spazio di reazione sarà: 70 : 10 × 3 = 21 metri.
Si divide, cioè, la velocità per 10 e si moltiplica per tre.
Lo spazio di arresto, invece, sarà: 70 : 10 = 7 × 7 = 49 metri.
Si divide la velocità per 10 e si moltiplica il risultato per se stesso.
La distanza di sicurezza
La distanza di sicurezza è la distanza che deve intercorrere tra un veicolo e
quello che lo precede in modo da poter evitare, in caso di frenata improvvisa,
collisioni. Tale distanza deve essere almeno pari allo spazio percorso durante
il tempo di reazione.
La distanza di sicurezza tra due veicoli dipende:
• dalla velocità;
• dalla prontezza di riflessi del conducente, dalla sua concentrazione e con-
dizione fisica;
• dalle condizioni atmosferiche e di traffico;
• dal tipo, peso e stato di efficienza del veicolo (freni e pneumatici);
• dalle condizioni della strada;
• dal carico del veicolo.
Le precedenze
Molti degli incidenti che si verificano in città potrebbero essere evitati se i
conducenti rispettassero le «regole della precedenza».
Analizziamo le più importanti:
• se il conducente arriva a un incrocio (intersezione) senza alcun segnale, è
tenuto a seguire la regola generale, dando la precedenza a chi proviene da
destra;
• in presenza di un semaforo funzionante, il conducente si ferma col rosso,
passa col verde, col giallo se può si ferma in tempo, altrimenti sgombera l’in-
crocio;
• se arriva a una rotatoria, il conducente ha l’obbligo di circolare secondo il
verso indicato dalle frecce;
• se sta arrivando un tram, il conducente deve fermarsi prima delle rotaie e
lasciarlo passare;
• se sta arrivando un autobus, il conducente non è obbligatorio dare la prece-
denza (a meno che non provenga da destra, secondo le regole generali), ma
è opportuno che lo faccia quando sta reinserendosi nel traffico dopo aver
sostato a una fermata;
• se sta arrivando un veicolo di emergenza (ambulanza, auto della polizia,
pompieri), il conducente deve rallentare, accostare a destra e lasciare tutto
lo spazio possibile per agevolarne il passaggio;
• se un pedone attraversa sulle strisce, ha la precedenza (fuori dalle strisce
pedonali è comunque necessario che i conducenti prestino molta atten-
zione);
• in presenza del segnale «dare precedenza», il conducente si ferma, se ne-
cessario, per dare la precedenza a destra e a sinistra;
7Area di competenza 3 Noi e il rispetto delle regole
• al segnale di stop, che indica di «fermarsi e dare la precedenza», il condu-
cente deve bloccare il veicolo anche se non vede nessuno e deve dare in
ogni caso la precedenza, sia a destra sia a sinistra.
Codice dei colori e forme dei segnali
La sicurezza stradale riguarda anche la conoscenza e la corretta interpreta-
zione del significato dei segnali stradali.
I segnali stradali possono essere di diverso tipo:
• verticali (i «cartelli»);
• orizzontali (le «strisce»);
• luminosi (i «semafori»);
• manuali (le «ingiunzioni» dei vigili e della polizia).
I segnali verticali si dividono in tre grandi categorie:
• i triangoli indicano «pericolo» (la natura del pericolo è rappresentata da un
simbolo);
• i cerchi con bordo rosso indicano un «divieto», quelli a fondo blu un «ob-
bligo»;
• i quadrati e i rettangoli forniscono «indicazioni» o «informazioni».
Il colore di fondo dei segnali quadrati o
rettangolari è diverso:
• il bianco serve a indicare o a condurre a
strade o a destinazioni urbane;
• il blu è utilizzato per indicare le strade
extraurbane o per condurre ad esse;
• il verde è utilizzato per indicare le auto-
strade o per condurre ad esse;
• il marrone fornisce indicazioni geografi-
che, ecologiche, di ricreazione e per i luo-
ghi di interesse storico, artistico, culturale
e turistico;
• il giallo viene utilizzato per segnali tem-
poranei di pericolo, cantieri, lavori in
corso e deviazioni;
• il nero indica zone industriali o centri
commerciali nelle zone periferiche ur-
bane.
I dispositivi di sicurezza
Conducenti e passeggeri viaggiano più sicuri grazie all’obbligo di dotare i
propri veicoli di determinati dispositivi di sicurezza.
Il casco elimina o riduce i traumi alla testa di ciclomotoristi e motociclisti ed
è determinante per evitare la morte per frattura cranica.
Le cinture eliminano o riducono il rischio di lesioni derivanti da urti violenti
contro lo sterzo, il parabrezza, il cruscotto o i sedili anteriori.
L’airbag (cuscino d’aria) è un dispositivo di sicurezza passiva, non obbligato-
rio, costituito da un cuscino gonfiabile di nylon che entra in funzione in caso
di incidente stradale con urto violento, assicurando al conducente e ai pas-
8Percorso 1 • Cittadinanza e… educazione stradale
seggeri la massima protezione. È di tipo frontale oppure laterale e può essere
pericoloso se non si indossa la cintura di sicurezza.
I poggiatesta prevengono, in caso di incidente, le lesioni alla colonna verte-
brale.
I seggiolini per trasportare bambini, opportunamente ancorati ai sedili, ser-
vono a proteggerli e trattenerli in caso di collisione.
Sicurezza su due ruote
Le «due ruote», cioè biciclette, ciclomotori e scooter (fino ai 50 cmc), moto
leggere (fino a 125 cmc) e motocicli offrono notevoli vantaggi, ma hanno
anche punti deboli.
Bisogna essere consapevoli della pericolosità dei mezzi a due ruote:
• in caso di urto si perde l’equilibrio in quanto le due ruote non danno alcuna
protezione;
• a causa dell’equilibrio instabile del mezzo, i rischi sono maggiori in situa-
zioni di intemperie, di vento e pioggia, di buche stradali e di scivolosità delle
pavimentazioni;
• se sfiorati da auto in sorpasso ad elevata velocità, i motociclisti risentono in
modo rilevante dello spostamento d’aria.
Ciclisti, ciclomotoristi e motociclisti sono tenuti a rispettare tutti i segnali di
pericolo, di divieto e di obbligo: non ci sono regole di circolazione particolari,
ma l’attenzione deve essere ancora maggiore data la maggiore vulnerabilità
dei mezzi a due ruote rispetto a quelli a quattro.
Guida all’esposizione orale
• Che cosa stabilisce l’art. 16 della Costituzione riguardo alla libertà del cittadino di muoversi sul terri-
torio nazionale?
• Quali sono i principi fondamentali contenuti nel Codice della strada?
• Definisci i concetti di spazio d’arresto, distanza di sicurezza, precedenza, in relazione alla circolazione
stradale.
• Quante e quali tipologie di segnali stradali sapresti riconoscere?
• Fai qualche esempio di dispositivo di sicurezza.
■ L’utilizzo dei dispositivi di sicurezza,
come il casco sui mezzi a due ruote
o la cintura di sicurezza in auto, è una
norma che va sempre osservata in-
nanzitutto per la propria incolumità. 9Unità di apprendimento 2
Norme di comportamento
per la sicurezza stradale
1. Comportamenti corretti
Le regole più importanti da osservare nella circolazione stradale per preservare la propria
sicurezza riguardano sia coloro che conducono un mezzo a motore sia ciclisti e pedoni.
Camminare sicuri
I pedoni non devono mai camminare al centro della carreggiata, perché questa è riservata
alla circolazione dei veicoli, ma devono utilizzare viali pedonali o marciapiedi. Sui mar-
ciapiedi non si deve intralciare la circolazione degli altri pedoni, costringendoli a cammi-
nare sulla strada.
Nel caso in cui non ci sia il marciapiede, è più prudente, nelle strade a doppio senso, cioè
con veicoli che provengono da entrambe le direzioni, camminare sul lato sinistro della
strada, per vedere meglio i veicoli che giungono in senso contrario e sottrarsi a possibili
investimenti.
Nelle strade a senso unico, cioè dove i veicoli circolano in un’unica direzione, il pedone
deve camminare sul lato destro, con i veicoli che sopraggiungono alle sue spalle. In que-
sto modo, infatti, il pedone non costituirà un ostacolo imprevisto per il conducente che
effettua un sorpasso.
Per i pedoni l’operazione più pericolosa è l’attraversamento della carreggiata.
Se sulla strada ci sono attraversamenti pedonali (strisce bianche disegnate in orizzontale
sull’asfalto, sottopassaggi o sovrappassi) a meno di cento metri di distanza, il pedone deve
servirsene obbligatoriamente.
Se sulla carreggiata manca l’attraversamento pedonale, il pedone deve:
• dare la precedenza ai veicoli;
• attraversare la carreggiata in senso perpendicolare ad essa, evitando traiettorie diagonali
o a zig zag, in modo che la durata dell’attraversamento sia ridotta al minimo;
• adottare particolare attenzione e prudenza;
• scegliere il momento più opportuno per attraversare, evitando di farlo in modo improv-
viso o correndo.
10Percorso 1 • Cittadinanza e… educazione stradale
Se l’attraversamento è regolato da semafori, bisogna os-
servare che tipo di segnalazione è attiva:
• il segnale di pedone rosso in atteggiamento di attesa ha il
significato di arresto, vieta quindi l’attraversamento e anche
il semplice impegno della carreggiata;
• il segnale di pedone giallo in atteggiamento di attesa ha il
significato di preavviso di arresto, ci consente di completa-
re l’attraversamento se l’avevamo già iniziato, ma ci vieta di
iniziare ad attraversare;
• il segnale di pedone verde in atteggiamento di movimento
ha ovviamente il significato di via libera, ma consente l’at-
traversamento soltanto nella direzione della luce verde. ■ Lanterne semaforiche per pedoni e
velocipedi.
Pedalare senza rischi
La bicicletta è un mezzo che si impara a condurre fin da bambini, è di facile
utilizzo, ha una meccanica molto semplice e, soprattutto, non inquina e per-
mette di fare attività fisica. Anche nelle grandi città bisognerebbe provare a
usarla più spesso, come mezzo di spostamento quotidiano, oltre che nelle
passeggiate.
Tuttavia, è bene ricordare che anche per guidare la bicicletta (o velocipede,
come viene chiamato dal Codice della strada), oltre a essere particolarmente
attenti e prudenti, bisogna conoscere e rispettare le norme di comportamen-
to a cui sono soggetti tutti gli altri veicoli.
Chi è alla guida di una bici deve ricordare che è vietato marciare affiancati ad
altri ciclisti, ma bisogna muoversi in fila indiana. Nel caso in cui siano pre-
senti apposite piste ciclabili, è obbligatorio usarle, altrimenti bisogna circo-
lare il più possibile vicino al margine destro della carreggiata, in modo da
non intralciare il transito dei veicoli a motore e procedere in linea retta.
Durante la guida bisogna evitare acrobazie e reggere il manubrio con tutte e
due le mani, tranne nel momento in cui si sta per effettuare uno spostamento
sulla carreggiata o una curva. In questo caso, infatti, bisogna segnalare la
propria intenzione ai veicoli che sopraggiungono, sporgendo un braccio
all’esterno, nella direzione in cui ci si sposta. In caso di improvviso arresto, il
braccio andrà alzato verticalmente sopra il capo. Sulle biciclette è vietato cir-
colare portando un’altra persona, ad eccezione dei bambini fino a 8 anni,
trasportati dai genitori con appositi seggiolini e poggiapiedi.
In alcune circostanze, i ciclisti devono scendere dalla bici e condurla a mano:
si tratta in genere di luoghi affollati, in cui la guida della bicicletta potrebbe di-
ventare pericolosa per i pedoni, o in caso di carreggiate con traffico intenso e
veloce, che metterebbero in pericolo il ciclista stesso.
La bicicletta va portata a mano anche dal tramonto del sole in Catarifrangenti
poi, se sprovvista di luci, o quando la situazione meteorologica Placchette di diversa forma
rende la strada pericolosa (nebbia, pioggia, vento forte). che hanno la particolarità
Prima di mettersi in marcia è opportuno controllare che le gom- di poter riflettere la luce
nel buio. Vengono impiega-
me non siano sgonfie e non abbiano il battistrada consumato, te per segnalazioni stradali
che i freni e il campanello funzionino correttamente, che luci e notturne o per rendere più
catarifrangenti siano in buono stato. La prima regola di sicurez- visibili biciclette o motorini
za del ciclista, infatti, è rendersi sempre visibile. quando non c’è luce.
11Area di competenza 3 Noi e il rispetto delle regole
Sicuri alla guida
I rischi sulla strada, soprattutto per chi guida un mezzo a motore, esistono ma
possono essere prevenuti ed evitati. Moderare sempre la velocità, mantenere
la distanza di sicurezza, osservare le norme sulla precedenza, sono le regole
d’oro per viaggiare sicuri. Bisogna inoltre fare una buona manutenzione del
proprio mezzo e tenerlo sempre in ordine, facendo attenzione soprattutto a
luci, fari (tutti i veicoli devono tenerli accesi anche di giorno sulle tangenziali
e autostrade), catarifrangenti (che sono indispensabili per farci vedere an-
che quando c’è poca luce), freni, gomme. Nelle ore notturne e con la pioggia,
inoltre, bisogna fare ancora più attenzione e procedere con cautela.
Per lo stesso motivo è consigliabile, per chi guida un mezzo a due ruote, non
indossare, di notte o in strade poco illuminate, indumenti scuri, ma abiti di
colore chiaro o giubbotti dotati di strisce o applicazioni catarifrangenti.
Ciclisti e motociclisti, inoltre, dovrebbero rinunciare a sciarpe e foulard, che
rischiano di impigliarsi nelle ruote o negli ingranaggi del motore, ed evitare,
in generale, un abbigliamento che non sia comodo e pratico.
Sentirsi in forma ed evitare distrazioni
Infine, prima di mettersi alla guida di un veicolo, bisogna assicurarsi di sen-
tirsi fisicamente e psicologicamente in forma. Se ci si sente stanchi, stres-
sati, affaticati, ammalati, assonnati, conviene sicuramente affidarsi ai mezzi
pubblici o fare un po’ di strada a piedi.
Inoltre ci sono dei farmaci, come ad esempio gli antibiotici o gli antistamini-
ci (usati contro le allergie), che indeboliscono e inducono sonnolenza. Anche
in questi casi è fortemente sconsigliato mettersi alla guida di un veicolo.
È molto importante, infine, evitare distrazioni di qualsiasi genere. Ascoltare
musica con le cuffiette o utilizzare lo smartphone mentre si è in marcia può
essere estremamente pericoloso in quanto aumenta le possibilità di distrarsi
e impedisce di sentire i rumori che provengono dalla strada e che a volte ci
avvertono di qualche pericolo (colpi di clacson, fischietto del vigile ecc.).
Guida all’esposizione orale
• Quali sono le principali regole che un pedone deve osservare in strada? E un ciclista?
• Ci sono alcuni comportamenti particolarmente pericolosi per chi guida un mezzo a motore. Fai qualche
esempio.
2. Guida e assunzione di sostanze pericolose
L’alcol agisce sul cervello umano alterandone alcune funzioni: attenzione,
percezione, valutazione dei pericoli, tempo di reazione agli stimoli. Per que-
sto è assolutamente vietato mettersi alla guida di un veicolo dopo aver bevu-
to alcolici. L’assunzione di bevande alcoliche è ai primi posti tra le cause di
incidenti stradali, soprattutto per i giovani di ritorno da locali e discoteche:
fenomeno tristemente noto come «le stragi del sabato sera».
Gli effetti dell’alcol sono strettamente legati alla sua quantità presente nel
sangue, cioè al tasso alcolemico, che si misura in grammi/litro. Viene con-
12Percorso 1 • Cittadinanza e… educazione stradale
siderato in «stato di ebbrezza», e in quanto tale punito dalla legge, il condu-
cente che abbia un tasso alcolemico compreso tra 0,51 e 0,8 grammi per litro:
in questo caso si incorre in una multa e nella possibilità di sospensione della
patente per un periodo che va da tre a sei mesi. Ma se il tasso alcolemico è più
alto e ci si mette alla guida, il reato diventa penale ed è punibile con l’arresto
fino a sei mesi.
Diverse le disposizioni per i minori di 21 anni e i neopatentati (coloro che
hanno conseguito la patene da meno di tre anni): per loro il divieto di assu-
mere alcol è assoluto, in quanto il limite imposto è di zero grammi per litro.
Resta da dire che individuare una corrispondenza tra il numero di bicchieri
bevuti e il tasso alcolemico non è semplice; diciamo che il sistema più sicu-
ro per non essere mai in difetto c’è ed è solo uno: non bere affatto prima di
guidare. Infatti, molti sono gli elementi che influenzano i tempi e le modalità
di assorbimento e smaltimento dell’alcol da parte dell’organismo; tra questi:
il peso corporeo del soggetto, la gradazione alcolica della bevanda e l’assun-
zione di cibi prima di bere.
L’alcol, inoltre, interagisce con altre sostanze, che ne moltiplicano gli effetti.
Bisogna sempre ricordare, ad esempio, di evitare di bere alcolici quando si
assumono farmaci: tranquillanti, ansiolitici, ma anche antidolorifici, alcuni
antistaminici e perfino sciroppi per la tosse.
L’accertamento della guida in stato di ebbrezza viene condotto con l’etilome-
tro: uno strumento capace di misurare la quantità di alcol presente nell’aria
espirata. Il rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico compor-
ta le stesse sanzioni previste per la «guida in stato di ebbrezza».
L’alcol non va mai abbinato con la guida, ma può essere consumato con mo-
derazione e appartiene alla tradizione gastronomica e culturale del nostro
Paese.
Per le droghe, invece, il discorso è completamente diverso: produzione, con-
sumo e vendita di sostanze stupefacenti sono vietati e severamente puniti.
Questo avviene perché le droghe provocano danni irreparabili al cervello, a
prescindere dalla quantità assunta, e generano nel consumatore una dipen-
denza fisica o psicologica.
La droga non va d’accordo con la guida, né con nessun’altra delle nostre at-
tività.
■ La guida in stato di ebbrezza è
estremamente pericolosa ed è pu-
nita dalla legge: se il conducente
viene trovato con un tasso alcolemi-
co particolarmente alto può essere
punito con l’arresto fino a sei mesi
(reato penale). 13Area di competenza 3 Noi e il rispetto delle regole
È chiaro che la legge punisce severamente chi si mette alla guida di un veico-
lo sotto l’effetto di droghe: queste sostanze non solo sono capaci di inganna-
re i nostri sensi e stravolgere le nostre percezioni, ma possono anche indurci
a sottovalutare le situazioni di pericolo e a sopravvalutare le nostre capacità,
dandoci la falsa impressione di essere invulnerabili.
3. Consigli utili per la circolazione in condizioni sfavorevoli
Vi sono alcune situazioni di circolazione piuttosto difficili, in cui si deve gui-
dare con estrema cautela allo scopo di prevenire incidenti. Vediamone qual-
cuna.
Quando piove
In caso di pioggia vi sono maggiori rischi per i conducenti: l’aderenza degli
pneumatici è ridotta, c’è la possibilità di sbandare in curva, la visibilità è limi-
tata dall’appannamento o dalla condensa sui vetri. È necessario tener presen-
te che l’inizio di pioggia rende il fondo stradale scivoloso e non sottovalutare
il rischio dell’aquaplaning, che fa scivolare le ruote sullo strato d’acqua che,
in caso di acquazzoni, si interpone tra le ruote e l’asfalto.
Tale fenomeno, di per sé molto pericoloso, si verifica più di frequente nel
caso di veicoli leggeri, che «planano» più facilmente sullo strato d’acqua
compressa, ed è causato dall’insufficiente deflusso dell’acqua dagli intagli del
battistrada. Generalmente, perché si verifichi è necessario procedere a una
velocità piuttosto elevata ma, qualora i pneumatici siano consumati, l’effetto
aquaplaning può avvenire anche a velocità ridotta.
In caso di pioggia la situazione di pericolo è più alta per le «due ruote». Nel
percorrere tratti stradali parzialmente allagati, quindi, è necessario aumenta-
re la distanza di sicurezza, procedere a bassa velocità e frenare gradualmente,
senza «inchiodare» (frenare di colpo).
Di notte
Di notte, con scarsa illuminazione, bisogna sempre prestare molta attenzione
all’andatura, adattandola all’ambiente e alla situazione. Se si segue un altro vei-
colo, è necessario usare le luci anabbaglianti, evitando gli abbaglianti che po-
trebbero limitare la visibilità del conducente del veicolo che ci precede. Anche
incrociando pedoni o veicoli bisogna usare le luci anabbaglianti e stare molto
attenti agli ostacoli, ai pedoni o ai ciclisti che transitano sul margine destro: è
molto difficile individuare i pedoni vestiti di scuro.
I veicoli meno visibili sono le auto di colore scuro, le biciclette e i motocicli.
Le biciclette senza luci e senza catadiottri (rifrangenti) rap-
Catadiottri presentano un pericolo grave per la sicurezza stradale; i cicli-
Dispositivi di segnalazione di cui
devono essere dotati tutti i vei- sti devono tenere assolutamente in ordine il catadiottro ros-
coli. Servono a delimitare la sa- so posteriore e i catadiottri gialli dei pedali e il fanalino rosso
goma del veicolo al buio, poiché posteriore acceso.
riflettono la luce ricevuta. Anche per i pedoni che circolano di notte su strade poco il-
luminate è consigliabile rendersi più visibili, indossando abiti
chiari o munendosi di qualche dispositivo rifrangente (bracciale, cintura, tac-
chi).
14Percorso 1 • Cittadinanza e… educazione stradale
Il Codice della strada rende obbligatorio per i veicoli, anche di giorno, l’ac-
censione dei fari anabbaglianti e delle luci di posizione in autostrada. I ciclo-
motori e i motocicli devono tenerli, invece, costantemente accesi anche nei
centri abitati.
Incidenti stradali
Se, nonostante un comportamento attento e rispettoso delle norme di circo-
lazione, si rimane coinvolti in un incidente, è importante mantenere la calma
e osservare le seguenti regole.
Chiunque resti coinvolto in un incidente con soli danni ai veicoli deve
fermarsi, sgombrare la carreggiata per evitare intralci o successivi inciden-
ti, scambiare le generalità con la controparte (indirizzo, telefono, numero di
polizza assicurativa, marca e tipo di veicolo). È sempre meglio evitare litigi e
discussioni.
Se con l’incidente si sono verificati danni a persone, bisogna fermarsi e met-
tere in atto ogni misura possibile per prevenire il coinvolgimento di altri vei-
coli; inoltre è necessario evitare, nei limiti del possibile, che vengano mo-
dificate le tracce e rimosse le vetture, per permettere la ricostruzione della
dinamica dell’incidente e l’accertamento delle responsabilità.
Si deve chiamare immediatamente la polizia (113), se necessario anche i vi-
gili del fuoco (115) o i soccorsi sanitari (118) e prestare assistenza alle perso-
ne ferite. Non si devono mai spostare i feriti gravi.
Guida all’esposizione orale
• Che cosa si intende per “stato di ebbrezza”? In quali sanzioni incorre chi è sorpreso alla guida dopo
aver bevuto alcolici?
• Perché assumere droghe prima di mettersi alla guida, e in generale sempre, può essere estremamen-
te pericoloso?
• In quali casi è necessario guidare con estrema cautela per evitare incidenti?
• Nel caso si resti coinvolti in un incidente stradale, come bisogna comportarsi?
15SINTESI
1. Gli utenti della strada sono tenuti a rispettare una serie di regole che nel tempo sono
state disciplinate e raccolte nel Codice della strada.
In vigore dal 1° gennaio 1993, è costantemente aggiornato.
Nuovo Codice della strada Importanti novità sono state introdotte nel 2003:
(1992) • patentino per la guida dei ciclomotori
• patente a punti
Alcune norme per la circolazione stradale sono particolarmente importanti per la
sicurezza.
• Conoscere le dinamiche di arresto del veicolo
• Mantenere la distanza di sicurezza
Le regole della sicurezza • Rispettare le regole della precedenza
• Conoscere i principali segnali stradali
• Utilizzare sempre i dispositivi di sicurezza
2. Comportamenti che vanno evitati da chi si mette alla guida di un mezzo perché
estremamente pericolosi e puniti dalla legge:
Guida in stato di ebbrezza (reato
Assunzione di alcol penale se il tasso alcolemico è
particolarmente alto)
Le stragi del sabato sera
Produzione, consumo e vendita
Assunzione di droghe di sostanze stupefacenti sono
vietati e severamente puniti
3. Alcune situazioni che rendono la strada particolarmente pericolosa sono:
Pioggia procedere a bassa velocità, aumentare la distanza di sicurezza,
(aquaplaning) frenare gradualmente
Buio usare luci anabaglianti (auto), catadiottri (biciclette), dispositivi
(scarsa visibilità) rifrangenti (pedoni)
Verificarsi di sgombrare subito la strada, chiamare i soccorsi (113: polizia; 115:
incidenti stradali vigili del fuoco; 118: ambulanza)
16AGORÀ DELLE CONOSCENZE
1. Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false e riscrivi in modo corretto quelle false.
V F
a. Le regole del Codice della strada valgono esclusivamente per coloro che guidano
mezzi a motore.
b. Il Nuovo Codice della strada è stato approvato nel 1992.
c. Nelle strade a senso unico il pedone deve camminare sul lato sinistro.
d. Nelle strade a doppio senso è più prudente camminare sul lato sinistro della strada.
e. Sulle biciclette è vietato circolare portando un’altra persona, ad eccezione dei
bambini di 8 anni trasportati dai genitori in appositi seggiolini.
f. I catarifrangenti possono essere utilizzati per rendere più visibili biciclette o motorini
quando non c’è luce.
g. Per i minori di 18 anni e i neopatentati vige il divieto assoluto di assumere alcol
quando ci si mette alla guida.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Fornisci una definizione per ciascuna delle seguenti espressioni.
..............................................................................................................
Spazio d’arresto ..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
Distanza di sicurezza ..............................................................................................................
..............................................................................................................
3. Riassumi le principali regole relative alla precedenza.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
17
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………SINTESI
1. La criminalità organizzata è un fenomeno molto diffuso in Italia, in particolare:
Struttura piramidale, fortemente
gerarchizzata: soldati o uomini
In Sicilia: “cosa nostra”
d’onore (famiglia), vertice di
comando (cupola)
Insieme di bande che si Gli affari illeciti svolti
compongono e scompongono, dalle mafie coinvolgono
In Campania: camorra
suddividendosi il dominio del l’intero territorio
territorio nazionale
Struttura orizzontale: ciascuna
In Calabria: ’ndrangheta famiglia ha il monopolio del
territorio su cui opera
2. Le attività delle mafie si possono distinguere in:
Affari tradizionali Estorsione (o racket), usura, traffico e spaccio di stupefacenti
Ecomafia: traffico dei rifiuti, abusivismo edilizio, infiltrazioni
Nuova mafia “imprenditrice” nella filiera alimentare, tratta degli animali, commercio di
reperti artistici e archeologici
3. La nuova “mafia imprenditrice” è attiva in numerosi ambiti.
Infiltrazioni nella filiera Le attività illegali si concentrano sulle contraffazioni dei marchi
agroalimentare e sulla falsificazione dei prodotti alimentari made in Italy
Zoomafia: competizioni clandestine tra cavalli, combattimenti
Tratta degli animali tra cani, traffico di fauna esotica o protetta, bracconaggio,
allevamenti illegali, macellazione clandestina, pesca di frodo ecc.
18AGORÀ DELLE COMPETENZE VERSO LA PROVA INVALSI
IL LETTORE COMPETENTE
Leggi il seguente testo, poi rispondi alle domande.
Un obiettivo ambizioso: il Piano Nazionale per la
Sicurezza Stradale (PNSS) – Orizzonte 2020
Rispetto ai risultati ottenuti dagli altri Stati membri della EU27 nel periodo 2001-2010, l’Italia è in
linea con la riduzione percentuale media europea del numero di morti su strada. In questo periodo
l’Italia ha altresì ridotto il tasso di mortalità del 46%, portandolo da 125 a 68 morti per milione di
abitanti, raggiungendo i livelli che Olanda, Svezia e Regno Unito avevano all’inizio del decennio.
5 L’Italia contribuirà al raggiungimento del target europeo fissando come obiettivo generale la
riduzione del 50% del numero dei decessi sulle strade entro il 2020, rispetto al totale dei decessi
registrato nel 2010. Di conseguenza, per raggiungere l’obiettivo prefissato, il numero di morti sulle
strade in Italia nel 2020 dovrà essere non superiore a 2.045 decessi.
È un obiettivo ambizioso, non facile da raggiungere, poiché migliore è il livello di sicurezza raggiunto,
10 maggiore è lo sforzo necessario per migliorarlo ulteriormente. Misure di vasta scala, di rapida
realizzazione ed efficacia, quali la Patente a punti, non sono facilmente replicabili. È richiesto
quindi uno sforzo in più, e questo Piano rappresenta un passo importante in tale direzione, per
individuare misure efficaci che permettano di agire su problemi specifici, destinando a ciò un
adeguato impegno di risorse che possono essere quantificate in prima ipotesi nella misura almeno
15 pari a quella resa disponibile nel precedente decennio.
Con tale target l’Italia contribuirà attivamente anche al raggiungimento dell’obiettivo stabilito al
2020 dall’ONU, relativo alla stabilizzazione e riduzione del livello previsto di morti sulle strade nel
mondo.
Con il conseguimento del dimezzamento delle vittime, l’Italia raggiungerebbe livelli di sicurezza
20 prossimi a quelli attualmente presenti nei Paesi più performanti in Europa (e anche nel Mondo),
quali Svezia, Regno Unito e Olanda. Il tasso di mortalità stimato sarà, infatti, pari a circa 33 morti
per milione di abitanti.
Oltre l’obiettivo generale di riduzione dei decessi, un obiettivo strategico molto importante è quello
di ridurre il numero di feriti sulle strade e la gravità dei ferimenti. Per stabilire un tale obiettivo, sono
25 necessari indicatori affidabili, diversificati per livelli di riferimento.
Sebbene negli Orientamenti della Commissione Europea sia espressa la volontà di definire un
obiettivo comune europeo anche sulla riduzione del numero di feriti, in particolare sul numero di
feriti “gravi”, allo stato attuale non esiste ancora in Europa una definizione comune di ferito “grave”
e di ferito “lieve”. La Commissione Europea sta procedendo in questa direzione con il fine di
30 arrivare a fissare un obiettivo di riduzione anche per il numero di feriti.
L’Italia, che sta collaborando ai lavori della Commissione Europea, sarà pronta ad uniformarsi alle
definizioni che saranno adottate a livello europeo, e ad aggiungere all’obiettivo generale sul numero
di decessi anche un obiettivo sul numero di feriti, conforme a quanto sarà stabilito dalla CE.
19AGORÀ DELLE
Area di competenza 3 Noi e il rispetto delle regole COMPETENZE
Variazione percentuale del numero di decessi su strada tra il 2001 e il 2010. (Fonte: Database Care, 2011)
(Testo tratto da PNSS Orizzonte 2020)
1 | A quale “obiettivo” fa riferimento il titolo?
A) Raggiungere il target di Olanda, Svezia e Regno Unito
B) Non superare i 2045 decessi nel 2020
C) Ridurre il numero dei decessi sulle strade entro il 2020
D) Ridurre il tasso di mortalità sulle strade del 46%
2 | Secondo quanto affermato nel testo, nel 2010 Olanda, Svezia e Regno Unito:
A) avevano già ridotto il tasso di mortalità sulle strade del 46%
B) avevano ridotto il tasso di mortalità sulle strade del 50%
C) registravano 125 morti su strada per milione di abitanti
D) registravano meno di 2045 decessi su strada all’anno
3 | Il termine “performanti” alla riga 20 significa:
A) avanzati
B) veloci
C) efficienti
D) civili
4 | Alle righe 24-25 si legge: “Per stabilire un tale obiettivo, sono necessari indicatori affidabili,
diversificati per livelli di riferimento”. A che cosa si riferisce l’espressione “tale obiettivo”?
Scrivilo.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
20AGORÀ DELLE
COMPETENZE Percorso 1 • Cittadinanza e… educazione stradale
5 | Secondo quanto riportato nel testo, la Commissione europea è al lavoro per varare un
nuovo programma relativo:
A) alla riduzione delle morti sulle strade per il decennio 2020-2030
B) alla riduzione dei feriti sulle strade
C) al dimezzamento dei feriti “gravi” sulle strade
D) alla definizione di ferito “lieve” e ferito “grave” sulle strade
6 | Sulla base di quanto affermato nel testo, stabilisci se le seguenti affermazioni sono vere o
false.
V F
a. L’Italia ha rispettato il target europeo nel decennio 2001-2010
b. La Patente a punti è una misura la cui efficacia può eventualmente replicarsi
c. Anche l’ONU ha varato un programma per la riduzione dei morti sulle strade
d. Se l’Italia dimezzasse ancora il numero di morti entro il 2020 raggiungerebbe i
livelli che attualmente hanno Olanda, Svezia e Regno Unito
7 | Leggendo i dati del grafico che correda il testo, che cosa è possibile affermare e che cosa
no?
Sì No
a. Il Paese in cui la variazione percentuale del numero dei decessi è maggiore è la
Romania
b. In Lituania e in Polonia la variazione percentuale del numero dei decessi è
pressoché uguale
c. Il Paese più performante risulta essere il Portogallo
d. L’Europa non è riuscita a dimezzare le morti su strada
e. In Italia e in Austria la variazione percentuale del numero di decessi su strada è
uguale
8 | Il grafico che correda il testo, rispetto alla comprensione dello stesso, è:
A) necessario
B) utile
C) accessorio
D) indispensabile
9 | Quale scopo si prefigge il testo?
A) Convincere il lettore ad avere comportamenti corretti in strada
B) Informare sulle politiche dell’Ue e dell’Italia per ridurre la percentuale dei decessi sulle
strade
C) Denunciare l’alta percentuale di decessi sulle strade in Italia
D) Divulgare il raggiungimento da parte dell’Italia del target europeo per il 2020
21Puoi anche leggere