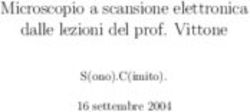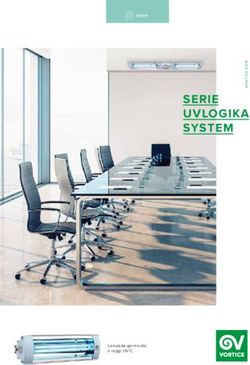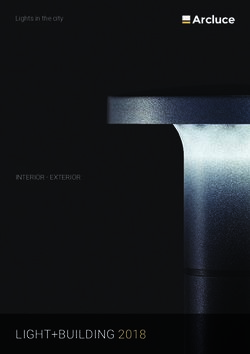AstRonomiA X Quale futuro ?
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Astrofisica
Astronomia X
Quale futuro ?
S
Cinquant’anni fa i celebra quest’anno il mezzo se- cosmiche più grandi con il loro contenuto
Riccardo Giacconi colo dalla nascita dell’astronomia dominante di materia oscura, e ai buchi
X (vedi l’articolo di Tommaso neri super massicci più distanti formatisi
(Premio Nobel 2002) Maccacaro, “le Stelle” n. 103, per una ri- solo un miliardo di anni dopo il Big Bang.
avviava l’osservazione costruzione storica). In tutti questi anni i C’è però anche un motivo fisico che ren-
progressi della strumentazione, al pari di de le osservazioni X così indispensabili.
del cielo nei raggi X. quelli scientifici che ne sono derivati, sono Mentre la luminosità del cielo visibile è
Dalle galassie attive stati prodigiosi. Dal primo esperimento dovuta in gran parte alla fusione nuclea-
ai buchi neri alla pionieristico condotto dal team di Riccar- re che alimenta stelle e galassie, il cielo a
do Giacconi nel giugno 1962, quando con raggi X trova la sua fonte di energia prin-
cosmologia, fu l’inizio un breve volo al di sopra dell’atmosfera di cipalmente nella gravità. Dalle binarie-X,
di una rivoluzione. un razzo con a bordo un piccolo contatore come Sco X-1, ai nuclei galattici attivi
Geiger si scoprì la prima sorgente extra- (noti con l’acronimo di AGN) – tra cui i
Qualche ombra sui galattica (Sco X-1), alle osservazioni più quasar – che costituiscono la maggioranza
nuovi progetti profonde del satellite Chandra condotte delle sorgenti nel cielo X al di fuori del-
di ricerca nel 2002 e che continuano tuttora, l’au- la Galassia, è il rapido accrescimento di
mento in sensibilità è stato di 10 ordini massa intorno al buco nero centrale (o alla
di grandezza. Ossia in soli 40 anni, le stella di neutroni, nel caso delle binarie)
osservazioni X hanno progredito di più che porta il gas ad orbitare a velocità re-
di quanto abbiano fatto le osservazioni lativistiche e a riscaldarsi a temperature
ottiche in 400 anni, passando dall’occhio tali da emettere radiazione X. In questo
nudo, al primo telescopio di Galileo, fino processo viene emessa radiazione anche in
all’Hubble Space Telescope (un salto di altre regioni dello spettro elettromagneti-
circa 24 magnitudini, corrispondente a co, ma è la radiazione X, particolarmente
sorgenti 4 miliardi di volte più deboli). quella dura, che può penetrare più delle al-
Questi progressi sono avvenuti sopratut- tre tutti gli strati di gas e polvere, e quindi
to nella banda “soft” dei raggi X (0,5-10 consente di esplorare le regioni più interne
keV), ma la tecnologia sta facendo passi vicino al buco nero. Questa conversione di
importanti anche nella banda X più dura energia gravitazionale in radiazione di alte
(fino a 80 keV, il range energetico dei rag- energie attraverso il processo di accresci-
gi X per la diagnostica medica). mento (con la formazione in alcuni casi
Non stupisce quindi se le osservazioni X anche di jet relativistici) è il meccanismo
hanno tanto contribuito in questi anni allo più efficiente che la natura ci offre per
sviluppo di molti campi dell’astrofisica e estrarre il contenuto energetico interno
della cosmologia. Dall’astrofisica stella- di una certa massa di materia (dato dalla
Piero Rosati re, con una capacità unica di rilevare la famosa formula E = Mc2), più efficiente
Nato a Roma nel 1963, ha lavorato con presenza e la natura di oggetti compatti, perfino del processo di fusione nucleare
Riccardo Giacconi alla Johns Hopkins come stelle di neutroni e buchi neri, non- dell’idrogeno. La scoperta che quasi tutte
University (Baltimore) ed è astronomo ché di misurare l’abbondanza dei vari me- (o forse tutte) le galassie (inclusa la nostra)
all’Osservatorio australe europeo, talli spazzati via dalle esplosioni di super- ospitano al loro interno un buco nero con
sede di Garching. novae, fino alla formazione delle strutture una massa che va da milioni fino a miliardi
50 • Le Stelle n. 111 • Ottobre 2012Astrofisica
di volte quella solare, che finisce per gio-
care un ruolo fondamentale nella forma- A Milano il futuro X
zione ed evoluzione delle galassie stesse, con il Nobel Giacconi
ha reso le osservazioni nella banda X parte
integrante dell’analisi multi-frequenza Convegno internazionale dal 1° al 5 ottobre
(radio, infrarosso, ottico, UV, fino ai raggi
Dal 1° al 5 ottobre, a Milano, con l’intervento del premio Nobel 2002 per la fisica Riccardo
gamma) ormai necessaria per decodificare
Giacconi, un congresso internazionale farà il punto sull’astronomia in raggi X a cinquant’an-
i segnali dell’universo. ni dalla sua nascita. Intitolato “X-ray Astronomy: towards the next 50 years!” e ospitato presso
Un’altra classe importante di sorgenti X è il Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci (via San Vittore 21), il
costituita dagli ammassi e gruppi di galas- convegno riunirà scienziati provenienti da tutto il mondo, dai pionieri dell’astronomia X sino
sie (che sono circa il 5% delle sorgenti X ai più giovani ricercatori. Non si discuteranno solo i risultati più recenti, ma si cercherà di
extragalattiche nella banda “soft”), la cui capire quali sono le migliori strategie tecnico-scientifiche da adottare nei prossimi decenni,
emissione X è anche il risultato della con- anche tenendo conto delle difficoltà di finanziamento emerse negli ultimi tempi. Tra i temi in
versione di energia gravitazionale. In que- discussione, pulsar, magnetar e resti di supernove, sistemi di stelle doppie con emissione in
raggi X, sorgenti ultraluminose, nuclei galattici attivi, fondo cosmico di raggi X duri, ammassi
sto caso, il gas intergalattico (in gran parte di galassie in raggi X, future missioni spaziali. Riccardo Giacconi parteciperà con la propria
idrogeno arricchito di elementi pesanti testimonianza alla sessione storica in programma nel pomeriggio di mercoledì 3 ottobre.
espulsi dalle supernovae), intrappolato L’incontro sarà aperto al pubblico.
nelle gigantesche buche di potenziale gra- Nel quadro delle celebrazioni del cinquantenario, a Milano dal 12 settembre è in corso la
vitazionale di questi sistemi, finisce pre- mostra “X l’Universo Invisibile”, percorso tra astronomia e arte presso l’ex - Chiesa di San
sto per raggiungere temperature di 1-10 Carpoforo, Via Marco Formentini 12.
milioni di gradi e quindi emettere raggi Altre informazioni: http://www.brera.inaf.it/xrayastronomy_anniversary/
X soffici sotto i 10 keV. Gli ammassi più
massicci (fino a 3-4 volte quello di Coma)
sono i più caldi, e al pari degli AGN e centrando i fotoni X su pochi secondi nomia X? I segnali degli ultimi anni non
quasar, costituiscono le sorgenti X più lu- d’arco permette di abbattere il rumore di sono incoraggianti. Dal lato scientifico
minose, rilevabili quindi fino a distanze fondo ed evitare la confusione tra ogget- gli stimoli non mancano. Le nuove do-
cosmologiche. ti vicini, permettendo così di fare lunghe mande aperte dalle scoperte degli ultimi
Non c’è dubbio che il grande balzo in esposizioni rivelando via via sorgenti più decenni sono molte e fondamentali, e ri-
avanti in questi 50 anni avvenne quando il deboli. In questo modo, gli specchi di chiederebbero telescopi più sensibili che
satellite Einstein (lanciato nel 1978 sotto Einstein permisero di scovare sorgenti possano esplorare vaste aree di cielo molto
la guida di Giacconi) portò nello spazio 100 volte più deboli di quelle trovate dalle più rapidamente. Per esempio, vediamo
per la prima volta un vero telescopio a missioni precedenti. gli effetti della presenza di buchi neri al
raggi X in grado di concentrare la radia- Nelle missioni successive anche l’area col- centro delle galassie sulla loro struttura e
zione soffice con la tecnica degli specchi lettrice degli specchi è aumentata (di più sulla formazione stellare, ma non abbia-
a incidenza radente. Questi sono di fatto di 10 volte) e i rivelatori CCD più sensi- mo ancora capito i meccanismi fisici che
una serie di fogli cilindrici concentrici, di bili hanno preso il posto dei contatori pro- determinano questa interazione. Le osser-
materiale metallico o ceramico, coperti da porzionali (come negli attuali osservatori vazioni X di ammassi di galassie fino ad
uno strato di oro o iridio, in grado di riflet- Chandra ed XMM-Newton che operano oggi hanno contribuito in modo significa-
tere la radiazioni X soffice, quando questa da poco più di 10 anni). Si è arrivati così tivo alla rivelazione della materia oscura, e
incide con angoli di 1-2 gradi. (Fig.1). ad aumentare la sensibilità di un altro fat- hanno confermato la presenza dominante
Prima di allora, l’informazione spaziale tore 100, e addirittura fino a 1000 nelle più di un’energia oscura nell’universo, ma non
da rilevatori X veniva ricostruita con la lunghe esposizione di Chandra. Il cam- sappiamo quasi nulla sulla natura fisica di
tecnica delle maschere codificate (con lo po X più profondo osservato fino ad ora queste componenti oscure.
stesso concetto della fotografia pinhole), è il cosiddetto Chandra Deep Field South, Ciò nonostante, il successore degli osser-
con risoluzioni non migliori di 10 minuti (Fig.2) un progetto avviato da Riccardo vatori Chandra o XMM/Newton è anco-
d’arco o dell’ordine del grado nella banda Giacconi proprio negli anni in cui ottenne ra in una fase preliminare di definizione
X dura. La concentrazione di raggi X per- il Nobel (2002) per i suoi studi pionieristi- del progetto e ben lontano dalla fase di
mise di ottenere vere e proprie immagini, ci. Tale campo è diventato ad oggi la zona costruzione. Un ruolo cruciale in questo
con risoluzioni angolari inizialmente mi- di cielo di gran lunga più esplorata da tutti ritardo l’hanno avuto i pesanti tagli di
gliori di 1 arcmin, che sono migliorate con gli osservatori sia da terra che dallo spazio, bilancio della Nasa degli ultimi 5 anni e,
le missioni successive fino a raggiungere a tutte le lunghezze d’onda. nello stesso tempo, la crescente compe-
0,5 arcsec con l’osservatorio Chandra, cioè tizione con altri progetti spaziali, alcuni
la nitidezza delle migliori osservazioni ot- Guardando avanti dei quali rivelatisi molto costosi, come il
tiche da terra. I prossimi decenni saranno ugualmente successore di Hubble, il James Webb Space
La possibilità di produrre immagini con- ricchi di successi e sorprese per l’astro- Telescope.
Le Stelle n. 111 • Ottobre 2012 • 51Astrofisica
glioramento della risoluzione angolare per
poter sfruttare il conseguente aumento di
capacità di rivelare oggetti più deboli e
fare spettroscopia di zone vicine in ogget-
ti estesi (resti di supernovae, ammassi di
galassie), senza esser limitati dall’effetto di
“confusione”. In caso contrario, il rapporto
costi/benefici non è vantaggioso.
Nella banda ottica (da terra) lo sviluppo
delle ottiche attive, cioè la capacità di con-
trollare la forma di grandi specchi sottili
per tenere le ottiche sempre a fuoco mi-
nimizzando aberrazioni di varia natura, è
stato alla base del successo dei telescopi di
8 m come il VLT. Allo stesso modo, si è
investito molto in questi anni nella tec-
nologia delle ottiche “adattive” in grado di
compensare in tempo reale gli effetti della
turbolenza atmosferica (seeing), avvici-
nandosi così al limite di diffrazione. Tale
tecnologia sarà essenziale per i telescopi
giganti (30-40 m) di prossima generazio-
ne: solo in questo modo si potrà sfruttare
tutta la loro potenza.
Per gli specchi a raggi X a incidenza ra-
dente, la nitidezza delle immagini è legata
principalmente alla capacità di controllare
la forma e l’allineamento dei fogli cilindri-
ci inseriti uno dentro l’altro e di renderli
La prima osservazione Chandra con posa di un milione di secondi del campo noto come Chandra Deep perfettamente lisci (polishing). Per mi-
Field South, ottenuta nel 2001 e divenuta un riferimento per studi a tutte le lunghezze d’onda con gliorare la loro rigidità si può aumentare
osservatori spaziali e a terra. Recentemente l’esposizione è stata portata a 4 volte tanto, equivalente ad lo spessore (gli specchi di Chandra sono
un mese e mezzo di osservazione. I colori delle sorgenti riflettono l’energia dell’emissione X: quelle più di vetro da 2 cm), a scapito però del peso
blu emettono raggi X più energetici, quelle rosse meno energetici. Il lato dell’immagine è pari a circa un complessivo che è un elemento determi-
terzo di grado. nante per i costi di lancio. Quindi per au-
mentare l’area collettrice, se da una parte
Inizialmente, Nasa ed Esa avevano deci- passaggio dalla fase di progettazione alla questi specchi devono essere sempre più
so di unire le loro forze nella costruzio- fase di costruzione, ATHENA ha subito grandi e numerosi, dall’altra devono essere
ne dell’International X-ray Observatory uno stop. Sarà invece la missione planeta- sempre più sottili.
(IXO), che doveva aumentare l’area collet- ria JUICE (JUpiter ICy moons Explorer) a Le immagini ad alta definizione di Chan-
trice di circa 10 volte permettendo studi essere lanciata nel 2022 alla volta di Giove dra, con il loro alto contenuto scientifi-
di spettroscopia X senza precedenti. Pre- (arrivo previsto nel 2030) per uno studio co e la loro stessa bellezza, sono state di
occupata per i costi (ben oltre il milardo di ravvicinato dei suoi satelliti. fatto una rivoluzione. Ma in mancanza
dollari) e avendo dato la priorità ad altre Stando così le cose, non ci sarà un altro os- di nuove tecnologie, non si riuscirà mai a
missioni, la Nasa è uscita dalla collabo- servatorio X di grandi dimensioni prima realizzare un telescopio molto più grande
razione internazionale nel 2010. L’Esa e del 2025. Oltre che in questioni di budget, di Chandra e con la stessa risoluzione. Tale
un consorzio comprendente molti istituti c’è da dire che il motivo di tali difficoltà compromesso ha limitato per esempio la
europei hanno portato avanti il progetto va anche ricercato nel modesto progresso risoluzione angolare di IXO (non migliore
con una versione ridimensionata del te- tecnologico degli specchi X degli ultimi di 5 arcsec), con conseguenti limitazioni
lescopio, chiamato ATHENA (Advanced due decenni, che non è stato pari a quello alle sue prestazioni scientifiche. Per questi
Telescope for High-ENergy Astrophysics), realizzato per altre bande, in particolare motivi di recente si è iniziato a studiare
nell’ambito delle missioni “large-class” quella ottica. come controllare in modo “attivo” anche
del programma Cosmic vision 2015-2025 In generale, un aumento dell’area col- specchi X correggendone la forma duran-
dell’Esa. Lo scorso maggio, però, in com- lettrice di un telescopio X (ma anche te il funzionamento (progetto SMART-X
petizione con altre due missioni per il nell’ottico) va accompagnato da un mi- americano).
52 • Le Stelle n. 111 • Ottobre 2012Astrofisica
In attesa di tali sviluppi, per fortuna ci do sono relativamente modeste, ASTRO- Sloan Digital Sky Survey (SDSS) nell’ot-
sono varie missioni di piccole dimensioni H porterà una serie di nuovi rivelatori tico ha fatto scuola, dimostrando tutta la
che terranno viva l’astronomia X nei pros- sensibili dai raggi X fino ai raggi gamma potenzialità delle survey nel gettare luce su
simi 10-15 anni. Prima fra tutte, nuSTAR (600 keV), con la capacità unica di fare problemi fondamentali, come la presenza
(NUclear Spectroscopy Telescope ARray), una osservazioni a raggi X con un’alta risolu- di energia oscura dalla distribuzione tri-
delle missioni Nasa della categoria small zione spettrale (o energetica) con la tecni- dimensionale di galassie nell’universo vi-
explorer (con costi dell’ordine di 100 mi- ca dei “microcalorimetri”. Ciò permetterà cino. La produzione scientifica (misurata
lioni di dollari) appena lanciata, che per di ricostruire la geometria e la cinematica in numero di pubblicazioni e in ampiezza
la prima volta produrrà immagini nella dei dischi di accrescimento interni degli del loro impatto) della SDSS ha supera-
banda X dura, fino ad 80 keV. Questo è AGN, osservando le deformazioni del- to perfino quella del telescopio Hubble e
stato possibile quando si è scoperto che le righe di emissione del ferro altamente dei migliori telescopi a terra. Utilizzando
applicando sugli specchi una serie di stra- ionizzato dovute all’effetto Doppler del- rivelatori sempre più grandi, nei prossimi
ti sottilissimi di diversi materiali (tecnica la materia in rotazione intorno a buchi 10 anni si stanno preparando survey anco-
multi-layer) si riesce a riflettere radiazione neri massicci. Le velocità sono così alte e ra più potenti dall’ottico e dal vicino infra-
X di alta energia che incide a piccoli ango- i campi gravitazionali così forti in questi rosso fino al radio.
li. In questo modo, con una risoluzione di casi che le osservazioni costituiscono un E nei raggi X? Anche in questo campo si
circa 45 arcsec (rispetto ai 12 minuti d’ar- test importante della relatività generale è rimasti un po’ indietro. L’ultima survey
co della missione Esa Integral), nuSTAR di Einstein. Inoltre si potranno studiare i di tutto il cielo è stata quella del satellite
troverà sorgenti 100 volte più deboli e po- moti interni del gas caldo negli ammassi ROSAT negli anni ’90, la prima ad essere
trebbe rivelarsi rivoluzionario. di galassie vicini e misurare con grande realizzata con specchi X, sensibile solo a
Si potranno scoprire buchi neri super accuratezza la composizione chimica dei basse energie (fino a 2 keV). Una nuo-
massicci particolarmente oscurati che plasmi nei resti di supernovae, gli eventi va missione tedesco-russa, eROSITA, è
sono sfuggiti anche a Chandra ed XMM/ dove vengono sintetizzati tutti gli elemen- in una fase avanzata di costruzione, con
Newton, che sono ciechi ad energie sopra i ti più pesanti dell’elio. lancio previsto nel 2014. Traccerà una
10 keV, risolvendo forse definitivamente il Anche a capacità di ASTRO-H di fare mappa di tutto il cielo nella banda X soft
problema della natura del fondo cosmico osservazioni su una vasta banda energeti- (fino a 7 keV), con una sensibilità 100
a raggi X. Questo, scoperto nel primo volo ca è molto importante, come dimostrato volte migliore di quella di ROSAT. La
del 1962 come un misterioso rumore di dal satellite italo-olandese Beppo-SAX scoperta di milioni di AGN e circa 50
fondo, è stato via via risolto in singole sor- (1996-2002), che per primo, grazie a que- 000 ammassi di galassie è assicurata. La
genti nella banda X soft man mano che la sta caratteristica, riuscì a identificare un combinazione di questi dati con quelli di
risoluzione angolare migliorava, come di- gran numero di lampi gamma e a svelare altre survey, per esempio nell’ottico e nel
mostrato dalle osservazioni più profonde la loro natura extra-galattica. ASTRO-H vicino infrarosso, moltiplicherà il valo-
di Chandra e XMM. Ma si è presto com- sarà in grado di produrre immagini fino re scientifico di tale missione e sarà una
preso che il grosso dell’energia di questo a 80 keV, come nuSTAR; ad energie più risorsa per molti anni. La sua principale
fondo, dovuto all’emissione integrata di alte, nella banda gamma, la radiazione ad limitazione è costituita dalla modesta ri-
tutti gli AGN dell’universo, rimane oscu- incidenza radente non viene più riflessa da soluzione angolare (circa 25 arcsec contro
rata nella banda soft e può emergere solo a alcun materiale. Ciò nonostante, da diversi i 60 di ROSAT). Il motivo è che eROSI-
energie superiori, intorno a 30 keV, dove è anni si sta studiando come fuocheggiare TA ha adottato il disegno classico degli
sensibile nuSTAR. i raggi gamma sfruttando la loro diffra- specchi X, per cui la risoluzione angola-
C’è poi molta attesa per le immagini che zione da parte della struttura cristallina di re è massima al centro dell’immagine
nuSTAR produrrà del centro galattico, che, diversi materiali, con primi risultati molto ma si deteriora rapidamente verso i bordi
come suggerito da mappe a bassa risolu- promettenti (lenti di Laue). La capacità del campo: un disegno non ottimizza-
zione ottenute da Integral nel 2005, con- di produrre immagini nella banda gamma to per survey di grandi aree di cielo. Per
tiene diverse sorgenti ad alta energia, oltre aprirebbe una nuova finestra sui fenomeni aggirare queste limitazioni, 20 anni fa
ad ospitare un buco nero di circa 4 milioni di alta energia nell’universo. Giacconi e i suoi collaboratori propose-
di masse solari. I primi risultati potranno Gli osservatori citati finora sono proget- ro per la forma degli specchi un disegno
arrivare già entro in 2012. tati per eseguire osservazioni puntate su alternativo che garantisce una risoluzione
L’agenzia spaziale giapponese Jaxa, dopo piccole regioni di cielo. Ma un ruolo im- costante di ~5 arcsec su un campo di vista
il successo del satellite ASCA negli anni portante in astronomia l’hanno sempre di 1°. Tale disegno è l’analogo a raggi X
’90, sta preparando, con lancio previsto nel avuto le survey di tutto il cielo, o grandi del telescopio Schmidt utilizzato per le
2014, una nuova missione: il satellite de- porzioni di esso. In questo modo, si fa un prime survey fotografiche di tutto il cie-
nominato ASTRO-H, il successore del sa- censimento completo delle varie classi di lo, in grado di coprirne con rapidità ed in
tellite Suzaku (lanciato nel 2005 e tuttora sorgenti e si esplorano grandi volumi di profondità grandi regioni. La tecnologia
in funzione). Anche se l’area collettrice e universo, svelando gli oggetti più rari e per la costruzione di questi specchi X a
la risoluzione angolare dei telescopi a bor- straordinari. In quest’ultimo decennio la largo campo è stata sviluppata interamen-
Le Stelle n. 111 • Ottobre 2012 • 53Astrofisica
te in Italia e la sua fattibilità dimostrata SITA si colloca bene a fare da ponte tra siche della materia in oggetti compatti o in
in diversi test. Purtroppo, però, questa ROSAT ed una tale survey di prossima prossimità di buchi neri, in condizioni di
macchina per survey, una collaborazione generazione. gravità estreme. Il satellite LOFT (Large
Italia-Usa denominata Wide Field X-ray Per finire, non vanno dimenticate le mis- Observatory For X-ray Timing), allo studio
Telescope (WFXT), ancora non è riusci- sioni specializzate per studiare la variabilità dell’Esa per un possibile lancio prima del
ta a trovare i finanziamenti necessari per temporale di sorgenti X, che sono un mez- 2025, permetterà di fare un grande salto in
la sua costruzione. In attesa di ciò, eRO- zo essenziale per esplorare le condizioni fi- avanti in questi studi.
Giacconi, padre dell’astronomia X
Riccardo Giacconi ricevette il premio Nobel per la fisica nel 2002 con l’americano Raymond Davis e il giapponese Masatoshi Koshiba. I tre
premiati, lavorando indipendentemente, hanno aperto due nuove finestre sull’universo, svelandone aspetti inediti: la finestra della radiazione X
e la finestra dei neutrini. La prima ci dà informazioni su alcuni dei fenomeni astronomici più violenti; la seconda ci rivela come funzionano le
reazioni termonucleari che avvengono nel nucleo del Sole e come avvengono i collassi delle supernove, cioè delle stelle molto massicce che
giungono al termine della loro esistenza.
Nel 2002 erano passati 18 anni dal precedente Nobel italiano per la fisica, ottenuto da Carlo Rubbia per la scoperta delle particelle W e Z.
Ufficialmente dal 1977 Riccardo Giacconi è cittadino americano, ma è nato a Genova il 6 ottobre 1931, si è laureato in fisica a Milano nel 1954
e ha poi mantenuto con l’Italia rapporti stretti e continui. E’ vero però che una borsa di studio lo portò negli Stati Uniti già nel 1956, e che da
allora quasi tutto il suo lavoro scientifico si è svolto aldilà dell’Atlantico.
Anni fa qualche giornalista parlò di Riccardo Giacconi come del “nuovo Galileo”. Il confronto è azzardato, eppure c’è qualcosa di vero. Come
Galileo perfezionò il cannocchiale inventato da un olandese e poi ebbe l’idea di usarlo per esplorare il cielo, così Giacconi, nella prima parte
della sua carriera scientifica, ha perfezionato lo speciale telescopio necessario per vedere gli astri che emettono radiazioni invisibili. Poi, in
piena maturità, è tornato alla luce visibile con gli strumenti più avanzati che esistano: ha diretto il telescopio spaziale «Hubble», lanciato dalla
Nasa nel 1990, tuttora il più grande telescopio in orbita e, dal 1993 al 1999, l’Osservatorio Australe Europeo (Eso), che ha i suoi strumenti sulle
Ande del Cile il maggior telescopio al suolo, il VLT, quattro specchi dal diametro di 8,2 metri equivalenti a un telescopio unico da 16 metri, con
una superficie di raccolta della luce di 210 metri quadrati.
Con Bruno Rossi, suo maestro e ispiratore, Giacconi è stato lo scopritore del
cosmo nei raggi X, la «finestra» che ci permette di studiare stelle di neutroni,
buchi neri, galassie attive. La prima osservazione risale al 1962. Con un
rudimentale rivelatore a bordo di un razzo americano, Giacconi trovò una
sorgente X nella costellazione dello Scorpione. «E’ stata una grande gioia -
racconta - ma anche una grossa sorpresa, perché allora non pensavamo as-
solutamente che esistessero sorgenti cosmiche in cui la radiazione X fosse
tanto forte. Il Sole emette in raggi X una parte infinitesima di energia, il resto
è luce visibile o infrarossa. Invece nello Scorpione trovammo un oggetto la
cui emissione X era mille volte maggiore di quella luminosa».
Giacconi si è laureato in fisica a Milano nel 1954 alla scuola di Giuseppe
Occhialini, un pioniere delle ricerche sui raggi cosmici: per inciso, un pre-
mio Nobel rubato all’Italia, perché Occhialini con Blackett e poi con F. Powell
mise a punto le tecniche per l’osservazione dei raggi cosmici che portarono
alla scoperta dei muoni e dei pioni, ma il premio andò poi soltanto a Bla-
ckett e a Powell. Nel 1956 Giacconi si trasferì negli Stati Uniti all’Università
dell’Indiana. In America nel 1959 Bruno Rossi, come Occhialini specializ-
zato nello studio dei raggi cosmici, già collaboratore di Fermi al progetto
della prima bomba atomica, suggerì a Giacconi di tentare l’osservazione
del cielo nei raggi X avvalendosi di uno speciale telescopio a incidenza
radente da installare su un satellite artificiale (il primo, lo Sputnik russo,
era stato lanciato nel ’57). Ma a Rossi e Giacconi bastò il lancio di un razzo
per individuare la prima sorgente cosmica in raggi X: appunto Scorpius X-1.
Le ricerche andarono avanti prima con piccoli satelliti come Uhuru (1970),
lanciato sotto la guida di Luigi Broglio dalla base italiana San Marco in
Kenya, poi con il grosso satellite Einstein, messo in orbita nel 1978, diretto
da Giacconi. Da allora sono stati messi in orbita osservatori per raggi X sem-
pre più potenti, fino ai recenti Beppo Sax (italiano), Chandra (americano)
Riccardo Giacconi, premio Nobel per la fisica, pioniere e Newton (europeo). Del Progetto Chandra Giacconi è primo ricercatore.
dell'astronomia in raggi X. Sullo sfondo il radiotelescopio da 100 Piero Bianucci
metri di Green Bank (credit: NRAO/AUI/NSF).
54 • Le Stelle n. 111 • Ottobre 2012Puoi anche leggere