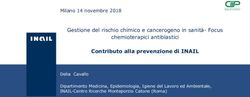ARCHIVISTICA III.0 Per una storia dell'archivistica informatica - DOTT.SSA SERENA FALLETTA
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Il fattore X: l'eXtensible Markup Language 1995: portare SGML su Internet, mantenendone le potenzialità ma rendendolo al tempo stesso più semplice e manipolabile 1996: Working Group finalizzato a definire le specifiche di un nuovo subset nasce l’eXtensible Markup Language, un metalinguaggio dalla sintassi semplificata, in grado di definire numerosi linguaggi associati per i link, i nomi dei tag, i fogli di stile e la descrizione di metainformazioni ancora abbastanza acerbo
XML: caratteristiche
a common syntax for expressive structure in data
Caratteristiche di XML:
• Famiglia dei linguaggi dichiarativi SGML
• Sviluppato dal W3C nel 1998
• Elaborazione avanzata di HTML
• Formato testuale: sia il markup che il testo sono stringhe di
caratteri
• Standard di pubblico dominio
• Indipendente da Hardware o Software
• Leggibile e archiviabile su qualsiasi supporto digitale, anche futuro
• SPEED: velocità ma anche acronimo di Storing, Publishing and
Exchanging Electronic Documents.XML e HTML
Come HTML, XML
• usa una codifica alfabetica
internazionale (unicode – UTF‐8)
• è indipendente dalla piattaforma,
libero e gratuito (open source)
A differenza di HTML, XML
• usa tag non predeterminati, ma
definiti da chi intende codificare il
documento
• separa la struttura semantica del
documento dalla sua
rappresentazioneXML: struttura. Elementi e attributi PROLOGO: DOCUMENT INSTANCE Serena Falletta ELEMENTI PADRI ED ELEMENTI FIGLI CHE POSSONO CONTENERE ATTRIBUTI: informazioni di secondo livello relative alle proprietà degli elementi es. Serena Falletta COMMENTI ignorati dal parser ( )
XML: vantaggi
• linguaggio di codifica flessibile alle esigenze degli studiosi
• rende disponibile il testo integrale delle fonti
• evidenzia partizioni e funzioni delle singole porzioni di testo
• mantiene il contesto
• meta-informazioni nascoste nell’output
• schema gerarchico di regolarizzazione di nomi e cose
notevoli
• seleziona e ordina dinamicamente i contenuti (costruzione
automatica di indici, liste, concordanze etc.)Cosa significa codificare in XML analizzare una fonte informativa per individuare la struttura semantica con la quale sono organizzati i dati. In base a tale struttura la fonte viene codificata = marcata Possiamo usare XML per u una fonte residente in un altro formato u codificare informazioni nuove In ogni caso, è possibile rappresentare i dati in qualsiasi modo per cui si ha a disposizione un file testuale intellegibile e riutilizzabile (output PDF, RTF, HTML etc.)
XML: ulteriori vantaggi
ü possibilità di mantenere l’integrità del testo, senza che esso
subisca la rilevante perdita di informazioni propria
dell’immissione dei dati all’interno di un database
ü documenti autodescritti
ü facile convertibilità a formati Web
ü sintassi universale
ü ripetibilità degli elementi, che permette strutture più flessibili,
in linea col carattere semistrutturato della documentazione
storica
ü strutturazione gerarchica degli elementi
ü produzione automatica del testo nel formato desiderato;
ü la capacità di elaborare i metadati inseriti e di effettuare
ricerche testualiXML: esperienze di utilizzo per la codifica dei
dati archivistici – strumenti di corredo
Gli esempi più noti in Italia :
1. la Guida generale degli Archivi di Stato italiani (Mibac-DGA):
dal 2002 è stata avviata la realizzazione di una versione
i n f o r m a t i c a i n X M L ( h t t p : / /
www.guidageneralearchivistato.beniculturali.it/)
2. gli Inventari degli archivi storici comunali del Lazio –
P r o g e t t o R I n A S C o , ( h t t p : / /
archivicomunali.lazio.beniculturali.it/ProgettoRinasco/)
3. gli inventari degli archivi comunali toscani ‐ progetto AST,
http://ast.signum.sns.it/XML e la Guida Generale agli AS. La Storia 1. La Guida a stampa 2. Il primo progetto di automazione (SGML) 3. Il Sistema Guida generale degli Archivi di Stato italiani (XML- EAD) 4. Gli aggiornamenti Cfr. P. Carucci. Sistema Guida Generale degli Archivi di Stato italiani, in «Archivi & Computer», XIV, 2/04
XML e il Progetto RInASCo
1. ricognizione degli
inventari e selezione
campioni rappresentativi
delle diverse tipologie
2. analisi e studio delle
caratteristiche
3. individuazione degli
elementi strutturali
significativi
4. bozza di modello dati
5. versione elettronica
6. aggiustamenti
7. outputXML e il Progetto AST
I sw per il lavoro archivistico e XML Caratteristiche: Ø database relazionali Ø impianto descrittivo basato su ISAD e ISAAR Ø XML formato di esportazione o importazione o conservazione dei dati Questo genere di strumenti permette inoltre di • codificare archivi di differente tipologia all’interno di un modello dati XML comune • usare campi descrittivi riconducibili a quelli definiti dagli standard metodologici cui fanno riferimento gli archivi • ricondurre gli elementi informativi all’interno di un’unica • recuperare e raccogliere dati senza problemi tecnici di modifica di strutture preesistenti
Ispirazioni. Alcuni modelli di edizione digitale
Il panorama non è ancora maturo:
u assenza di pagine introduttive ad illustrazione del
progetto
u trascrizioni articolate nel segno della libertà
interpretativa
u riduzione al minimo di apparati e note
u impossibilità di reperire nomi e qualifiche del curatore
o dei patrocinatori del progetto
u manca, per chi si occupa di documenti e soprattutto
di quelli medievali, un modello scientifico e
operativo prevalenteIspirazioni. Fontes Civitatis Ratisponensis
Ispirazioni. Le Cartulaire blanc de Saint Denis
Ispirazioni. Le Cartulaire blanc de Saint Denis
Ispirazioni. Beowulf elettronico
Ispirazioni. Vercelli Book Digitale
Ispirazioni. Codice diplomatico Lombardia Medievale
CDLM: scopo http://www.lombardiabeniculturali.it/cdlm/ mettere progressivamente a disposizione degli studiosi – riproponendo nella nuova forma digitale edizioni già note, avviando nuovi cantieri, proseguendo nella ricerca di materiali inediti o poco conosciuti –, in un unico ambiente e con alcuni indispensabili strumenti di ricerca, la documentazione d’archivio prodotta, conservata e tramandata da chiese e monasteri ‘lombardi’ o proveniente (ma a noi giunta soprattutto attraverso gli archivi di quelle stesse chiese e di quei monasteri) dalle cancellerie delle massime autorità politiche e religiose e dai comuni cittadini fra l’VIII e il XII secolo
RECAP: ricerca in archivio e informatizzazione nel campo delle fonti documentarie e degli archivi storici sedimentati l’informatica si applica ad attività di descrizione, valorizzazione e utilizzazione delle fonti PROBLEMA: digitalizzazioni parziali e spesso poco omogenee diverse tipologie di intervento: - digitalizzazione di fonti documentarie - creazione di archivi digitali per la ricerca - informatizzazione degli strumenti di ricerca
Rapsodia della digitalizzazione la messa a disposizione dei documenti è comunque rapsodica: soprattutto, rende evidente ed accentua il carattere puntiforme e tendenzialmente decontestualizzato che queste fonti assumono nel momento in cui vengono consultate. Si tratta, in definitiva, di iniziative che puntano a valorizzazioni di memorie locali: la scelta dei documenti da digitalizzare, anche per i costi che comporta, viene infatti quasi sempre effettuata in base a criteri non di tipo scientifico, ma intesi a soddisfare la coltivazione della memoria (che è un fenomeno in forte crescita, come testimonia anche la trasformazione dell’utenza che frequenta gli archivi) più che a favorire il lavoro di ricerca storica (che rimane, in ogni caso, una dimensione specialistica)”: tesori più che documenti d’archivio Documenti, archivi digitali, metafonti di Andrea Zorzi
Dalla fonte alla metafonte I due pilastri su cui poggia l’edificio testual-culturale moderno – autorship e stabilità – sono stati garantiti nei secoli da un carattere difficilmente discutibile: la materialità della fonte. Qualunque progresso tecnico – si pensi alla riproducibilità: diffusione della carta, stampa, fotografia, microfilm – non ha fatto che ribadire il primato dell’oggetto fisico. Queste tecnologie, per quanto rivoluzionarie, non attuano il passaggio da uno stato fisico all’altro D. Fiormonte, Il documento immateriale, in Il documento immateriale. Ricerca storica e nuovi linguaggi, in «L’Indice dei libri del mese», Dossier 4 (maggio 2000), a cura di G. Abbatista e A. Zorzi
Come cambia il concetto di risorsa storico- archivistica nell'era digitale Metafonti o Metarisorse: non la semplice trascrizione digitale dei documenti ma fonte arricchita da una gamma di strumenti di indagine • regesti • inventari • immagini • saggi • bibliografie • database • motori di ricerca in grado di arricchire determinarne nuovi modi di lettura e fruizione
Il concetto di metafonte Jean-Philippe Genet - VII Congresso Internazionale dell’Associazione History and Computing (Bologna 1992): dimensione intermedia, nella gerarchia della documentazione storica, generata dalla creazione di nuove fonti - la questione delle fonti come veicolo rappresentativo della realtà
Un salto indietro: la dottrina delle fonti di Droysen Gustav Droysen: Ø quellen (fonti vere e proprie), a carattere intenzionale (mediate, monumenti), che hanno come fine la rappresentazione o il ricordo Ø uberreste (avanzi): immediate, prive di intenti testimoniali 3 regole: 1) criterio dell’immediatezza delle fonti; 2) criterio della prossimità ad un evento; 3) la fonte non-scritta èpiù attendibile di quella scritta
Teoria delle fonti: documento/monumento
Importanza riconosciuta alle forme di trasmissione
Ø impossibilità di concepire un metodo scientifico per
la classificazione delle fonti (Croce, Chabod)
Ø riconoscimento della natura monumentale di ogni
documento (Focault, Le Goff)
Il documento è monumento. È il risultato dello sforzo
compiuto dalle società storiche per imporre al futuro,
volenti o nolenti, quella data immagine di se stesse (J.
Le Goff, Documento/monumento)
Riformulazione dell’odierno concetto di documento:
«Ogni entità fisica, di qualunque forma e materiale, in
cui siano registrate delle informazioni», G. ViginiLa Scuola delle Annales
• fondata da Marc Bloch e Lucien Febvre
• profondo rinnovamento nel dibattito in
corso
• allargamento del campo delle fonti
• storiografia concreta e priva di
condizionamenti schematici
• contro una concezione della storia basata
su una teoria ristretta delle fonti
• riflessione sulle pratiche di
conservazione, fissazione, ricostruzione e
reintrepretazione della memoria storica
• storia totale, fondata su una definizione
aperta e potenzialmente illimitata delle
fontiUna rottura radicale «Che cos’è infatti una risorsa se non la possibilità di dar risposta a quesiti ed esigenze interamente riconducibili al problema che lo storico, in un dato momento della sua attività, si pone, e assai difficilmente riconducibili ad uno standard?» le risorse (o fonti, nel linguaggio più tradizionale degli storici) non sono quello che risulta racchiuso in un contenitore prestabilito e preordinato, fisico o virtuale, ma ciò che lo storico individua come tale in relazione ad un problema R. Minuti, Internet e il mestiere di storico. Riflessioni sulle incertezze di una mutazione, in «Cromohs», 6 (2001), pp. 1-75
Metafonti: domande e interrogativi Se accettiamo l'idea della metafonte come oggetto storico caratterizzato da provvisorietà, perennemente allo stadio di semilavorato e sempre suscettibile di mutamenti, ci dobbiamo chiedere: 1) come cambia il rapporto degli utilizzatori con le fonti digitali o metafonti, nel modo di ricercarle, di utilizzarle e infine di comunicarle? 2) Come si convive con i problemi della immaterialità, dinamicità, fragilità, rischio di manipolazione dei documenti digitali? 3) Quale sarà il destino delle fonti digitali? E di quelle tradizionali?
Codifica digitale: un processo NON-NEUTRO Il prodotto finale della codifica è qualcosa di ben diverso da un facsimile del documento originario, ovvero è il risultato di un processo di elaborazione e ricontestualizzazione assolutamente non-neutro, che non ammette ingenuità Come tutte le scienze sociali, ma forse con un po’ di ritardo, la storia odierna passa dall’implicito all’esplicito. La codificazione dei dati presuppone la loro definizione; la loro definizione implica un certo numero di scelte e di ipotesi tanto più coscienti in quanto bisogna pensarle in funzione della logica di un programma F. Furet, Il quantitativo in storia, in Fare storia. Temi e metodi della nuova storiografia
Puoi anche leggere