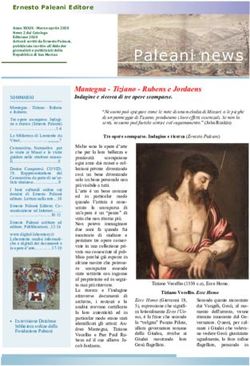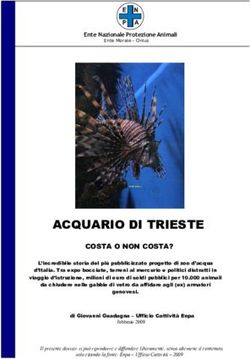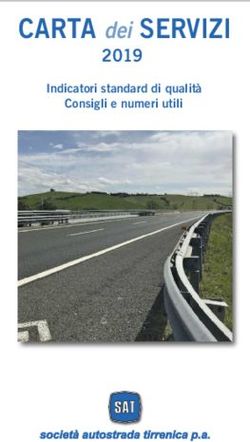7 ICT e sistemi smart per le costruzioni - Dipartimento ABC
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
7
ICT e sistemi smart per le costruzioni
L’Agenda Digitale per l’Europea è una delle sette iniziative della strategia Europa 2020 per una crescita in-
telligente, sostenibile e inclusiva dell’Europa. L’obiettivo che essa si pone è di ottenere vantaggi socioeco-
nomici sostenibili da un mercato unico digitale, basato su internet veloce e ultra-veloce e su applicazioni
interoperabili. In particolare, il settimo pilastro dell’agenda sottolinea i benefici per la società europea de-
rivanti dall’applicazione dell’ICT (Information and Communication Technologies) ed evidenzia la necessità
di soluzioni intelligenti per un vasto numero di utenti e per usi quotidiani. Documenti quadro e strumenti
finanziari nel settore della ricerca sono pertanto orientati a promuovere progetti in cui il mondo dell’ICT
sia progressivamente connesso a quello reale.
Da qui assume un ruolo centrale la capacità di costruire connessioni tra le potenzialità
dell’ICT e le esigenze della società in quanto attore beneficiario di politiche sostenibili, di risparmio e va-
lorizzazione di risorse, inclusa quella dei beni culturali.
In questo quadro si colloca l’attività di ricerca del Dipartimento che mira a mettere a
sistema competenze differenti al fine di raccordare policies e technologies, come già avvenuto in occasione
di alcuni progetti di ricerca condotti sia a livello europeo, sia locale. Molteplici sono gli ambiti di ricerca
intrapresi e consolidati in questi anni.
In primo luogo, l’ambito dell’organizzazione e della gestione di processi costruttivi evo-
luti in ambiente BIM (Building Information Modeling); la possibilità di disporre, lungo l’intero ciclo di vita
di un’opera, di un unico sistema integrato – in grado di raccogliere, gestire ed esportare informazioni
190
07-20161123.indd 2 29/11/16 12.53proprie dell’oggetto edilizio o infrastrutturale – rappresenta un significativo potenziale di innovazione per
l’intero settore delle costruzioni, anche se ancora molto deve essere fatto nella direzione della condivisio-
ne culturale tra i soggetti coinvolti, sia sul piano metodologico, sia sul piano strumentale.
In questo il Dipartimento è in prima linea, in quanto ospita il Capitolo Italiano di Buil-
dingSmart, l’associazione indipendente nata per diffondere l’interoperabilità di dati e informazioni rela-
tivi a edifici e infrastrutture garantita dallo standard IFC. Fondata nel 2004 presso l’allora dipartimento
BEST, quando l’attualità di questi temi in Italia era soltanto l’intuizione di alcuni esperti, l’associazione
è stata rilanciata sulla base di una ampia condivisione della rilevanza strategica della sua azione, che
promuove la digitalizzazione (il passaggio al BIM) della filiera delle costruzioni attraverso l’adozione degli
standard aperti promossi da BuildingSMART International. Questo significa promuovere l’interoperabilità
sia come presupposto tecnico per la condivisione dei dati, sia come attitudine alla integrazione e coope-
razione tra i molti soggetti che intervengono nella filiera dell’edilizia attraverso l’intero ciclo di vita delle
costruzioni. BuildingSMART Italia riunisce quindi tutti i diversi soggetti (committenti, progettisti, imprese
di costruzione, produttori, case di software, gestori, università e centri di ricerca) che intervengono nella
filiera, proponendosi come luogo di dialogo aperto e collaborativo al fine di individuare e facilitare sia le
azioni necessarie per rimuovere gli ostacoli che ritardano l’innovazione, sia le azioni che possono invece
incentivare l’adozione di procedure e strumenti più avanzati, contribuendo alla innovazione e alla compe-
titività del Paese, dando voce alle diverse componenti del settore e garantendo l’aggancio con gli scenari
internazionali. Come è noto, la continua espansione dell’impiego degli strumenti digitali in edilizia è una
realtà consolidata in molti Paesi, tanto che l’adozione di questi strumenti è per le aziende italiane una
condizione necessaria per la competitività. Il ruolo di raccordo con BuildingSMART International consen-
te a BuildingSMART Italia sia di avere un osservatorio ai massimi livelli sull’andamento dell’innovazione
digitale sul mercato globale, sia l’adozione di adeguati standard di qualità, in un settore che altrimenti
potrebbe essere esposto a forti diseconomie anche per la carenza di informazione. Sulla base di queste
ragioni, BuildingSMART Italia ha elaborato una roadmap italiana, analoga a quelle già prodotte in altri
Paesi, che sarà ulteriormente e continuamente elaborata dagli aderenti dell’associazione, e vuol essere un
contributo alle decisioni strategiche per il Paese.
In secondo luogo, l’ambito della costruzione di modelli BHIMM (Built Heritage Informa-
tion Modeling Management); in questo caso la sfida principale consiste nel garantire la gestione della com-
plessità geometrica, costruttiva e stratigrafica dell’architettura, valore autentico di un manufatto antico,
sia durante le fasi di scomposizione dell’edificio nei suoi elementi costruttivi, sia nella fase di modellazio-
ne e di comunicazione con altri software. L’obiettivo è quello di mettere a punto piattaforme che consen-
tano la condivisione dei dati tra i vari attori coinvolti nel processo e la divulgazione dei risultati ottenuti
ai professionisti, alle istituzioni pubbliche e a tutti i soggetti coinvolti, in modo da rendere il modello BIM
un concreto strumento di progettazione e gestione del costruito nel tempo.
In terzo luogo, l’ambito dello studio delle metodologie per il rilevamento e la tutela
delle costruzioni e dell’ambiente costruito con un particolare interesse per i sistemi SMART (Self
191 ICT e sistemi smart per le costruzioni
07-20161123.indd 3 29/11/16 12.53Monitoring and Reporting Technology) e per i sistemi geomatici, sia in ambito satellitare (space), sia in
ambito terrestre (ground).
In quarto luogo, l’ambito dell’approfondimento della relazione tra progetto e fabbrica-
zione digitale, anche attraverso la sperimentazione basata sull’impiego delle più avanzate tecnologie CAM
(Computer Aided Manufacturing).
Infine, l’ambito dello sviluppo di interfacce tra software di modellazione architettonica
3D e sistemi territoriali, i GIS (Geographic Information Systems). Questi ultimi, nati come sistemi integra-
bili con dati di diversa natura, raccolti in database e collegabili spazialmente tra loro, si sono ampiamente
diffusi supportando un ampio ventaglio di applicazioni che vanno dall’analisi, alla pianificazione, preven-
zione, simulazione e gestione dell’intervento.
1. Building information modeling per il project, construction and facility management
Il processo edilizio implica, nei suoi tre sottoprocessi (decisionale, esecutivo e gestionale), un ampio ed
eterogeneo insieme di informazioni che occorre organizzare e trasferire durante le diverse fasi. Tali in-
formazioni riguardano sia aspetti tecnico-operativi, sia aspetti di tipo economico-gestionale e vengono
sottoposte alla verifica e all’utilizzo di differenti operatori secondo diversi livelli di approfondimento.
In questo contesto la gestione dell’informazione attraverso sistemi ICT è lo scenario di
riferimento. In particolare l’impiego di sistemi basati sul BIM rende possibile la raccolta e la condivisio-
ne delle conoscenze necessarie al corretto sviluppo e controllo di ogni fase del processo edilizio che si
articolano necessariamente in una serie di peculiarità definite volta per volta dall’oggetto della specifica
indagine.
Su questo fronte il Dipartimento ha profuso uno sforzo continuo che avuto un momento
di particolare intensità nel progetto INNOVance (per il Ministero dello Sviluppo Economico), sviluppato in
collaborazione con quindici partner nel campo della ricerca (Politecnico di Torino, Università Federico II
di Napoli, ITC-CNR, Consorzio TRE, ISTEDIL, ecc.) e nel campo delle associazioni e delle imprese (ANCE,
ANDIL, UNICMI, Federlegno, ATECAP)1. Lo sviluppo della ricerca ha portato alla definizione del primo
prototipo di banca dati nazionale unificata contenente le informazioni – di natura tecnica, scientifica, eco-
nomica e legale – utili alla filiera delle costruzioni. Sfruttando le nuove potenzialità in materia di intero-
perabilità dei sistemi offerte dai software esistenti, la banca dati è stata pensata per favorire l’integrazione
di tutti i soggetti della filiera delle costruzioni, a partire dalla fase di progettazione, fino alla costruzione
del manufatto edilizio e alla sua successiva gestione2.
1. A. Pavan, B. Daniotti, F. Re Cecconi, S. Lupica Spagnolo, S. Maltese, M. Chiozzi, D. Pasini,
V. Caffi, Construction Information Management (CIM), INNOVance for the construction process,
in AA.VV., Energy, sustainability and building information modeling and management,
Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2014.
2. A. Pavan, B. Daniotti, F. Re Cecconi, S. Lupica Spagnolo, S. Maltese, M. Chiozzi,
D. Pasini, V. Caffi, INNOVance: Italian BIM Database for Construction Process Management, in
192
07-20161123.indd 4 29/11/16 12.53Il progetto INNOVance ha perseguito lo scopo di ridurre le incomprensioni tra i soggetti
che operano nelle diverse fasi del processo edilizio (committenza, progettisti, imprese, produttori di com-
ponenti, gestori, utenti) che risultano particolarmente critiche in ragione delle inefficienze tecniche ed
economiche, degli sprechi, dei ritardi e dei contenziosi che esse determinano. Un sistema che garantisca
l’univocità e la completezza dell’informazione si traduce, immediatamente, nel contenimento dei costi,
nella riduzione dei tempi, nell’innalzamento del livello qualitativo del prodotto e, non da ultimo, nel
conseguimento della sostenibilità ambientale, economica e sociale del processo. Gli sviluppi del progetto
sono legati al trasferimento in ambito normativo attraverso la definizione di standard nazionali e la par-
tecipazione ai comitati tecnici internazionali ISO e CEN.
Un ambito di ricerca di particolare interesse, con particolare riferimento alla gestione
delle diverse fasi del processo, è costituito dall’Information Modeling, dove gli aspetti informativi stanno
assumendo un ruolo rilevante rispetto alla modellazione geometrica3. Sempre più diffusi sono i modelli
che introducono la variabile del tempo (4D modeling) e dei costi (5D modeling). Nella rappresentazione
dei contenuti informativi ai diversi livelli, i dati alfanumerici vengono rappresentati in maniera semplice
attraverso visualizzazioni tridimensionali che mutano nel tempo e nello spazio; nel 4D modeling, per
esempio, la modellazione della fase temporale del cantiere, mostra come una sequenza di attività possa
essere tradotta in sequenze di scene tridimensionali e, in alcuni casi, in forma di curve e di istogrammi.
L’elevata mole di informazioni rende tuttavia questi metodi difficilmente praticabili per il governo del
processo di progettazione, costruzione e gestione di edifici e infrastrutture. La nuova sfida è quindi co-
stituita dalla messa a punto di sistemi in grado di guidare i processi attraverso la visualizzazione grafica
delle informazioni senza mediazioni indebite: i sistemi di Visual Project and Program Management. Questi
ultimi possiedono infatti interessanti potenzialità, sia sul fronte dell’assicurazione agli stakeholder dei
risultati attesi per ogni commessa, sia sul fronte di una maggiore affidabilità dell’intero processo edilizio
dal momento che la consistente quantità di dati che i modelli sono in grado di gestire permette di creare
nuove metriche di analisi e di controllo dell’andamento del processo. Queste possibilità saranno sfrutta-
bili da committenze e da società di progettazione evolute in grado di usare l’Information Modeling come
strumento di lavoro sin dalle prime fasi di ideazione dell’opera, trasformandosi in digital builders in grado
di prefigurare il progetto e affrontare preventivamente tutti i problemi che potrebbero sorgere durante
l’intero ciclo di vita. La struttura della committenza in grado di sfruttare tutti i benefici dell’Information
Modeling, richiederà altresì un nuovo tipo di appaltatore, in grado di organizzare e controllare in modo
nuovo tutta la sua catena di fornitura. L’applicazione del Visual Project and Program Management, anche
Proceedings of the ICCCBE 2014, International Conference on Computing in Civil and Building
Engineering, ASCE, Orlando 2014, pp. 641- 648.
3. F. Re Cecconi, A. Pavan, S. Maltese, BIM based project management in construction, in
Proceeding of the ICEC 2014, IX World Congress, Re-Engineering Total Cost Management,
Milano 2014.
193 ICT e sistemi smart per le costruzioni
07-20161123.indd 5 29/11/16 12.53attraverso la simulazione (statistica) del comportamento degli utenti dell’opera, sarà quindi in grado di
anticipare le scelte e rendere il processo più efficiente.
Per quanto riguarda la progettazione del cantiere, occorre sottolineare come l’organiz-
zazione della fase esecutiva abbia una valenza strategica per il successo dell’intervento, in quanto un
approccio preventivo superficiale rispetto alle potenziali criticità del cantiere si traduce in un aggravio di
risorse temporali ed economiche per la committenza e per l’impresa, implica un innalzamento del livello
di rischio per la salute e la sicurezza delle maestranze e delle attività antropiche al contorno e determina
una riduzione della qualità finale delle opere. Su questo versante, il Dipartimento ha intrapreso un per-
corso di ricerca teso alla individuazione di metodi e strumenti utili alla integrazione della progettazione
cantieristica all’interno del processo decisionale. Tra questi, particolare attenzione è stata dedicata alla
messa a punto di modelli funzionali di progettazione integrata manufatto-cantiere in grado di coniugare,
in ambiente BIM, gli aspetti della cantieristica con gli altri aspetti del processo.4 Le numerose sperimen-
tazioni condotte hanno consentito la realizzazione di archivi informatici gestibili con QR-code o apposite
interfacce grafiche. Si è inoltre provveduto alla modellazione sistematica di elementi cantieristici quali ap-
prestamenti, macchinari e attrezzature di cantiere connotati ognuno da un repertorio informativo, utile a
guidare e a condividere le scelte di progettazione operativa e cantieristica con gli altri operatori.5 Su questo
fronte numerose sono state le sperimentazioni: il recupero della Torre Velasca di Milano, l’ampliamento
del Teatro alla Scala di Milano6, lo studio di fattibilità per il montaggio delle facciate della Torre Hadid di
City Life a Milano, la ricostruzione e restauro della Basilica di S. Maria di Collemaggio a L’Aquila, il restau-
ro della facciata della Chiesa di S. Francesco di Paola a Milano, la realizzazione di nuove Palazzine Resi-
denziali in Milano e hinterland, il varo della passerella pedonale di collegamento tra il podio delle Torri
Varesine, il podio delle Torri Garibaldi a Milano, la costruzione della Nuova autostrada A33 Asti-Cuneo.
La fase gestionale del processo edilizio, con particolare riferimento ai temi del facility
e del property management, costituisce un ulteriore punto focale della ricerca condotta nel Dipartimento
in ambito BIM. In questo campo il BIM si configura come un valido strumento per organizzare le politi-
che manutentive, per prevedere la vita utile e il relativo life cycle cost; quindi, per orientare gli studi di
fattibilità e di valorizzazione e per ottenere un controllo di gestione orientato al presidio della redditività
dell’investimento e al controllo del conto economico.7
4. M.L. Trani, M. Cassano, M. Minotti, D. Todaro, Construction site BIM requirements, in
Proceedings of the 30th Annual ARCOM Conference, Portsmouth, UK 2014, pp. 663-672.
5. M.L. Trani, B. Bossi, M. Cassano, D. Todaro, BIM oriented equipment choice on
construction site, in Proceedings of the 8th International Structural Engineering and
Construction Society (ISEC) Conference, Sustainable Solutions in Structural Engineering and
Construction, Sydney 2015.
6. M.L. Trani, B. Bossi, M. Cassano, D. Todaro, BIM level of detail for construction site design,
in “Procedia Engineering”, n. 123 (2015), pp. 581-589.
7. G.M. Di Giuda, V. Villa, F. Paleari, M. Schievano, BIM modeling of the existing school
194
07-20161123.indd 6 29/11/16 12.53In particolare, per quanto riguarda i gestori immobiliari, si sostanzia un valore aggiunto
in termini competitivi, giacché l’adozione del BIM identifica uno strumento esecutivo molto efficace per
pianificare e ottimizzare le attività, ovvero per modellare le operazioni connesse all’erogazione dei servizi
e per attuare un controllo di commessa puntuale, volto al monitoraggio della qualità (service level agree-
ment, key perfomance indicator, facility condition index).
Nell’attuale fase le modalità di integrazione con strumenti del tipo BMS (Building Ma-
nagement Systems) e con sistemi informativi specificamente dedicati al facility management (CAFM –
Computer Aided Facility Management, CMMS – Computerized Maintenance Management Systems, IWMS –
Integrated Workplace Management Systems) rappresentano aree applicative fondamentali per il definitivo
avvio del cosiddetto BIMM (Building Information Modeling Management).
L’organizzazione di modelli BIM a supporto dell’impostazione di contratti e capitolati
per l’affidamento di servizi tecnici e amministrativi, ossia per la programmazione tecnico-economica del-
la manutenzione e più in generale per l’efficienza dei servizi di facility e property management, costituisce
un’area applicativa dalle grandi potenzialità di sviluppo. In questo ambito, stante la necessità di un aggior-
namento continuo delle informazioni, il BIM garantisce output operativi fondamentali per una gestione
ottimizzata: dal controllo della commessa (reportistica), alla generazione dei fascicoli del fabbricato.
L’emanazione della Direttiva Comunitaria 2014/24/EU European Union Public Procu-
rement Directive ha posto le basi normative a partire dalle quali fare evolvere gli ordinamenti degli Stati
membri in materia di appalti (servizi, forniture e lavori) verso sistemi di Collaborative Procurement. Il
dato è tanto più significativo se si considera il fatto che nella Direttiva è data la possibilità alle amministra-
zioni di richiedere l’uso di specifici strumenti di modellazione informativa per l’edilizia e le infrastrutture,
di stabilire che l’offerta economicamente più vantaggiosa venga valutata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, di determinare i criteri economici e qualitativi da utilizzare al fine di valutare il miglior
rapporto qualità/prezzo connesso all’oggetto dell’appalto, introducendo in questo modo criteri basati sui
principi del rapporto costo/efficacia e della determinazione dei costi del ciclo di vita.
Si tratta di una sicura innovazione nella gestione degli appalti pubblici, soprattutto in
un contesto come quello italiano dove il criterio principe per l’aggiudicazione dei lavori è stato il massimo
ribasso, con le storture conseguenti che hanno reso il ricorso alle varianti in corso d’opera patologico.
Il perno su cui ruota tutta l’architettura del sistema è costituito dalla capacità della
committenza di rappresentare i propri bisogni e le proprie esigenze in maniera predeterminata ed univoca
heritage for investment planning, in AA.VV., Environmental sustainability, circular economy and
building production. Sostenibilità ambientale, economia circolare e produzione edilizia, Maggioli,
Santarcangelo di Romagna, 2015, pp. 29-48; G. M. Di Giuda, V. Villa, L. Loreti, BIM to manage public
procurement with award criterio Most Economically Advantageous tender, in AA.VV. Environmental
sustainability, circular economy and building production. Sostenibilità ambientale, economia circolare
e produzione edilizia, cit., pp. 9-28.
195 ICT e sistemi smart per le costruzioni
07-20161123.indd 7 29/11/16 12.53con un approccio prestazionale. Mentre le specifiche che progettisti e imprese metteranno in campo
dovranno essere misurate quale differenza tra la qualità attesa dal committente e la qualità effettiva del
bene edilizio.
È evidente che l’applicazione dei criteri posti alla base delle modalità di affidamento dei
lavori, così come previsto dalla Direttiva, richiede metodi e strumenti informativi dell’intero processo che
trovano nell’ambiente BIM un terreno fertile. Lo sforzo che dovrà essere fatto dai protagonisti del settore
delle costruzioni è quello di immaginare formule contrattuali sul modello del Construction Management
at Risk e dell’Integrated Project Delivery per dare piena applicazione ai modelli di progettazione e costru-
zione integrata.
Un ultimo fronte di ricerca riguarda la possibilità di descrivere una relazione tra i dati contenuti
all’interno dei modelli BIM elaborati alla scala dell’edificio e le mappe urbane, laddove queste ultime costituiscono
un database contenente informazioni geo-riferite.8
La ricerca si indirizza alla formazione di un portale, inteso come strumento che permet-
ta di convogliare un gran numero di informazioni riferite ai singoli edifici, dal quale i diversi operatori
possano attingere i dati relativi all’esistente.
La ricerca si fonda su una precedente esperienza condotta per la città di Milano (e-Map-
ping) e da un’estensione della sperimentazione delle potenzialità del progetto INNOVance e si muove nella
direzione di individuare le modalità di un raccordo tra il dato architettonico e quello urbano, offrendo
così la possibilità di considerare gli edifici come oggetti BIM contenenti dati con differenti possibilità di
fruizione. A seconda del target di utilizzo possono essere previsti accessi diretti e differenziati da parte di
professionisti o studiosi interessati al manufatto esistente. Nella stessa sezione relativa all’edificio possono
essere predisposte sezioni di caricamento dati per favorire, con semplici drag and drop, il caricamento
di nuove informazioni da parte degli utenti. La piattaforma, implementabile, potrebbe essere aggiornata
dagli stessi utenti prevedendo, nel suo accrescimento, la possibilità di raccogliere dati attraverso processi
continui con moderatore, oppure attraverso la raccolta di dati con invio spontaneo mediante dispositivi
di comunicazione individuali.
2. Il Building Heritage Information Modeling Management: modellare la complessità,
governare processi inclusivi
L’attività di ricerca svolta nel Dipartimento nell’ambito della modellazione tridimensionale e del BIM
assume una particolare connotazione quando applicata al patrimonio costruito.
8. C. Bolognesi, G. Procacci, Between GIS Environment and 3D Modelling, in Mo.Di.
Phy Modelling from digital to physica Proceedings, Lecco 2013; C. Achille, C. Bolognesi,
F. Fassi, Good practice: analysis of the vulnerability of the seven churches of Monza,
in ISBP – 1° International Symposium on Building Pathology Proceedings, Porto 2015.
196
07-20161123.indd 8 29/11/16 12.53In questo caso, l’applicazione del BIM impone uno sforzo notevole in termini di inte-
roperabilità tra i formati e in termini di capacità di concepire i modelli a partire da una scomposizione e
ricomposizione dell’edificio per elementi a diverso livello di dettaglio geometrico (LoD – Level of Detail),
ovvero per livelli di semplificazione di dettaglio differenziati in funzione degli utenti e delle finalità.
Uno dei campi di ricerca di maggiore interesse in ambito BIM è la sperimentazione
degli approcci LoD analoghi a quelli utilizzati in cartografia per la piramidazione di immagini al fine di
consentire la gestione e la visualizzazione di immagini in alta risoluzione, come per esempio quelle da
satellite, da drone o le immagini panoramiche. Ovviamente questo concetto trasposto nella modellazione
è più complesso e richiede:
–– lo sviluppo di protocolli di modellazione inclusivi rispetto alla complessità degli edifici in termini ge-
ometrici-costruttivi, attraverso lo sviluppo di modelli gerarchici LoD based; si tratta di superare i limiti
di una modellazione BIM sviluppata per la progettazione del nuovo caratterzzata da oggetti semplici e
replicabili, attraverso l’introduzione di oggetti parametrici caratterizzati da una elevata complessità e
specificità;
–– la definizione di protocolli per la gestione di infrastrutture di dati, dei differenti flussi informativi inclu-
sivi ed interoperabili attraverso lo sviluppo di interfacce di database a supporto della gestione di processo,
della conservazione preventiva, simulazione di scenari, progetto post-danno, ma anche della gestione,
controllo e monitoraggio nel tempo;
–– la sperimentazione di trasmissione di flussi modelli-informazioni multi utente, professionisti e speciali-
sti da un lato in un ambito multi-disciplinare, e cittadini e turisti dall’altro, a supporto di politiche inclu-
sive di quella Reflective Society che l’UE chiede di aiutare a crescere come condizione di una salvaguardia
realmente efficace. La ricerca, nel quadro della standardizzazione di formati interoperabili IFC (Industry
Foundation Classes) (piattaforma Building Smart, Open Geospatial Consortium) si propone di definire pro-
tocolli interoperanti con i differenti ambienti e software d’analisi strutturale ed energetica, a supporto di
processi di gestione avanzati.
La multiscalarità dei sistemi BIM costituisce un altro tema prioritario: si tratta in altre
parole di fare in modo che i BIM possano rappresentare adeguatamente e senza soluzione di continuità
realtà complesse, per loro natura caratterizzate da scale di osservazione e di indagine molto differenti, da
quella dell’edificio a quella del territorio: è il caso dei beni architettonici, delle infrastrutture, dei distretti
energetici. Si tratta di passare da sistemi BIM verticali nati per gestire un edificato puntuale, spesso di
nuova costruzione, a sistemi in grado di affrontare realtà orizzontali anche attraverso il connubio tra BIM
e GIS, dotandosi degli strumenti indispensabili per supportare quella circolarità di informazioni necessa-
ria per affrontare adeguatamente temi di frontiera come nel caso delle green infrastructure, delle circular
smart cities, includendo anche le tematiche climatiche fino al contributo remote sensing.
In questa prospettiva si colloca la ricerca affrontata all’interno del Dipartimento
nell’ambito del BHIMM. I beni culturali presentano infatti livelli di complessità confrontabili con quelli
tipici della progettazione e della gestione infrastrutturale, sia dal punto di vista morfologico sia dal punto
197 ICT e sistemi smart per le costruzioni
07-20161123.indd 9 29/11/16 12.53di vista dell’interazione di gruppi disciplinari diversi e di logiche informative talvolta molto distanti: le
esperienze condotte sulla basilica di Collemaggio a L’Aquila (Ripartire da Collemaggio per EniServizi)9, sul
ponte Azzone Visconti a Lecco e Castel Masegra a Sondrio (La conservazione programmata nello spazio
comune retico per INTERREG)10 rappresentano un promettente punto di partenza.
Partendo dal presupposto che la conservazione del patrimonio costruito sia strettamente
connessa al concetto di manutenzione programmata degli edifici11, è sempre più necessario avere a dispo-
sizione uno strumento informatico che consenta, in maniera agile, efficiente ed implementabile, di racco-
gliere, interrogare, condividere e gestire tutti i dati relativi al bene, compresi quelli inerenti la sua storia,
la sua geometria e il suo stato di conservazione, registrati in elaborati grafici e in database descrittivi.
Un modello BHIMM deve garantire l’interoperabilità con altri software impiegati per
analisi specifiche, come per esempio le indagini strutturali, la valutazione economica, l’organizzazione e
la gestione del cantiere, la valutazione delle prestazioni energetiche12: proprio questo passaggio rappresen-
ta oggi uno dei nodi chiave della ricerca, la cui sfida principale è di carattere culturale.
Dal punto di vista della rappresentazione, le più recenti tecniche di rilievo consentono
di acquisire, anche in breve tempo, una grande quantità di dati 3D, in particolare impiegando laser scan-
ner terrestri o software fotogrammetrici sempre più user friendly che consentono l’estrazione di nuvole
di punti da modelli di immagini semplicemente acquisite attraverso camere digitali. Tale imponente
mole di dati deve essere impiegata per realizzare modelli 3D il più possibile fedeli al costruito, alla sua
reale geometria e al suo stato di conservazione. Ciò pone questioni di carattere progettuale e operativo:
innanzitutto in relazione al livello di discretizzazione del modello finale che si vuole ottenere e sulla sua
scomposizione in elementi costruttivi parametrizzabili, in secondo luogo in relazione alle problematiche
9. D. Oreni, R. Brumana, S. Della Torre, F. Banfi, L. Barazzetti, M. Previtali, Survey turned
into HBIM: the restoration and the work involved concerning the Basilica di Collemaggio after
the earthquake (L’Aquila), in “ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and
Spatial Information Sciences”, vol. II-5 (2014).
10. L. Barazzetti, F. Banfi, R. Brumana, G. Gusmeroli, D. Oreni, R. Previtali, F. Roncoroni,
G. Schiantarelli, BIM from laser clouds and finite element analysis: combining structural
analysis and geometric complexity, in “The International Archives of the Photogrammetry,
Remote Sensing and Spatial Information Sciences”, vol. XL-5/W4 (2015), pp. 345-350;
L. Barazzetti, F. Banfi, R. Brumana, G. Gusmeroli, M. Previtali, G. Schiantarelli Cloud-
to-BIM-to-FEM: Structural simulation with accurate historic BIM from laser scans, in
“Simulation Modelling Practice and Theory”, n. 57 (2015), pp. 71-87; L. Barazzetti, F. Banfi,
R. Brumana, M. Previtali, Creation of Parametric BIM Objects from Point Clouds Using Nurbs,
in “Photogrammetric Record”, vol. 152 n. 30 (2015), pp. 339-362.
11. S. Della Torre, a cura di, La conservazione programmata del patrimonio storico architet-
tonico, Guerini e Associati, Milano 2003.
12. M. Previtali, L. Barazzetti, R. Brumana, B. Cuca, D. Oreni, F. Roncoroni, M. Scaioni,
Automatic facade modelling using point cloud for energy efficient retroffiting, in “Applied
Geomatics”, vol. 6 (2014), pp. 95-113.
198
07-20161123.indd 10 29/11/16 12.53connesse alla modellazione di elementi geometrici complessi e irregolari, con i software oggi disponibili
sul mercato. Quest’ultimo aspetto è legato, da un lato, a una questione puramente geometrica di model-
lazione tridimensionale, connesso alla difficoltà nell’uso di superfici NURBS (Non Uniform Rational Basis-
Splines) per generare volumi irregolari nei software di modellazione pura, dall’altro al problema dei limiti
delle librerie di elementi costruttivi disponibili nei software di modellazione parametrica.
Le librerie si basano su oggetti personalizzabili in funzione di specifiche proprietà, non
solo dimensionali, che consentono di essere importate dall’utente per essere utilizzate nella progettazione.
Nell’ambito dei beni culturali il processo di importazione non è utilizzabile stante l’unicità dei contesti
nei quali si opera. Tuttavia, librerie geografiche di oggetti possono essere l’inizio di atlanti storicizzati che
allineerebbero in modo sincronico e diacronico elementi caratterizzati da tecniche costruttive differenti o
ricorrenti; l’interazione tra BIM, alla scala dell’edificio, e GIS, alla scala del territorio, consentirebbe poi
di sfruttare appieno le informazioni così organizzate. Quest’ultimo è uno dei temi centrali per il futuro
sviluppo della ricerca. La ricerca internazionale è infatti orientata alla creazione di librerie condivise e al
riconoscimento di una terminologia comune. Molto lavoro deve essere ancora fatto in questa direzione,
al fine di evitare un’eccessiva semplificazione e banalizzazione dei modelli, che li renderebbe impiegabili
solo a livello locale. Il livello di discretizzazione dei manufatti oggetto di intervento, così come le moda-
lità di rappresentazione delle attività di restauro e la disponibilità di librerie di oggetti impattano sulla
progettazione operativa e di sicurezza, i cui esiti possono influire sulle scelte progettuali. L’analisi 3D delle
fasi esecutive è in grado di porre in luce anticipatamente una serie di criticità – legate al contesto, alla
accessibilità e alla fruibilità in sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché alla programmazione delle sequenze
di intervento – la cui soluzione preventiva è in grado di porre al riparo da sorprese gli operatori tecnici
ed economici di un intervento. Proprio legate alle esigenze di gestione ordinaria e straordinaria del can-
tiere sono rappresentative le esperienze di ricerca legate ai cantieri manutentivi perpetui come il Duomo
di Milano13 e la Basilica di San Marco a Venezia14, che hanno portato alla creazione di un prototipo15 di
13. F. Fassi, C. Achille, L. Fregonese, Surveying and modelling the Main Spire of Milan
Cathedral using multiple data source, in “The Photogrammetric Record”, vol. 26 (2011),
pp. 462-487; C. Achille, F. Fassi, L. Fregonese, 4 Years history: From 2D to BIM for CH – The
main spire on Milan Cathedral, in G. Guidi, A.C. Addison. Proceeding of VSMM 2012. Virtual
Systems in the Information Society, pp. 377-382, Milan 2012.
14. L. Fregonese, L. Taffurelli, 3D Model for the documentation of Cultural Heritage: the wooden
domes of St. Mark’s Basilica in Venice in “The International Archives of the Photogrammetry,
Remote Sensing and Spatial Information Sciences”, vol. 38-5/W1 (2009), pp. 1-6.
15. F. Fassi, S. Parri. Complex Architecture in 3D: From Survey to Web, in “International
Journal Of Heritage In The Digital Era”, vol. 1 (2012), pp. 379-398.
16. F. Fassi, C. Achille, A. Mandelli, F. Rechichi, S. Parri, A new idea of BIM system for
visualization, web sharing and using huge complex 3D models for facility management, in
“The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information
Sciences”, vol. 40-5/W4 (2015), pp. 359-366.
199 ICT e sistemi smart per le costruzioni
07-20161123.indd 11 29/11/16 12.53sistema HBIM chiamato BIM3DSG.16 Questo sistema è stato ideato per essere utilizzato in cantiere per la
raccolta, la georeferenziazione real-time e l’utilizzo delle informazioni legate all’edificio a supporto delle
attività manutentive e di conservazione. La filosofia originale è stata quella di mettere a punto un unico
sistema informativo creato ad hoc per i Beni Culturali Complessi che si adatti alle più diverse realtà con-
siderando che le strutture architettoniche hanno esigenze, funzioni, problematiche, modi di gestione e
manutenzione differenti. Nelle attività manutentive, conservative e di restauro, l’aspetto fondamentale
da considerare è la moltitudine di attori17 che intervengono sullo stesso bene contemporaneamente o in
tempi successivi e che devono potere comunicare tra di loro e condividere dati e informazioni. Per questo
motivo il sistema informativo non deve essere rigido e preconfezionato, ma al contrario, dinamico per
permettere di strutturare i casi studio in maniera diversificata a seconda delle molteplici esigenze dalla
struttura analizzata ma anche delle scelte metodologiche ed operative adottate dai diversi specialisti. Il
sistema informativo realizzato si basa anch’esso su uno o più modelli digitali 3D (di qualsiasi formato) e su
un sistema di interconnessione e di scambio di informazioni che è personalizzabile da parte dell’operatore
in funzione proprio delle sue esigenze e delle particolarità del caso studio.
Sempre sul fronte dell’organizzazione del cantiere, nel Dipartimento è in corso la ricerca
MIUR PRIN Site Design, Planning & Management, tesa a sviluppare e asseverare metodi e strumenti per
una clash detection relativa alle risorse materiali, tecniche e temporali – e alla loro sicurezza d’uso – ne-
cessarie al compimento di un intervento sul costruito.
Il mondo complesso dei beni architettonici costituisce il cuore sperimentale di inter-
facce inclusive multi-tasking multi-purpose e multi-user di gestione nel tempo che potranno poi essere
trasferiti ad altri ambiti.
Occorre infine osservare come le logiche, le metodiche e gli strumenti messi a punto
nel caso di interventi sul patrimonio monumentale possano essere applicati anche all’edilizia diffusa. La
ricerca europea EASEE (Envelope Approach to improve Sustainability and Energy Efficiency in existing
multi-storey multi-owner residential building nell’ambito del 7° Programma Quadro per la Ricerca e lo
Sviluppo Tecnologico per l’Unione Europea) illustra le opportunità di impiego del BIM negli interventi di
recupero dell’edilizia residenziale pubblica, supportando il cantiere dalla fase di rilievo, alla realizzazione
degli interventi di riqualificazione, fino al monitoraggio delle prestazioni energetiche finali.
3. Metodi di rilevamento e tecniche SMART (Self Monitoring And Reporting Technology)
per la tutela delle strutture e dell’ambiente costruito
La rapidissima evoluzione di calcolatori, reti e ICT, unitamente allo sviluppo di tecniche di misura
innovative, ha reso disponibili una serie di nuovi sistemi per il rilevamento, il monitoraggio e la
17. F. Rechichi, A. Mandelli, C. Achille, F. Fassi, Sharing High-Resolution Models and Information On
Web: The Web Module of BIM3DSG System, in “The International Archives of the Photogrammetry,
Remote Sensing and Spatial Information Sciences”, vol. 41-B5 (2016), pp. 703-710.
200
07-20161123.indd 12 29/11/16 12.53tutela delle costruzioni e dell’ambiente costruito. Tali sistemi, denominati SMART, sono caratterizzati
dall’integrazione delle funzioni di: acquisizione dati (misure sperimentali); descrizione e analisi di
specifiche situazioni (ad esempio, l’evoluzione dello stato di un edificio, di una linea ferroviaria, di un
impianto per la produzione di energia, ecc.) in base ai dati disponibili; supporto decisionale predittivo
(ovvero riconoscimento automatico di anomalie, classificazione della loro gravità ed eventuale ripristino
di un pre-definito livello di sicurezza e funzionalità).
Metodi di rilevamento e sistemi SMART possono essere finalizzati sia alla valutazione degli effetti di eventi
eccezionali e/o del naturale invecchiamento, sia all’ottimizzazione degli interventi di manutenzione (in-
frastrutture ed edifici pubblici) e conservazione programmata (monumenti e Beni Culturali).
Dal momento che i sistemi SMART hanno la caratteristica di generare elevati volumi di
dati da elaborare in tempi relativamente rapidi mediante tecniche robuste ed automatiche (ossia indipen-
denti dalla presenza di un operatore), le tecniche ed i sensori di misura delle grandezze significative ai fini
delle valutazioni finali devono essere pienamente funzionali alla formazione di tali valutazioni; in altri
termini, l’hardware (preposto all’acquisizione di dati sperimentali ed informazione di base) è rilevante nel-
la misura in cui rappresenta l’appropriata periferica del software (a cui è demandata l’analisi automatica
dei dati registrati e la formazione della decisione).
Nel seguito, non essendo possibile una descrizione di tutte le metodologie hardware e
software disponibili, si presenta una sintesi delle attività di ricerca in corso presso il Dipartimento sull’in-
terferometria radar per la misura degli spostamenti di strutture (in condizioni statiche e dinamiche) e sui
metodi geomatici, in particolare quelli satellitari, in quanto tali tecniche di misura appaiono in prospettiva
futura particolarmente adatte all’utilizzo nell’ambito di sistemi SMART.
Misura remota degli spostamenti mediante interferometria radar
Una significativa innovazione tra i sistemi di monitoraggio remoto è costituita dall’interferometria radar:
studi sui principi dell’interferometria applicata a sistemi radar a banda larga hanno, infatti, condotto allo
sviluppo di un innovativo sensore radar in grado di effettuare la misura, remota e simultanea, dello spo-
stamento (in condizioni statiche o dinamiche) in differenti punti di una struttura, con accuratezza e preci-
sione dell’ordine di 0.02 mm18. Tale sensore è stato oggetto, dopo alcune preliminari applicazioni e prima
dell’inizio della produzione industriale, di accurati studi di validazione (esecuzione di indagini dinamiche
18. C. Gentile, G. Bernardini, An interferometric radar for non-contact measurement of
deflections on civil engineering structures: laboratory and full-scale tests, in “Structure and
Infrastructure Engineering”, n. 6 (2010), pp. 521-534.
19. C. Gentile, Deflection measurement on vibrating stay cables by non-contact microwave
interferometer, in “Non-Destructive Testing & Evaluation International”, n. 43 (2010),
pp. 231-240; C. Gentile, A. Saisi, Ambient vibration testing and condition assessment of the
Paderno iron arch bridge (1889), in “Construction and Building Materials”, n. 25 (2011),
pp. 3709-3720.
201 ICT e sistemi smart per le costruzioni
07-20161123.indd 13 29/11/16 12.53di vibrazione ambientale e prove dirette di carico su ponti stradali).19
L’interferometro radar (IDS mod. IBIS-S) consiste di un modulo sensore, un’unità di
controllo e acquisizione su PC ed un’unità di alimentazione. Il modulo sensore, costituito da un radar
coerente per la generazione, trasmissione e ricezione di segnali elettromagnetici, ha peso di 12 kg e viene
di norma installato su un supporto rigido dotato di una testa rotante, che permette l’orientamento nella
direzione desiderata. Il PC di controllo, a standard industriale ed adatto a condizioni d’utilizzo estreme,
è connesso al sensore mediante un’interfaccia USB e consente la gestione del sistema, la configurazione
dei parametri di acquisizione, la memorizzazione e l’elaborazione numerica dei segnali acquisiti nonché
la visualizzazione di risultati parziali in tempo reale. Infine, l’unità di alimentazione è costituita da due
batterie a 12 V che forniscono energia al sistema per una durata di oltre quattro ore consecutive.
Va rilevato che l’interferometro radar è un sensore trasportabile con facilità ed è in gra-
do di effettuare la misura remota di spostamenti in un gran numero di posizioni riflettenti appartenenti
ad una struttura e poste a distanza dal sensore dell’ordine di 300-500 m (anche in dipendenza dall’angolo
di incidenza delle onde elettromagnetiche sulle regioni riflettenti). Il sistema descritto è in grado di indi-
viduare la posizione (distanza dal sensore o range) e lo spostamento di differenti bersagli nello scenario
illuminato dal radar facendo ricorso: alla tecnica di trasmissione denominata SF-CW (Stepped Frequency-
Continous Wave), basata sull’emissione di onde elettromagnetiche di lunga durata (Continuous Wave) e
frequenza variabile a gradini (Stepped Frequency), che consente di distinguere differenti bersagli nello sce-
nario illuminato dal radar se la loro distanza relativa è maggiore di 0.50 m; all’interferometria radar, che
consente di valutare lo spostamento di ogni bersaglio individuato nello scenario illuminato dall’antenna
radar, una volta che l’immagine dello scenario stesso è stata determinata con passo temporale Δt, in base
alla differenza di fase dei segnali ricevuti nei successivi tempi di acquisizione.
L’interferometro radar è stato spesso utilizzato nel passato contemporaneamente a con-
venzionali sensori a contatto (accelerometri, trasduttori di spostamento) a fini di validazione. Una volta
completata la caratterizzazione metrologica del sensore, le applicazioni più recenti sviluppate all’interno
del Dipartimento o in collaborazione con altri centri di ricerca (Università di Perugia, Politecnico di Bari,
Università di Cambridge, CTTC di Barcellona) hanno riguardato:
–– la valutazione del fattore di amplificazione dinamica di ponti;20
–– l’esecuzione di campagne speditive di valutazione del periodo fondamentale di edifici storici;21
–– l’esecuzione di misure ripetute sugli stralli dei ponti al fine di monitorare dello stato della struttura;22
20. C. Gentile, G. Luzi, Radar-based dynamic testing of the cable-suspended bridge crossing the
Ebro River at Amposta, Spain, in AIP Conference Proceedings, vol. 1600 (2014), pp. 180-189
21. A. Saisi, C. Gentile, A. Ruccolo, Pre-diagnostic prompt investigation and static monitoring of
a historic bell-tower, in “Construction and Building Materials”, n. 122(1) (2016), pp. 833-844.
22. C. Gentile, A. Cabboi. Vibration-based structural health monitoring of stay cables by
microwave remote sensing, in “Smart Structures and Systems” n. 16(2) (2015), pp. 263-280.
23. C. Gentile, F. Ubertini, Radar-based dynamic testing and system identification of a
202
07-20161123.indd 14 29/11/16 12.53–– lo studio del comportamento dinamico di antenne strallate e linee di trasmissione.23
Inoltre, essendo lo spostamento una grandezza altamente sensibile alle diminuzioni di rigidezza general-
mente associate al verificarsi di un danno, sono in corso presso il Dipartimento studi rivolti all’utilizzo
degli spostamenti misurati dal radar per l’identificazione diretta di anomalie strutturali e danneggiamenti.
Metodi geomatici per la tutela delle costruzioni e dell’ambiente costruito
Tra le metodologie disponibili per il rilevamento e la tutela delle costruzioni un particolare interesse
scientifico è rivolto a quelle geomatiche. Le normali applicazioni sono ancora spesso confinate in una
moltitudine di sistemi locali indipendenti, mentre in un’ottica a più alto livello potrebbero essere unificate
potendo disporre anche di tecnologie satellitari per la geo-referenziazione dei dati.
I tradizionali metodi geomatici di controllo delle strutture e dell’ambiente costruito
prevedono l’utilizzo congiunto di diversi dispositivi di misura e metodologie di analisi delle informazioni
numeriche.24 Tra le moderne tecnologie geomatiche da ground per la misura degli spostamenti, attual-
mente da ritenersi ben consolidate e utilizzate in diversi ambiti, si annoverano innanzitutto gli strumenti
in grado estendere le misure alle superfici, come nel caso del laser scanning terrestre e della fotogramme-
tria digitale.25 L’uso di moderne stazioni totali motorizzate (precisione di qualche decimo di millimetro)
e di laser tracker (precisione dell’ordine dei centesimi di millimetro) consente invece il monitoraggio di
punti specifici sui quali sono stati posizionate apposite mire ottiche.26 Tali dati sono spesso integrati da
altre tecniche in grado di rilevare spostamenti lungo particolari direzioni (come la verticale nel caso delle
livellazioni) oppure con misure localizzate mediante sensori in fibra ottica e misure deformometriche con
basimetri, estensimetri e comparatori millesimali.
L’uso dei dati da spazio è invece un settore in rapida espansione che non va però inteso
come un puro ambito di ricerca, come dimostrato da diverse applicazioni pratiche con elevate frequenze
di acquisizione e su aree estremamente vaste. Spazio è in questo caso inteso come l’insieme di tecnolo-
gie satellitari in grado di osservare la superficie terrestre dallo spazio esterno con satelliti posti a diverse
distanze in funzione del dato da rilevare, che sia un segnale radio, una immagine ottica nel visibile o
in altre parti dello spettro delle onde elettromagnetiche. Va pertanto ricordato come nuove applicazioni
SMART per la tutela delle strutture sono oggi realizzabili sfruttando le informazioni provenienti da nume-
guyed mast, in AIP Conference Proceedings, vol. 1457 (2012), pp. 318-325.
24. M. Scaioni, L. Barazzetti, A. Giussani, F. Roncoroni, M. Previtali, M. Alba, Photogrammetric
techniques for monitoring tunnel deformation, in “Earth Science Informatics”, vol. 7 n. 2
(2014), pp. 83-95.
25. R. Fedele, M. Scaioni, L. Barazzetti, G. Rosati, L. Biolzi, Delamination tests on CFRP-
reinforced masonry pillars: Optical monitoring and mechanical modeling, in “Cement and
Concrete Composites” n. 45 (2014), pp. 243-254.
26. L. Barazzetti, A. Giussani, M. Previtali, F. Roncoroni, Laser tracker technology for static
monitoring of civil infrastructure, in “Lasers in Engineering”, vol. 32 n. 3-4 (2015), pp. 263-294.
203 ICT e sistemi smart per le costruzioni
07-20161123.indd 15 29/11/16 12.53rose missioni spaziali nazionali ed internazionali. Di particolare interesse risultano le osservazioni GNSS
(Global Navigation Satellite System), che al momento si basano su dati GPS (Global Positioning System) e
GLONASS (Global'naja Navigacionnaja Sputnikovaja Sistema) con l’integrazione dei (pochi) satelliti del si-
stema Galileo in orbita. Le applicazioni GNSS trovano impiego nella tutela delle infrastrutture sfruttando
i vantaggi di un posizionamento di tipo differenziale, ovvero mediante l’unione di un ricevitore fisso su
un punto di coordinate note e una serie di ricevitori posizionati sulle aree di interesse. Algoritmi di moni-
toraggio da immagini satellitari ottiche ad alta risoluzione sono invece ancora in fase di sviluppo, per la
complessità intrinseca nell’automatizzazione delle misure.
Va però segnalato come le nuove metodologie di object-based change detection, ovvero
quelle in grado di segmentare le immagini generando gruppi di pixel omogenei secondo particolari ca-
ratterizzazioni radiometriche, possono fornire un valido supporto per l’analisi delle costruzioni, essendo
queste ultime rappresentate nelle immagini da vari oggetti separati da linee di discontinuità geometrica
e/o radiometrica.
Le principali applicazioni delle tecnologie geomatiche al settore delle costruzioni e
dell’ambiente costruito spaziano dall’analisi del singolo edificio, allo studio dei distretti, fino ad arrivare
all’indagine delle grandi infrastrutture (ponti, dighe, gallerie, strade, ecc.) e di interi sistemi urbani. In
quest’ultimo caso, è possibile analizzare ed ottenere rapide informazioni durante il normale ciclo di vita
delle opere, oppure dopo eventi calamitosi quali frane, alluvioni, eruzioni vulcaniche e terremoti.
In conclusione, si può affermare che l’analisi delle informazioni geomatiche a più li-
velli è senza dubbio un settore di ricerca in cui l’integrazione delle tecniche di monitoraggio all’interno
di processi capaci di arricchire le più tradizionali operazioni è un elemento imprescindibile, mentre oggi
tali operazioni sono spesso condotte in modo indipendente, senza quindi sfruttare appieno i vantaggi in-
trinseci in un progetto multi-sorgente, multi-risoluzione e soprattutto multi-utente. L’unione dei dati ai
vari livelli, da quelli terrestri ormai consolidati a quelli da spazio ove ancora è necessario provvedere allo
sviluppo di nuove metodologie di elaborazione automatica, dovrà avvalersi sia di apposite funzioni dipen-
denti dalla specifica applicazione, sia di funzioni più generali per la co-registrazione delle informazioni.
Questa seconda parte del lavoro richiederà l’analisi delle nuove tipologie di dati ed in-
formazioni integrate a quelle esistenti ed in parte già utilizzate. Risolvere le problematiche di integrazione,
offrendo strumenti automatici per l’armonizzazione delle informazioni, significherà offrire ad una larga
utenza nuovi strumenti SMART di analisi in cui non ci si dovrà occupare delle operazioni di base sul sin-
golo dato, spostando sin da subito l’attenzione verso i requisiti dell’applicazione e, in altre parole, ai fini
di un lavoro direttamente produttivo.
4. Progettazione con strumenti computazionali e tecniche avanzate di produzione
L’architettura, in particolare quella considerata diffusa, è spesso piuttosto lenta nell’assorbire innovazioni
che, in altri settori, come quelli del disegno industriale o dell’industria manifatturiera, vengono veloce-
mente metabolizzate. Tuttavia, l’innovazione tecnologica che si avvale di strumenti computazionali e
204
07-20161123.indd 16 29/11/16 12.53tecniche avanzate di produzione sembra oggi consentire l’introduzione, anche per l’architettura e l’inge-
gneria, di metodi di progettazione e produzione maggiormente efficaci per quanto riguarda il processo di
elaborazione, costruzione e gestione dei manufatti edilizi.
Per strumenti computazionali si intendono tutte quelle tecniche che fanno riferimento
a modelli matematici che consentono di sviluppare simulazioni numeriche della realtà, ossia di utilizzare
codici per informare un modello dell’oggetto da realizzare, sovente tridimensionale. La possibilità di com-
putare o codificare alcuni processi permette di accorciare la distanza tra la creazione di un modello virtua-
le e la sua realizzazione che oggi può contare anche su tecniche avanzate di produzione. Nello specifico si
fa riferimento a strumenti come i centri di lavoro a controllo numerico, le stampanti 3D, i bracci robotici,
che si avvalgono di tecnologie evolute per poter produrre elementi con tolleranze bassissime, contando su
un’elevata interoperabilità tra diversi software e su interfacce digitali user friendly.
Il Dipartimento è da tempo attivo in questo ambito con particolare riferimento al rap-
porto tra progetto e fabbricazione digitale; al rapporto tra forma, materiale e prestazione nei sistemi
costruttivi realizzati con strumenti di produzione avanzati; ai nuovi processi costruttivi evoluti con mo-
dellazione BIM; all’integrazione tra software generativi, di modellazione BIM e gestionali; alla individua-
zione di modelli evoluti di workflow delle informazioni; infine, a scala più ampia, è impegnato sul fronte
dell’integrazione tra software di modellazione architettonica 3D e sistemi territoriali GIS.
Prospettive e implicazioni della progettazione computazionale
La personalizzazione del progetto è da sempre un elemento caratteristico del processo di costruzione
dell’ambiente costruito. Meno esplorate sono le possibilità di controllare questo processo attraverso l’in-
tervento diretto nella costruzione degli strumenti informatici.
La digitalizzazione del settore sembra invece decollare in modo molto rapido sia sul
fronte degli strumenti tecnici del progetto (software di modellazione, strumenti di simulazione, base dati)
sia sul fronte della finalizzazione contrattuale del manufatto (norme orientate al BIM, appalti su base di-
gitale, disegni di produzione prodotti direttamente dal progettista e non solo dal produttore industriale).27
Entrambi questi fronti raccontano come il processo di costruzione sia sempre meno legato a fasi succes-
sive poco ottimizzate e legate a operatori coinvolti ma sia sempre più orientata a valorizzare efficienza,
qualità e competenza.
Tecniche avanzate di produzione: la tecnologia di stampa additiva e prototipazione rapida per un efficien-
te passaggio dal modello alla produzione edilizia
Nell’ambito della struttura laboratoriale del Dipartimento sono state attivate sperimentazioni che utilizza-
no le più avanzate tecnologie CAM (Computer Aided Manufacturing), dalle macchine a controllo numerico
27. R. Naboni, I. Paoletti, Advanced Customization in Architectural Design and Construction,
Springer, Milano 2015.
205 ICT e sistemi smart per le costruzioni
07-20161123.indd 17 29/11/16 12.53Puoi anche leggere